Igor Ebuli Poletti
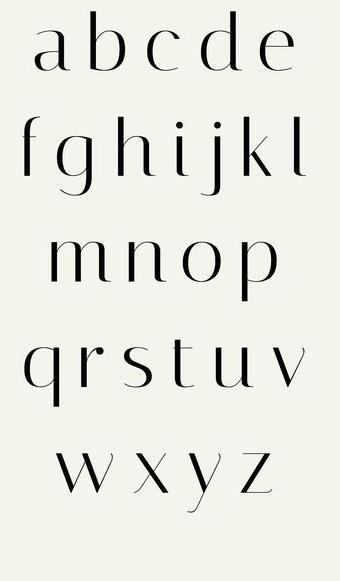

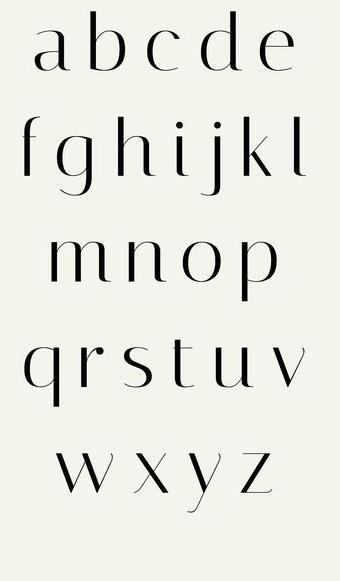
Il bio vegano
La bio vegana
La pittrice che di lavoro fa altro
La milanese a New York
Gli scampi crudi e le dame
La signora milanese iscritta al FAI
La cucina della signora milanese
La carpa dell’hair designer
La salsa bernese che non è bernese
Il feng shui e il divano a forma di fegato di struzzo
Il buffet
Gli uomini con le giacche con le toppe
La sarta vegana
L’influencer in Giappone
Il sessantenne in Harley
Il poeta
Il dentista di destra e il dentista di sinistra
L’ingegnere
Due donne, una sola toilette
Lo pseudo pittore con le ascelle pezzate
La fotografa impegnata
Il bio vegano
Il biovegano ha una età indefinibile, essendo l’ età anagrafica una convenzione protocapitalistica, purtuttavia collocabile nell’ultimo quarto di vita di un mammifero europoide a zampa media; non è possibile dire zampa corta o zampa lunga perché entrambi i casi presuppongono un deprecabile giudizio di valore che può offendere l’esemplare. Di statura elevata, indossa spesso scarpe fatte a mano da volenterose contadine messicane che non sanno che quello che stanno cucendo in un capannone senza aria condizionata andrà a rivestire i piedi bulbosi del biovegano, che le indosserà solo ed esclusivamente per scendere e salire dal suv color ghiaccio con targa ticinese, perché essendo fatte a mano sono terribilmente scomode. Il biovegano sarà il felice possessore di un pappagallo, un disgraziato psittaciforme dai colori sgargianti che vola libero nel suo attico di 450 mq accatastato come magazzino di granaglie; il pappagallo si chiamerà fridakahloanarchiasperanzaevcarità scritto tutto di seguito ed essendo diventato incontinente dopo essere stato nutrito a tofu e erbe minori dalla moglie del biovegano cagherà ovunque, soprattutto sul pavimento in parquet bianco antiscivolo che viene pulito a mano 5 volte alla settimane dalle due donne delle pulizie haitiane senza permesso di soggiorno, pagate 5 euro a settimana dal biovegano con le scarpe strette fatte dalle messicane che lavorano in un hangar senza aria condizionata che lui usa solo per salire e scendere dal suv perché gli limano gli alluci, il resto del tempo verrà dominato da un paio di sneaker firmate da un noto cestista NBA con profili in oro zecchino sulla tomaia.
Per quanto riguarda il lato, o l’angolo, che potremmo definire latamente riproduttivo/sessuale il biovegano si attesta, con delicatezza, su posizioni attendiste neolamarckiane. L’atto o processo, come preferisce definirlo, deve essere perpetrato in una ampia zona erbosa, erba medio alta che nasconda ma non del tutto, con accompagnamento di melismi ornitologici e grida di upupa, essendo l’upupa l’animale traslazionale del vegano. Per un certo periodo di tempo questo ruolo venne ricoperto dal riccio ma venne accantonato quasi subito per evidenti, eccessivi rinvii a pratiche sessuali dominate dalla mera quantità. Il bio vegano predilige la scelta e la cura del rapporto. Il problema che si annida nei visceri, contratti per l’emozione, degli amplessanti vegani è la presenza, eventuale, di una boassa altrimenti nota come merda di vacca dal
peso variabile tra i 3 e i 5 chili e la forma di un cappello alpino senza penna: non potendo tradire il suo credo ecologista il biovegano fingerà indifferenza, sarà anzi felice di inserire il suo microcomportamento sessuale nell’alveo della grande Madre Natura, ma, tuttavia, dopo essersi accoppiato puzzerà inevitabilmente e fortemente di merda e correrà a lavarsi, presumibilmente sotto una doccia prodotta da una azienda tedesca con 5 filiali in Polonia e 3 in Slovacchia che non rispetta nessun codice etico e che ha una pagina facebook gestita da una comunicatrice sovrappeso.
La bio vegana
La bio vegana si presenta al negozio accompagnata da 15 volpini nani, tutti di colore diverso, con 13 guinzagli in canapa lavorata a mano da un gruppo di commercialiste che dopo l’uscita di 678 circolari del Ministero delle Finanze in un giorno solo hanno deciso di produrre guinzagli fatti a mano. La lieve asimmetria tra il numero dei volpini e quello dei guinzagli è spiegata dal fatto che 2 di questi volpini, Lotario e Anassimene, soffrono di crisi abbandoniche e sono destinatari di un solo guinzaglio. La bio vegana indosserà un ampio impermeabile colore malva, colore inutile che nessuno sa quale sia, un cappello a falda larghissima con un criceto impagliato, un paio di scarpe simil tecniche con un tacco in gomma vulcanizzata ricavato dai copertoni di una autocisterna andata a fuoco, una sciarpa in finta seta, in realtà materiale sintetico, fatta a macchina da una terzista sottopagata in nero, una giacchina giallo senape con alcune margherite in vera plastica applicate sulla schiena, questo per evocare un panorama cripto-bretone, e un ombrello, che porta con sé soprattutto quando non piove, con la faccia di Frida Kahlo che muove le orecchie quando si apre l’ombrello. Ovviamente non avrà una borsa ma una sacca di tela laotiana, fatta a Como ma con scritto Luan Prabang sull’etichetta, con alcuni delfini che inseguono a loro volta altri delfini che a loro volta inseguono ancora altri delfini perché il delfino è un animale che non ha mai un cazzo da fare tutto il giorno, se non finire su borse finto laotiane. Varcata la soglia del negozio, dopo aver liberato gli orribili quadrupedi nani, impegnati ad orinare copiosamente sulle banane cilene in esposizione, la bio vegana si dirigerà con passo deciso verso il pane in esposizione, e inizierà ad osservarlo con lo sguardo salmastro del marinaio che scende a riva dopo 5 mesi di navigazione in mare aperto, laddove la bio vegana proveniva da un incontro col suo banchiere etico, che era arrivato in ufficio a bordo di un SUV di 7 metri per 8.
La pittrice che di lavoro fa altro
La pittrice ontologicamente spuria dipinge solo nei fine settimana degli anni bisestili, possiede una casa al mare comprata nei primi anni ’90 dal primo marito e si fotografa spesso i piedi. La pittrice ontologicamente spuria (spuria in quanto ontologica, ché nella sua pittura non vi è predicato, né soggetto, solo pigmento che cerca disperatamente un’essenza, un fondamento, una necessità, e fallisce con metodo), codesta pittrice, dicevasi, esercita l’arte solo nei fine settimana degli anni bisestili, il che, calcolando la periodicità gregoriana del tempo detratta della stasi creativa causata da gastriti e congiuntiviti cromatiche, comporta una produzione complessiva di sette quadri e mezzo, l’ultimo dei quali rappresenta un melone aperto che piange, lacerato da un cucchiaio IKEA. Costei, nomen ignotum ma di nome Elisabetta-Raffaella nei gruppi WhatsApp dei colleghi (lavora in banca, filiale con moquette e distributore a gettone di minestrina), possiede una casa al mare, a San Vincenzo, già di proprietà del primo marito, cardiologo omeopatico e collezionista di bustine di zucchero fallate. La casa è arredata in stile "sconfitta borghese post-sovietica": rattan sbiadito, piatti appesi con gabbiani dipinti da alunni ciechi e un'acquasantiera svuotata per contenere incensi giapponesi. Il vero nucleo pulsante della sua estetica, però, è il piede: se ne fotografa spesso i due (in controluce, su piastrelle liguri, o accanto a conchiglie stitiche), alla maniera di certi poeti decadenti che cercavano nei propri alluci un’epifania del nulla. Le foto vengono postate su Instagram con didascalie tipo “trasparenze dell’essere #bluGadda”, oppure “oggi il mare ha i miei piedi dentro”, mentre nei commenti si avvicendano architetti innamorati e troll con feticismi minuziosi. Dipinge con acquarelli del Lidl e una pena lancinante per il padre che non le disse mai che i suoi disegni erano belli. Nei rari momenti di euforia artistica, sempre preceduti da un aperitivo amaro e una telefonata alla cugina femminista, urla al soffitto “SONO LA FRIDA DI FOLLONICA!” e poi si addormenta sulla tela. Un giorno, forse, il MOMA le dedicherà una retrospettiva invisibile, fatta solo di didascalie scritte in punta di biro: “Opera assente. Ma l’intenzione c’era. ”
La milanese a New York
E' come a Milano solo che essendo a New York deve farci sapere che è a New York e tende a mugolare ogni volta che vede un cartello scritto in inglese, solo che essendo New York negli Stati Uniti tutti i cartelli sono scritti in inglese e la milanese expat temporanea mugola spesso, se non sempre. La milanese a New York è come se fosse a Milano ma è costretta a parlare in inglese e a vestirsi di un nero meno nero di quello milanese perché le hanno detto che il nero NY tende al grigio e non al deep black di piazza Missori, perché a NY per quanto possa sembrare impossibile non esiste una piazza Missori, il che da una idea netta di quanto gli americani non sappiano dare i nomi alle piazze e di come siano così indefettibilmente rudi e superficiali, e a nessuno sembra opportuno ricordare come Giuseppe Missori, il colonnello garibaldino a cui è dedicata la piazza, fosse nato a Mosca da genitori bolognesi, ma piazza Missori resta piazza Missori. Appena arrivata a NY la milanese chiede un caffè ed ottiene la consueta tanica di brodaglia nerastra che travasa con rara perfezione psicodinamica in uno dei 5 thermos griffati Louis Vuitton che si è portata da casa. Non è del tutto corretto scrivere griffati perché effettivamente i contenitori non hanno una forma terrestre ma sembrano le bottiglie di salsa di soia che si usano all’Akiba Fukurou di Tokio, il bar dei gufi: enormi, sagomati in modo iperrealista, hanno causato alla milanese problemi non irrilevanti alla dogana, poi risolti con una lunga, articolata e dialetticamente angosciante telefonata al consolato italiano.
Gli scampi crudi e le dame
La presenza di alcuni scampi crudi aveva creato qualche turbamento in due delle dame invitate alla cena, la milanese e la bresciana: la milanese, già dotata di un connaturato senso per la fellatio multipla e altresì portatrice di seni appena rifatti, tesi come due palle da biliardo che siano prossime ad andare in buca, era sconvolta dal fatto che lo scampo fosse stato cotto da vivo e presagendone la sofferenza si tormentava nervosamente il dito medio della mano destra sul quale giaceva un anello a forma di vitello morto, mentre la bresciana pensava solo a mangiare, sperando che tutti gli scampi arrivassero alla loro lunghezza massima, stabilita dalla Natura e da wikipedia in 24 cm., misura che alla bresciana ricordava qualcosa anche se non sapeva esattamente cosa. Entrambe indossavano un elegante abito estivo con un profondo spacco posteriore e ampie, intense aperture laterali che mostravano con generosa opulenza le gambe solcate da alcune massime di Archiloco, in greco antico. Per discutibile guizzo di revanscismo sociale il tatuatore, filologo romanzo trombato all’ultimo concorso vinto dalla prima cugina del titolare di cattedra, laureata in agronomia ma molto veloce ad apprendere, aveva scritto sulle cosce tonificate da ore di esercizi in piscina la ricetta della sogliola alla mugnaia in greco antico, ma né la milanese né la bresciana sospettavano di avere un pesce sempre con sé. La bresciana si era avvicinata al tavolo delle insalate fingendo di sapere di che cosa si trattasse, ossia di un singolo tavolo, così identificato nel tempo e nello spazio, dedicato alle sole insalate, che vi giacevano sopra come dei pasticcini dimentichi di mani interessate. Le concrezioni vegetali erano disposte in ordine cromatico, dal verde più intenso e squillante a quello più tenero e muto, che non squillava affatto, ed erano ancora intonse, essendo le signore milanesi di plastificazione diversa proficuamente intense a parlare le une con le altre senza ascoltarsi, essendo una delle costituenti del loro epòs esistenziale quello di parlare senza ascoltare nessuno. Accanto ad ogni insalata c’era un piccolo segnaposto stampato in un grazioso carattere senza grazie, di cui si intuiva una oscura utilità ma che nessuno riusciva a leggere, pur fingendo di avere capito tutto. Preceduta da un leggero stridio di rondoni caduti al suolo perché stufi di vivere era, nel frattempo, entrata la dama major, la proprietaria dell’appartamento, vestita con un abito color confetto drappeggiato ad ampie volute, un veliero di carne, molta, ed ossa, ben celate, che avanzava nel mare della serata con la sicurezza altera di un incrociatore, pur essendo solo un veliero. L’altezza della dama major era di poco superiore al metro e 56 centimetri ma in virtù di un complesso e insondabile sistema di carrucole ponti mobili e rialzi interni sfiorava il metro e 85 centimetri, riempiendo i centimetri
mancanti tra la sua altezza effettiva e quella posticcia di debordante tracotanza. Parlava con voce sapientemente wagneriana, un alternarsi di toni scuri con altri ancora più scuri, e tutto stava procedendo per il verso giusto fino a quando, avvolta da metri di sartiame sericeo, non si avvide di uno dei camerieri avventizi, assunti in nero per la serata dal marito della dama major, che le apparve davanti all’improvviso con un vassoio sul quale erano allineate 4 aragoste morte, disposte artisticamente a formare la lettere E di Elena, che era propriamente il nome della dama major. Il cameriere era magrebino, con un piccola testa coperta da un vello di ricci neri di piccola consistenza, era sbucato da dietro le ampie spalle di una delle bresciane, spalle forgiate da ore e ore di piscina e di altre flessioni innaturali dei trapezi, e si era trovato avviluppato senza alcuna possibilità di districarsene nelle invadenti volute di tessuto dell’abito di seta che lo avevano dapprima bloccato per i piedi, quindi legato come un coniglio prima di essere cucinato, e, preda non voluta di questi lacci di Cardin, si era scoperto seduto tra le gambe della dama major, dove aveva trovato un ambiente comodo e per nulla asfittico: tuttavia, dopo che il suo corpo si era trovato accosciato a forza, le aragoste avevano deciso di prendere il volo, proiettarsi verso l’occaso incipiente e, dopo aver trasvolato l’ala est dell’ampio salone delle feste si erano infilate, tutte e quattro, in altrettante scollature a V di 4 signore presenti, per la precisione una mora, una bionda naturale, una bionda tinta e una rossa tenue: ivi insediatesi, si erano bloccate. Qualche gridolino di gioia, avere una aragosta morta in mezzo alle tette era uno dei desideri reconditi delle annoiate puerpere, subitamente seguito da un tonfo sordo, primigenio, come se la crosta terrestre si fosse rotta in quel momento. La dama major aveva perso i sensi, non era pronta ad avere un cameriere magrebino in mezzo alle gambe, e il suo occipite si era trovato momentaneamente senza afflusso sanguigno, facendola rovinare a terra come uno gnu colpito da un cacciatore; con un inatteso guizzo di salvezza il cameriere era riuscito a mettersi in salvo accanto al pianoforte, pochi istanti prima che il condominio di carne gli cascasse addosso con un fragore inopinato. Alla vista del tonfo sordo tutte si girarono dall’altra parte, cercando una foglia di insalata da sgranocchiare. Anche la milanese inghepardata sconta una certa residua difficoltà di movimento pur nel suo costante e invincibile inghepardimento: sicura, ormai certa della definitiva saldatura dei punti di sutura delle 67 operazioni di chirurgia estetica che le hanno tralasciato solo il lobo dell’orecchio destro, che ha infatti un colore diverso dal resto della copertura epidermica, si lancia sicura verso la sua utilitaria azzurra con interni in pelle marrone chiaro, si lascia avvincere dal suo stesso slancio, si cala sicura nelle spire del suo avvitamento femorale, vede, con nettezza, la portiera della
deliziosa vettura ma, a un tratto, sente uno strappo, un piccolo clangore, un impercettibile spostamento dell’aria circostante, un rumore di piccione morto che cade al suolo pur in assenza di piccioni morti, quindi si ferma, si arresta sul ciglio del marciapiede, abbassa lo sguardo ad accarezzare le unghie dei piedi finemente pittate di un indaco che ricorda quello del pavimento di un quadro di van Gogh, si porta una mano, la sinistra, al petto, e capisce che la verità della cosa è una sola, la gonna superavvolgente che le era stata cucita sui glutei si era miserevolmente strappata al centro, e la ferita oscena del tessuto si stava propagando silenziosamente a tutto il resto. Battito accelerato, finta di corpo, disinvolto trascinarsi verso il mezzo, ingresso strisciante nello stesso, respiro primordiale profondo, ricomposizione della parte restante dell’outfit fedifrago. Ricerca delle chiavi di accensione, contenute all’interno di un raffinato portachiavi di pelle di squalo, nota per la sua morbidezza al tatto, strano che lo squalo possa avere una pelle così morbida ma la milanese da tempo non si pone più domande, ma le chiavi non si trovano. Non ci sono. Sono ritornate nel ventre dello squalo, pensa la milanese, le avrò lasciate da Evandro (il parrucchiere che si chiamerebbe Arturo, di Molfetta, ma che si fa chiamare Evandro Fashion Guru), sotto una di quello orrende poltrone a forma di testicolo, il non plus ultra in fatto di sedei per parrucchieri, ma adesso non posso uscire da qui, se solo mi alzo mi si vede il culo, ma, UN MOMENTO, ecco la tardiva, imprevista resipiscenza, parola IMPRONUNCIABILE se non si possiedono molari perfetti, se sono seduta qui dentro devo essere entrata in questa macchina, e per aprire la portiera le chiavi devo averle avute, quindi apertura immediata del finestrino, collo che si allunga in modo innaturale all’esterno, chiavi che ballano seguendo una danza della mesoindia infilate nella serratura della portiera, elegante mano affusolata che esce, veloce, ratta, a ghermirle, conseguente accensione del cocchio celeste, robusta grattata prima dell’inserimento della marcia, partenza a razzo verso casa, ampio respiro di sollievo, gonna in fase di disfacimento totale. Su tutto questo le unghie color indaco restano al loro posto, tutte e 20 (10 dei piedi e 10 delle mani, la consueta pittatura polidattilica della milanese).
La signora milanese iscritta al FAI
La signora milanese iscritta al FAI si era decisa ad iscriversi ad una associazione che le interessava quanto il sesso delle carpe del laghetto davanti a casa solo dopo che la visita dal ginecologo le aveva restituito un quadro di assoluta normalità, il fatto che non avesse più mestruazioni a 59 anni era del tutto normale, anche se uno dei suoi tre chirurghi estetici l’aveva descritta come una magnifica quarantenne, subito dopo aver ricevuto conferma del bonifico transitato sul suo conto corrente. La scossa gli era arrivata da un impercettibile, per gli altri, trasalimento del suo orologio iperdigitale atto a ricevere mails fare caffè illuminarsi ad abundantiam accompagnare la sua vita anche nei momenti più inutili, quali quelli durante i quali riceveva del denaro dalle sue pazienti che sentendosi quarantenni, non capivano perché non avessero più il loro appuntamento mensile con la fertilità. L’iscrizione al FAI permetteva, tra le altre cose, di visitare alcune delle più belle ville e villotte e villazze della sua zona ed essendo socia fondatrice e patrona delle arti e dei mestieri, quali arti poi, e quali mestieri, una delle attività che avrebbe dovuto donare alla Associazione era quella di stare in piedi accanto alle porte aperte delle villotte, lei si era specializzata in queste, le ville e le villazze erano di competenza delle amiche over seventy, fingere di essere felice di essere lì, fingere di non indossare scarpe con 36 cm. di tacco e fingere di sapere chi erano gli autori dei quadri appesi alle pareti. Il tutto con la trasognata noncuranza di chi non ha nessuna intenzione di fare quello che sta facendo ma che pensa, nel retro delle sue stanze cerebrali, che se non lo facesse sarebbe peggio, e in questi saloni pieni di quadri che non conosceva e tappetti che, pensava, sarebbero stati meglio nella sua casa al mare, di solito c’era sempre una leggera aria condizionata, che le permetteva di respirare l’aria infuocata delle estati lombarde senza eccedere nella enfiagione dei suoi seni paranasali, di recente costruzione, Una sola volta, rimasta perfettamente incisa nella sua mente bicamerale, era successo che in una comitiva di visitatori svettasse, per altezza e colore dei capelli, un rosso vivo che aveva conosciuto la speranza del castano, una pallida imitazione di una femminista di sinistra che, con una borsa di tela riciclata con alcune strane scritte in tedesco e un paio di incongrui, per la signora, pantaloncini corti con tasche applicate ai lati avesse alzato il suo dito indice e, con voce insolitamente vibrante, avesse indicato una scritta a caratteri cubitali che ornava tutto il salone e che lodava in modo fragorosamente acritico il ventennio fascista nella persona del suo fondatore: la signora milanese, equidistante dalla politica e da ogni forma di pensiero minimamente evoluto perché la politica non paga gli alimenti ma gli ex mariti sì, sia di destra che di sinistra che di centro, aveva
alzato le spalle, si era drappeggiata uno scialle in seta del Borneo intorno al collo con la decisione e la destrezza con la quale Horatio Nelson aveva dato inizio alla battaglia di Trafalgar e, fissando la rossa anguicrinita le aveva sibilato, fissandola nei rotondi e spalancati occhioni femministi “Beh, certo, questa è storia, è storia” e si era girata verso il ritratto della baronessa Manfredi, la padrona di casa, deceduta per una rovinosa caduta da cavallo nella lontana estate del 1911. Meglio le baronesse decedute che le rivoluzionarie in visita, signora mia. Quelle almeno non parlano. La signora milanese aveva un appuntamento con la signora bresciana in un sushi bar in zona duomo ma era in considerevole ritardo perché il nuovo smalto organico cruelty free arrivato in settimana dalla Thailandia faceva una fatica estrema ad asciugarsi, forse in Thailandia c’è più sole, si chiedeva la signora, ma il ritardo si stava facendo imbarazzante, la bresciana la stava aspettando e nel concilio forense delle sue amicizie la bresciana era nota per la puntualità e per la tendenza a rimarcare per tre lustri chi, poverino, fosse arrivato in ritardo ad un appuntamento, emettendo una bolla di scomunica che avrebbe segnato a fuoco le carni della malcapitata: poiché alle sue carni teneva molto, non fosse altro per i soldi che aveva speso per mantenerle così turgide, la signora milanese, effettuando un salto concettuale che le avrebbe sicuramente creato una c efalea tensiva per le successive 48 ore, aveva abbandonato a malincuore l’idea di indossare uno dei suoi 89 sandali pitonati e si era decisa a offrire una possibilità alle sneakers Powerball Ranger Suntan 600, che avevano il non trascurabile particolare di essere scarpe chiuse, con le dita e le conseguenti unghie dei piedi al coperto. Comprimendo una fitta di dolore che le dilagava nello sterno rimise a posto i sandali nella scarpiera con le ante in onice, emise un grosso sospirò ed infilò i piedi nelle Suntan 600, e solo in quel momento capì che 600 era il peso delle calzature, ed era espresso in chilogrammi. Dopo averle allacciate tentò di alzarsi, riuscì fortunosamente a raggiungere una posizione semieretta ma la scarpe la trascinavano inesorabilmente verso il basso, riusciva a fare solo dei piccoli, brevi passi con le gambe rigide e le rotule scricchiolanti: nel sedersi per cercare un momentaneo sollievo aveva avuto una fascicolazione improvvisa alla gamba destra che era scattata innaturalmente in avanti proprio mentre i due carlini nani, Edo e Eda, si stavano avvicinando allo specchio della cabina armadio per guardarsi. Animali orrendi, dotati di piccole zampette vestigali e una monoespressione di orripilante idiozia, non si aspettavano in alcun modo che la loro amorevole padrona potesse colpirli direttamente con una scarpa dal peso unitario così elevato, e in pochi secondi i loro corpi vennero prima proiettati verso la parete est, poi verso quella sud, quindi verso quella nord per poi arrivare a fine corsa nell’acquario in titanio che conteneva Osiride, un
piccolo e grazioso piranha di circa 2 anni ipovedente. Seguendo il rumore dell’acqua che si increspava in seguito alla caduta dei due corpi canini, Osiride pensò che fosse già ora di cena e fece quello che avrebbe fatto un piranha in un caso del genere, aprì le mandibole e le richiuse per 32 volte di fila, ricavandone una certa soddisfazione. La signora milanese con l’arto ancora in estensione arrovesciò entrambi gli occhi verso l’alto e con le sclere ormai bianche cadde al suolo, svenuta, emettendo un piccolo rantolo, tipo un ruttino.
La cucina della signora milanese
La cucina della signora milanese raggiunge con estrema facilità l'estensione di un ettaro, circondato da fitte siepi di lauroceraso del mar Nero. Al centro di questa superficie da campo di calcio svetta, c'è sempre qualcosa che svetta, una cucina di acciaio e legno con 9 forni, 6 forni a microonde, 89 fuochi, tre filippini nati vicino a Varese inseriti direttamente nel forno centrale, pronti all'uso. Il corpo centrale della cucina è comandato in remoto grazie a un telecomando che viene gestito dal riconoscimento oculare e dal battito di ciglia della signora milanese che, purtroppo, tende a utilizzare la sua cucina nei mesi estivi, durante i quali però indossa costantemente occhiali Cartier in peltro stagnato, avvolgenti, che rendono estremamente complesso il controllo del kombinat cuciniero. In quei casi di oscuramento palpebrale la cucina non può funzionare, resta inattiva e di solito la signora milanese con ospiti o senza ospiti dirotta la sua attenzione ridolinesca verso insalate pronte, meloni messicani a fetta elicoidale, piatti freddi o tiepidi, insalate di riso con un elemento che deve essere in aperta contraddizione con l’insalata di riso stessa, vedi del mango tagliato in modo irregolare o delle piramidi di mortadella bio. Quello che va detto sin dall’inizio, let’s get this out of the way, please, è che la cucina della signora milanese (Milano centro, ma con un certo risentimento per Brera, ché le pare un quartiere da poveri con la passione per le pashmine) non è una cucina nel senso tradizionale del termine. È un sistema. Un aggregato. Un conglomerato semi-autonomo. Un’entità pulsante di legni norvegesi evaporati e acciaio criogenizzato, dotata di un’estetica post-monastica da monastero tibetano disegnato da un architetto ucraino sotto stimolazione magnetica transcranica. Superficie utile: un ettaro. Che è già ridicolo, ma accettiamolo per amore del paradosso. L’ettaro è bordato da siepi di lauroceraso importato (clandestinamente?) dal Mar Nero, una varietà tossica per i gatti ma adorata dalle api anoressiche. Al centro ovvio che c’è un centro, c’è sempre un centro, e svetta, svetta sempre qualcosa, in ogni narrazione antropocentrica l’ego è verticale si erge questa monumentale cucina madre, un mostro a nove teste formato da:
• 9 forni tradizionali, ciascuno con funzione preghiera tibetana incorporata
• 6 microonde, uno dei quali serve esclusivamente per scaldare la crema per i piedi
• 89 fuochi, ma nessuno acceso da febbraio
• 3 filippini (nati vicino a Varese, particolare importante, perché questo li rende “integrati” nel senso in cui lo intende il Corriere della Sera), posti dentro il forno centrale, non come cuochi, ma come elementi strutturali del forno stesso si muovono solo in caso di brunch emergenziale.
L’intero blocco operativo è controllato da un telecomando a riconoscimento oculare progettato da un team di ingegneri con master in Psicocibernetica culinaria. Funziona così: la signora guarda, sbatte le ciglia una volta, e parte il risotto. Due volte: il forno si autodecontamina. Tre: i filippini preparano il guacamole usando solo il pensiero. Ora: problema. La signora milanese, nei mesi estivi, sviluppa una dermatite da esposizione aristocratica e quindi indossa ininterrottamente degli occhiali Cartier in peltro stagnato (stagnato! chi stagnerebbe volontariamente il peltro? Solo chi ha già un borsino del rame personale in casa). Occhiali avvolgenti, mascherina paraocchi da equino depressivo, effetto navicella spaziale. Il riconoscimento oculare quindi fallisce sistematicamente, il kombinat culinario si blocca in loop, e la signora è costretta a ordinare sushi di design da un ristorante dove il riso viene disposto con il laser. Nel frattempo, i tre filippini stanno ancora nel forno. Leggono Proust in lingua originale, aspettano il segnale. Ma la signora non sbatte più le ciglia. Ha un piccolo tic solo per il gin tonic.
La carpa dell’hair designer
La signora milanese si reca in media 5 volte al mese dal suo parrucchiere, che assolve per lei a una funzione di mera catarsi, pur ignorando, la signora milanese, che cosa voglia dire catarsi, mentre sa perfettamente per istinto nativo che cosa significa parrucchiere. Il salone che ospita il luogo di finissaggio del capello è ricavato da un vecchio hangar con pareti ricoperte di boiserie di legno di faggio, da terra al cielo, con un parziale recupero del pavimento originario del quale sono state conservate anche alcune macchie di grasso, ormai seccate, che hanno creato alcune piccole scritte da pavimento, dei piccoli graffiti orizzontali che il nuovo proprietario spaccia per etruschi, anche se sono solo macchie di grassi di 45 anni prima. La pettinatura della signora milanese si basa su due capitelli corinzi della haute couture contemporanea, con nuvola o senza nuvola; il capello può essere lavorato fino a farlo diventare una massa cubiforme fintamente controllata, a nuvola, appunto, o rigidamente ingabbiato in piccoli parallelepipedi irregolari, a forma di mattoncini Lego, sistemati in modo asimmetrico su tutta l’estensione del cranio della signora milanese dalle mani sapienti del maestro della capigliatura, che fischiettando a labbra rigidamente serrate lavorerà sulla testa delle sue clienti per circa 4 minuti, creando forme aberranti ispirate al feng shui, al Chumon giapponese, alla corretta comprensione buddista, il tutto per una cifra che oscillerà tra i 500 e gli 800 euro, con o senza fattura in relazione al tipo di nuvola. In alcuni di questi saloni, solo nei migliori, una piscinetta di gomma gialla al centro della sala d’aspetto conterrà 5 coppie di carpe giapponesi, che saranno però dei cavedani dipinti sotto sedazione con pigmenti naturali. La piscinetta di gomma gialla è stata acquistata in un negozio di giocattoli ma si finge sia del grande designer giapponese Hoshio Tokimura, che ha fatto della apparente ipersemplicità del suo design la chiave principale del suo stile. Da anni non si presenta più in pubblico e pare viva con due enormi giraffe di gomma verde, perché avrebbe desiderato dei dinosauri ma la ditta produttrice, del trevigiano, si è sbagliata e gli ha preparato due giraffe: per questo motivo, le ha ridipinte di verde e non esce più di casa. Si chiamano Nikita e Gustav. Quando i pigmenti naturali dei cavedani scemano, il cavedano viene delicatamente sollevato con un retino, a salone chiuso, e servito con patate e verdurine nella casa al mare dell’hair designer. Le patate e le verdurine sono collocate nel piatto seguendo la delicata forma grafica di un haiku di Basho, che spesso non ha un significato particolarmente pregnante ma che conferisce al tutto una smagliata eleganza.
La salsa bernese che non è bernese
La milanese di anni indefinibili ma rientrabili in un compasso temporale che va dai 45 ai 65 prepara la salsa Bernese, sempre che esista una salsa Bernese anche nel mondo e non solo nella aspra interiorità della milanese, senza mettere mai i pollici dentro la elegante macrociotola in legno non trattato anche se é stato trattato in segreto. I pollici, ne ha due, restano in attesa degli sviluppi della salsificazione, non sempre fausti. Le uova sono sempre in numero dispari, la penuria di galline a Berna ha reso indispensabile questo accorgimento, l’ideale sarebbe se fossero 3 ma spesso sono 7 o 9 perché a Milano le galline e le relative uova abbondano. Dopo essere state percosse da un piccolo egg intruder in wolframio sull’uovo si formerà una crepa a forma di pentacolo, che degenererà in un collasso del tegumento fino alla fuoriuscita dell’uovo interiore, l’altro-dasé dell’uovo ancora integro. Giunta a questo stadio della produzione, la milanese interromperà temporaneamente il processo per la consueta lezione di pilates acrobatico, appendendosi al balcone del salone e ballonzolando per 4 minuti sopra le biciclette elettriche di corso Buenos Aires. Poi cadrà, senza volerlo, su un raider cileno laureato in microbiologia, per risalire nel suo appartamento e proseguire la salsificazione bernese.
Il feng shui e il divano a forma di fegato di struzzo
Il divano a forma di fegato di struzzo è una delle vette della milanese che è tornata dal mare, tornata dalla montagna, tornata dal lago, tornata dal fisioterapista e non sa come impegnare i preziosi minuti delle sue preziose giornate. Nessuno, ovviamente, sa esattamente come sia fatto un fegato di struzzo, a parte forse gli struzzi, ma la milanese sa cose che nessuno sa. Dopo un momento di raccoglimento, dopo aver ucciso un acaro dispettoso che aveva deciso di fare l’acaro sulla sua tela di Marcel Audobon, genio martinicano della pittura fatta coi glutei dipinti e ripassati nel pan grattato, si era decisa a compiere il grande passo, one small step for la milanese, one giant leap for mankind, e comprare un divano in tessuto damascato Paisley Blossom lungo 14 metri, a forma di fegato di struzzo, il dernier cri dell’arredamento di interni ambrosiano, il grido di dolore per chi avrebbe dovuto consegnarglielo e montarlo. Poiché nessun vivente sapeva come era fatto un fegato di struzzo, a parte, forse, lo struzzo che era collaborativo, il divano era una grande L con al centro un elemento di discontinuità o di asimmetria, una microseduta in peltro che si sposava perfettamente col resto della struttura; ai lati due comode maniglie erano state predisposte per eiettare gli eventuali ospiti indesiderati, che avrebbero percorso un semicerchio perfetto sfiorando la Monstera Deliciosa, altrimenti nota come la pianta del formaggio svizzero per via della sue enormi foglie bucate che la facevano assomigliare a una groviera, e sarebbero caduti nella piscina ospitata dal terrazzo al piano inferiore, di proprietà della famiglia Clerici Colombo Martinetti Clerici, che viveva in Kenia 314 giorni l’anno. C’era un solo problema, il feng shui nella persona della arredatrice milanese di feng shui, amica intima della milanese che deve comprare un divano per il salotto dell’ala est.
Il buffet
Il buffet è la versione attuale del blòt norreno, il sacrificio degli armenti che propiziava una particolare generosità degli dèi nei confronti degli umani. Il buffet è un rito iniziatico che soddisfa alcune precise categorie normative, che approfondiremo in seguito. Le macrotipologie dei buffetisti si tripartiscono nei silenziosi della respirazione circolare, nei finti zoppi e nei preponderanti settuagenari. I silenziosi della respirazione circolare. In questa categoria l’età è fluida, troviamo preadolescenti che si disputano il campo di azione con sessantacinquenni con sneakers verdi, il dato comune è la capacità di respirare solo con i seni paranasali facendo uso delle formazioni muscolo-membranose meglio note come guance come magazzini per lo stoccaggio e la successiva ingestione di tutto quello che si trova sul tavolo del buffet, comprese eventuali posate in legno, tovaglioli, saliere: le guance di questi soggetti aumentano di volume fino a raggiungere dimensioni simili all’horrea Galbana, che al tempo dell’imperatore romano Galba raggiungeva una estensione di circa 21.000 mq. In esse i silenziosi riescono a fare coesistere ogni tipo di sostanza commestibile, come si ricordava più sopra, e la loro straordinaria abilità di usare soli i seni paranasali per respirare li rende totalmente autonomi da altre forme più consuete di inspirazione. I loro nasi sono spesso più lucidi, alcuni assumono forme aerodinamiche, questa funzione che sviluppa l’organo li rende straordinariamente efficaci nel trangugiare 16 panini al latte senza cedere al paonazzo o alla complicanza respiratoria. Solitamente arrivano ai lati del buffet, già ampiamente respirati, lanciano una occhiata da agrimensore alla postazione, e iniziano a tritare, essendo anche dotati di dentatura perfette, tutto quello che incontrano nel loro campo visivo, anche oggetti inanimati, come si ricordava più sopra. I silenziosi della respirazione circolare, detti anche “gli aerofagi liturgici” si muovono nel perimetro buffet con una grazia anfibia, fluttuante, come se le caviglie toccassero appena il suolo. L’occhio è sempre avanti, ma lo sguardo è fisso in basso, là dove si annida il profumo dell’Empireo in miniatura: il trancetto di quiche, la falda di roast beef freddo, la mousse in bicchierino da laboratorio. Essi non parlano. Non fiatano. Respirano in loop, come gli ottoni in orchestra sinfonica. L’aria entra e rientra, mai sprecata. È una respirazione funzionale, quasi sacramentale, utile alla gestione del flusso gastrointestinale ma anche alla mimetizzazione tra la folla. Silenziosi, sì. Ma predatori. Predano a rate. Non vanno mai all’assalto, non alzano mai il tono, non emettono segnale. Ti passano accanto che non li senti eppure il tuo piatto si svuota, l’oliva è sparita, l’ultimo crostino di baccalà è già stato inghiottito con la tecnica dello yoga laringeo. Sono gli unici a conoscere i punti ciechi del buffet: lo
snodo tra il cameriere e il vassoio caldo, l’istante in cui il piatto nuovo sostituisce quello vecchio, ancora vuoto. Lì loro si materializzano, operano, scompaiono. C’è chi dice siano addestrati. C’è chi li ha visti nei funerali quanto nei battesimi, sempre con quella postura da figura professionale, da aggregato umano interinale, da entità liminare tra il bisogno e l’astinenza. Non interagiscono. Non ringraziano. Ma si sa, nemmeno gli dèi del blót pretendevano parole: bastava il sangue. Oggi basta il tartinabile. Oggi li trovi ovunque, come le erbacce nei marciapiedi di quartiere gentrificato: gli uomini con le giacche con le toppe non si estinguono, si mimetizzano. Sembrano passati di moda, ma in realtà hanno solo raffinato la strategia evolutiva. Hanno sostituito la cravatta con il foulard, lo sguardo smarrito con quello accigliato, l’aria da bibliotecario con quella da “mentore del pensiero laterale”. Sono sopravvissuti agli anni Ottanta, ai Novanta, a internet e alla sigaretta elettronica, portando con sé la loro armatura semifoderata, quella giacca color marroneforesta-bagnata con le toppe a contrasto che gridano: ho letto un paio di saggi, ma con umiltà. In contesti lavorativi si mimetizzano tra i consulenti, ma è solo una copertura: in realtà sono in missione antropologica. Presenziano a fiere, a conferenze, a vernissage con vino frizzante da discount, e hanno sempre un aneddoto pronto su quando “una volta, in Toscana”, perché ci hanno fatto un master. Parlano spesso con la mano a cucchiaio, a metà tra il gesto mediterraneo e il segnale massonico. Amano le metafore agricole: la semina, il raccolto, il frutto del lavoro, la potatura del brand. Le toppe, sia chiaro, non sono un dettaglio: sono un emblema. Un badge d’identità. Una forma di escrescenza simbolica, come la gobba di certi santi iconografici o l’occhio velato dei veggenti. Più sono consumate, più vale il personaggio: nessuno si fida di un toppato nuovo. Le toppe devono portare memoria, saper raccontare una laurea presa nel '91, un seminario su Deleuze e la comunicazione d’impresa, una piadina mangiata con entusiasmo a Rimini durante un festival dell’innovazione. Eppure, sono inoffensivi. Sono come i pipistrelli: brutti, antichi, vagamente inquietanti, ma incapaci di fare del male. Salvo quando ti consigliano un libro.
Gli uomini con le giacche con le toppe
Gli uomini con le giacche con le toppe sono tra di noi dalla fine degli anni ’60, ossia da quando un capo che era di esclusiva pertinenza di nobili inglesi decaduti astigmatici e agricoltori laziali troppo impegnati a stare chinati sui campi per andare a comprarsi degli abiti nuovi ha rotto gli argini che lo contenevano ed è dilagato nella moda maschile, con uno tsunami iniziale che si è poi trasformato in un lago tranquillo, un territorio irriguo nel quale commercialisti leggermente sovrappeso e esperti di marketing del surgelato sguazzano allegri come cavedani infoiati. Il cavedano è un pesce dalla foia spesso incontenibile. La toppa sui gomiti della giacca era nata come un rammendo, un necessario riempimento dei buchi che spesso diventavano voragini che altrettanto spesso dilaniavano la stoffa proprio in quella posizione. In parallelo con la nascita del kintsugi, la raffinata tecnica di restauro dei ceramisti giapponesi di fine ‘400 che riparavano con l’oro le tazze in ceramica rotte, con ampio utilizzo di lacca urushi, il mercante fiorentino Pela Gualducci del Sesto di Oltrarno metteva delle pezze rosso fuoco sulle maniche rotte delle camicie che vendeva, guadagnando così il triplo e non nascondendo la riparazione ma, al contrario, evidenziandola. Nulla si inventa e tutto si trasforma, e da Firenze a Tokio si facevano le stesse cose, usando parole diverse. La giacca di tweed con le toppe trova la sua collocazione ideale su una station wagon condotta, per esempio, dal sullodato commercialista con un lieve sovrappeso, che sarà uso indossarla mentre si reca nella casa di campagna, insieme a chi vuole lui; questo non lo specifichiamo ulteriormente perché non siamo in alcun modo voglioso di entrare nei privati, che supponiamo fastosi, dei commercialisti lievemente sovrappeso. Il braccio giacerà parzialmente inerte e penzolante fuori dal finestrino, per agevolare la piena distensione della toppa a contrasto, e verrà improvvisamente ritratto dopo essere stato centrato dal fecaloma di un piccione irriguardoso, che accompagna spesso le macchine di chi va in campagna. Dopo aver superato alcune curve insidiose e aver sbagliato strada 29 volte, seguendo erroneamente le indicazioni del navigatore tarato in swahili che non riesce a modificare, l’uomo con la giacca con le toppe in modalità week-end comincerà a fingere di apprezzare l’aria cristallina della campagna, il delicato afrore di merda bovina che nella campagna ha il suo spazio elettivo, la presenza di insetti dal corpo traslucido che entreranno senza requie nell’abitacolo della vettura e si infileranno sotto la manica destra della giacca, quella impegnata a cercare di tutelare il braccio che sta cercando si sintonizzare Netflix sullo schermo da 23 pollici del computer di bordo, con decidua fortuna, e ivi decideranno di fermarsi, cominciando a creare un prurito
insopportabile al guidatore, che comincerà a sentire anche muti, continui e intense lamentazioni della sua prostata. Essendo villa Ada o villa Elena o villa Graziosa, questi i nomi più gettonati, lontana ancora quella manciata di chilometri inconciliabili con la sua prostata, il conducente cercherà un angolo particolarmente ameno dove fermarsi per espletare la indifferibile pratica urinaria, trovando in un faggio su un poggio un locus animae perfetto, con vista sulla vallata sottostante. Tale angolo appartato sarà tuttavia considerato un luogo ameno anche da una piccola ma unita famigliola di cinghiali che non essendo a conoscenza dell’importanza della giacca con le toppe vi si recherà poco prima del sopraggiungere dell’uomo con la giacca con le toppe. Un delicato giuoco di sguardi, la faccia dell’uomo che si allineerà all’occhio destro del cinghiale, un piccolo spasmo dell’orbicolare, una zampa, questa del cinghiale, che disegnerà alcuni piccoli cerchi nel terreno, ecco la giacca prendere il volo, le toppe sui gomiti diventare ali di un enorme gabbiano, l’uomo cadere nell’abitacolo della prestigiosa autovettura, la macchina partire improvvisamente, il cinghiale sogghignare, l’uomo capire all’improvviso l’importanza della prostata nella sua vita.
La sarta vegana
Può sembrare un azzardo retorico e concettuale e forse lo è, ma la sarta vegana è apparsa su questa terra nel primo quarto dell’ultima metà della prima parte del secondo quarto del terzo quinto del sesto secolo d. C., più precisamente intorno al 2015. Il vegano è un distillato senza zucchero del vegetariano, e incardinerà la sua esistenza sul rifiuto di tutto quello che non finisca con una consonante, a parte il tofu che termina con una vocale ma nessuno è perfetto e il vero vegano accoglie, esalta, abbraccia e salvifica l’imperfezione, essendo già perfetta la Natura (che, peraltro, finisce anche lei con una vocale, almeno in italiano). Il nostro fenotipo sociologico di sarta vegana avrà due nomi e sette cognomi, rivendicando con finta noncuranza una origine nobiliare testimoniata da sette casali in campagna, due ville al mare, una in montagna e una in collina, sede di una delle sue 12 associazioni no profit chiamate, rispettivamente: Il Melo, Il Pero, La nutria che venne dal freddo, La Giara di Elisa, La focaccia di Giada, Pitosfori e Nasturzi, Le margherite di Elos, Geo, Gea, Gei, Gechi e Rane. Lei stessa avrà 5 nomi e 8 cognomi, crederà nel potere salvifico del mango e della papaia e creerà arditi modelli sartoriali con scollature attiche, rigorosamente accollate, con poca o nulla presenza di epidermide esposta: una delle caratteristiche intrinseche del veganesimo, quando applicato ai tessuti, è quello di coprire tutto, il più possibile, per evitare che ogni indebito lucore della carne possa distrarre l’adepto dalla coltivazione del proprio Sé e dal meditare, con un pianto muto, sul triste destino della Terra e della Umanità. I vegani sono olistici, non riescono mai a pensare a una sola cosa per volta ma abbracciano tutto il Creato con le mani immerse nel panteismo. La nostra sarta vegana, ad esempio, usando un nome di fantasia, Camilla Maria De Tassis Lingiardi Colombo, quando si reca al bar a consumare un cappuccio di soia tiepido non pensa solo al suo cappuccio di soia ma alla pecora nana del Caucaso, animale nato doppiamente sfigato in quanto pecora e in quanto del Caucaso, e non metterà lo zucchero nel cappuccio, per aiutare la suddetta pecora che non lo saprà mai e resterà per sempre nana. Le pecore, spiace dirlo, sono animali fortemente insensibili, se aiutate, anche a distanza, non ringraziano ma considerano loro tutto dovuto. Spesso questa cosa non viene detta, esiste uno spettro omertoso intorno alla irriconoscenza ovina, ma il problema esiste, ed è di difficile se non di impossibile soluzione.
L’influencer in Giappone
Dopo essere arrivato in Giappone senza essere certo di volere andare in Giappone, e dopo avere preso in locazione un appartamento di 17 metri quadrati senza avere mai avuto l’intenzione di farlo ma ormai era lì, Niki l’influencer, nome che non significava niente ma Nicola era troppo cheap, appoggiò le borse a terra, si tolse il giaccone, si sedette sulla tazza del cesso, e vide subito davanti a sé una serie di luci verdi, poi gialle, poi ancora verdi, poi arancioni mentre un braccio telescopico alla fine del quale era innestato in pennello in pelo di martora che visitava con una gentilezza seconda all’ostinazione i suoi testicoli. Aveva conosciuto il famoso cesso giapponese, o della tazza autopulente. Sapeva, dopo aver esperito nei lunghi giorni che precedevano la partenza del suo primo vero viaggio dopo 27 anni, che il Giappone era lontano, che mangiavano un pesce velenoso e che in quel Paese la tazza del cesso faceva tutto da sola ma un conto è leggere queste cose su una guida al Giappone stampata male su carta riciclata, un altro conto è sentirsi i testicoli vellicati da un braccio meccanico azionato da un pulsante che non volevi premere che agisce in modo coordinato su entrambi. E’ tutto molto diverso, arditamente diverso, e mentre lo pensava il braccio continuava a muoversi. Dopo aver aspettato che finisse questa pratica criptoerotica, dopo aver pensato e aver deciso che no, non era il caso che si fumasse una sigaretta né che chiedesse al cesso se aveva un nome e se tutte le volte sarebbe successa la stessa cosa o doveva considerare quello che era successo un evento del tutto straordinario, con i testicoli perfettamente puliti e profumati si alzò per uscire dalla stanza, angusta, dove era ospitato il piccolo trono della peristalsi. Nel farlo non poté sottrarsi a un’occhiata furtiva ai testicoli coi quali conviveva da alcuni decenni, e gli parvero entrambi perfettamente rotondi, senza quelle ostentate differenze di volume e posizione che aveva sempre notato: effetto della pulizia intratazzale, rifletté, o forse semplice suggestione, rifletté sulla precedente riflessione, che lo aveva visto padrone della sua amigdala. Niki l’influencer era un maestro della riflessione doppia, prima pensava a una cosa, poi a una cosa diversa, quindi tendeva a dimenticarle entrambe. Uscito dal bagno, andò a schiantarsi contro un comodino rettangolare con gli spigoli in titanio, sopra il quale era appoggiato un cavallo di plastica blu, una deità che, in teoria, avrebbe dovuto proteggere la stanza e i suoi occupanti, che però cambiavano spesso quindi doveva essere più che altro legato alla stanza che agli occupanti, essendo un cavallo azzurro un Dio animale abbastanza inaffidabile, almeno in apparenza. I 18 metri quadrati dell’appartamento erano occupati da un bagnetto di 3.5 metri, una cucina a cubicolo di 2 metri, uno spazio vuoto che
occupava i metri restanti e una scala in legno di faggio che portava a un soppalco sopra il quale c’era un futon, tipico, scomodissimo, insensato letto giapponese e il poster pubblicitario di una birra alla ciliegia con la parte destra piena di numeri di telefono, per lo più illeggibili. Dopo aver strappato il poster si sentì subito meglio ma poco dopo si sentì subito peggio perché il poster copriva il disegno fatto probabilmente da qualche ubriaco ipovedente di un topo, presumibilmente giapponese anche se aveva tutte le caratteristiche di un topo europeo, che cercava di mangiare quello che restava di un piatto di ramen. Prese quindi quello che restava del poster e lo rimise sopra al topo. Ora aveva fame. Probabilmente il topo ricoperto gli aveva messo fame, in qualche modo doveva cercare di mangiare qualcosa, se possibile di commestibile anche per un non giapponese. Dopo un ultimo, fuggevole sguardo al topo ormai ricoperto, uno sguardo che non si sapeva se descrivere meglio come appunto fuggevole o trasognato, uscì da quella che sarebbe diventata la sua casa per il prossimo anno e subito inciampò in un gatto di gomma rosa con una zampa che andava su e giù in modo inconsulto. Non era tanto il fatto che fosse di gomma rosa, dava per scontato che in Giappone ci fossero molti gatti di gomma rosa, ma che si muovesse da solo, cosa che un gatto di gomma di regola non dovrebbe fare, gli fece nascere una fuggevole perplessità, che era però già scomparsa quando arrivò davanti a una banca, e non cercava una banca, e poi a un bar, e non cercava un bar, infine davanti a quello che cercava, un locale di 6 metri per 3, con le pareti rosso ciliegia, che gli era stato consigliato da Gianni Zio Toby Pertusi, il suo amico grafico e esploratore artico che dopo avere esplorato migliaia di chilometri di ghiacciai si era trasferito a Tokio da due anni. Avrebbe dovuto incontrarlo nei prossimi giorni, se riusciva a trovare il biglietto giallo sul quale aveva segnato la via in cui avrebbero dovuto vedersi: due islandesi a Tokio, un bel titolo per un romanzo, pensò, che non avrebbe letto nessuno, pensò ancora, tanto nessuno legge più niente, pensò per la terza volta. Il locale era accogliente, secondo gli standards giapponesi, che conoscono solo i giapponesi, e nemmeno tutti, e consisteva in una lunga stanza di forma rettangolare con al centro un lungo tavolo anch’esso rettangolare, con 3 sedie da una parte e 2 dall’altra, per dare movimento alla stanza, pensò, che cosa me ne faccio di una stanza che si muove, pensò di nuovo, ma io nono sono giapponese a loro magari le stanze che si muovono piacciono, pensò nuovamente, poi smise di pensare, aveva fame, e si sedette dal lato con le tre sedie, gli sembrava più educato. Dopo pochi minuti arrivò una cameriera, graziosa ma minuta in modo peculiare, non raggiungeva probabilmente il metro e 30 centimetri, che dopo averlo salutato salì su un cubo di plastica, che portava legato alla cintura, per arrivare almeno con la faccia al tavolo. La faccia
era rotonda, abitata in modo improvvido da un paio di occhi neri, uno semichiuso, e sormontata da una sottile coltre di capelli color pancia di narvalo, giapponese. Il narvalo giapponese ha la caratteristica di vivere in Giappone. Ne ha anche altre, ovviamente, ma essendo giapponese tende ad una riservatezza che ha una inesorabilità che non può essere minimamente scalfita da nessuno. Forse solo da un altro narvalo, ma esiste una scarsissima comunicazione intraspecifica. Dopo aver appoggiato la faccia al tavolo, con una insospettabile agilità mandibolare, essendo anche la mandibola appoggiata al tavolo insieme al resto della faccia, la gentilissima signorina, che si chiamava Taiko, snocciolò con inappuntabile efficienza nipponica il cibo disponibile quella sera, aggiungendo alcuni risolini di approvazione, due, o di vera estasi, quattro, di commento alle proposte, impiccandosi con la lingua sul tonkatsu ai fiori di mirtillo. Il tonkatsu ai fiori di mirtillo era assolutamente invitante, ma vista l’ora e vista anche le faccia della gentilissima signorina che era bluastra con alcune vistose gore giallognole, Niki l’influencer decise di ordinare quello che sembrava un pollo, forse arrosto, sicuramente morto. Il menu era illeggibile, non solo perché era scritto in giapponese ma soprattutto perché i caratteri tipografici che erano stati utilizzati transitavano da 1.5 mm a 3 mm nel caso dei titoli della sezione, che campeggiavano sulle pagine gialline in uno svettante rosso intenso, con alcune screziature ocra che si vedevano solo se ci si avvicinava al menu a distanza di naso, come aveva appena fatto Niki l’influencer, in ciò impedito da un naso di dimensioni insolitamente generose per un islandese, che solitamente nasce con seni paranasali appena accennati e passa buona parte della sua vita a vergognarsene: Niki l’influencer disponeva invece di un perfetto e imponente naso attico, con una struttura da tempio greco, compreso il pronao. Era arrivata l’acqua, in una caraffa a forma di giraffa. Era una giraffa strana, o meglio era una caraffa strana a forma di giraffa strana, e aveva una coda lunghissima dalla quale veniva fatta uscire l’acqua che avrebbe trovato riparo e alloggio nel bicchiere che Niki l’influencer si era messo davanti, bicchiere che non abitava forme strane, era un semplice bicchiere a forma di bicchiere, solo che era nero. Pece. Intenso. E essendo nero non si poteva vedere quanta acqua ci fosse e quanta fosse ancora necessario aggiungere, e Niki l’influencer, fin da piccolo, aveva sempre detestato i bicchieri neri e le cose che hanno un colore che ti impedisce di vedere quello che c’è dentro. Cose inutili, aveva sempre pensato.
Il sessantenne in Harley
Il sessantenne con Harley, fatalmente destinato a politraumatismi non meglio specificati né specificabili, è il punto di approdo del trentenne che ha dovuto vendere la moto perché si è sposato, ha avuto due figli, ha comprato una viletta a schiera con una ipotesi di giardino di 21 mq di cui sette di barbecue e 5 di dondolo in legno Ikea che si incastra e non funziona, è stato promosso a capo area di qualcosa per capire ancora meno quello che già non capiva prima, e ha simulato gioia e passione e felicità per un autoarticolato elettrico svedese che frigge come una piastra per capelli ogni volta che viene caricato. Solitamente, ma non è una regola generale, tende a farsi crescere i capelli sulle spalle, almeno una, e raccoglie le propaggini pelose, precocemente impoverite e ricche di quintuple punte, in un codino da capo indiano della tribù dei Pomos capitato per errore in una kebabberia di Sesto ed Uniti o di Buccinasco. Avendo strappato alla moglie il permesso di acquistare una moto dopo tre decenni di inutilizzo, appoggiandosi in eguale misura al concetto filosofico-esistenziale del “si vive una volta sola” e a diete autoinflitte a base di gallette di riso e sardine, ha acquistato una Harley Davidson di terza mano col cavalletto rotto, cosa che scopre quando cerca di tenerla in piedi mentre il motociclo del peso di circa tre quintali striscia, silenziosamente e inesorabilmente, verso la sua caviglia, salvata da una fioriera in cemento dietro la quale cerca riparo, mentre i tre quintali su ruote si appoggiano delicatamente su alcuni fiori giallognoli, che entrano nella categoria di chi una volta era e ora non è più. Assistendo impietrito al trapasso vegetale il nostro sessantenne cercherà affannosamente video tutorial sulla rete digitando, in un lasso temporale non superiore ai tre minuti, le seguenti key words: SOLLEVARE MOTO CADUTA – SOLLEVARE HARLEY SENZA BLOCCARSI CON LA SCHIENA – FARE LEVA PER SOLLEVARE MOTO CADUTA – TETTE ENORMI MENTRE MANGIA LA PIZZA, laddove l’ultima ricerca era rimasta, incancellata, nella cronologia del telefonino. Gli appariranno quindi alcuni giovani culturisti ecuadoregni che, facendo leva sulla parte inferiore del telaio, solleveranno tre moto suonando contemporaneamente il flauto, un giovane islandese che rialza tre Zundapp e tre pecore per aumentare il peso, le pecore apparentemente ancora vive, un life coaching che ti spiega che non è il caso di rialzare niente e che se è caduta è meglio lasciarla lì, un cuoco che si esprime in una lingua sconosciuta che ha alterato l’algoritmo di ricerca per essere in grado di spiegare come si impanano le olive anche quando tu, povero sessantenne nascosto dietro una fioriera piena di fiori morti, vuoi sapere come si solleva da terra una Harley senza morire nell’operazione. La mente, intanto, lavora con frenesia, pensa al set di mazze
da golf comprato sette anni prima, tuttavia, lo stimola la mente, l’unico utilizzo sensato di una mazza da golf in una situazione del genere sarebbe quello di darsela in testa, la mazza da baseball non c’è più, perché non c’è più, l’avrò regalata a qualcuno, errore gravissimo, le mazze da baseball possono sempre tornare utili, avrei potuto utilizzarla come leva, io mi intendo di leve, avevo anche fatto un esame di fisica, se avessi una mazza da baseball potrei usarla come leva primaria, lo avevo letto anche nelle memorie di Richard Feynman, anche se lì non si faceva cenno a una Harley (parliamo, come si vede, di un sessantenne di buone letture e di buona costituzione fisica), la divagazione neurale stava assumendo la caratteristica della frenesia. John Fante, cosa avrebbe fatto John Fante, lo avevo letto al liceo perché piaceva alla Curzi, che mi ignorava, giustamente, cosa avrebbe fatto Fante in una situazione del genere? Cosa avrebbe fatto con una Harley caduta per terra, forse non guidava una Harley, forse non guidava del tutto, forse non è un esempio da seguire, con tutti questi forse qui non ne esco più, questo era il tornado lessicale che aveva preso possesso della sella turcica del nostro sessantenne, che fissava spaurito e impotente un’altra, corposa sella, che lo guardava come l’uovo al centro di una scodella di ramen. Poi, quasi all’improvviso, una luce, un bagliore gli apparve davanti: sarà stato Feynman, sarà stata la Curzi sotto forma di ricordo biondo e inavvicinabile (il sessantenne ignorava che la forma attuale della Curzi era quella di una manta di 98 chili di peso, troppi carboidrati e aperitivi con amiche), sarà stata la famosa necessità che sembrerebbe aguzzare l’ingegno, una idea si fece strada nel garage in cui stava consumandosi quella ordalia. La moto avrebbe cessato di essere una moto e sarebbe diventata una installazione di arte moderna, un pezzo di land art proprio nel garage di casa, prevenendo così le ire immarcescibili della moglie che, rientrando, avrebbe assistito a questa prodigiosa trasmutazione. Anche i fiori morti sarebbero stati parte dell’opera, il segno del decadimento della esistenza, della corsa sfrenata dell’uomo verso l’unico epilogo possibile, ossia la Morte. Del resto Opalka dipingeva numeri neri su sfondo bianco, esposti al Centre Pompidou a Parigi, Yoko Ono va beh Yoko Ono lasciamola perdere, Elisabeth Charlotte “Pipilotti” Rist ha dipinto di rosa un tram, con l’aggravante di essere svizzera, per l’esattezza di Grabs, un piccolo centro abitato con meno di 7000 abitanti del cantone San Gallo, lui, il nostro sessantenne, che manteniamo senza nome perché il suo nome possa essere quello di tutti o di nessuno, lui aveva tutto il diritto di considerare l’Harley collassata al suolo perché aveva il cavalletto rotto un’opera d’arte, a cui avrebbe, forse, dato anche un titolo. Finalmente tranquillo, quasi felice di essere sopravvissuto al crollo del motociclo e, con questa che gli sembrava una idea geniale, anche alle cavalcata wagneriana di
moglie e figli verso di lui, il sessantenne si rimise in piedi, rialzò il colletto della polo bianca Ralph Lauren, e cercò, sempre in rete, uno scooter usato di media cilindrata.
Il poeta
Il poeta autopubblicato conoscerà una modesta carriera nel parastato che gli avrà lasciato ampio spazio di riflessione sulla morte, sulla vita, sulla stagista bionda che lo osserva come un orango potrebbe osservare la pelle floscia di una banana senza banana, sul destino dell’uomo e sul valgismo al piede destro, che lo accompagna dal compimento del trentacinquesimo anno di età. Ingegno considerato immenso da sé stesso, l’autopubblicato avrà scritto, nel mezzanino, al buio, inosservato da moglie e figlie, tre, tutte abitate da un disprezzo profondo nei confronti del padre, circa 670 liriche, tutte con la parola Speme nel titolo e la presenza ricorrente del lemma caduco alla seconda strofa. Grazie all’aiuto di un amico grafico che lavora come autista in nero avrà proceduto, negli anni, alla pubblicazione di sette Sillogi poetiche regalate a tutti i suoi congiunti, alcuni dei quali si sono nel frattempo suicidati, i sopravvissuti hanno sviluppato vasti eczemi in ampie porzioni del corpo. La presentazione della sua ultima opera, un complesso circolo di rime in –ere di 67.000 versi, si sarà tenuta nella libreria annessa al centro commerciali I giaguari, sulla A6, bivio per Savona. Molti degli intervenuti, ingannati dalla pubblicità a caratteri cubitali, pensando a uno spettacolo di lap dance, avranno doviziosamente inventato sequele di pietose e patetiche bugie per le consorti, sperando in una serata di tette e birra, mai, nemmeno nei loro incubi più neri e tonitruanti, avrebbero potuto immaginare che si sarebbe trattato della lettura pubblica dell’ultima opera del poeta autopubblicato, i 67.000 versi di cui sopra, dall’evocativo e possente titolo Frenuli e anime. Tra di essi la lingua rasposa del terrore chiede spazio, i loro femori, le loro articolazioni si bloccano, la respirazione si fa affannosa, lenta, poi veloce, le tempie pulsano seguendo un sabba orgiastico, almeno lì, nella mente, un’ orgia, la mani tremano e cercano una via di uscita che non c’è, e in quel momento il poeta autopubblicato si alza, afferra il microfono con una mano e un immenso tomo con una orripilante copertina lucida, lo apre, il fruscio delle pagine viene amplificato empiamente in tutta la sala, l’empietà del testo inedito, e si appresta, con un ghigno solo malamente nascosto da un inizio di triplo mento, a leggere la prima lirica della silloge, della lunghezza di 16 pagine in carattere 8, Bodoni, tutto grassetto perché la parole poetica deve essere incisiva. Dal fondo della sala un urlo, uno dei convenuti si è infilzato la mano sinistra con una forchetta ma la forchetta era di plastica, si è solo graffiato senza svenire: un uomo alto, brizzolato, con un giubbotto di pelle rossa, palesemente a disagio, deglutisce una tartina al latte al prosciutto e zola senza togliere lo stuzzicadenti che la teneva insieme, insegue oscuri tentativi di suicidio ma ottiene il solo risultato di rimanere con la bocca
orribilmente spalancata e lo zola che gli cola sul giubbotto. Altri due uomini urlano e 5 persone, tutte vestite con incongrue giacchette color carta da zucchero, prendono in ostaggio una sesta persona e si chiudono nei bagni, mnacciando di nutrirsi di sola carta igienica per le prossime 48 ore che tanto è sempre fibra. Il poeta autopubblicato freddo, immobile, con la impietosità di un acaro, gli acari sono molto impietosi, continua a leggere, con tono monocorde e costante: dal bagno cominciano a provenire muggiti di piacere, la carta igienica bagnata ricorda, come sapore, il tofu.
Il dentista di destra e il dentista di sinistra
Il dentista di sinistra è essenzialmente uguale al dentista di destra, a parte qualche trascurabile particolare. Ne elenchiamo qualcuno: il poster del Che nel retrostudio, scolorito e ingiallito come un molare devitalizzato negli anni '80; l’abbonamento a una rivista culturale che tiene in sala d’attesa accanto a “Focus” del 2013; una tendenza compulsiva a fare battute passive-aggressive su “questo Paese” mentre ti trapana l’arcata inferiore. Anche lui ama l’ordine, il silenzio, la poltrona regolabile in pelle sintetica color ardesia rotta al centro. Anche lui ha una segretaria con la voce da centralinista RAI 1976, un figlio che studia economia e una panda 4x4 d’epoca verde ramarro per andare in montagna. Anche lui è ossessionato dalle gengive, che vede sotto forma di BTP a sette anni, ha studiato in una facoltà pubblica ed oggi è fiero del suo studio privato. Crede ancora in certi valori, ma solo se sterilizzati. La sua rivoluzione è la detartrasi una volta ogni sei mesi. Una volta andava ai concerti, oggi va a convegni sul bruxismo. Dice di votare con la coscienza, ma non ha mai saltato un’elezione da quando c’è la ricevuta sanitaria detraibile. Il dentista di destra, invece, ha il crocifisso in bella vista e il poster del GP di Monza 2004. Ama il titanio più dell’oro, a meno che non si tratti di investimento. Ma anche lui, alla fine, ti raccomanda il collutorio, ti parla mentre hai il divaricatore in bocca, e ti dà appuntamento tra sei mesi, sapendo benissimo che tornerai tra dodici. La verità è che entrambi credono nel libero mercato del dolore odontoiatrico, e sanno che l’unica ideologia davvero trasversale è quella della parcella. 1. la ostensione pubblica della laurea. Il dentista di destra la collocherà sotto una pala da altare del tredicesimo secolo illuminata dal basso da tre faretti fatti a mano, a luce fredda, che saranno puntati sul nome, sul cognome, sul nome del relatore che sarà anche senatore della repubblica. Il dentista di sinistra collocherà la laurea in una cornicetta leggera, in legno di corniolo, accanto alla foto in bianco e nero di un gozzo recuperato a una vendita all'asta a Capalbio, precedentemente appartenuta a un commercialista che ci aveva fatto i giro del mondo per fermarsi a Portoferraio.
2. la macchina. Il dentista di destra sarà felice possessore di un SUV di fabbricazione tedesca, di lunghezza superiore ai 25 metri, con 16 ruote motrici montate su 6 mozzi indipendenti, di colore nero o giallo limone o verde opaco o ocra, pur non sapendo nessuno che colore sia l’ocra. Gli interni in pelle con cuciture a contrasto recheranno le sue iniziali e il suo codice fiscale, pronto per essere memorizzato dai passeggeri prima della emissione delle prossime fatture. Il tettuccio, apribile, non sarà azionato elettricamente ma aperto e chiuso da una famiglia di maltesi, ex guardie cantonali, di altezza inferiore ai 56 cm., che vivono nel vano portaoggetti rivestito di radica. Il dentista di sinistra sarà invece
appagato e morigerato proprietario di una familiare svedese dei primi anni '70 con volante Momo in legno e logo di associazione per la salvaguardia e la tutela del mulo nano di Gallura al centro. La vettura sarà azzurra o bianca con gli interni accuratamente ripuliti e deodorati con una piccola quercia bonsai attaccata alla leva del cambio, rigorosamente manuale, che renderà molto difficile effettuare cambi di marcia fluidi, rendendo la marcia della vettura simile a quella di un procione obeso, il tutto, però, in un ambiente deodorato naturalmente dalla piccola quercia bonsai; i sedili posteriori ospiteranno ancora il sedile anatomico dei figli, ormai trentacinquenni e gay e architetti di interni a Locarno, che saranno la cuccia, atipica ma tanto comoda e soprattutto sicura, di Molly, un Dogue de Bordeaux di 49 chili acquistato all'allevamento di Federica Invalsi Melzo Capitonna De Picis Eryl Ognibene Mariafranca, che caga senza alcuna soluzione di continuità (il cane, non la signora Capitonna De Picis Eryl Ognibene Mariafranca). Il tettuccio non sarà apribile ma imbullonato con dei pezzi di risulta del Meccano, originale, con scatola e garanzia. Il dentista di sinistra circolerà con questa Volvo di settima mano con targa svizzera, perché va bene essere di sinistra ma dopo una vita passata a devitalizzare molari qualche decimigliaio di euri depositati in qualche fidata casa di gnomi del cantone elvetico se li sarà anche meritati, di colore bianco latte o panna. La differenza tra il bianco latte e il bianco panna riposa nella mente del vostro concessionario di fiducia. La macchina avrà degli interni in pelle molto usata, recanti tracce di qualcosa che è meglio non sapere e delle zampate di Lollo e Brigida, la coppia di cani da caccia che il nostro odontoiatra ha recuperato in un santuario dei cani da caccia abbandonati in Sardegna. Nessuno di quegli splendidi bracchi era mai stato abbandonato, soprattutto nessuno abbandonerebbe mai un bracco in Sardegna, ma la loro certificazione falsa di trovatelli dal pelo lucido ne aumentava il prezzo di vendita, e quasi improvvisamente la Sardegna si è ritrovata terra di bracchi abbandonati e mirto in bottiglie di vetro.
L’ingegnere
Il giorno in cui arrivò la lavatrice nuova con un grande e silenzioso oblò che lo fissava come l'occhio di una cernia all' ingegnere tutto l'oggetto parve un tostapane, e non gli prestò la attenzione dovuta, trascuratezza di cui si sarebbe dolorosamente avveduto solo molto più tardi, con toni drammatici. L’ingegnere aveva una adorazione infantile per i tostapane, da piccolo, avrà avuto poco più di tre anni, aveva assistito per caso, essendo nudo in una vaschetta di gomma arancione a subire il lavacro rituale a cui vengono sottoposti tutti i treenni, al momento della uscita della fetta di pane tostato dal blocco sidereo, un astro atterrato sul tavolo della cucina della madre, e da quel momento aveva sempre associato la fetta che esce a velocità saturnina da un tostapane un sentimento di gioia profonda e di gratitudine per essere al mondo. Al contempo, aveva sviluppato un odio profondo per il colore arancione e per le vaschette di gomma: era abituato a comprarne una decina tutti i mesi per poi distruggerle in giardino con una vecchia vanga che dopo una vita trascorsa ad ammonticchiare zolle di terra ora veniva usata per distruggere vaschette e catini di gomma. Era per lui naturale pensare che tutto quello che vedeva fosse, in primo luogo, un tostapane, spingendosi al punto logicamente successiva, ossia che l’oggetto a cui aveva attribuito la capacità funzionale di un tostapane si comportasse come tale, incontrando in questo ambito un numero non indifferente di frustrazioni, solo parzialmente mitigate e rese meno aspre dal suo carattere, fatto di grande equilibrio e di rese continue al suo innato raziocinio. Raramente, dopo aver tentato di fare uscire una fetta di pane già imburrato da una scarpiera, affettava superiore coscienza di sé e, non visto, si chiudeva in bagno a inveire contro le cassettiere che non sono dei tostapane. Per questi motivi era del tutto normale che quello che successe sia successo, ossia che la lavatrice venne scambiata per un tostapane e volutamente ignorata nella pregustazione differita del suo godimento. Per alcuni, lucenti giorni l’ingegnere usciva, andava al lavoro, si controllava la riga dei capelli, sempre perfettamente in asse col naso, invero generoso, e dopo aver indossato la camicia aspettava che una delle sue 6 cravatta autoannodanti si facesse compagna del suo collo e lo rendesse pronto per uscire. In queste giornate di sospensione del piacere pregustato, l’occhio di cernia della lavatrice non mancava mai di incrociare la pupilla oblunga e orientaleggiante dell’ingegnere, ospitata da un viso olivastro dai tratti egiziaci. Dopo una decina di giorni di doloroso evitamento, una sera, intorno alle sette, l’ingegnere fece una cosa: appoggiò tre fette di pan carrè sulla lavatrice, facendo molto attenzione ad appoggiare sulla superficie perlacea la parte pulita della
fetta, quella scevra di burro, marmellata di melograno e burro di arachidi chiarificato in Malesia, che erano stati spalmati con generosa noncuranza sulla parte opposta: l’ingegnere odiava il concetto di vicarianza, per lui le fette non erano mai tutte uguali e le parti delle stesse, anche se potevano sembrare identiche, non lo erano affatto, una doveva essere in qualche modo riempita, l’altra no. Così fece, e dopo averle appoggiate, cominciò ad aspettare, seduto sul divano di velluto verde a forma di frattale, con ampi avvallamenti nella parte mediana, che aveva collocato proprio di fronte alla lavatrice che lui pensava essere un tostapane. Che non era un tostapane ma bensì una lavatrice, efficiente, ultimo modello, con cestello a carica manuale perché anche le lavatrici ultimo modello hanno il cestello che deve essere caricato da una mano umana al termine della quale c’è un essere umano che è il proprietario di quella mano, e anche di un’altra, di solito. Tutto questo, sia pure confusamente, l’ingegnere, pur essendo un ingegnere, lo sapeva, senza averlo prima intuito. Gli ingegneri non intuiscono, gli ingegneri sanno.
Dopo aver atteso per circa 34 minuti il divano cominciava a scottare: i glutei dell’ingegnere erano dotati di un contatore interno che cominciava a fare aumentare la temperatura del professionista dopo il trentratreesimo minuto di inattività, e così aveva fatto, anche questa volta. Alzatosi di scatto dal divano per fare cessare il calore che lo stava avvolgendo, l’ingegnere decise di farsi un caffè con due ciambelle di 7 mm di diametro, riservando quelle dal diametro maggiore, di 9 e 12, rispettivamente al sabato e alla domenica, giornate in cui l’attività di calcolo e di ricerca lo occupava meno e la giornata poteva essere dedicata alla esaltazione della sapidità ciambellistica. Giova sapere che l’ingegnere aveva elaborato un metodo, cristallizzato in alcune slides di presentazione che aveva catalogato sotto la sigla Donuts fractals o D. F. contenute in una cartellina di colore giallo che campeggiava al centro del computer del suo laboratorio, proprio al centro della bocca dello squalo morto che utilizzava come salvaschermo, per mangiare in modo soddisfacente le ciambelle, odiando la differenza e l’invarianza nella serialità. In tale metodo veniva chiarito, senza possibilità di errori, che la ciambella infrasettimanale deve avere un diametro non superiore ai 9 mm, non deve presentare bruciacchiature o commessure sulla superficie, deve essere cotta in modo uniforme e contenere un numero massimo di 3 bolle di cottura: alla mancata corrispondenza di uno di questi elementi il manufatto dolciario deve essere smaltito con l’umido. Se il prodotto soddisfa tutte le caratteristiche appena descritte, può passare alla fase di degustazione, che si strutturerà a sua volta in due sottofasi successive, fase 1 collocazione della ciambella sul piattino, di colore bianco, con una inclinazione di 54 gradi rispetto all’asse radiale del
piattino stesso, e fase 2, utilizzo di una forchettina da dolce in wolframio anticato, con impugnatura in bachelite, non trattata, con la quale praticare sette incisioni a uguale distanza sul lato destra e altre sette sul lato sinistro, in ognuna della quali verrà versato del succo di ribes appena spremuto. La nota penuria di ribes da spremere non fermerà il nostro ingegnere, che creerà una spuma di ribes col cascame di lavorazione del pesce palla.
Due donne, una sola toilette
Due donne milanesi chiuse nella stessa toilette diventano tre dopo che una ha visto che l'altra indossa lo stesso paio di scarpe. La donna milanese si avvicina alle vetrine cambiando scarpe, disindossa il tacco da 14 cm che la accompagna dal risveglio e indossa un paio di comodissime e silenziosissime pantofoline bretoni comprate a Buccinasco. Il silenzio è fondamentale per impedire alla seconda e alla terza donna milanese che stanno guardando la stessa vetrina che una terza donna milanese sta facendo la stessa cosa. Non è un errore. È una moltiplicazione sociale, un’apertura di dimensione. Lì, tra le piastrelle grigio Armani e il profumo agrumato del sapone automatico, si crea una bolla di realtà aumentata dove nulla sarà più come prima. La prima donna, bionda chimica, blazer sabbia, sguardo da ufficio stampa dell’inferno, incrocia la scarpa. Tac. Riconoscimento immediato: stivaletto cuoio, tacco 5, taglio diagonale laterale. Le stesse. Le sue stesse. L’identità vacilla. La seconda, scura, occhi mascara waterproof, borsa oversize che potrebbe contenere un neonato e un iMac a, se ne accorge un istante dopo. Silenzio. Il tempo si ferma. Una delle due respira più forte. Forse tutte e due. La terza, perché ormai c’è una terza, è lo spettro del confronto. Non è né l’una né l’altra: è il concetto astratto di “originalità perduta”. Si manifesta nel riflesso impercettibile dello specchio, nel suono delle unghie sul touchscreen, nel microgiudizio silenzioso che entrambe formulano come un algoritmo sentimentale: chi le ha messe meglio? Chi le ha comprate prima? Chi le deve togliere per sempre da domani? La toilette, da luogo di pausa, si è fatta campo di battaglia ontologico. L’acqua scorre. Nessuna osa uscire per prima. Le scarpe sono identiche. Marca italiana con nome francese, modello lanciato sei mesi fa, diventato virale su Instagram e subito ritirato dalla boutique per "esclusività selettiva". Le hanno scelte entrambe, indipendentemente, credendo di operare un gesto singolare, pensato, differenziante. E ora eccole lì, a due metri di distanza, chiuse nella toilette del secondo piano di un noto concept store di via Turati, dove le porte non arrivano mai fino in fondo, dove la luce è calibrata per non far paura alla pelle. La prima, Giulia, marketing manager, 41 anni, divorzio strategico alle spalle, nuova relazione con un architetto cinico ma spirituale, incrocia le braccia. Fa finta di controllare se ha rossetto sui denti. Non ne ha. È solo un gesto per tenere ferme le mani, per non toccare lo smartphone e googlare “come gestire il trauma di un’identità stilistica duplicata”. La seconda, Federica, PR freelance, 36 anni, con un podcast sull'empowerment femminile in fase di lancio, si aggiusta i capelli. Li tira indietro con le dita, le unghie curate effetto vetro. Poi osserva la scarpa della prima riflessa nello specchio sopra il lavabo, in una diagonale perfetta. È lei a parlare per prima.
“Carine, vero?” dice, e la voce le esce rotonda, neutra, come se stesse commentando il tempo.
“Comodissime”, risponde Giulia, con un tono troppo veloce, quasi difensivo, come chi ha appena scoperto che il suo DNA non è esclusivo.
Silenzio. Le due si scrutano senza guardarsi. Ciascuna sta misurando l’altra: quanto ha pagato? Dove le ha prese? Le ha viste su un’influencer o è una pioniera? Chi ha il diritto morale di indossarle oggi? In quel momento nasce la terza. La donna-esiziale. Non è una presenza fisica. È un'emanazione psichica. Una versione di loro due, ibrida, armata di consapevolezza crudele e tagliente. È la donna che indossa la stessa scarpa meglio, senza pensarci, senza volerlo, e che fa sembrare loro due delle comparse di provincia in un dramma di Ibsen ambientato a CityLife. La donna-esiziale è l’effetto collaterale di ogni convergenza estetica non prevista. Appare ovunque due donne milanesi competono passivamente sul piano dell’apparenza: non giudica, decide. Chi ha perso. Chi dovrà cambiare taglia. Chi è già vecchia dentro. A quel punto, l’aria cambia. Giulia tossisce. Federica si passa un dito sulla tempia. I neon tremolano lievemente, o forse è solo la coscienza che vibra.
“Beh, ci vediamo in sala.”
“Certo. A dopo.”
Escono. In ordine inverso rispetto all’entrata. Non si guardano più. La guerra è stata lampo. Ma esiziale.
Lo pseudo pittore con le ascelle pezzate
Lo pseudo pittore con le ascelle pezzate non espone, esiste per il solo fatto di essere le sue ascelle, che esistono per il solo fatto che esiste lui. La sua sola presenza è opera, la sua sudorazione una performance a ciclo continuo che sottopone a un severo stress lavorativo le sue ghiandole sudoripare. Compare in orari imprevisti a inaugurazioni in spazi semi-industriali con catering orientato all’umami e al finger food con tartine al latte scadute e prosciutti cotti nel 1956, dove le opere sono quadri quadrati appesi con nastro da pacchi e titoli come “Senza Titolo #34 bis (dopo pranzo)”. Indossa camicie di lino grezzo, spesso non stirate, spesso bianche, spesso col taschino, rigorosamente senza giacca. Il colore è sempre sbagliato per la stagione. L’alone sotto l’ascella sinistra compare subito, come se avesse fretta di segnalare la sua autenticità biologica. La destra segue poco dopo, simmetrica e rassegnata. Non dipinge da anni “troppo tossico il sistema dell’oggetto”, dice mentre ingolla bollicine di dubbia provenienza da bicchieri in plastica eco-compostabile. È passato all’arte concettuale ma senza avvisare nessuno. I suoi ultimi lavori sono raccolte di etichette dei vestiti cucite a mano su pannelli di cartone da trasloco. Nessuno ha chiesto spiegazioni, per rispetto e per noia. La pezzatura ascellare è parte del discorso. Non è trascuratezza, è disinnesco dell’estetica igienista borghese. È una citazione liquida del corpo al lavoro, ma in chiave postproduttiva. Quando qualcuno lo guarda con orrore misto a disagio, lui sorride: “il corpo è il primo medium, il più sincero”. Poi si gratta l’orecchio con l’indice, come gesto di rottura semantica. Ha sempre una borsa di tela piena di nulla. A volte estrae un taccuino moleskine senza nulla scritto, solo piegato. Una volta ha portato un pezzo di muro caduto da casa sua e lo ha lasciato lì, “per farlo parlare da solo”. Qualcuno l’ha raccolto e rivenduto su Vinted. Lo pseudo pittore con le ascelle pezzate è sempre vicino a qualcuno che sta cercando di andarsene. Si aggira tra curatori, DJ, editor in fuga. Non è chiaro se abbia mai venduto qualcosa. Ma tutti lo conoscono. E quando lo incrociano, annuiscono piano. Perché sanno che non si tratta di arte. Si tratta di resistenza umida.
La fotografa impegnata
La fotografa della fotografa non cerca soggetti, li documenta mentre credono di documentare. Il suo compito non è testimoniare l’evento, ma riprendere chi testimonia. È il secondo occhio sul primo occhio. L’ombra con il sensore acceso. Vive nei margini, ma pubblica al centro. Nessuno le ha chiesto nulla, eppure c’è, sempre, immancabile, come un glitch algoritmico in giacca di jeans oversize. La riconosci dal passo felpato, dallo sguardo perennemente valutativo, e dalla reflex sospesa al collo con cinghia colorata vintage (che ha comprato nuova, su Etsy, da una seller di Bristol con trauma affettivo irrisolto, gradevole piercing alle grandi labbra e packaging confetto). Scatta a raffica, sempre in orizzontale, sempre leggermente di lato. Il soggetto preferito? La fotografa vera. Quella con lo sguardo ispirato, accovacciata, intenta a cogliere “il taglio giusto”. Lei la insegue. La fissa. La cattura mentre cattura. Non firma mai le sue foto. Al massimo le carica su Instagram in bianco e nero con caption tipo “vedere chi guarda” o “archivio di sguardi su sguardi”. Hashtag: #metaimage #visualmemory #shewhoshot. A volte la fotografa vera se ne accorge. La guarda, la ignora, poi la fotografa a sua volta. È lì che nasce il corto circuito espressivo: una guerra silenziosa di lenti e messa a fuoco, fatta di microspostamenti tattici e gesti che sembrano casuali ma sono posizionamenti esistenziali. Da fuori, sembrano amiche. Ma nessuna delle due seguirebbe l’altra su un social senza mutua approvazione preventiva. La fotografa della fotografa non espone. Ma partecipa a ogni mostra. Dice di “stare raccogliendo materiale per un progetto”, da anni. Nessuno sa quale. C’è chi dice che abbia un archivio enorme, ordinato per data, lente usata e colore dello smalto delle mani di chi scattava. Quando la vedi arrivare, significa che una fotografa più importante sta per fare qualcosa. Lei non crea. Aspetta la creazione per darle un contorno narrativo. È una cornice che si muove. E se la guardi troppo a lungo, sei già dentro il suo scatto.