
Tutta la cultura indipendente di Amburgo. Una mappatura + Reportage da Accra, tra colonialismo e voglia di riscatto + Dove la storia ha radici profonde. Viaggio culturale nelle Asturie













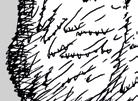







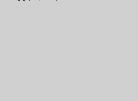


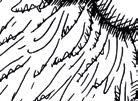



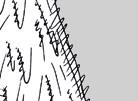
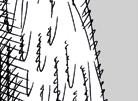


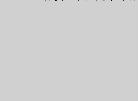














Tutta la cultura indipendente di Amburgo. Una mappatura + Reportage da Accra, tra colonialismo e voglia di riscatto + Dove la storia ha radici profonde. Viaggio culturale nelle Asturie













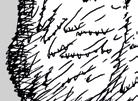







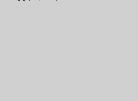


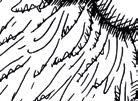



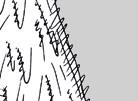
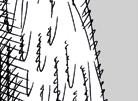


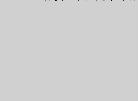













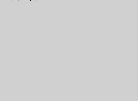


Emilia Giorgi (a cura di)
Silvano Manganaro, Claudia Pajewski giro d'italia: L'Aquila
Saverio Verini studio visit: Alice Peach
Alberto Villa Il futuro è morto. E noi lo abbiamo ucciso + Giulia Giaume (a cura di) news 24
Alberto Villa
dietro la copertina Morbide creature.
Le opere di Bao Rong, al confine tra scultura e performance
30
Margherita Bordino focus
Lo schermo dell’arte 2025: cinema, arte e nuove visioni a Firenze. L’intervista a Silvia Lucchesi 32
Dario Moalli
libri
Fenomenologia del maranza Il nuovo libro di Tommaso Sarti
44
Valentina Silvestrini architettura
“La trasformazione degli edifici è un territorio di libertà”. Intervista a Umberto Napolitano, l’architetto che sta rinnovando il MAXXI di Roma
45
Cristina Masturzo mercato
Da Londra a Parigi, l’autunno in viaggio del mercato dell’arte
46
Valentina Tanni window AI ASMR. Disordini sensoriali generati
50
Giorgia Losio
COSA SUCCEDE AD AMBURGO: SPAZI, RETI E NOMI DELLA CULTURA INDIPENDENTE
Una mappatura della città e della sua scena indipendente. Qui produrre cultura dal basso è possibile ed efficace, anche grazie a un proficuo dialogo con le istituzioni. Una lezione da imparare e da applicare anche in Italia
58
Niccolò Lucarelli
VIAGGIO CULTURALE AD ACCRA. LA CAPITALE DEL GHANA È UN MOSAICO DI ESISTENZE IN CERCA DI RISCATTO
Un racconto che intreccia storia, arte, tradizioni e ferite della capitale del Ghana. Un luogo che fu chiave della tratta degli schiavi e poi simbolo di indipendenza, ma che oggi si trova ancora preda da colonialismi vecchi e nuovi
Alex Urso (a cura di) short novel Alec Trenta
Questione di corpi, questione di posti
110
Santa Nastro (a cura di) talk show C’è veramente parità di genere nel settore dell’arte contemporanea in italia?
112
Massimiliano Tonelli Didascalie di mostre e musei. Fatela facile per favore
113
Christian Caliandro Una cultura sempre più preda dell'enshittification
114
Fabrizio Federici Musei e pubblico: notizie dalla Spagna 115
Angela Vettese L'ascesa del cinema espanso
116
Marcello Faletra
Jean Genet, la Palestina e noi
117
Anna Detheridge Dopo l'ultimo cielo
76
Livia Montagnoli
A Forlì una grande retrospettiva su Letizia Battaglia. La fotografa che cercava la vita
78
Marta Santacatterina L’affascinante e bizzarro “altrove” di Rodney Smith arriva in Italia. La mostra a Rovigo
80
Emma Sedini
A Villa Manin la nuova Esedra di Levante inaugura con un incredibile viaggio nella storia dell’arte
84
Helga Marsala A La Galleria BPER di Modena una mostra sul potere della parola come strumento di conoscenza
90
Stefano Castelli
Gli intrichi di filo di Chiharu Shiota al MAO di Torino: bozzolo amniotico o “prigione”?
92
Beatrice Caprioli A cent’anni dalla nascita, l’artista nippo-americana Ruth Asawa torna al MoMA di New York
94
Bianca D’Ippolito La nuova Fondation Cartier di Parigi. Intervista alla direttrice dei progetti strategici e internazionali
96
Santa Nastro Beato Angelico protagonista di una grande mostra a Firenze
98
Ferruccio Giromini
opera sexy
Mateja Petkovic: amplessi, amplessi
Caterina Angelucci
osservatorio non profit
Campo XS a Genova: da ex macelleria a luogo di sperimentazione artistica e sociale
66
ASTURIE. C’È UN COACERVO DI STORIA E CULTURA NELLA
SPAGNA DEL NORD
Una terra antica, che affonda le radici nella preistoria e custodisce con grande orgoglio il suo patrimonio altomedievale. Le Asturie conservano il germe della Spagna moderna, e noi ve le raccontiamo
86
Valeria Radkevych
Jeff Wall. La fotografia che pensa a se stessa in una importante mostra a Torino
88
Ludovica Palmieri
Koide Narashige, il pittore che amava le donne. La retrospettiva a Osaka
Alessandra Mammì Inaugura la Quadriennale del 2025. Una ricognizione della grande rassegna romana
100
Marta Santacatterina Audioguide: esperienze sempre più coinvolgenti per le grandi mostre
102
Grandi Mostre in Italia in queste settimane












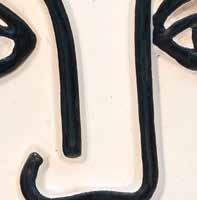












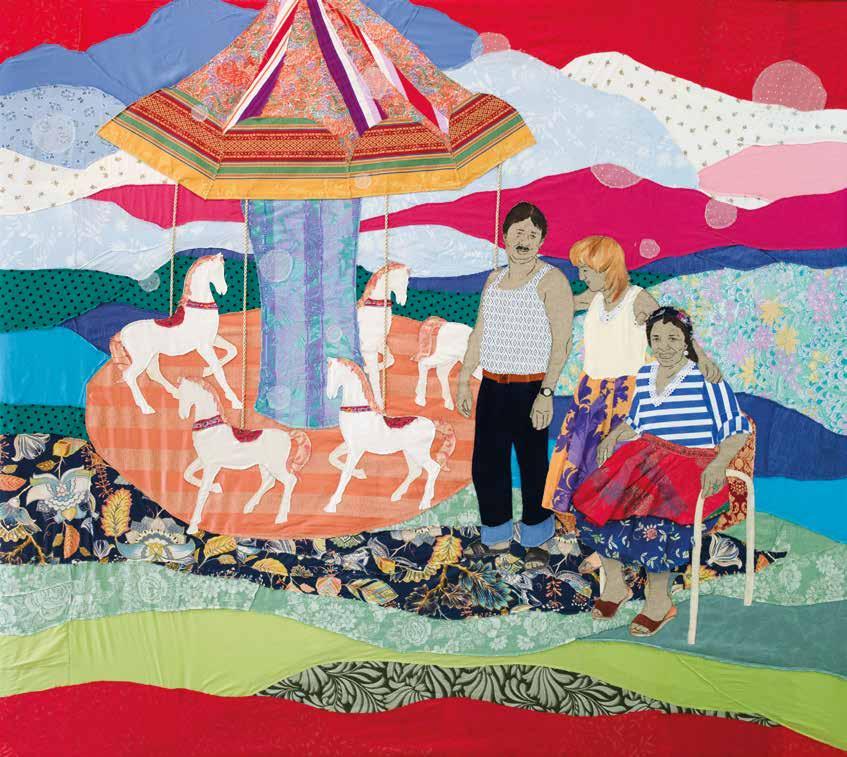
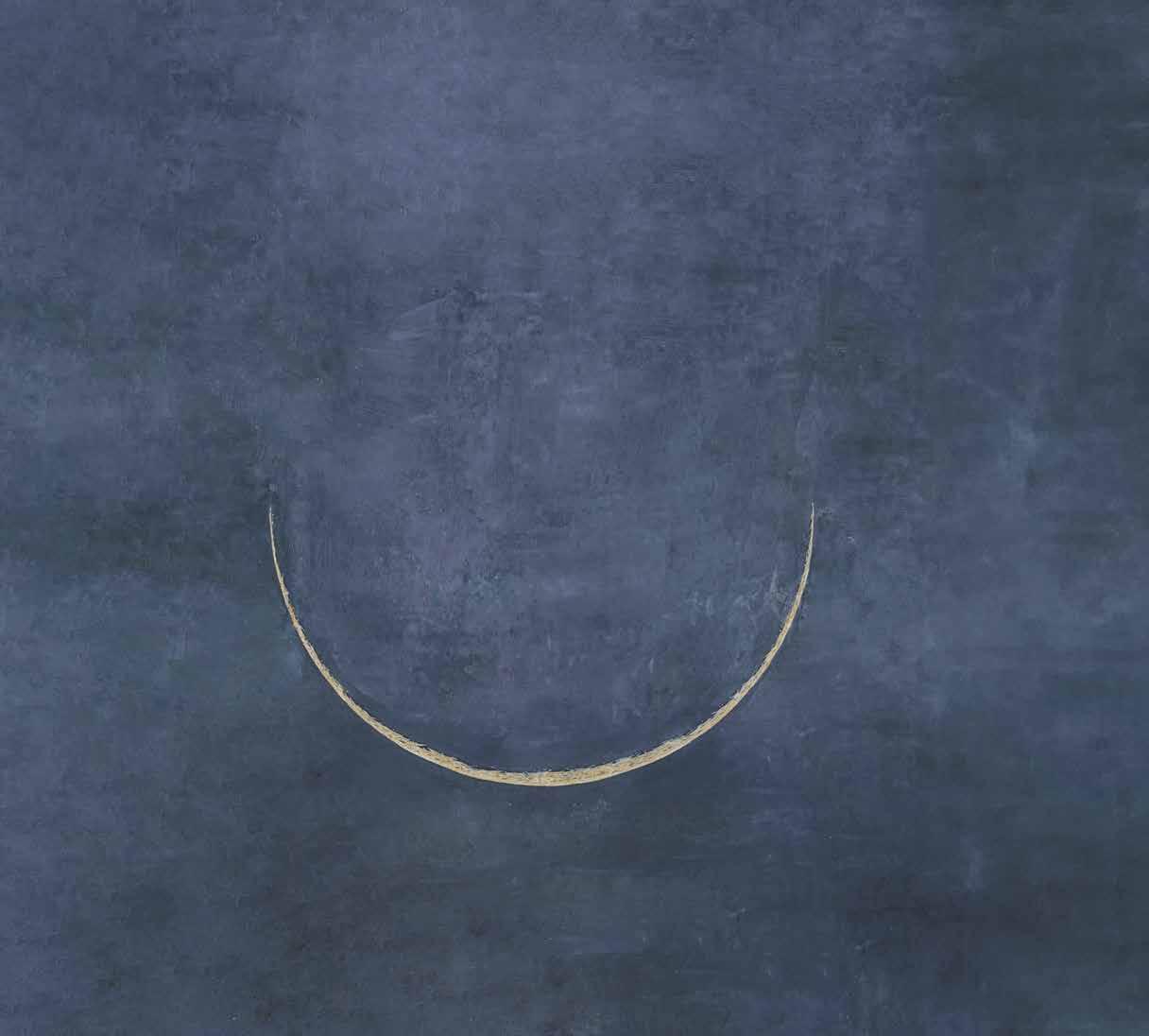

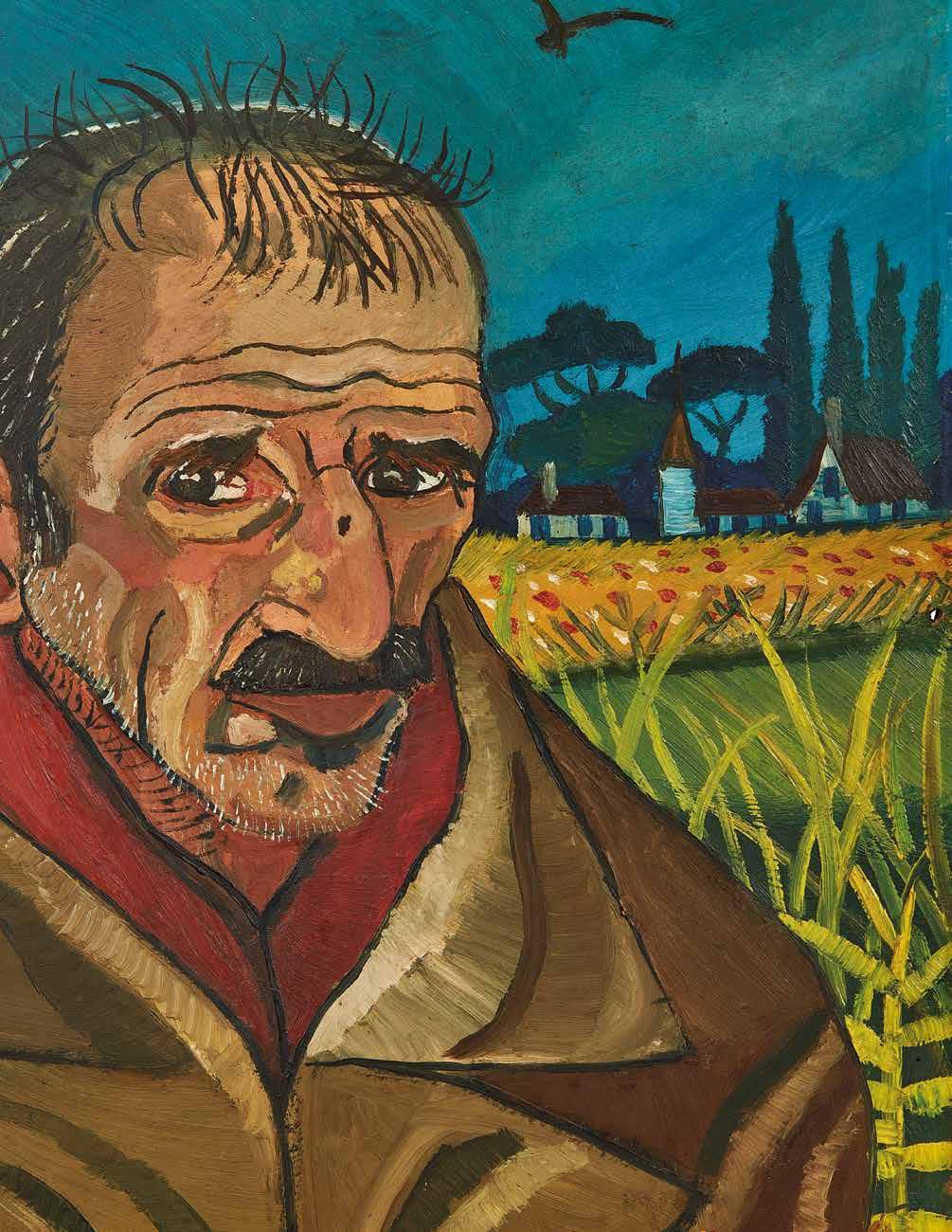

a cura di EMILIA GIORGI
SILVANO MANGANARO, storico dell’arte e curatore [testo]
CLAUDIA PAJEWSKI [foto]
Negli ultimi anni, chiunque arrivasse a L’Aquila percorrendo l’A24 veniva colpito dal gran numero di gru che si stagliavano all’orizzonte. Una foresta metallica che svettava sopra i tetti del capoluogo abruzzese, caratterizzando quello che a lungo è stato definito “il cantiere più grande d’Europa”.
Ora le gru stanno diminuendo un po’ alla volta, generando uno strano sentimento che sembra andare in controtendenza rispetto al resto del Paese: mentre la gran parte degli italiani di anno in anno ha la sensazione che le cose vadano sempre peggio, gli aquilani danno l’impressione di vivere proiettati nel futuro, convinti che le cose, passo dopo passo, vadano avanti anziché indietro. Infatti, con calma ma con costanza, aprono nuovi negozi in centro, pezzi di città vengono restituiti ai cittadini, riaprono palazzi, cortili e luoghi culturali. L’assegnazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026 sembra aver messo la ciliegina sulla torta a questo sentimento, generando un clima di orgoglio e di grandi aspettative. Vedremo cosa accadrà… Anche perché, a dirla tutta, L’Aquila non è una città “facile” o priva di contraddizioni e conflitti.
Già la sua fondazione, infatti, è da considerare un presagio. Nata nel 1254 in chiave antifeudale fu, poco dopo, rasa al suolo da Manfredi di Svevia (nel 1259) mentre, nei secoli successivi, ci pensarono i terremoti a farne di nuovo un cumulo di macerie: nel 1315, nel 1461, nel 1703 e, infine, nel 2009.
Eppure, la città resiste e, come recita il motto del suo stemma, “immota manet” (resta immobile, ferma nelle sue convinzioni). Però, in questa apparenza granitica, si insinuano le ambiguità, frutto di domande inevase. Ad esempio, sempre nello stesso stemma, assieme al motto e all’aquila rampante, ci sono 3 lettere, PHS, che nessuno sa bene cosa significhino. Probabilmente un errore di trascrizione del cristogramma IHS, ma non vi è certezza. Una inspiegabile “inesattezza”, un po’ come quella che si riscontra nella celebre Fontana delle 99 cannelle che, se hai la pazienza di contarle, non sono realmente 99.
La città è un rebus o un enigma; vedi, ad esempio, la possente presenza del Castello cinquecentesco che sta lì, nascosto da un parco e un po’ defilato, senza mai aver avuto una vera funzione: non fu mai teatro di battaglie, non ospitò guarnigioni numerose, né servì davvero come baluardo difensivo. Gli fa da contrappunto, esattamente dall’altra parte della città, l’altrettanto defilata Basilica di Collemaggio, con la sua facciata di pietre locali bianche e rosa pallido. Anche se questa, un senso e una funzione ce l’ha avuta e ce l’ha tutt’ora.
Sempre in tema di dualità, mi viene da pensare al Corso che, in realtà, ha due nomi: si chiama Corso Vittorio Emanuele II quello che dalla Fontana Luminosa arriva a piazza Duomo e Corso Federico II quello che prosegue fino alla Villa Comunale. Fin qui niente di strano; la cosa interessante è che il lungo rettifilo, con una prospettiva a cannocchiale, ha come fondale scenografico ben due catene montuose: a nord il Gran Sasso e a sud, verso porta Napoli, il Sirente-Velino.
Ma per me l’ambiguità più grande è il fatto che, dopo il sisma del 2009, la città ha deciso che l’unico segno di modernità andasse racchiuso all’interno dei muri dei palazzi e delle chiese, dove è stata usata la più sofisticata tecnologia per restaurare e consolidare gli edifici. Per il resto, a parte la contestata ripavimentazione del Corso e di Piazza Duomo, gli unici segni della contemporaneità – anche il MAXXI è finito in un Palazzo settecentesco! – sono l’Auditorium di Renzo Piano, che in realtà doveva essere temporaneo, e le altrettanto fintamente temporanee abitazioni residenziali del progetto C.A.S.E. (Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili) che gli aquilani chiamano “Case di Berlusconi” o, più ironicamente, “berluschouse” o “piercase”.
Insomma, personalmente, da quando interrogo questa città ancora non riesco ad avere una risposta definitiva, come quando chiedo: “Ma si scrive dell’Aquila o di L’Aquila?”


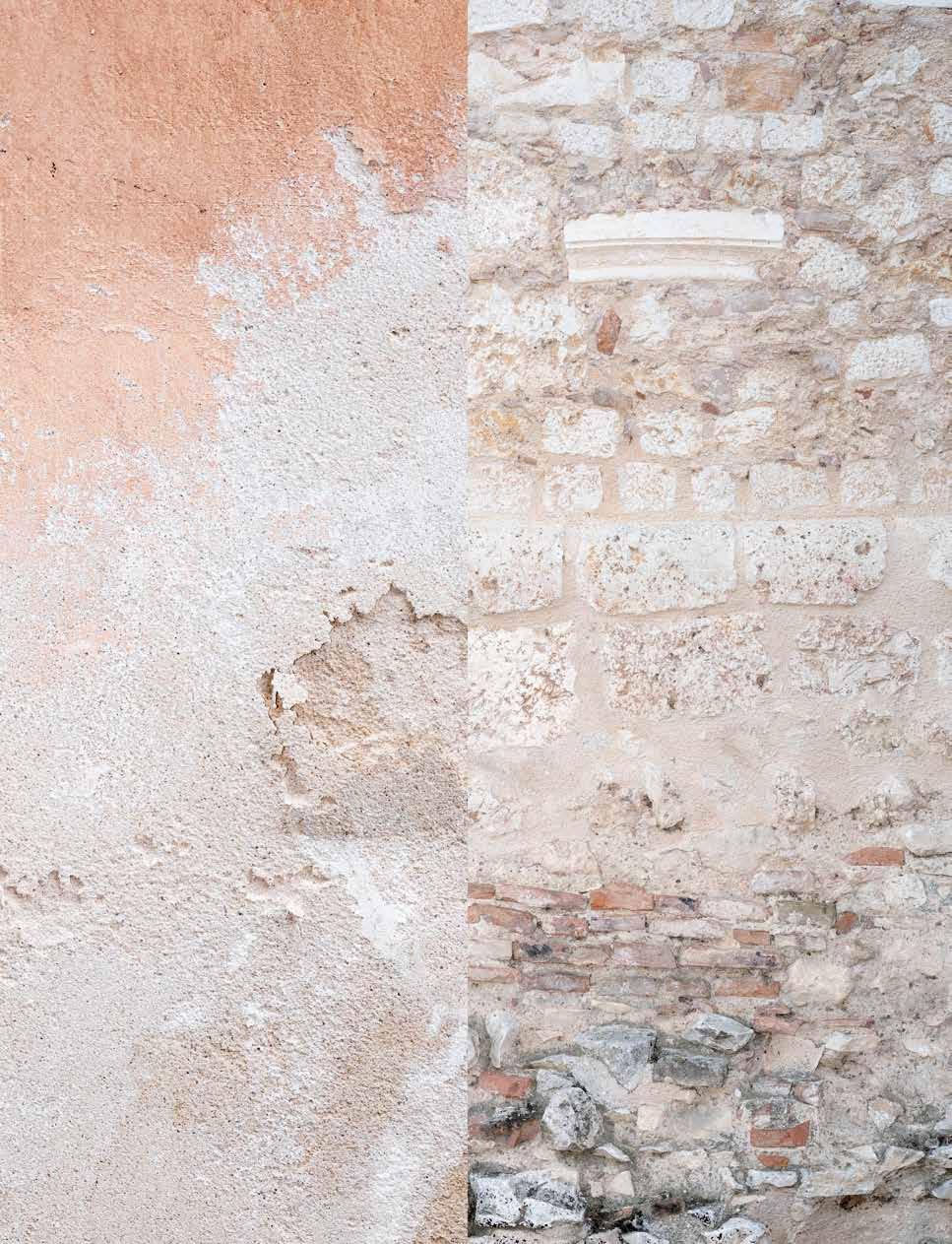



di SAVERIO VERINI
Lo studio di Alice Peach è un piccolo cantiere dotato di una vitalità controllata, dove le idee vengono cucinate a fuoco lento. Un laboratorio di oggetti compostamente sfasati, di giocattoli imperfetti, di progetti felicemente disfunzionali. Le sue opere sembrano create da un bambino che si diverte ad assemblare le cose secondo una logica rigorosamente atipica; un passatempo serio, più che un divertimento. Questa attitudine trasmette alle opere dei sentimenti contrastanti: giocosità e delicatezza, ma anche un senso di destabilizzante malinconia. L’interesse per la manipolazione – di oggetti e concetti – è sempre percepibile, così come appare chiara l’intenzione di ricomporre, pezzo per pezzo, un catalogo anomalo della realtà che circonda l’artista. Come un puzzle disseminato di sottili incongruenze.
Sembra che la tua ricerca artistica sia ancorata a un immaginario e a uno stupore infantili. È, però, un’infanzia apparentemente lontana da quella che potrebbe aver vissuto una persona nata nel 1996 come te. Si può dire che la tua pratica sia alimentata da questa sfasatura temporale?
Si tratta di un’osservazione legittima. Anche se il mio lavoro non riguarda direttamente l’infanzia, è vero che ricerco negli oggetti e nei materiali che ho attorno delle potenzialità inedite che generano in me uno stupore e una risposta istintiva. Mi affascina ciò che sfugge alla vista e alla memoria e, attraverso il lavoro, si traveste di forme sempre diverse. A questa dimensione immaginifica cerco di accedere attraverso una combinazione di intuito (unendo pittura, disegno, stampa, scultura…) e una ricerca sul linguaggio (etimologia, fenomenologia, simbolismo…).
Come si sostanzia tutto ciò nella tua pratica?
Il mio lavoro è spesso composto da moduli e frammenti, come un puzzle che non segue una logica perché non vuole spiegare, ma reinterpretare esperienze e ricerche che, nel processo creativo, si mescolano fino a dissolversi. Periodicamente mi lego a motivi specifici (paracaduti, insetti, gazze ladre…) che ripropongo in varie forme e materiali per esaurirli del loro significato e tradurli in altro. Come quando si ripete una parola tante volte fino a perderne il senso. Un ulteriore aspetto, forse comune a un approccio naïf, è che mi muovo senza progettualità, anzi, preferisco lavorare partendo da un’idea, ma lasciando che il lavoro “succeda” da sé, attraverso errori di percorso, soluzioni improvvisate e accantonando progressivamente la rappresentazione qualcosa di definito.
Mi colpisce il “calore” delle tue opere: c’è il disegno, c’è l’impiego frequente di un materiale come il legno, così come la ripresa di supporti – fogli di carta già usati, grafiche pubblicitarie – con un loro vissuto. Nel tuo lavoro le cose acquistano una loro umanità, lontana dalla freddezza del design indu-
Preferisco lavorare partendo da un’idea, ma lasciando che il lavoro “succeda” da sé
striale, pur mantenendo un legame con esso. Ti riconosci in questo cortocircuito?
Entrambi i miei genitori, e molte altre persone che hanno orbitato la mia infanzia, lavorano nel mondo del design e dell’architettura. Ho quindi sempre riconosciuto l’importanza degli oggetti, sviluppando una curiosità verso il percorso che dà loro vita. Il carattere degli oggetti, poi, si definisce soprattutto nella relazione che costruiamo con essi, come individui e come società: scomporre, disegnare e riassemblare oggetti è il mio modo per osservarne il valore estetico, sensoriale, affettivo, al di là di quello funzionale. Questo rapporto con le cose, inoltre mi porta a cercare materiali che hanno avuto una vita precedente. Le cose degli altri, gli scarti, soprattutto, mi attraggono, e mi piace andare a cercarli nelle falegnamerie, nel retro dei negozi, in fondo ai cassetti… Lavorare così, per me, significa aggiungere o trasformare significato, piuttosto che fabbricarlo.
Poi esistono oggetti folli e tutt’altro che funzionali. Nella moda questo accade spesso: l’abbigliamento in alcune sue espressioni assurde, trasforma le persone in creature ibride, come accadeva con i cappelli femminili tra il XVI e il XIX Secolo. Ultimamente, la mia ricerca si concentra proprio su questo: comportamenti di mimetismo e dissimulazione che si attuano attraverso l’uso di oggetti – per creare diversivi, illusioni ottiche, distorsioni.
Quanto peso ha nella tua ricerca la formazione alla Gerrit Rietveld Academie di Amsterdam? E, in generale, in che modo ha inciso il lungo periodo che hai trascorso all’estero?
Alla Rietveld Academie ho studiato nel dipartimento TXT (text e textile), che univa insegnamento tecnico, ricerca concettuale e scrittura. Molti degli insegnamenti della scuola li ho interiorizzati negli anni successivi alla laurea, periodo in cui il mio lavoro è cambiato tanto. Mi sono trovata tra il 2020 e il 2022 a Berlino a lavorare in un contesto più solitario e concentrato rispetto a quello dell’accademia, un po’ per
Alice Peach è nata a Bari nel 1996. Di origine anglo-italiana, vive a Milano. Dopo la laurea in Fine Art and Textiles alla Gerrit Rietveld Academie di Amsterdam (2020) trascorre due anni a Berlino, per rientrare in Italia nel 2023. Attualmente si divide tra il suo studio a Milano e Losanna, dove nel corso dell’ultimo anno accademico ha collaborato con il docente Federico Nicolao al progetto di ricerca Assemblée des écritures all’ECAL – École cantonale d’art de Lausanne. È tra gli artisti selezionati per la terza Edizione del programma di residenze Nuovo Gran Tour 2025-2026 promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea, che la porterà a lavorare alla Cité Internationale des Arts, a Parigi. Ha partecipato a diverse mostre personali e collettive all’estero e in Italia. Tra gli spazi espositivi che hanno ospitato il suo lavoro si ricorda: Clima Gallery, Milano (2025), Vin Vin, Vienna (2025), Studio Hanniball, Berlino (2025), Colli Gallery, Foligno (2025), Magma Maria, Offenbach am Main (2024), La Placette, Losanna (2024), Sentiment Zh, Parigi (2023), Heerz Tooya, Vishovgrad (2023), Castiglioni Gallery, Milano (2023), Associazione Barriera, Torino (2023).
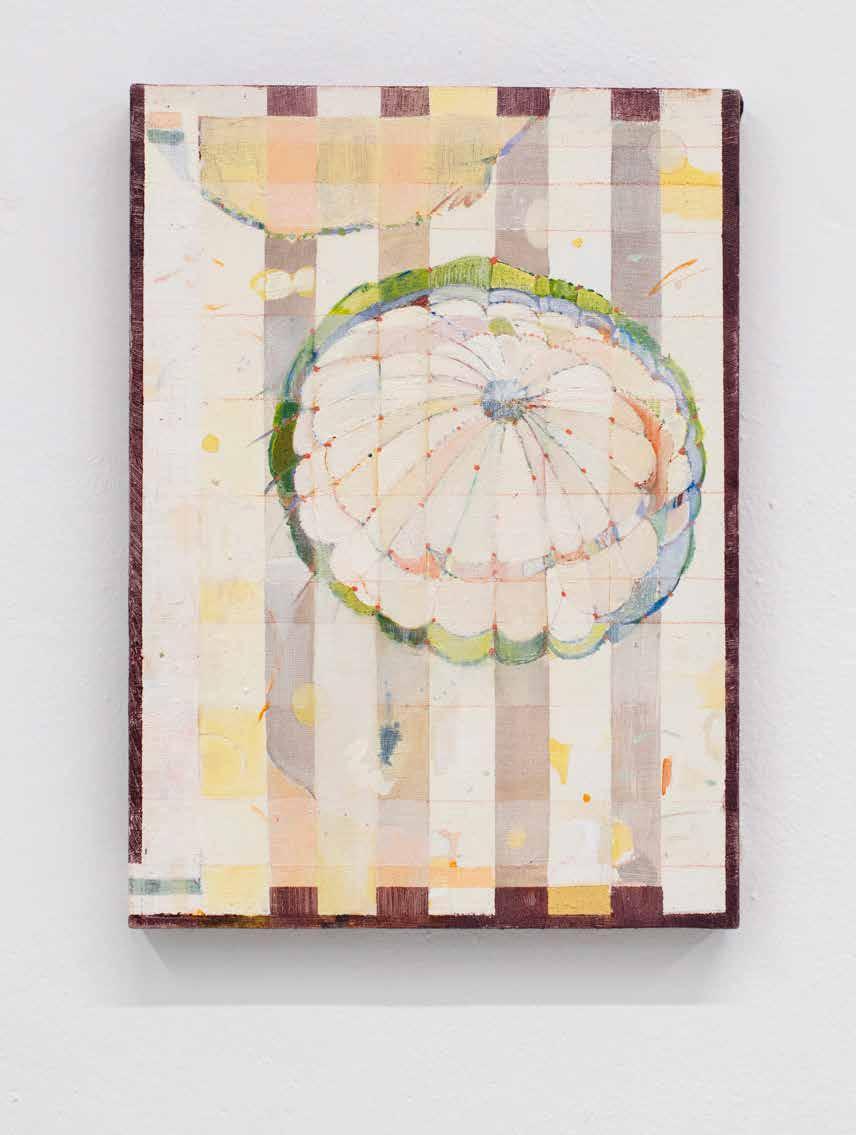

Succo della Esse, 2023, matite colorate su sottobicchieri di carta, coriandoli a forma di mela, nastro adesivo, legno di obeche, 76,4 x 56,2 cm. Veduta dell’installazione in occasione della mostra Small world, a cura di Sentiment Zurich, allo Studiolo Belleville, Parigi. Photo Julien Gemaud
Significant chip, 2025, legno multistrato di betulla, plexiglas, barra di acrilico, stecchi da gelato scolpiti, carta, paillettes, 106 x 42 x 7 cm

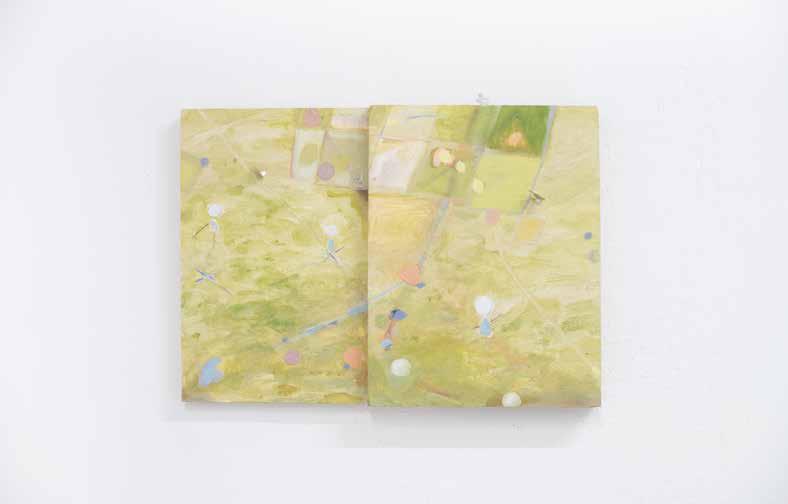
The Champions, 2024, olio e carta su tavole assemblate, 20 x 35 cm. Veduta dell’installazione in occasione della mostra Haloes & Hula-Hoops allo Studio Hanniball, Berlino. Photo Clara Sartor
NEI NUMERI PRECEDENTI
#58 Mattia Pajè
#59 Stefania Carlotti
#61 Lucia Cantò
#62 Giovanni de Cataldo
#63 Giulia Poppi
#64 Leonardo Pellicanò
#65 Ambra Castagnetti
#67 Marco Vitale
#68 Paolo Bufalini
#69 Giuliana Rosso
#70 Alessandro Manfrin
#71 Carmela De Falco
#72 Daniele Di Girolamo
#73 Jacopo Martinotti
#74 Anouk Chambaz
#75 Binta Diaw
#76 Clarissa Baldassarri
#77 Luca Ferrero
#78 Francesco Alberico
#79 Ludovica Anversa
#80 Letizia Lucchetti
#81 Bekhbaatar Enkhtur
#82 Federica Di Pietrantonio
#83 Nicola Bizzarri
#84 Francesca Brugola
#85 Giuseppe Lo Cascio
#86 Daniele Formica
via del Covid, un po’ per scelta. È stato fondamentale avere quel tempo. Oggi compongo le mie tele cucendo insieme scarti di tessuto, e integro nei lavori pattern tessili trovati su archivi online di musei e istituzioni… Il tessuto è presente come sfondo e supporto al lavoro, ma anche come riferimento concettuale a un ordine strutturale.
Quali sono gli artisti – in qualsiasi campo – che ti hanno influenzata?
La tecnica di Lucy McKenzie, l’approccio istintivo di Helen Marten, i colori di Pierre Bonnard, gli scritti (oltre ai quadri) di Agnes Martin, le installazioni di Hanne Darboven, la teatralità di Paolo Uccello… La minuziosità di ognuno mi ispira moltissimo. Aggiungo anche il saggio La scrittura delle pietre di Roger Caillois.
Che rapporto hai con i social network e il modo in cui, attraverso di essi, vengono veicolate le immagini delle opere? Te lo chiedo perché il tuo lavoro – con i suoi dettagli – mi sembra richieda una prossimità fisica difficilmente rimpiazzabile da una visione a distanza.
Oltre a Instagram, ho un sito dove pubblico le fasi di produzione e sviluppo della mia ricerca: foto di lavori in dive-
Le cose degli
altri, gli scarti, soprattutto, mi attraggono, e mi piace andare a cercarli nelle falegnamerie, nel retro dei negozi, in fondo ai cassetti…
nire, immagini d’archivio, testi e appunti personali. Questo approccio tra archivio e blog, mi serve per osservare l’evoluzione del lavoro, ma anche per mostrare ad alcune persone aspetti del processo creativo e della quotidianità in studio, che sui social si perdono o non si hanno modo di conoscere. Instagram, lo uso come strumento relazionale per conoscere artisti, scoprire progetti e iniziative.
I prossimi progetti?
Da circa un anno collaboro con il professor Federico Nicolao a un progetto di ricerca presso l’ECAL di Losanna. Per la conclusione del progetto, sto realizzando una serie di sculture che saranno presentate a gennaio a Losanna. Sempre a gennaio parteciperò a una mostra a Milano con il progetto 13vetrine, curato da Stefania Carlotti e Margaux Dewarrat. Nel frattempo, mi preparo alla partenza per Parigi, dove da dicembre trascorrerò tre mesi in residenza alla Cité Internationale des Arts, nell’ambito del progetto Nuovo Grand Tour 2026.
ALBERTO VILLA
Difficile pensare al futuro, quando tutto intorno si sgretola. La mia generazione lo sa bene. Dal nuovo millennio lo sfaldamento dello strapotere occidentale si è vertiginosamente esasperato. Dopo aver partecipato a conflitti o addirittura averli provocati, ripetuti crolli finanziari, denatalità, populismi, pandemie e orecchie da mercante di fronte a tragedie umanitarie vicine e lontane, l’Occidente non può più nascondersi dietro il ruolo di “garante della pace”, una farsa storica tanto quanto odierna. Ma probabilmente è giusto così: gli imperi sorgono e implodono, per essere poi sostituiti da altri grandi poteri. Intorno a noi regna ancora quella “permacrisi” la cui fine sicuramente c’è ma non si vede, perché dall’avvenire non giunge nessuna luce in grado di illuminarla. Rifiutando di arrenderci a questo destino di oscurità, cerchiamo invece i lumi in quello che c’è stato, che poi è il destino ultimo di tutte le cose: il
passato. Se lo leggiamo in questa prospettiva, la stessa avanzata dal filosofo kenyano John Mbiti in riferimento ad alcune culture dell’Africa Orientale (African Religions and Philosophy, 1969), il tempo sembra scorrere al contrario – dal presente al passato, seguendo gli eventi nel loro verificarsi (e quindi nel loro configurarsi come già accaduti). Sulla scia di questa linea del tempo inversa a quella che ha sempre guidato l’Occidente e la sua economia, questo numero di Artribune Magazine guarderà più al presente e al passato che al futuro. Nelle prossime pagine, più che tendenze, proposte e previsioni, troverete ratificazioni, riletture, viaggi a ritroso. E soprattutto luoghi in cui tutto questo è possibile: dalla Palestina contemporanea e passata, di cui è necessario continuare a parlare per non accontentarci di un accordo di pace fasullo, ad Amburgo, con la sua vibrante scena artistica indipendente;
dalla regione spagnola delle Asturie, terra ricca di storia e di preistoria, ad Accra, capitale ghanese piena di contraddizioni dovute a un colonialismo cambiato, certo, ma mai finito. Persino la copertina del magazine, dall’aspetto futuristico e alieno, trae origine da un’antica favola cinese, reinterpretata in scultura e performance dalla giovane artista Bao Rong. Cambiare prospettiva sullo scorrere del tempo significa anche accettare l’inconsistenza del futuro: non perché un futuro non sia possibile, ma proprio perché esiste solo nel momento stesso del suo verificarsi, nel suo diventare passato. E quindi ogni approccio al domani, ogni richiesta di fiducia nel futuro non può che confrontarsi con la sua nebulosità, e allo stesso tempo con la concretezza di promesse infrante, con la tangibilità di un progresso sociale tanto declamato quanto pericolante.
A Barcellona apre un nuovo spazio per l’arte contemporanea all’interno di Casa Batllò di Antoni Gaudì
LIVIA MONTAGNOLI L Per la prima volta nella storia museale di Casa Batllò, architettura-manifesto di Antoni Gaudí che proprio nel 2025 festeggia il ventesimo anniversario della sua iscrizione a Patrimonio Mondiale dell’Unesco, il secondo piano dell’edificio aprirà al pubblico, a partire dal 31 gennaio 2026. Ma non è questa la novità più attesa per il futuro del palazzetto che nel 1906 Gaudí progettò per la famiglia Batllò al civico 43 di Passeig de Gràcia: a partire dal 2026 l’arte contemporanea entrerà stabilmente tra le proposte del sito, con 230 metri quadri di spazio espositivo a disposizione al secondo piano dell’edificio, trasformato per l’occasione dallo studio Mesura. Il piano, pensato come una galleria, accoglierà due mostre all’anno, a partire dal progetto Beyond the Façade – una mostra interattiva sulla luce e il movimento – del collettivo londinese United Visual Artists, fondato da Matt Clark. In concomitanza con l’inaugurazione prevista per il 31 gennaio, United Visual Artists proietterà anche un inedito videomapping sulla facciata dell’edificio, contribuendo allo storia del progetto Casa Batllò Contemporary, che nel 2026 coincide con il centenario della morte di Gaudí.

Render of Casa Batlló Contemporary Exhibition
Space. Image courtesy of Mesura
LIVIA MONTAGNOLI L Mentre c’è attesa per scoprire come, nel 2026, Gibellina saprà interpretare il ruolo di prima Capitale italiana dell’arte contemporanea, al Ministero della Cultura è stata proclamata Alba come città vincitrice per il 2027. A contendersi il titolo erano arrivati sei progetti finalisti, per otto città (quattro hanno partecipato in forma aggregata): Alba (CN), Chioggia (VE), Foligno e Spoleto (PG), Pietrasanta (LU), Termoli (CB), Varese e Gallarate (VA). La giuria ha motivato la scelta di Alba indicando che “il progetto si distingue per l’eccellente capacità di coniugare rigenerazione territoriale, innovazione artistica e partecipazione diffusa, attraverso un programma culturale di altissimo profilo. Si radica in una tradizione d’avanguardia che negli anni ha trasformato il territorio in laboratorio creativo, proiettandosi verso il futuro con iniziative destinate a diventare appuntamenti fissi nel panorama artistico nazionale e internazionale”.
Il Padiglione Italia alla Biennale Arte 2026
sarà curato da Cecilia Canziani con progetto di Chiara Camoni
Sarà la coppia di curatrice e artista Cecilia Canziani – Chiara Camoni a occupare il Padiglione Italia alla Biennale Arte di Venezia 2026. Un progetto tutto al femminile, quello selezionato dal ministro della Cultura Alessandro Giuli per rappresentare l’Italia alla 61. Esposizione Internazionale d’Arte dal 9 maggio al 22 novembre 2026. Per Giuli la proposta “è una notevole declinazione al femminile di un ‘materialismo magico’ che antichizza il presente, con sapienti evocazioni mediterranee, citazioni e imitazioni trascendenti. Il progetto mostra una rara capacità di trasformazione della Natura in un laboratorio artistico vivente”. Il progetto Con te con tutto di Camoni (Piacenza, 1974) presentato e curato da Canziani (Roma, 1976) ha quindi battuto sia quello presentato da Valentino Catricalà, Scola Aperta, del duo Formafantasma; sia quello presentato da Marta Papini, Parlare di notte di Guglielmo Castelli e Giulia Cenci.
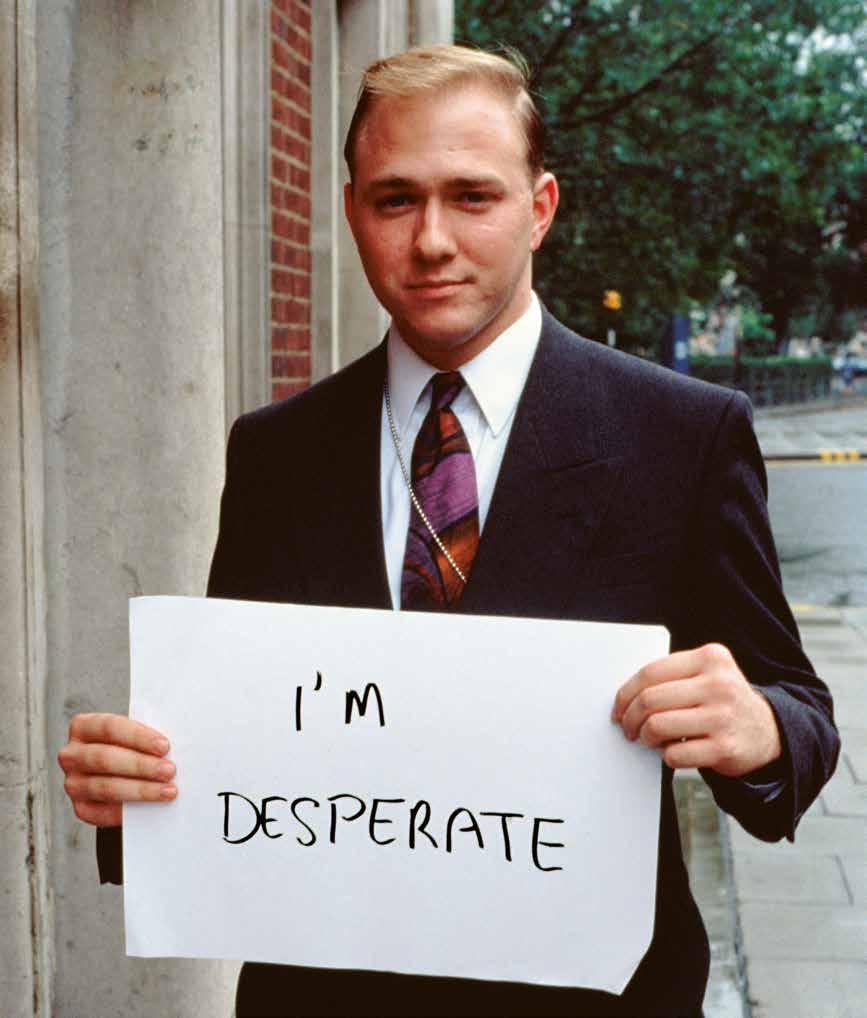
DIRETTORE
Massimiliano Tonelli
DIREZIONE
Santa Nastro [vicedirettrice]
Giulia Giaume [caporedattrice]
COORDINAMENTO MAGAZINE
Alberto Villa
Valentina Muzi [Grandi Mostre]
REDAZIONE
Caterina Angelucci | Irene Fanizza
Claudia Giraud | Livia Montagnoli
Ludovica Palmieri | Roberta Pisa
Emma Sedini | Valentina Silvestrini Alex Urso
PROGETTI SPECIALI
Margherita Cuccia
PROGETTO GRAFICO
Alessandro Naldi
PUBBLICITÀ
Cristiana Margiacchi | 393 6586637
Rosa Pittau | 339 2882259
Valentina Bartarelli | 347 6590514 adv@artribune.com
EXTRASETTORE
download Pubblicità s.r.l. via Boscovich 17 — Milano via Sardegna 69 — Roma 02 71091866 | 06 42011918 info@downloadadv.it
COPERTINA ARTRIBUNE
Bao Rong, THE HOLE, 2025 PVC fabric, electric control, mixed media, 365h x 415w x 195d cm
Photo credit: Bao Rong Studio
Special thanks: Carl Kostyal Gallery
COPERTINA GRANDI MOSTRE
Letizia Battaglia, Quartiere Kalsa. La bambina con il pane. Palermo, 1979 (dettaglio) © Archivio Letizia Battaglia
STAMPA
CSQ — Centro Stampa Quotidiani via dell’Industria 52 — Erbusco (BS)
DIRETTORE RESPONSABILE Paolo Cuccia
EDITORE & REDAZIONE
Artribune s.r.l. Via Ottavio Gasparri 13/17 — Roma redazione@artribune.com
Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 184/2011 del 17 giugno 2011
Chiuso in redazione il 23 ottobre 2025
VALENTINA SILVESTRINi L Proprio mentre si appresta a intraprendere uno dei più ambiziosi e articolati iter di trasformazione architettonica dei suoi secolari spazi, a Siena il Complesso museale Santa Maria della Scala consolida la sua reputazione di luogo d’elezione per l’espressione di tutte le discipline artistiche. Così, dopo il debutto datato 2024, XENOS. Festival di performance si conferma tra le iniziative di punta nel palinsesto autunnale dell’istituzione culturale senese, con alcune novità rispetto all’edizione d’esordio.

Quattro giorni dedicati alla performance al Santa Maria della Scala Dal 13 al 16 novembre 2025, alcuni ambienti della centralissima sede senese tornano dunque ad accogliere artisti italiani e internazionali, invitati anche a misurarsi con le peculiarità del sito, le sue stratificazioni storiche, il suo impareggiabile patrimonio artistico e architettonico. Ancora una volta affidato alla direzione artistica di Anna Lea Antolini, “XENOS “non ‘porta’ la performance a Siena: la fa rinascere dal Santa Maria della Scala” ha sottolineato a riguardo Cristiano Leone, Presidente della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala. A susseguirsi nelle quattro giornate della kermesse saranno infatti “accadimenti inediti che respirano con le sale, gli affreschi, la memoria del luogo. Saranno momenti unici e irripetibili, possibili solo qui e solo con il pubblico” ha evidenziato Leone.
Il programma di “XENOS. Festival di performance” a Siena La Cappella del Manto, la sala intitolata allo scrittore Italo Calvino (del quale ricorre proprio nel 2025 il quarantennale della scomparsa), la Sala San Pio e il monumentale Pellegrinaio, contraddistinto dalla presenza di affreschi sia nelle pareti laterali che nelle volte a crociera della copertura, sono gli ambienti del Santa Maria della Scala scelti per l’edizione 2025 di XENOS. Festival di performance. Al loro interno, gli artisti coinvolti proporranno due distinte tipologie di performance. Il programma include infatti performance site specific, appositamente concepite per il complesso senese e legate, a vario titolo, ai suoi apparati decorativi e alla sua identità architettonica. Completano l’offerta le performance itineranti, che traggono la loro forza e singolarità dall’esperienza fisica di attraversamento, intesa come occasione di scoperta visiva e spaziale. Pur nella loro eterogeneità, tutte le performance intendono incoraggiare nel pubblico una forma di interazione con gli artisti e con il sito, provando a indirizzare il pensiero anche verso quanto non si rivela al primo sguardo.
Da Virginio Sieni ad Alice Mariani: a Siena in arrivo grandi artisti Danza, musica, poesia, divulgazione artistica e perfino la realtà virtuale scandiscono le giornate di XENOS. Per tutta la durata del festival sarà possibile mettersi alla prova con Lo sguardo in virtual reality attraverso la performance digitale WAVE di Bart Hess, il cortometraggio HALF LIFE di Robert Connor e con l'opera FEMINA | IRIS di Riccardo Giovinetto. Da segnalare la performance inaugurale Nello sguardo di Teodora Axente – con Alessandra Cristiani, Jacopo Giarda e musica dal vivo con il trio jazz di Silvia Bolognesi e gli studenti dell’Accademia Siena Jazz – il cui punto di partenza saranno le opere della stessa Axente al centro della mostra Metamorfosi del Sacro (al Complesso Museale Santa Maria della Scala, dal 14 novembre 2025 all’11 gennaio 2026). Sono attesi a Siena Alice Mariani, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Marta Ciappina, Premio Ubu 2023 come miglior performer, il pluripremiato coreografo e danzatore Virgilio Sieni, lo storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani, il violinista Yury Revich, il performer Giacomo Luci, la coreografa Stefania Ballone, il collettivo KOR'SIA e i coreografi internazionali Noé Soulier e Arno Schuitemaker. Prevista anche l'esibizione del Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”, diretto dal Maestro Lorenzo Donati. Solo sabato 15 e domenica 16 novembre sarà attivo un laboratorio (per bambini dai 7 ai 10 anni) ispirato al Teatro dei Ventagli di Italo Calvino, di e con Delfina Stella
RiciclatoPEFC
Questoprodottoè realizzatoconmateria primariciclata
www.pefc.it
PEFC/18-31-992
Siena, dal 13 al 16 novembre
XENOS. Festival di performance
Complesso museale Santa Maria della Scala
nella foto: Sulla leggerezza, Foto © Virgilio Sieni
Inquadra il QR code per il programma dettagliato:

di ALBERTO VILLA
L’universo gonfiabile della giovanissima artista Bao Rong è irresistibile.
La sua opera The Hole, in copertina di Artribune Magazine 87, reinterpreta un’antica favola cinese e tratta i temi della nascita, della rinascita e della trasformazione. Ne parliamo con lei in questa intervista

Pochi nomi della sua generazione stanno ricevendo la stessa attenzione internazionale di Bao Rong (Huizhou, 1997). A nemmeno trent’anni, è stata inserita tra i “10 migliori artisti emergenti” dall’UCCA (il più rilevante centro d’arte contemporanea di Pechino) ed è stata la prima artista cinese donna a ricevere una mostra personale alla prestigiosa Saatchi Gallery di Londra. Nel 2023 ha ottenuto il diploma in Scultura al Royal College of Art, dopo una formazione alla China Academy of Art di Hangzhou e alla School of the Art Institute di Chicago. In Italia l’abbiamo vista solo due volte: la prima – in tempi ancora non sospetti – nel 2022 alla fiera milanese d’arte emergente ReA! e la seconda nel 2025, sulla Pista 500 della Pinacoteca Agnelli a Torino. Guardando i suoi lavori, possiamo solo dire che ci piacerebbe vederla decisamente più spesso. Negli anni, Bao Rong ha maturato uno stile inconfondibile, accostandosi a quella che oggi si definisce Inflatable Art: sculture gonfiabili, talvolta cinetiche e di grandi dimensioni, che non possono che catturare l’attenzione dello spettatore. Sono opere che fanno della leggerezza, fisica ed estetica, un punto di forza e una chiave per leggere un mondo fin troppo appesantito dalla sua stessa assurdità. Non si tratta di affrontare superficialmente la realtà, o di negare le difficoltà contemporanee: al contrario, Bao Rong vuole restituire dignità all’umorismo e al gioco, potenti strumenti emozionali, cognitivi e sociali troppo a lungo sottovalutati. Il tutto senza rinunciare a quello che rende tale
in alto: Bao Rong, Enigma , 2023, PVC fabric and rubber elastic tubes, 380x320x350cm. Credits: Bao Rong Studio
a destra: Bao Rong, Alien Babe No.2 , 2023, PVC fabric, inflated swimming pool, yoga ball, vibration machine, toys, foam clay, 103 x 95 x 95 cm. Credits: Bao Rong Studio
un’opera d’arte: la sua irrisolvibile ambiguità. Lasciamoci trasportare allora nel mondo di Bao Rong, allo stesso tempo morbido e perturbante, alieno e umanoide, profondamente cinese e sapientemente occidentale.
Qual è stato il tuo primo incontro con l’arte contemporanea?
Ero molto giovane quando ho iniziato a dipingere, ma era soprattutto pittura ad olio e disegno accademico. Il mio primo incontro con l’arte contemporanea è stato alle scuole superiori, quando vidi Fontana di Marcel Duchamp, anche se all’epoca non lo compresi del tutto. Fu solo all’università che ebbi modo di studiare arte contemporanea in modo sistematico, visitando mostre, leggendo e approfondendo autonomamente. Quando poi mi sono trasferita a Chicago, ho iniziato a studiare la storia dell’arte contemporanea all’Art Institute.
Nel tuo Paese natale, il fermento artistico è particolarmente vibrante in questi anni. Cosa ti ha spinto a continuare la tua formazione al di fuori della Cina?
Nonostante in Cina l’arte contemporanea si sia sviluppata velocemente, l’educazione artistica non è stata altrettanto rapida. Quando frequentavo le scuole – circa dieci anni fa – il sistema didattico era ancora molto legato all’estetica tradizionale. Volevo com-

prendere in che modo l’arte opera all’interno di diversi sistemi culturali e formativi – in termini di insegnamento, realizzazione di mostre e anche vita quotidiana. Studiare all’estero mi ha garantito un certo tipo di distanza, che mi ha aiutata a guardare a me stessa in modo più oggettivo. Il mio nome, Bao Rong (包蓉), significa “inclusione” o “tolleranza” in cinese. Spero di continuare a crescere e trasformarmi attraverso lo scambio culturale, rimanendo aperta, fluida e in conversazione con mondi differenti.
La tua pratica artistica comprende pittura, performance e, soprattutto, scultura. Cosa ti attira di più di questo medium?
La scultura mi permette di riflettere contemporaneamente sullo spazio, sul corpo e sul materiale. È allo stesso tempo concreta e carica di emozione. Adoro il modo in cui la scultura occupa uno spazio reale, respira insieme con lo spettatore, come un’estensione del corpo. Una conversazione silenziosa tra la materia e l’essere umano.
Le tue sculture sono spesso cinetiche o gonfiabili, a volte entrambe. C’è una vitalità sorprendente, a tratti aliena, all’interno del tuo lavoro. È qualcosa che ricerchi attivamente?
Sì, mi interessa molto il momento in cui l’artificiale comincia ad apparire vivo, quando un movimento meccanico riesce, d’un tratto, a suscitare empatia. La qualità “aliena” ha anche a che fare con l’estraniamento: qualcosa di non familiare può riflettere la condizione umana in modo più autentico.
C’è un innegabile senso dell’umorismo e giocosità nei tuoi lavori. Credi che questo approccio, piuttosto che adottare un tono più serioso, possa essere più efficace nell’affrontare le assurdità della vita contemporanea?
Assolutamente sì. L’umorismo è una strategia di sopravvivenza. Il gioco permette alle persone di fronteggiare realtà difficili o assurde in modo più leggero. Mi piace creare opere che in un primo momento fanno sorridere le persone, per poi farle riflettere sul perché stanno sorridendo.
La copertina del magazine è un dettaglio dal tuo lavoro The Hole, installato a Hong Kong la scorsa primavera. Hai anche attivato questa grande scultura gonfiabile con il tuo corpo. Puoi raccontarci la genesi dell’opera e le ambiguità che esplora? Ho concepito questo lavoro a partire dal luogo in cui sarebbe stato esposto. Lo spazio aveva una grande vetrata e, al di là, una montagna – una vista rara nel denso panorama urbano di Hong Kong. Mi ha ricordato un antico testo cinese, Il ruscello dei fiori di pesco: “Il fiume finì ai piedi di una montagna e qui il barcaiolo vede una piccola apertura, da cui sembrava filtrare della luce. Decide allora di lasciare la sua imbarcazione e di entrare. All’inizio il varco è molto stretto, a malapena percorribile, ma dopo alcuni passi si apre improvvisamente su un vasto e luminoso paesaggio”. Volevo ricreare quella sensazione, costruendo una grande scultura che bloccasse la vista e invitasse gli spettatori a infilarsi dentro una piccola apertura, per poi emergere in uno spazio ampio e pieno di luce. C’è una riflessione sui concetti di nascita, rinascita e trasformazione. Strisciare all’interno del corpo di

questa “creatura” gonfiabile è allo stesso tempo assurdo e confortevole, come se si diventasse un parassita di un organismo gigante, un intruso che entra in un’altra forma di vita. In un’altra versione, ho sostituito il mio corpo con un paio di gambe meccaniche (che poi sono quelle che si vedono sulla copertina) che continuavano a scalciare, cercando di procedere senza successo e senza fine. Il movimento continuo ed estenuante di chi è intrappolato in un loop eterno. L’opera esplora quindi come il corpo può essere sia macchina sia prigioniero di se stesso, indagando quel confine sottile tra controllo e sottomissione.
Hai anche lavorato con la tua stessa immagine, mediante autoritratti pittorici e scultorei che riflettono sull’idea di distorsione. Dopotutto, anche le tue sculture gonfiabili sono soggette a simili trasformazioni. Sei particolarmente interessata nel concetto di cambiamento?
Sì, la trasformazione mi affascina. Il gonfiarsi e lo sgonfiarsi richiamano l’atto di respirare, sono metafore di emozione, fallimento, rinascita. La distorsione, per me, non è distruzione; è un processo di divenire.
In quale direzione si sta evolvendo la tua pratica artistica?
Bao Rong, The Wheels Keep Turning , 2024, Mixed media, 100cm (H) x 80cm (W) x 80cm (L). Credits: Bao Rong Studio
Sto cercando di realizzare opere più interattive e ritualistiche, che invitino la partecipazione collettiva, piuttosto che la contemplazione individuale. Sono anche interessata a sfumare il confine tra scultura pubblica e performance, trasformare gli spazi in ambienti morbidi e respiranti dove le persone possano giocare e riposarsi. O semplicemente esistere.

Clemen Parrocchetti, Senza Titolo, 1969 © Tiberio Sorvillo
SANTA NASTRO L La storia dell’arte è satura di corpi. Corpi splendidi e scultorei, corpi abbandonati, corpi floridi, vistosi, feriti, suturati, angosciati. Sono corpi che parlano e che raccontano, piattaforme di storie, non sempre edificanti. Anche la mostra Ironia ribelle di Clemen Parrocchetti (Milano 1923 – 2016), curata a Palazzo Medici Riccardi a Firenze da Stefania Rispoli e Marco Scotini, ne parla. Mostrando, innanzitutto, che siamo di fronte ad un’artista sontuosa, capace di spaziare tra i media con uno stile unico e inconfondibile, padroneggiando con consapevolezza la grande arte del passato per creare un linguaggio totalmente nuovo, verso un corpo politico femminile che si riappropria di se stesso. A volte è disgiunto, scollegato, al tempo stesso rigoglioso, come nella serie pittorica Amore e divorazione (1969) che accoglie il visitatore introducendolo nel mondo anticonformista di Parrocchetti, fatto di bocche che mordono, vagine e seni che lasciano poco spazio alla seduzione, denti affamati, in una tavolozza ai limiti del pop. Sovvertendo, inoltre, gli stereotipi del fare muliebre, Parrocchetti prende in mano strumenti di cura o tratti dal lavoro domestico o ancora ago, filo e spolette. Fila arazzi. Lavora con i tessuti creando le sue soft sculptures (Lamento del sesso, 1978), che anticipano le più note opere di Louise Bourgeois. La mostra, promossa dal Museo Novecento Firenze e con la direzione artistica di Sergio Risaliti, segue non a caso la programmazione dell’istituzione fiorentina che sta dando rilevanza a maestre come appunto Bourgeois, Marion Baruch, Jenny Saville e Cecily Brown tra le altre.
Con Parrocchetti l’arte diventa qualcosa di più: è uno strumento di militanza politica (Manifesto. Promemoria per un oggetto di cultura femminile, 1973), seguendo le istanze di movimenti come quelle del gruppo Lotta Femminista di Padova o intersecando il Gruppo Immagine di Varese, soprattutto nel 1978 (Macchina delle frustrazioni o Barriere), con le note vicende che porteranno la compagine alla Biennale di Venezia. I temi, dunque, della subalternità del ruolo della donna e del salario al lavoro domestico (dove il carico è mentale, pratico e anche sessuale) e del riscatto della donna nell’alveo di una dimensione esterna all’ambito familiare, dell’emancipazione del corpo e del libero arbitrio su di esso senza condizionamenti sociali, intervengono prepotenti e con singolare lucidità nel suo lavoro. Fino alle opere dell’ultimo periodo che attestano ancora una volta la grandezza dell’artista. Sempre precorrendo i tempi Parrocchetti coglie, infatti, in largo anticipo l’aspetto intersezionale di uno sguardo che mette in comunione il corpo femminile con quello animale, ponendo sullo stesso piano questione ambientale e di genere. E via libera, dunque a blatte, pidocchi, meduse, parassiti, insetti, ma anche a cani. In un’alleanza femminista tra corpi irregolari, bestie e donne, un’unione non gerarchica contro il potere dominante maschile e la sua sete insaziabile di controllo.
Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma punta anche sull’arte contemporanea. E nell’Ipogeo arriva un allestimento immersivo
VALENTINA MUZI L Il Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia diventa non solo un simbolo di rigenerazione architettonica, ma anche un luogo di pensiero e creazione, dove il contemporaneo non è invasione, ma possibilità di racconto. La prima mostra è una riflessione sulla fragilità della modernità e sull’armonia possibile tra passato e futuro di Keita Miyazaki (Tokyo, 1983). Curato da Pier Paolo Scelsi, con la co-curatela di Ilaria Cera e la direzione artistica di Riccardo Freddo, il progetto espositivo entra in dialogo con la storia e l’architettura del “teatro d’acque” del museo d’arte antica romano, aprendosi ai linguaggi dell’arte contemporanea. Dotdotdot firma intanto il nuovo allestimento multimediale dell’Ipogeo del Museo. Concepito come una discesa nella necropoli, il progetto trasforma lo spazio sotterraneo della Villa in un’esperienza narrativa immersiva incentrata sul culto dei morti come chiave per comprendere la città dei vivi.

Cantieri Narranti. Si chiama così la piattaforma online che racconta i restauri di Roma
LIVIA MONTAGNOLI L La piattaforma online Cantieri Narranti, con i relativi strumenti social a potenziare la comunicazione, è nata con l’intento di condividere con un pubblico quanto più ampio possibile, attraverso un racconto corale e coinvolgente, gli interventi che ogni giorno impegnano la squadra di restauratori, storici dell’arte e archeologi, architetti e archivisti, paesaggisti al lavoro sul patrimonio culturale di Roma. Uno strumento – già sviluppato un paio d’anni fa ma entrato a regime proprio nel corso del 2025 – per dare evidenza agli interventi in corso e in fase di attivazione, per promuovere in modo organico e innovativo i progetti dedicati alla conservazione del patrimonio culturale della Capitale, per fare dei cantieri luoghi di storie da scoprire, seguire e visitare.
A Villa Adriana inaugura un nuovo percorso che valorizza la collezione d’arte antica del sito archeologico romano
LIVIA MONTAGNOLI L Sotto la direzione di Andrea Bruciati, il cui mandato è scaduto nella primavera 2025 dopo otto anni di grandi restauri e nuove progettualità, Villa Adriana ha beneficiato della riapertura degli spazi dei Mouseia (Musei del Canopo) e del debutto del percorso Yourcenar, un cammino che riapre al pubblico un collegamento storico tra il Teatro Greco e il Tempio di Venere. Ma anche del recupero dei bacini d’acqua del Canopo, del Pecile e del Teatro Marittimo. In questa operazione di rilancio si inserisce il nuovo percorso espositivo dei Mouseia, che consente di valorizzare il contesto monumentale e, al contempo, di ampliare lo spazio espositivo e migliorare l’offerta culturale dell’area archeologica.
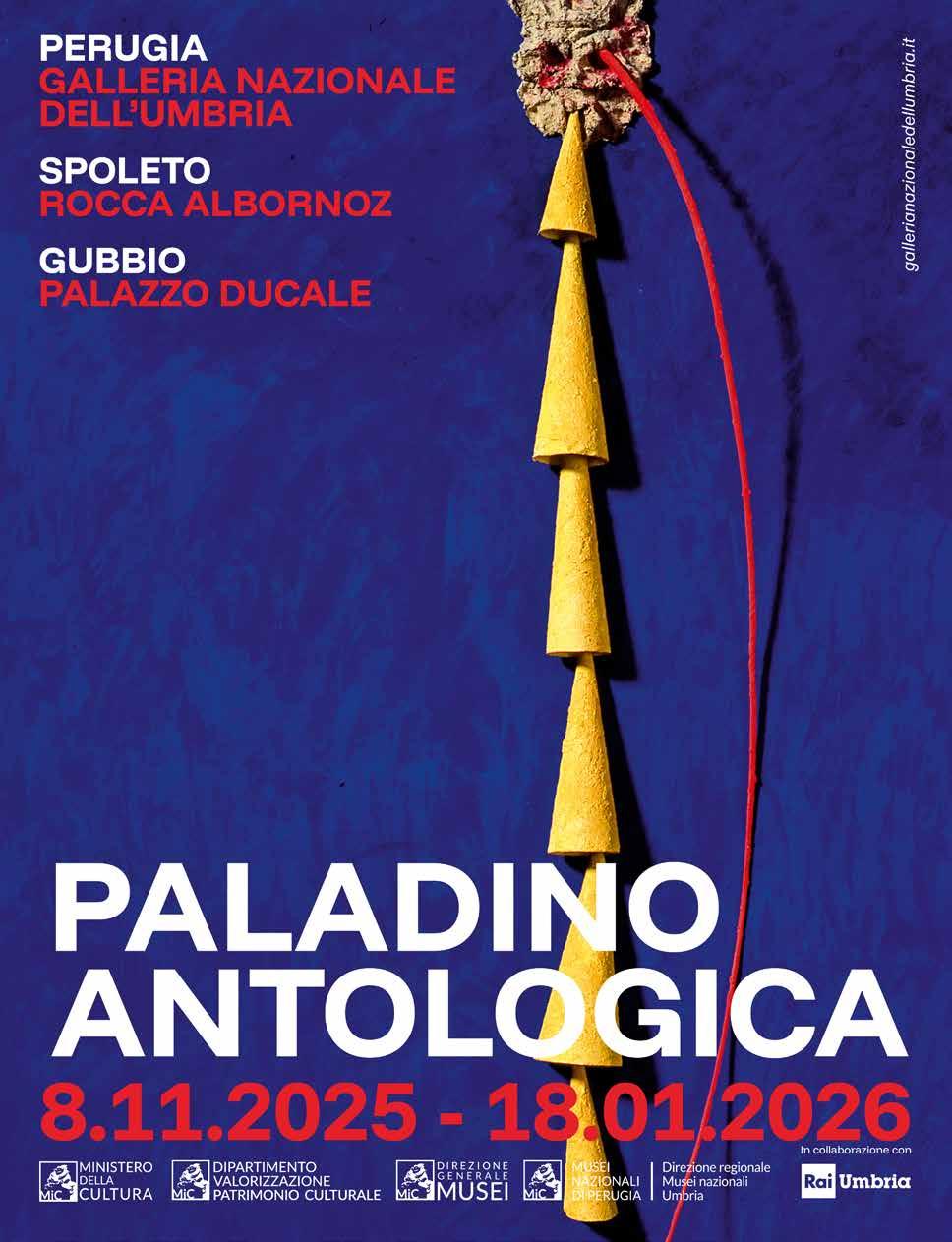
Le edicole rinascono come spazi culturali. I nuovi esempi di Napoli e Rovigo

VALENTINA MUZI L Nei primi Anni Duemila le edicole in Italia erano circa 40mila; nel 2024 ne sono sopravvissute meno di 12mila. Sagome vuote color verde scuro che si stagliano in piazze e vie, come l’ex edicola in Piazza Matteotti a Rovigo che, grazie all’idea delle storiche dell’arte Elisa Giuliani e Ilaria Parini, si è trasformata in Edicò, un nuovo polo culturale della città. “L’edicola riapre con una nuova veste. Non ha perso la sua natura comunicativa: l’ha trasformata. Oggi ci parla attraverso opere d’arte, illustrazioni, laboratori, incontri ed eventi, prende spunto dalle storie delle persone e le restituisce sotto nuove forme”, scrivono le fondatrici. Inaugurata a settembre 2025, Edicò si pone come nuovo punto di riferimento culturale ospitando mostre di artisti e illustratori emergenti (a cominciare dal fotografo rodigino Mattia Zoppellaro). Non solo, lo spazio intende valorizzare il territorio e coinvolgere la comunità attraverso workshop, incontri con artisti, contest, performance e laboratori. “Il progetto Edicò nasce da un brainstorming, e grazie a un fondo privato che ha dato modo di realizzarlo assieme a un crowdfunding per sostenere i costi”, spiegano ad Artribune Giuliani e Parini. “L’idea era quella di dare risalto a tutti quei luoghi che stavano chiudendo nella città di Rovigo, soprattutto le edicole. Un tema che ha radici profonde nella comunità”.
A Ravenna torna la Biennale di Mosaico Contemporaneo. Tre mesi di mostre, laboratori e arte pubblica
LIVIA MONTAGNOLI L Con la direzione di Daniele Torcellini, la Biennale di Mosaico Contemporaneo si pone l’obiettivo di raccontare un linguaggio artistico millenario mettendone in luce la capacità rinnovarsi e dialogare con la contemporaneità. dLa IX edizione della Biennale si tiene dal 18 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, animando Ravenna con tre mesi di eventi, mostre e installazioni diffusi in tutta la città, a partire dalla mostra inaugurale Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera, dedicata al legame tra l’artista francese e la tecnica musiva – legame che nasce proprio a Ravenna, nel 1954, quando Chagall visita la città e rimane profondamente colpito dalla bellezza e dalla spiritualità dei mosaici bizantini – e allestita al MAR per presentare un capitolo ancora poco noto del suo percorso creativo.
Inaugura a Chicago la Land School. Il nuovo progetto di rigenerazione urbana di Theaster Gates

CATERINA ANGELUCCI L Propone un’esperienza di fruizione basata sulla sottrazione il nuovo spazio espositivo EDICOLA480 a Napoli. Qui ogni intervento, della durata di 30-40 giorni, non è accompagnato da alcun apparato: l’opera è “lasciata sola, esposta, collocata in uno spazio che ne concentra l’energia e ne amplifica la presenza”. L’obiettivo? Offrire una decantazione rallentata del tempo, in cui l’osservazione si fa più profonda e consapevole. Il progetto è ideato dal curatore e direttore artistico Massimiliano Bastardo e promosso dall’associazione culturale 480 Site Specific. E la sede è proprio un’ex edicola di Via San Pasquale, nel quartiere Chiaia, riconosciuto dai più come centro dell’arte contemporanea in città: “La scelta di un’unica opera non limita ma al contrario apre: rende possibile un contatto più diretto, intimo e consapevole con la ricerca degli artisti emergenti e mid-career invitati a partecipare”, spiegano dall’organizzazione. Il format non è una novità: EDICOLA480 prende ispirazione da precedenti storici come la leggendaria Pièce Unique di Lucio Amelio a Parigi, riportandone l’intuizione nel contesto contemporaneo napoletano. E come l’edicola di un tempo distribuiva notizie e storie, oggi questo spazio rinnova la sua missione: l’arte come racconto. EDICOLA480 non ha finalità commerciali, ma è pensato come piattaforma culturale, uno spazio etico, lontano dalle logiche del mercato e vicino invece a quelle dell’esperienza artistica.
Un altro pezzo di storia brutalista che se ne va. Il leggendario Hotel du Lac di Tunisi viene demolito

GIULIA GIAUME L Per gli amanti del Brutalismo è un perfetto esempio dell’architettura d’impatto degli Anni Settanta, per gli amanti della fantascienza una struttura evocativa che ricorda quelle del primo capitolo della saga di cappa e laser più famosa di sempre, Star Wars. Tutti hanno una propria idea del leggendario Hotel du Lac, l’albergo che dai primi Anni Settanta troneggia nel centro di Tunisi con la sua figura a piramide rovesciata, o, per i più romantici, di uccello sul punto di spiccare il volo. Un tempo metafora della Tunisia da poco uscita dalla colonizzazione francese, da decenni è uno spazio abbandonato e in rovina, motivo per cui dopo lungo dibattito oggi viene demolito, nell’ottica di sostituirlo con una nuova struttura ricettiva.
Alle porte di Milano nasce il Museo Nazionale di Fotografia
LIVIA MONTAGNOLI L Ha debuttato pochi giorni prima dell’inizio della Biennale di Architettura di Chicago, che si protrarrà fino alla fine di febbraio 2026, l’ultimo progetto promosso da Theaster Gates (1973), che a Chicago è nato, vive e lavora. L’iniziativa è promossa dalla Rebuild Foundation, organizzazione artistica no-profit fondata nel 2009 dall’artista nel South Side di Chicago (l’area a più alta densità afroamericana della città), come piattaforma di sviluppo culturale attraverso l’arte. La Land School, centro per le arti realizzato in 7 anni di lavoro (e 12 milioni di dollari di investimento) grazie al recupero di una scuola elementare abbandonata, è l’ennesimo tassello di questa operazione di rigenerazione urbana.
Da MUFOCO a MUNAF. Non è solo la sigla a fare la differenza nella trasformazione del Museo di Fotografia Contemporanea in Museo Nazionale di Fotografia. Aperto nel 2004, il MUFOCO nasceva come primo (e ancora oggi unico) museo pubblico in Italia dedicato interamente alla fotografia e all’immagine tecnologica, trovando casa negli spazi della seicentesca Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo (hinterland di Milano), rinnovati nel 2024 su progetto dello studio Dotdotdot. Ora, dopo un articolato iter amministrativo e giuridico, il museo adotta il nuovo Statuto che sancisce la nascita della Fondazione Museo Nazionale di Fotografia, di cui il Ministero della Cultura è ente fondatore e promotore, insieme alla Città metropolitana di Milano e al Comune di Cinisello Balsamo.










Lo schermo dell’arte festeggia la sua diciottesima edizione confermandosi come uno degli appuntamenti più originali e riconosciuti nel panorama internazionale delle moving images Dal 12 al 16 novembre 2025 Firenze torna crocevia di artisti, curatori, produttori e pubblico, con un programma che spazia tra film, installazioni, realtà virtuale e incontri. Non un semplice festival, ma un progetto indipendente e no profit che negli anni ha saputo crescere, aprirsi alla produzione, sostenere le nuove generazioni di artisti e creare una comunità viva attorno al dialogo tra arte contemporanea e cinema. Ne abbiamo parlato con la sua fondatrice e direttrice, Silvia Lucchesi
Dopo diciotto edizioni, quale è l’identità de Lo schermo dell’arte?
L’identità del festival si è costruita anno dopo anno ed è cambiata molto rispetto all’inizio. La prima edizione era dedicata esclusivamente ai documentari sull’arte contemporanea e aveva un programma molto ridotto. Oggi, invece, la maggior parte delle opere sono film realizzati dagli artisti stessi. Abbiamo imparato a lavorare in modo trasversale, connessi alle realtà artistiche e ai cambiamenti tecnologici e sociali che ci circondano. Gli artisti hanno una grande capacità di restituire in immagini i sentimenti e le trasformazioni del mondo contemporaneo, e il festival riflette tutto questo.
Negli ultimi anni avete anche avviato un progetto di produzione. Di cosa si tratta?
VISIO Production Fund è un progetto che ci rende molto orgogliosi. Nasce in relazione a VISIO, il programma di residenza dedicato ad artisti under 35 che lavorano con le moving images ideato e curato da Leonardo Bigazzi. Ogni anno, otto giovani selezionati con una open call arrivano a Firenze, seguono il festival, parte-
cipano a incontri e presentano i loro progetti. Tra questi, tre vengono prodotti. Attraverso il VPF, sosteniamo gli artisti proprio nella fase più delicata, quella della produzione. Non tutti sono agli inizi, alcuni hanno già avuto mostre importanti, ma il nostro supporto resta prezioso. Anche grazie a VISIO e alle co-produzioni con la Fondazione In Between Art Film, il Centro Pecci, il FRAC Bretagne e Human Company, Lo schermo dell’arte è oggi un soggetto di riferimento nel panorama internazionale delle moving images.
Lo schermo dell’arte è un progetto indipendente: come riuscite a mantenerlo sostenibile?
È un’organizzazione no profit che vive grazie a bandi pubblici, al sostegno di enti locali e di partner privati. Riceviamo risorse da Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Comune di Firenze. Tra i privati, il nostro main sponsor è Gucci. E facciamo parte della rete 50 Giorni di Cinema a Firenze, un progetto della Fondazione Sistema Toscana. Sono partner che ringraziamo per la stima che ci rivolgono che ci permette di fare il nostro lavoro mantenendo coerenza e indipendenza. Oltre al festival lavoriamo anche su altri progetti come quelli rivolti al mondo della scuola o quelli rivolti al territorio, che ci impegnano durante l’anno. Tutte le iniziative che realizziamo contribuiscono allo Schermo dell’arte, sia dal punto di vista del progetto culturale sia da quello della sostenibilità economica. Quest’ultima rimane uno degli aspetti più delicati della vita di un soggetto che come il nostro lavora nel campo culturale.
C’è un filo conduttore nell’edizione 2025?
Non c’è mai un vero e proprio tema unico. A differenza di molti festival, non abbiamo sezioni competitive o premi. Il nostro intento è quello di curare un programma che riflette ciò che avviene nel mondo dell’arte, dando voce alle nuove esperienze. Naturalmente, emergono linee forti: quest’anno, ad esempio, ci sono film che affrontano la blackness, la questione palestinese, il rapporto uomo-ambiente, l’uso delle nuove tecnologie. Ci interessa mostrare un panorama ampio e stimolare riflessione attraverso opere che riteniamo significative.
Ogni anno proponete anche un focus su un artista. Chi avete scelto questa volta?
Quest’anno il focus è dedicato a Randa Maroufi, artista marocchina che abbiamo conosciuto grazie a VISIO. Presenteremo cinque suoi film tra cui l’ultimo, L’MINA, prodotto dalla Fondazione In Between Art Film e presentato a Cannes. Maroufi lavora su temi quali identità femminile, migrazione, lavoro, utilizzando spesso il reenactment: ricostruisce in studio scene di vita reale con attori non professionisti, creando un cortocircuito tra finzione e realtà che porta lo spettatore a porsi interrogativi. È un’artista di grande talento e siamo felici di mostrare il suo lavoro.
Quest’anno ci sarà anche spazio per il VR molto importante. Come lo integrate nel festival?
Grazie a una collaborazione con l’Università di Pavia, presentiamo due opere VR realizzate da Claudia Losi e Valentina Furian. Sono due artiste italiane che stimiamo molto, e nessuna delle due aveva mai lavorato prima con la realtà virtuale. Per loro è stata una sfida affascinante. Le opere saranno visibili alla Strozzina di Palazzo Strozzi, nostro partner storico. Il festival ha sempre mostrato opere realizzate con i nuovi mezzi, dal VR all’intelligenza artificiale, che gli artisti utilizzano con grande libertà nei loro lavori.
Il festival ha anche una forte dimensione comunitaria. In che modo si manifesta?
Ogni anno, nei giorni del festival, si crea una vera e propria comunità: artisti, curatori, produttori, partner istituzionali, giovani di VISIO e naturalmente il pubblico. Gli incontri, le lecture e i momenti prima e dopo le proiezioni generano dialogo, idee e nuove collaborazioni. Non è solo una festa, ma anche un’occasione concreta di lavoro e networking. L’atmosfera è informale, senza tappeti rossi, e proprio per questo molto apprezzata dai nostri ospiti.
E guardando al futuro, quali sono le sfide principali?
Silvia Lucchesi
Il panorama culturale e produttivo è in continuo cambiamento. La sfida più grande riguarda i linguaggi: l’intelligenza artificiale, ad esempio, è destinata a diventare uno strumento sempre più presente nelle mani degli artisti. Non sappiamo ancora come evolverà, ma certamente segnerà nuove possibilità espressive. Il compito del festival sarà quello di accompagnare e valorizzare queste nuove esperienze.

Pisciare sulla metropoli: l’Estetica della (Re)Esistenza, tra Trap, Islam e i Nuovi Barbari Urbani è il saggio edito da MachinaLibro che decostruisce il panico morale sul “maranza”, figura emblematica della gioventù italiana con background migratorio. L’autore, Tommaso Sarti, analizza come la musica Trap e un Islam giovanile e ibrido siano gli strumenti scelti da questa generazione per urlare la propria (re)esistenza e rivendicare uno spazio in città sempre più inospitali. Ne parliamo con lui.
Il titolo è folgorante: Pisciare sulla metropoli. Che immagine di città e di gioventù mette in campo?
Mette in campo contesti abitativi (città, ma anche periferie e province) sempre più inospitali e sottoposti a pervasivi processi di marginalizzazione, razzializzazione e criminalizzazione. Città violente in cui il disagio, la richiesta di cambiamento e le aspirazioni delle nuove generazioni sono prevalentemente, se non esclusivamente, affidate alla mano repressiva dello Stato. Attraverso i classici processi di panico morale che intenzionalmente tendono a ridurre a questione morale qualsiasi forma di malcontento e di conflittualità, si sono costruiti dei “nuovi diavoli popolari” che hanno preso il nome di “maranza”, incarnando la figura che più di tutte mette in luce le criticità del sistema Italia, ossia i e le giovani con background migratori italiani che bussano alla porta del Paese per urlare la loro (r)esistenza e la loro voglia di riscatto. Sono quei e quelle giovani che ci ostiniamo a chiamare “seconde generazioni” e che sono stanchi di essere considerate solamente nelle dicotomie di utili o pericolosi. Hanno deciso di iniziare a raccontarsi e di costruire delle comunità resistenti a partire dagli strumenti a loro disposizione: alcuni hanno scelto la musica, altri la religione, altri ancora l’attivismo, ma tutti e tutte sono accomunati dalla volontà di provare e cambiare radicalmente il posto in cui vivono.
Il libro nasce da un’etnografia lunga anni tra periferie milanesi, provincia veronese e ambienti online. Com’è riuscito a costruire fiducia e prossimità con un gruppo volutamente eterogeneo?
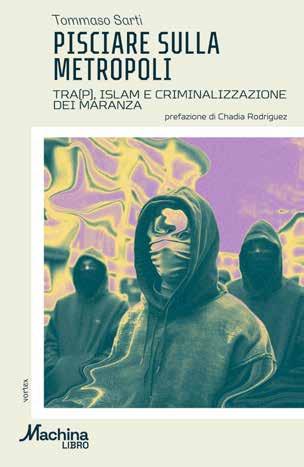
Pisciare sulla metropoli. Trap, islam e criminalizzazione dei maranza di Tommaso Sarti MachinaLibro, 2025 pag. 160, € 16
alle loro storie fino ad arrivare a passioni e interessi comuni. Da un punto di vista sociologico la scelta di rompere con quella “giusta distanza” tra ricercatore e protagonisti della ricerca, decidendo di entrare nel loro mondo per sporcarmi le mani e non per essere osservatore neutrale, e la scelta d’intervistare lasciando il maggior spazio possibile di esposizione e ragionamento ha completato l’opera. Punto di partenza e condizione essenziale di questo lavoro di ricerca era quello di non voler dare voce perché, proprio per il posizionamento di cui sopra, sono convinto che questi e queste giovani non hanno bisogno di qualcuno che li racconti, quanto piuttosto che qualcuno li ascolti. Consapevole del mio privilegio e della mia posizione ho scelto di sfruttarle per offrire un modesto contributo come alleato e come megafono per ragazzi e ragazze che, avendo trovato un ulteriore spazio di espressione, hanno potuto decostruire e rielaborare quelle stesse etichette, come “criminale” o “fondamentalista”, attraverso le quali vengono descritti e rappresentate da “esperti” che non hanno mai avuto intenzione di parlare con loro.
La fiducia è venuta a crearsi nel tempo e con intensità diversa a seconda dei contesti, il rapporto più stretto è quello che si è venuto a creare con i ragazzi della provincia di Verona, che vedevo tutti i giorni, perché sono amico dei fratelli o amici più grandi. Con gli altri e le altre la fiducia è venuta a crearsi conoscendoci, capendo il mio posizionamento, il perché mi stessi interessando
L'AUTORE
Tommaso Sarti è dottorando in Scienze Sociali presso il dipartimento FISPPA dell’Università di Padova con un progetto sull’autorappresentazione dei giovani musulmani in Italia e sulla loro relazione con la cultura di strada e la musica (t)rap. Ha scritto vari contributi per MUN Magazine, Studi sulla Questione Criminale, Antigone e Machina
Lei legge la (t)rap come “lingua delle migrazioni” capace di ibridare mistilinguismo, fede e vissuti di strada. Dal caso Baby Gang a San Siro alle strofe che mescolano italiano, arabo e francese: cosa ci dicono questi materiali sulla repressione, ma anche sulla possibilità di costruire appartenenze e visibilità oltre gli stereotipi?
È quello che ha sempre fatto il rap, essere strumento d’espressione di quelle masse razzializzate e criminalizzate da parte di un potere bianco e reazionario. Lo ha fatto negli Stati Uniti e in Francia e lo sta facendo ora in Italia, racconta quotidianità violente accomunate da sistemi economico sociali razzisti. L’Italia ha dovuto aspettare la (t)rap perché la linea del colore diventasse un elemento centrale all’interno della scena e questo è dovuto, precursori a parte, proprio a quella nuova generazione che è cresciuta musicalmente con questo genere. Accantonando facili generalizzazioni, attraverso le tracce viene messa in scena e raccontata la vita, spesso brutale, dei nostri e delle nostre giovani, vengono raccontati i sa-
ONTOLOGIA E POLITICA DEL “MOSTRARE” NEL DISPOSITIVO ESPOSITIVO
Mostra come dispositivo. Prospettive di ricerca sull’esperienza espositiva curato da Alessandro Ferraro, non è una mera antologia sulla storia espositiva, ma un’indagine rigorosa che si inserisce nel fervido dibattito critico che da un decennio analizza la mostra come medium artistico de facto. L’assunto è chiaro e affascinante: il curatore non è un mero selezionatore di oggetti, ma un “progettista di legami” la cui soggettività si riflette nel display. La prima sezione, dedicata alla mostra-opera, offre saggi di estremo interesse, come l’approfondimento di Vincenzo Di Rosa sulla complessa Monte di Pietà di Christoph Büchel a Venezia (2024). Il volume, infine, spinge il lettore oltre le opposizioni canoniche: Giorgia Rizzioli supera la dialettica tra black box e white cube per investigare il cinema nello spazio urbano in prospettiva post-mediale, mentre la riflessione sulle pratiche relazionali e il concetto di “laboratorio portatile” dell’artista Elena Mazzi chiude la ricognizione sulle possibilità del fare artistico.
Mostra come dispositivo. Prospettive di ricerca sull’esperienza espositiva a cura di Alessandro Ferraro Postmedia books, 2025 pag. 128, € 16,90
C’è un’Italia che si ricompone in un colpo d’occhio: Roma dopoguerra, Piazza del Popolo, l’Osteria dei Menghi, poi set, studi, redazioni. Incontri impossibili. Artisti e intellettuali italiani 1954–1968 restituisce Paolo Di Paolo (in mostra al Palazzo Ducale di Genova fino al 6 aprile) come autore “dilettante” nel senso più alto, chi fa per diletto e, proprio per questo, con responsabilità estetica, e come ritrattista che trasforma l’incontro in un patto tra sguardi. Il volume curato da Silvia Di Paolo è un libro-narrazione prima ancora che un catalogo: la biografia luminosa e tardivamente riconosciuta si intreccia con la storia visiva del Paese. Il filo conduttore è il ritratto come “psicologia applicata”: Moravia e Cardinale, de Chirico e Lollobrigida, Pasolini, Ungaretti, Accardi. La sezione degli “Incontri impossibili” fa esplodere l’ironia montaggistica di un’Italia che, in quegli anni, metteva in cortocircuito cinema, letteratura, arte, costume. Ma il libro vale anche per come ragiona sulla fotografia. Di Paolo confessa la propria “filosofia dietro all’immagine”: dallo scarto di Pannunzio (“troppo bella” una foto di Pasolini) al richiamo kantiano di una forma che non illustra ma pensa, passando per la kalokagathía che mischia bello e buono in un’emozione necessaria.
Paolo Di Paolo. Incontri impossibili. Artisti e intellettuali italiani 1954-1968 a cura di Silvia Di Paolo Electa, 2025 pag. 304, € 39
crifici e i sogni, vengono raccontati i conflitti e i modi per sopravvivere in strada e alla strada, vengono rappresentate le violenze istituzionali, violenze che accomunano i/le giovani di diversi contesti territoriali. Attraverso questo genere i/le giovani con background migratori stanno trovando qualcosa che gli permette di non sentirsi più isolati, una lingua comune come l’arabo li unisce a livello transnazionale e un Islam plurale e giovanile li riavvicina a quella fede da cui, per le condizioni e le scelte di vita, pensavano di doversi allontanare.
Nel libro emergono gesti concreti di “Islam di strada”: che idea di Islam giovanile italiano ne esce? Ovviamente ci tengo a specificare che non voglio generalizzare, il libro non ha
CARLO MOLLINO: ANATOMIA DI UN FANTASMA MODERNO
Più che una monografia, questo Rizzoli curato da Paola e Rossella Colombari è un romanzo d’avventura documentato: dalla telefonata che nel 1980 le porta a un “mobile clavicembalo” alla scoperta del deposito Lattes, fino alle prime consacrazioni internazionali e d’asta. Il volume orchestra capitoli tematici alternando racconto famigliare, saggistica e apparati iconografici in gran parte dal Fondo Mollino del Politecnico di Torino; un saggio di Mario Cucinella reinscrive l’autore nel panorama globale. Ne esce un Mollino “totale”, dove ogni pratica alimenta l’altra. Anche il design, qui, è teatro di desideri: l’“arabesco” in legno curvato, il tavolo-dinosauro e le scenografie d’interno dove capitelli, specchi e tende compongono una grammatica surreal-popolare. L’accuratezza del volume mette in risalto anche l’influenza cruciale della fotografia, definita espressione fondamentale del suo mondo onirico e surreale. La sua camera oscura non fu solo documentazione, ma strumento di indagine cognitiva, attraverso cui Mollino sperimentò con la sensualità e il volto femminile, culminando nei ritratti erotici della sua garçonnière.
Carlo Mollino. Architetto, designer, fotografo Paola e Rossella Colombari Rizzoli, 2025 pag. 224, € 75
l’intenzione di fare una mappatura di cosa sia o cosa non sia Islam. Questa è la loro interpretazione, è soggettiva ed è valida proprio per questo. Sappiamo che parlare di Islam al singolare è sbagliato. Detto questo quello che emerge dalla ricerca è la volontà da parte dei/ lle giovani musulmani di essere considerati come soggetti politici legittimi e visibili senza per questo dover rinunciare alle proprie caratteristiche. Emerge un Islam plurale e non respingente verso quelle soggettività che fuoriescono dai dettami e dall’ortoprassi musulmana. Emerge un Islam che viene scelto perché c’è uno studio alla base, un Islam che libera e che costruisce comunità, un’Islam critico e aperto all’interpretazione, un Islam che si oppone all’oscurantismo e all’assoggettamento occidentale così come alle inter-
pretazioni reazionarie e culturaliste delle vecchie generazioni. Emergono musulmani e musulmane che stanno costruendo l’Islam italiano. Penso che istituzioni e media hanno avuto trent’anni per imparare a non schiacciare l’Islam tra folklore e allarme sicurezza disinteressandosene completamente e ancora adesso non mostrano alcun interesse a riguardo. Non credo molto nel cambiamento per concessione di chi comanda, così come non posso fare previsioni, credo però che ci sia rabbia tra i/le giovani e che non ci sia più voglia d’insegnare qualcosa a qualcuno che per di più non ha alcuna volontà ad ascoltare e imparare.
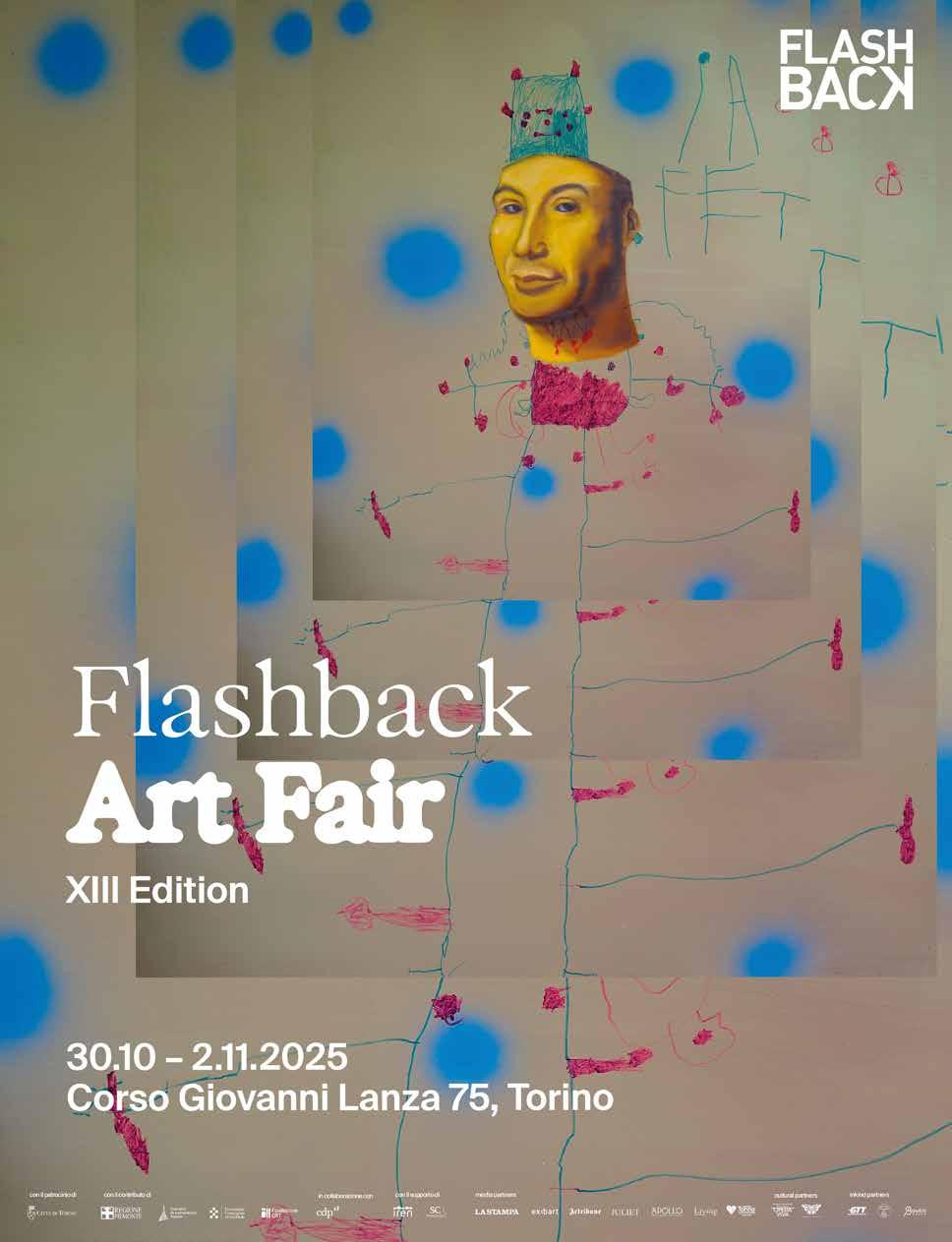


Un artista francese ha trasformato la facciata di Christie’s a Parigi in un’opera d’arte
VALENTINA MUZI L A Parigi, al numero 9 della lussuosissima Avenue Matignon, dal 2011 Christie’s abita gli spazi dell’edificio progettato dall’architetto René Sergent nel primo Novecento. In occasione di Art Basel Paris 2025, la parte esterna dello storico palazzo francese si trasforma con Le Fil Rouge, l’intervento site specific di Stéphane Thidet (Parigi, 1974) che ricopre l’intera facciata con grandi nastri rossi, ripercorrendo la storia dell’edificio (visibile sino all’11 gennaio).

Nasce una nuova casa editrice culturale in Italia: “Pubblicheremo cose inventive e preziose”
Vista dell'installazione
Le Fil Rouge di Stéphane Thidet. Per gentile concessione dell'artista e della Galerie Aline Vidal. Foto
Jean-Philippe Humbert. Per gentile concessione di Christie's
IL MINISTERO DELLA CULTURA INVESTE OLTRE 200 MILIONI DI EURO SULLA VALORIZZAZIONE ARTISTICA IN ITALIA E ALL’ESTERO.
Negli ultimi giorni il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha firmato due decreti complementari, volti l’uno a rigenerare il patrimonio nazionale, l’altro a promuovere la cultura e l’arte italiana nel mondo. A questi si aggiungono 15 milioni per 5 “grandi progetti” tra Puglia, Veneto Toscana, Lazio ed Emilia Romagna: eccoli.
GIULIA GIAUME L Ruoli di responsabilità e dirigenza in Electa, Einaudi, Mondadori, Allemandi, Skira, Rizzoli e in istituzioni pubbliche e private: è il pedrigree nell’editoria e nella cultura italiane di Stefano Piantini e Fabio Achilli, che ora fondano la propria casa editrice, Cluster-A. Una nuova realtà che si presenta come “singolare, inventiva, immaginosa” e che punta a lavorare al recupero di opere dimenticate o fuori commercio, oltre che all’esplorazione di nuove proposte narrative e saggistiche. Tre le collane: c’è Satori, riferita all’esperienza del risveglio nella pratica buddista, che ospita titoli di narrativa, poesia e varia; poi, Prisma, che allude all’effetto di scomposizione sotteso a una visione sfaccettata, e che riunisce libri di saggistica (critica, filosofica, storica, biografica); e infine Retina, che raccoglie libri illustrati, edizioni facsimile e limited.
NECROLOGY
FREDIANO FARSETTI (1934 – 21 OTTOBRE 2025)
L DANIELA PALAZZOLI (1940 – 13 OTTOBRE 2025)
L DIANE KEATON (5 GENNAIO 1946 - 11 OTTOBRE 2025)
L FABIO CIRIFINO (1949 – 4 OTTOBRE 2025)
L JANE GOODALL (3 APRILE 1934 - 1 OTTOBRE 2025)
L TAKAKO SAITO (1929 – 30 SETTEMBRE 2025)
L CLOTI RICCIARDI (1939 – 26 SETTEMBRE 2025)
L CLAUDIA CARDINALE (15 APRILE 1938 - 23 SETTEMBRE 2025)
L ROBERT REDFORD (18 AGOSTO 1936 - 16 SETTEMBRE 2025)
A Parigi nacque l’amore
tra Christo e Jeanne-Claude: ora la città dedica loro una piazza sotto il loro ponte impacchettato
CLAUDIA GIRAUD L Christo e Jeanne-Claude hanno una piazza a loro dedicata a Parigi. La città dove i due artisti si sono conosciuti e innamorati (quasi 70 anni fa) ha deciso di celebrare con questo riconoscimento il 40esimo anniversario della loro opera più importante, The Pont Neuf Wrapped. L’inaugurazione della storica piazza – che circonda la statua di Enrico IV sul Pont Neuf ed è ora ribattezzata
Place du Pont Neuf - Christo e Jeanne-Claude – è accompagnata da un ambizioso progetto di rivisitazione del Pont Neuf che sarà realizzato dall’artista parigino JR nel 2026.
LIVIA MONTAGNOLI 1 2 3 4 5
A Otranto arriveranno quasi 2 milioni di euro per riqualificare gli spazi pubblici del centro storico
A Badia Polesine (Rovigo) oltre 1 milione di euro per la valorizzazione e il restauro del Museo Civico Baruffaldi
A Firenze 3 milioni di euro finanzieranno il GalileoLab, uno spazio per i cittadini, le scuole e i visitatori in cui sarà raccontato e valorizzato il contributo di Firenze e della Toscana alla storia della scienza, tramite mostre, attività dimostrative e iniziative educative
A Sasso Marconi, in provincia di Bologna, 3 milioni di euro saranno utilizzati per il restauro del Mausoleo Marconi e Villa Griffone
A Roma la nascente Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte a Palazzo San Felice riceverà 6 milioni e mezzo di euro per la conservazione e la fruizione del patrimonio bibliografico
Christo and JeanneClaude, The Pont Neuf Wrapped, Paris, 197585, Photo Wolfgang Volz © 1985 Christo and JeanneClaude Foundation
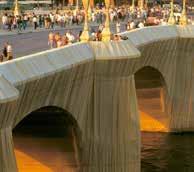
Il Museo Picasso di Parigi si espande ancora.
Entro il 2030 nuovo spazio per mostre e un parco di sculture
LIVIA MONTAGNOLI L Sono passati 40 anni dall’inaugurazione del Musée Picasso di Parigi, che apriva le porte il 28 settembre del 1985 nel cuore del Marais, negli spazi dello storico Palazzo Salé. Dopo l’inaugurazione del Centro di ricerca, destinato a studiosi e artisti in residenza, e in concomitanza con le celebrazioni per il suo 40esimo compleanno, il museo annuncia un’ulteriore e ambiziosa espansione che costerà oltre 50 milioni di euro. Picasso 2030 è l’etichetta del progetto che sarà completato, per l’appunto, entro il 2030, quando inaugurerà una nuova ala per le esposizioni temporanee (che dispongono attualmente di 400 metri quadri: ne avranno 800). Il progetto prevede, inoltre, l’allestimento di un parco liberamente accessibile al pubblico, che collegherà il giardino del museo con l’adiacente piazza Leonor Fini.









MATEJA PETKOVIC: AMPLESSI, AMPLESSI
FERRUCCIO GIROMINI
Curiosa nota preliminare di stampo linguistico: il nome slavo di persona Mateja, corrispondente al nostro Mattia, può essere sia maschile sia femminile; è prevalentemente maschile in Serbia, invece più spesso femminile in Croazia e Slovenia. Mateja Petkovic, argomento odierno della nostra conversazione, va inteso al maschile: nato a Belgrado, vi ha studiato anche Arti Applicate, ma dal 2012 vive in Germania, a Monaco, dove lavora soprattutto come sviluppatore di videogames. Intanto si diletta pure di pittura: anzitutto numerosi ritratti, molto ricercati e apprezzati, e a latere molte opere prettamente erotiche. Ma attenzione: la sua lunga esperienza con il digitale lo ha portato presto a intervenire sensibilmente (e per fortuna con speciale sensibilità) sulla sua tecnica pittorica tradizionale, nata e cresciuta con gli oli e gli acrilici sulla tela. La sua pittura digitale sta dunque sospesa tra qui e là, con buona pace degli apocalittici e forse persino degli integrati. In particolare, è stato il suo incandescente libro per adulti Milk for my coconut (Editions Caurette), torrida raccolta di dipinti spesso molto espliciti, a far conoscere meglio nel mondo la sua attività di “pittore del sesso”. La definizione non è peregrina. Petkovic ama ritrarre con ricorrente ed evidente diletto corpi nudi, colti nel bel mezzo di azioni erotiche o autoerotiche; ed esegue la sua opera con effetti che si impongono indubbiamente raffinati (nonostante la pericolosa materia trattata) e a lor modo spettacolari. Corpi in amore, sempre. La fascinazione anatomica. L’inclinazione passionale. Il gusto libero della trasgressione. E una vasta e profonda cultura pittorica (con evidenti echi di Lucian Freud e Jenny Saville, per citare solo i riferimenti più moderni e contemporanei – ma c’è molto altro, a voler andare indietro nel tempo). Le sue immagini catturano per eleganza compositiva, luministica, tecnica in generale, capacità di coinvolgimento emotivo. Gli amplessi che Petkovic riprende in scena e ci offre in visione riescono a essere duri e teneri allo stesso tempo, spudorati quanto innocenti. E, ciliegina sulla torta, a volte neppure manca la classica sigaretta del dopo…
→ Nel rione Prati di Roma è nato un nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea. Reception Rome è fondato e gestito dagli artisti Jean Jacques du Plessis e Ilaria Ortensi. A inaugurarlo un progetto con protagonista l’artista americano Jesus Benavente.
→ A Torino durante la settimana dell’arte apre un nuovo spazio espositivo. Una piattaforma editoriale diventa galleria. La nuova realtà, nata per volontà della piattaforma editoriale Chiaromonte, intende porsi come una riflessione sulla relazione tra oggetti quotidiani, spazio e percezione emotiva.

→ Novità in Umbria. A Narni c’è uno spazio espositivo nei sotterranei di Palazzo dei Priori. Si chiama Spin-OFF ed è il nuovo progetto di THEPÒSITO Art Space che sceglie di promuovere tutto ciò che rimane ai margini, tra linguaggi ibridi, visioni anomale e tempi obliqui.
→ In Toscana nasce un nuovo polo culturale e aggregatore sociale: mostre, libreria, ristorazione e formazione a Castelfiorentino. Aperto in una prima veste l’anno scorso, CAMBIO inaugura ora gli ultimi spazi a completamento del progetto, tra sale espositive per mostre di fotografia e architettura, libreria e numerosi spazi dedicati ad attività culturali e formative.
→ A Roma in un’ex pasticceria del Pigneto nasce un nuovo spazio per l’arte . Si chiama Prosa contemporanea e punterà su una ricerca contemporanea che unisce arte e design. A dirigerlo è Alberto Dambruoso.
→ In un’ex caserma in Abruzzo nasce uno spazio dedicato alle ceramiche d’artista. Ad aggiungersi alla vasta rete di iniziative targate Fondazione No Man’s Land, questo spazio a Loreto Aprutino, fuori Pescara, vuole essere un luogo “che intreccia la pratica artistica, la formazione e la sperimentazione collettiva”
→ A Milano, in Porta Venezia, inaugura il nuovo avamposto della Galleria Alessandro Albanese in collaborazione con Julius Clinic, storica clinica milanese. Oltre alle mostre, lo spazio ospiterà anche laboratori artistici rivolti ai pazienti
→ La galleria Amanita dopo New York apre in un palazzo storico di Roma. Situata al piano terra di Palazzo dei Pupazzi (conosciuto anche come Palazzo Crivelli), al civico 24 di Via dei Banchi Vecchi, la galleria trova sede in uno degli edifici rinascimentali più affascinanti della città
Nelle Marche la città di Camerino riapre il suo Museo Diocesano nove anni dopo il terremoto
@milkformycoconut
LIVIA MONTAGNOLI L L’Arcidiocesi completa la prima importante restituzione di un edificio pubblico nella zona rossa, riaprendo il Palazzo Arcivescovile e il Museo Diocesano ospitato al suo interno dal 1965. Un incoraggiamento a credere nella rinascita, tanto più che a Camerino, come in altri centri delle Marche colpiti gravemente dal sisma del 2016, i cantieri hanno recentemente – e finalmente – iniziato a moltiplicarsi. La riapertura del Palazzo Arcivescovile e del Museo Diocesano -già una prima volta fermato dal sisma del 1997 e rinato nel 2004 – rappresenta, dunque, non solo il recupero di un edificio, ma il ritorno di un simbolo della storia e della memoria collettiva di Camerino, che soprattutto tra Trecento e Quattrocento ha conosciuto una grande fortuna commerciale e stabilità sociale, con una fioritura di committenze pubbliche e la nascita di una “scuola” artistica locale. Il nuovo allestimento è una riscrittura del percorso di visita, pensato in senso tipologico per accompagnare il visitatore in un viaggio attraverso le diverse forme artistiche. Si parte dai dipinti su tavola, dagli affreschi e dagli stendardi processionali, per proseguire con le grandi tele, le oreficerie e i paramenti sacri. Interessante e di grande qualità artistica per i pezzi esposti è l’incursione nella scultura lignea che ben rappresenta la fioritura dell’arte rinascimentale camerte.
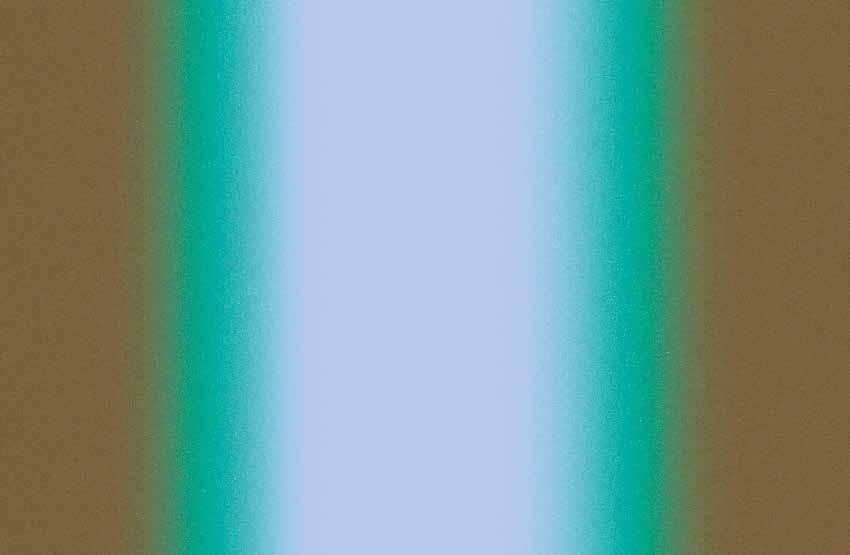

AGenova, tra Piazza del Campo e Via del Campo, un’ex macelleria è diventata un luogo di sperimentazione artistica e sociale. Si Chiama Campo XS e con i suoi appena trentatré metri quadrati è oggi uno degli spazi più interessanti della scena contemporanea genovese (e non solo). Fondato nel 2023 da Carina Negrone – imprenditrice attiva nel campo della comunicazione e della moda e amministratrice dell’impresa sociale La Posta Nuova – Campo XS nasce dal desiderio di coniugare ricerca artistica, rigenerazione urbana e inclusione sociale. Ristrutturato dallo Studio Sirotti di Genova con un intervento che ne valorizza la struttura originaria, dal ceppo in legno alle piastrelle e ai ganci metallici della vecchia bottega, lo spazio si presenta come un white cube accessibile ai più, parte integrante del paesaggio urbano e del tessuto multiculturale che lo accoglie.
La principale declinazione di Campo XS è Campo Aperto, progetto biennale sostenuto in primis da Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Carige e Fondazione Friends of Genova, che lega il mondo dell’arte contemporanea a quello del terzo settore. La programmazione si costruisce attraverso una call aperta ad artisti e curatori ed esplora tematiche sociali, psicologiche e antropologiche attraverso pratiche site-specific. Parallelamente, la collaborazione con l’Associazione Consulta Diocesana per i Minori e le Famiglie permette di coinvolgere persone, in particolare minori o neomaggiorenni, in situazioni di fragilità nei processi organizzativi e negli allestimenti per lo sviluppo di nuove competenze lavorative, trasformando lo spazio in occasione di inclusione e partecipazione. “La call è rivolta sia ad artisti che a curatori. Gli artisti possono anche partecipare in autonomia, ma in quel caso devono autocurarsi. È successo, per esempio, con Maurizio Segato, che ha inaugurato il primo ciclo di Campo Aperto con La Tana nell’ottobre 2024, e ha curato personalmente il proprio progetto. In generale, però, prediligiamo la combinazione curatore-artista. È anche possibile che vengano selezionati dei collettivi: quest’anno, ad esempio, ci saranno Kvas e Brosio, curati da Viola Cenacchi. L’obiettivo è lasciare la massima libertà possibile sia nel dialogo tra curatore e artista, sia nella partecipazione di più artisti, purché ci sia coerenza e un filo conduttore che dia senso al progetto nello spazio. Non diamo temi prestabiliti: chiediamo solo che ci sia specificità”, racconta Carina Negrone ad Artribune.
L’obiettivo è lasciare la massima libertà possibile sia nel dialogo
tra curatore e artista, sia nella partecipazione di più artisti, purché ci sia coerenza e un filo conduttore che dia senso al progetto nello spazio
IL COMITATO SCIENTIFICO DI CAMPO XS
Il comitato scientifico, composto per la prima edizione da Pinksummer Contemporary Art, Studio Sirotti, il collettivo curatoriale Mixta, la curatrice indipendente Anna Daneri e il produttore culturale Carlo Antonelli, nella selezione di Campo Aperto ha coinvolto artisti nazionali e stranieri, orientandosi sull’autenticità dei progetti in relazione allo spazio, all’originalità della proposta e alla fattibilità della stessa, senza limiti di età o medium. Altri criteri fondamentali sono la realizzabilità del progetto e la rilevanza del tema trattato: “Il comitato seleziona cinque progetti, poi ci si confronta collettivamente per la scelta finale. Forniamo un budget che copre i costi vivi della mostra: produzione, trasporti, allestimento e tutto ciò che serve per rendere possibile il progetto”. Tuttavia, Campo XS, lo spazio fisico, ospita anche eventi autonomi rispetto a Campo Aperto, tra cui (negli anni) le mostre di Nuvola Ravera e Marko Tardito e Michele L. Mulas, oppure Trevisani, e Thyself Agency di Luca De Leva in collaborazione con Pinksummer. Poiché Campo Aperto si svolge da ottobre ad agosto, nei periodi di intervallo viene invitato un artista a intervenire nello spazio. A settembre 2025, per esempio, è stata ospitata la mostra From Blue to Bytes di Mulas e Tardito. “Capisco che il nome possa creare confusione”, interviene Negrone. “Campo XS è lo spazio, mentre Campo Aperto è il progetto sociale e artistico, finanziato da Compagnia di San Paolo, Fondazione Friends of Genova e Fondazione Carige. Gli altri eventi che avvengono nello spazio sono invece autoprodotti o autofinanziati. Per il nome dello spazio abbiamo preso spunto sia dalle dimensioni che dall’ubicazione in piazza del Campo, mentre per il progetto Campo Aperto ci siamo ispirati alla possibilità di aprire a curatori indipendenti, ad artisti giovani e non, conosciuti e non, nazionali, internazionali o locali”.
La progettazione sociale di Campo XS e lo sviluppo di workshop volti a sviluppare nuove esperienze di proto-lavoro per i partecipanti sono costruiti insieme a Consulta Diocesana per le attività a dei Minori e delle Famiglie, coinvolgendo le persone che vivono negli alloggi della Consulta. Giovani come Asia e Michael, ma anche Tania, una donna adulta, che collabora al progetto perché abita vicino allo spazio e ha bisogno di un impiego compatibile con la gestione familiare. Tutte le persone coinvolte vengono accompagnate da Michela Davi, in costante contatto con Carina e con gli educatori. “Con lei ci confrontiamo su tempistiche, paghe e modalità di inserimento. Il pro-



Maurizio Segato, La Tana (courtesy of Silvia Mazzella)
getto sociale mira a generare un impatto positivo sulle persone e sulla comunità creando nuove competenze e accompagnando i destinatari dei workshop in un percorso volto al recupero di autonomia, quello artistico un impatto positivo sugli artisti e sulla qualità della programmazione”. Ad accompagnare Carina nella curatela in-site, gestione e organizzazione di Campo XS c’è Martina Montagna, giovane curatrice, che lavora sul progetto occupandosi di comunicazione, curatela e gestione quotidiana, in collaborazione con Riccardo Sirotti per gli allestimenti e con Annalisa Gatto per la parte grafica. “Martina è una figura fondamentale: io vivo tra Bologna e Genova, quindi cercavo la collaborazione di una persona in loco. L’ho conosciuta come curatrice di uno dei progetti selezionati nel primo anno e da lì è nata una forte sintonia, è il mio braccio destro. Mentre la gestione amministrativa del progetto è portata avanti dalla Posta Nuova issrl, con la consulenza di Giovanni Lombardo per quanto riguarda la misurazione dell’impatto sociale dell’attività”.
E come si rapporta Campo XS nei confronti degli altri spazi dedicati alla ricerca contemporanea di Genova? “C’è un dialogo abbastanza costante. Con Florida, che è proprio vicino a noi, ci scambiamo pareri, visitiamo reciprocamente le mostre ed è anche successo che organizzassimo una talk nel loro spazio, dato che Campo XS è molto piccolo. Loro c’erano già quando siamo arrivati, e
A Genova negli ultimi cinque anni è nata una rete di spazi indipendenti che dialogano tra loro, creando un percorso diffuso di arte contemporanea fuori dai circuiti istituzionali
ci siamo conosciuti durante i primi sopralluoghi. Condividiamo una visione comune e un approccio sperimentale. Palazzo Bronzo, invece, è stato coinvolto direttamente tramite la prima call di Campo Aperto per il progetto di Death of Master, oltre ad avere collaborato con noi per aspetti di allestimento o documentazione. In generale, a Genova negli ultimi cinque anni è nata una rete di spazi indipendenti che dialogano tra loro, creando un percorso diffuso di arte contemporanea fuori dai circuiti istituzionali. È importante, perché la città non ha molti spazi dedicati alla sperimentazione culturale e quelli che esistono stanno diventando dei punti di riferimento”.
Fondamentale nella crescita di Campo XS, aggiunge Negrone, la consulenza di Francesca Pennone e Antonella Berruti di Pinksummer Contemporary Art, della curatrice Anna Daneri e del comitato scientifico, che fin dall’inizio ha caratterizzato l’approccio sperimentale dello spazio, a cui dal 2026 si aggiungerà probabilmente anche Stefano Pirovano di Conceptual Fine Arts.
CHI SOSTIENE CAMPO XS
C’è qualcosa che vorresti aggiungere? “Sì, mi piacerebbe che venissero citate le fondazioni e i soggetti che hanno sostenuto il progetto, perché senza di loro non sarebbe stato possibile.
Oltre alla Compagnia di San Paolo (nostro maggiore sostenitore) e alla Fondazione Friends of Genova che lo sostengono stabilmente, abbiamo il supporto di Fondazione Carige e della Clinica Montallegro. Finanziatori

privati possono partecipare sostenendo singole voci di specifiche mostre, come è successo con Quarta Immobiliare per Made in Italy di Drifters. La loro partecipazione e il loro entusiasmo mi danno personalmente molta speranza, soprattutto in quanto non appartenenti al sistema dell’arte. Tra i patrocini abbiamo quello non oneroso del Comune di Genova e della Fondazione Italia Patria della Bellezza, mentre tra i partner esteri Galerie Neu di Berlino, MARS –Maternal Artistic Research Studio di Friburgo, un collettivo di artiste donne che sostengono progetti artistici durante la maternità e Werkraum Warteck di Basilea. Da parte di questi è previsto che divulghino le future call fra gli artisti a loro collegati e di loro conoscenza, in modo da garantire l’ampia partecipazione di progetti internazionali. Per noi il mix geografico è importante, e stiamo lavorando per costruire altri partenariati in UK e in altri Paesi. La prossima call per il biennio 2026/2028 sarà aperta dal 1° maggio al 30 giugno 2026. Attendiamo progetti!”.
→ La Tana, di Maurizio Segato (3.10.2024 – 3.12.2024)
→ From Mouth to Ear, Body to Body, Hand to Hand, di Rebeca Pak, a cura di Livia Milani (12.12.2024 –22.02.2025)
→ Discorso in forma di paesaggio del collettivo Death of Master, a cura di Federica Balletto e Martina Montagna (6.03.2025 – 11.05.2025)
→ Made in Italy del collettivo Drifters (22.05.2025 – 27.07.2025)
→ Tik Tok Chakra, Vlog di uno sciamano tech di Rai Montoro, a cura di Laura Rositani (2.10.2025 – 30.11.2025)
→ Where is everybody di Stefania Galegati, a cura di Angelo Leonardo (11.12.2025 – 1.03.2026)
→ Filibloom Splat di Ermanno Brosio e Andrea Kvas, a cura di Viola Cenacchi (12.03.2026 – 17.05.2026)
→ Tales of Female Beasts di Hannah Kindler, a cura di Hanna Weber (29.05.2026 – 26.07.2026)
#47 Almanac Torino
#51 Sonnestube Lugano
#53 Numero Cromatico Roma
#57 Metodo Milano
#59 Spazio in Situ Roma
#62 Spazio Bidet Milano
#64 Mucho Mas Torino
#67 La portineria Firenze
#69 Spazio Y Roma
#71 spazioSERRA Milano
#73 Spaziomensa Roma
#78 Viaraffineria Roma/Catania
#81 Panorama Venezia
#84 Settantaventidue Milano
“LA TRASFORMAZIONE DEGLI EDIFICI È UN TERRITORIO DI LIBERTÀ”.
Intervista a Umberto Napolitano, l’architetto che sta rinnovando il MAXXI di Roma
VALENTINA SILVESTRINI L Impegnato in Italia, a Siena, nella riqualificazione del Complesso Museale Santa Maria della Scala, lo studio italo–francese LAN (Local Architecture Network) è capofila del team di progettazione che nel 2022 ha vinto il concorso del cosiddetto Grande MAXXI. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio, il MAXXI Hub, e di un parco urbano nel quartiere Flaminio. Contestualmente all’avvio della gara per l’affidamento dei lavori e per la loro realizzazione (gestita dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un primo lotto da 14 milioni di euro nell’ambito di un piano da 25 milioni complessivi), l’architetto Umberto Napolitano (cofondatore LAN) ha illustrato le peculiarità dell’intervento e le ricadute attese per l’intero quadrante cittadino ad Artribune. “Fin dai primi disegni, che sono veramente belli, il progetto di Zaha Hadid tenta di mettere in tensione Via Guido Reni e Via Masaccio, che sono due strade parallele, con il ponte e con il Tevere; tramite l’edificio cerca di qualificare e definire lo spazio pubblico, in modo che si crei un grande percorso capace di attraversare il quartiere fino a portarlo al di là del fiume. Questa logica in cui il pieno configura il vuoto e l’edificio si mette al servizio della città è qualcosa a cui sentiamo fortemente di appartenere come progettisti: la nostra risposta è andata totalmente in questo senso” spiega il progettista, dettagliando perché con il MAXXI Hub+Green l’istituzione culturale capitolina si proietta verso nuovi traguardi. “Usiamo l’edificio come podium, invitiamo la gente sul tetto e lì completiamo l’offerta degli spazi aperti pubblici. Ci saranno quindi una scala e due ascensori esterni che attraversano l’edificio ma non si fermano nei vari piani, perché arrivano nello spazio all’aperto che sarà anche un vero giardino (…). È come se portassimo il resto di Roma nel MAXXI”.

UN COLOSSO DELLA FARMACEUTICA IN CAMPO PER IL FUTURO DI PARMA

A novant’anni dalla sua fondazione, a Parma il Gruppo Chiesi ha avviato un ambizioso intervento di rigenerazione urbana nel dismesso stabilimento produttivo di Via Palermo, nel quartiere San Leonardo. Entro il 2028, è attesa l’apertura di un hub multifunzione senza precedenti per la città emiliana: il Chiesi Gardens. L’iter è iniziato nel biennio 2017/18, con un processo bottom up; quindi una rosa di studi di architettura di base in Europa ha partecipato alla consultazione promossa dall’azienda. La proposta progettuale dello studio 51N4E e del collettivo di architettura e ricerca TEN è emersa come la più convincente e affine al sistema valoriale del Gruppo Chiesi e il cantiere è ai nastri di partenza (VS)
COSA STA FACENDO LA DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA DEL MIC PER LA RIGENERAZIONE URBANA?
La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ha annunciato i 21 progetti vincitori della 7ª edizione del Laboratorio di Creatività Contemporanea (2025-2027), l’avviso pubblico che sostiene la crescita e il consolidamento dei centri culturali indipendenti, nati da processi di rigenerazione avviati dal basso. Delle 241 candidature pervenute, 237 sono state ammesse alla valutazione; l’investimento pubblico sfiora i 2 milioni di euro. Da Palermo a Milano, da Roma a Napoli, fino ai piccoli centri e ai territori vulnerabili, le iniziative selezionate dalla Commissione raccontano un’Italia che sperimenta nuovi linguaggi culturali e modelli innovativi nella costruzione delle comunità. In una lunga intervista disponibile sul sito di Artribune, il direttore generale della Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiC, Angelo Piero Cappello, ha spiegato che gli obiettivi perseguiti nel fronte della rigenerazione urbana sono “attivare comunità, migliorare la qualità della vita nei territori marginali o in trasformazione e rafforzare il senso di appartenenza attraverso processi culturali condivisi. In altre parole: mettere la cultura e l’arte al centro della cura dei luoghi”. È inoltre pari a 900mila euro il finanziamento per il nuovo progetto Il Museo Rigenera, che mira a rafforzare il ruolo delle istituzioni culturali nelle città, aree periferiche incluse. Perché “i musei, le biblioteche, gli archivi e gli istituti culturali possono e devono diventare protagonisti della rigenerazione urbana e sociale” afferma Cappello. (VS)
ROMA: 60 MILIONI DI EURO PER L’EX CASERMA DONATO AL TRULLO Sono passati 10 anni dall’ultima volta che la Caserma Donato ha aperto le sue porte al quartiere Trullo. Un tempo sede del Genio Trasmissioni dell’Esercito, l’edificio è rimasto chiuso e isolato, segnato dal degrado e dall’abbandono. Oggi, però, prende il via un ambizioso progetto di rigenerazione urbana da 60 milioni di euro: la giunta Gualtieri ha approvato uno schema d’intesa con l’Agenzia del Demanio per la riqualificazione dell’intero complesso e delle aree circostanti, con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio moderno, sostenibile e integrato nel tessuto urbano. La struttura, a seguito della demolizione parziale degli attuali capannoni, ospiterà una nuova piazza pubblica, servizi civici, spazi condivisi, aree verdi e abitazioni destinate all’edilizia sociale, aprendo l’area verso il quartiere e il vicino parco di Monte Cucco. (Carolina Chiatto)
Iscriviti a Render, la newsletter di Artribune che ogni due settimane approfondisce il mondo dell’architettura e della rigenerazione urbana. Basta scansionare il QR code qui a fianco
CRISTINA MASTURZO L Si è aperta con un rocambolesco furto al Louvre degno di Arsène Lupin, la settimana dell’arte di Parigi, dove la gigante Art Basel Paris ha iniziato la sua quarta edizione con le danze delle sue preview e le sue 206 gallerie partecipanti, per accogliere poi il pubblico dal 24 al 26 ottobre 2025, e le tante fiere collaterali in città, da Paris Internationale a Offscreen. Il mondo dell’arte ha fatto appena in tempo a fare il punto e ad archiviare Londra, coi risultati delle aste e le vendite dalle fiere Frieze London e Frieze Masters, che già si è volati a vedere come se la cava l’inarrestabile e irresistibile capitale francese, che, con la magnifica infrastruttura museale e l’IVA sull’arte al 5,5%, non solo sul fronte delle fiere, ma anche su quello delle aste, con i cataloghi enormi e ricchissimi di Christie’s e Sotheby’s per l’arte moderna e contemporanea, che incarnano di certo, al momento, le selezioni migliori e più attese in Europa.

LE FIERE FRIEZE LONDON E FRIEZE MASTERS. LA RIPRESA DI LONDRA A OTTOBRE 2025
Alla chiusura delle edizioni 2025 delle fiere ammiraglie di Londra, Frieze London e Frieze Masters, il mercato dell’arte della capitale britannica si è mostrato in netta ripresa, con vendite robuste per le gallerie e collezionisti presenti, seppure meno internazionali e più riflessivi sugli acquisti, che hanno privilegiato le opere nei range di prezzi più contenuti.
Sotto gli iconici tendoni tirati su a Regent’s Park, nel mezzo di un perfetto autunno londinese, la capitale britannica ha mostrato però di che ottima pasta è fatta, scrollandosi di dosso ogni profezia apocalittica sulla tenuta del suo mercato dell’arte e nonostante gli effetti negativi della Brexit che ancora si fanno sentire, così come di una situazione fiscale non troppo favorevole per i ceti più facoltosi, offrendo alle gallerie la possibilità di esporre in un contesto pensato, curato e produttivo e di trovare interlocutori qualificati per le proposte artistiche delle scuderie. Quello che pare essere mancato è però una certa internazionalità del pubblico, in particolare la presenza dei collezionisti americani che nelle ore in cui scriviamo sono, invece, confluiti a Parigi per Art Basel Paris. Numerose, alla fine della fiera, le vendite registrate e raccontate sin dal giorno di preview, mercoledì 15 ottobre 2025, e protrattesi fino alle ultime ore di domenica 19 ottobre, per un parterre di espositori che ha portato a Londra la varietà dell’arte, dall’antichità al contemporaneo, trovando un bilanciamento efficace tra la necessità di assecondare i trend di mercato e la capacità di sostenere il valore culturale della nuova ricerca artistica.
TORNA AL GRAND PALAIS UNA NUOVA ART BASEL PARIS
A poche ore dalla chiusura dell’Art Week londinese, al Grand Palais si montava e allestiva tutto il necessario per la nuova edizione di Art Basel Paris, che quest’anno ha introdotto un nuovo slot di accesso anticipato in fiera, “Avant Première”: una preview di ultra-VIP scelti dalle gallerie e a cui offrire “un’esperienza particolarmente intima e privilegiata”, oltre che auspicabilmente e concretamente orientata alle vendite, nella giornata del 21 ottobre 2025, prima ancora della consolidata preview First Choice VIP del 22 ottobre. Al di là di uno sfoggio di esclusività incrementale, questa nuova articolazione sembra piuttosto rispondere all’affluenza in calo alle grandi
fiere globali di clienti con importanti poteri di spesa. D’altro canto, molti collezionisti lamentano, invece, le troppe opere già vendute prima dell’apertura delle fiere, fino allo scoraggiamento finale nel pensare di visitare eventi a cui si rimane a bocca asciutta. Ovviamente laddove si chieda tutti lo stesso bene. Di certo, per ora, la preview della preview è andata a sovrapporsi con l’apertura di fiere collaterali come Paris Internationale, drenando via collezionisti e attenzione dal segmento delle gallerie giovani e mid-size. E trasformando anche la privilegiata First Choice in una scelta almeno “seconda”. Tante le opere che sono state vendute, infatti, da quanto riportato almeno dalle mega-gallerie internazionali di Art Basel Paris ad ARTnews, già il martedì 22. “Sono tutti qui”, ha commentato il gallerista Thaddaeus Ropac, che in queste prime ore ha già trovato collezionisti per un’opera di Alberto Burri (€4,2 milioni) e due di Georg Baselitz (a €3,5 milioni una e €1,2 milioni l’altra). Hauser & Wirth ha chiuso in questa primissima giornata le trattative per l’opera più importante che aveva in fiera, Abstraktes Bild del 1987 di Gerhard Richter – protagonista di un’enorme retrospettiva in città, alla Fondation Louis Vuitton – per $23 milioni. In un totale di una dozzina di lavori già andati, da Lucio Fontana a George Condo. Tra le altre vendite ultra-milionarie delle prime ore di Art Basel Paris c’era anche un dipinto di Modigliani da Pace Gallery, venduto per $10 milioni, mentre da David Zwirner ha trovato un nuovo proprietario una scultura di Ruth Asawa per $7,5 milioni. E sono solo gli affari delle prime ore, mentre ci sono ancora tutti i giorni della settimana, per verificare se tutto il sistema dell’arte potrà beneficiare del nuovo Sistema Parigi. O se, invece, tutte le luci della città non stiano illuminando solo i player forti e fortissimi di una filiera dell’arte che, a tratti, lavora su un confine scivolosissimo tra ricerca e cultura e lusso e privilegio.
Art Basel Paris al Grand Palais
Iscriviti alla nostra newsletter settimanale Incanti per non perdere nessun aggiornamento sul mercato dell’arte. Basta scansionare il QR code qui a fianco!

Materassi di crème caramel, kiwi di vetro, angurie di peluche, dessert a base di lava fumante. Sono solo alcuni degli oggetti assurdi che potrebbe capitarvi di vedere scrollando su TikTok in questo periodo. Fanno mostra di sé all’interno di brevi video dall’atmosfera sospesa e surreale, creati con l’intenzione di stimolare i recettori sensoriali degli utenti, offrendo piacere e rilassamento. Evoluzione dei video “satisfying” che già da un decennio invadono le piattaforme social, rappresentano l’ultima frontiera dell’ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response), genere già molto popolare che proprio grazie a questi nuovi contenuti sta vivendo una seconda giovinezza. Se fino a poco tempo fa i content creator dovevano sporcarsi le mani con slime, schiuma e poltiglie varie per produrli, oggi grazie alle applicazioni di intelligenza artificiale possono generare le combinazioni di oggetti e materiali più impensate toccando soltanto la tastiera del computer. Bastano un’idea assurda e un paio di prompt. Il risultato è visivamente potente, sonoramente accurato e capace di trattenere anche lo sguardo dell’utente più distratto. La riproduzione iperdefinita di materiali e superfici, unita agli accostamenti sempre più incongrui (affondare i denti in una lampadina, riposare su un letto di ghiaccio, mangiare una bottiglia fatta di gelato, tagliare un’onda marina con il coltello), trasforma questi video in pillole di pura visionarietà surrealista. Difficile, infatti, guardarli senza ripensare al genio di Meret Oppenheim, che nel 1936 esplorava gli effetti perturbanti del disordine sensoriale rivestendo una tazza da tè con del pelo di gazzella cinese (Colazione in pelliccia). Un’opera, la sua, che a distanza di quasi un secolo continua a colpire l’immaginazione di chi la osserva, innescando un potente corto circuito. Mentre la discussione sulla post-verità assume toni sempre più accesi, e l’intelligenza artificiale generativa invade il nostro orizzonte visivo con immagini sempre più credibili, il mondo dei contenuti virali sembra andare contro corrente, sfruttando le potenzialità dei nuovi strumenti per visualizzare l’impossibile
Internet Roadtrip è un’applicazione che trasforma la navigazione online in un viaggio collettivo. Sul sito, lanciato lo scorso maggio dal programmatore Neal Agarwal, gli utenti possono guidare (tutti insieme) un’automobile virtuale che percorre il mondo attraverso Google Street View. Possono votare la direzione da prendere, suonare il clacson e cambiare stazione radio, scegliendola tra quelle disponibili nell’area in cui si trova la macchina.
neal.fun/internet-roadtrip

Weird AF (Weird As Fuck) è una trilogia di cortometraggi che esplora le implicazioni emotive, culturali ed estetiche legate all’uso massiccio dell’intelligenza artificiale generativa. L’autrice, Silvia Dal Dosso del collettivo Clusterduck, descrive con profondità e ironia l’universo assurdo e contraddittorio della post-verità, un ecosistema visivo in cui tutto diventa possibile. La voce narrante, anch’essa generata, è quella, inconfondibile, del regista britannico Adam Curtis.
@hawaidolphino
DISEGNARE IL MONDO
Wplace è un progetto di disegno collaborativo ideato dallo sviluppatore brasiliano Murilo Matsubara. Ispirato al più celebre R/Place, ospitato negli scorsi anni dalla piattaforma Reddit, permette agli iscritti di creare immagini e scritte colorando i pixel disponibili su una grande mappa del mondo. Il sito ha attirato milioni di utenti in pochi giorni e si sta trasformando in una tela vibrante fatta di immagini, simboli e messaggi.
wplace.live
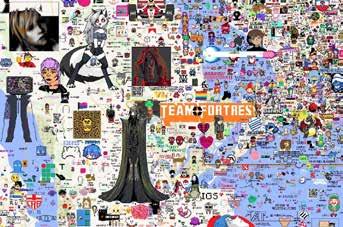

Sviluppato dallo studio di design Modem e basato su una tecnologia open source, Dream Recorder AI, traduce le descrizioni verbali dei sogni in narrazioni visive, da rivedere e contemplare al risveglio. Dream Recorder può essere tenuto sul comodino e utilizzato come diario onirico: non ha bisogno di essere collegato a uno smartphone e non disturba la quiete della camera da letto. modemworks.com/projects/dreamrecorder
In un web ossessionato dalla viralità e dominato dagli algoritmi, Astronaut.io invita alla scoperta di contenuti nascosti, quelli che nessuno (o quasi) finisce per vedere. Il sito offre una selezione di video recenti caricati su YouTube e li sceglie in base alle visualizzazioni: verranno mostrati solo quelli che ne hanno zero o poco più. Una collezione di momenti intimi e casuali provenienti da ogni parte del mondo.
astronaut.io
L’ARCHITETTO DI MINECRAFT
Manofdutch è un utente di YouTube e X molto conosciuto per le sue strabilianti costruzioni virtuali nel mondo di Minecraft. Neolaureato di stanza nei Paesi Bassi, trascorre centinaia di ore ogni mese all’interno del famoso videogioco, dove riproduce con maniacale fedeltà paesaggi e architetture ispirati ai dipinti del Secolo d’Oro olandese. Non manca qualche incursione nel contemporaneo: di recente ha infatti realizzato lo scenario del video game apocalittico The Last of Us.
@manofdutch

LIBRI SABOTATI

“Sabota poeticamente i tuoi libri elettronici”. Si presenta con questo slogan il sito Book Saboteur, un’applicazione che permette di intervenire in maniera creativa sul testo di qualsiasi libro in formato digitale. Basta caricare un file in formato EPUB e decidere che genere di sabotaggio operare: si possono inserire spoiler da altri libri e film, alterare casualmente le maiuscole, censurare frasi e molto altro ancora…
booksaboteur.com
Midjourney è una delle applicazioni di intelligenza artificiale maggiormente usate per la produzione di immagini, sia fisse che in movimento. Alla fine di agosto la piattaforma ha annunciato la nascita del sito Midjourney.tv, un’emittente web che trasmette 24 ore su 24 filmati generati. La piattaforma pesca dal vastissimo bacino di contenuti prodotti dai propri utenti, montandoli all’interno di una rotazione casuale.
midjourney.tv

Per la prima volta in quasi un millennio, l’Arazzo di Bayeux tornerà in Gran Bretagna. Nel 2026, la famosa opera verrà esposta al British Museum nell’ambito di una collaborazione storica con la Francia. Nel frattempo, il Museo che normalmente lo custodisce in Normandia rimarrà chiuso per lavori di rinnovamento. In attesa di questo atteso - e contestatoevento, si può godere dell’eccellente riproduzione online, che permette di esplorare il manufatto in tutti i dettagli grazie alle immagini ad altissima risoluzione.
bayeuxmuseum.com
dal 12.09
al 13.11.25
Accademia
delle Arti del Disegno
Sala delle
Esposizioni
Via Ricasoli 68, Firenze

Maggiori informazioni

Informal Art | Surrealism | Art Brut

Castello di Miradolo 11 ottobre - 8 dicembre 2025
Via Cardonata, 2 San Secondo di Pinerolo (TO) fondazionecosso.it
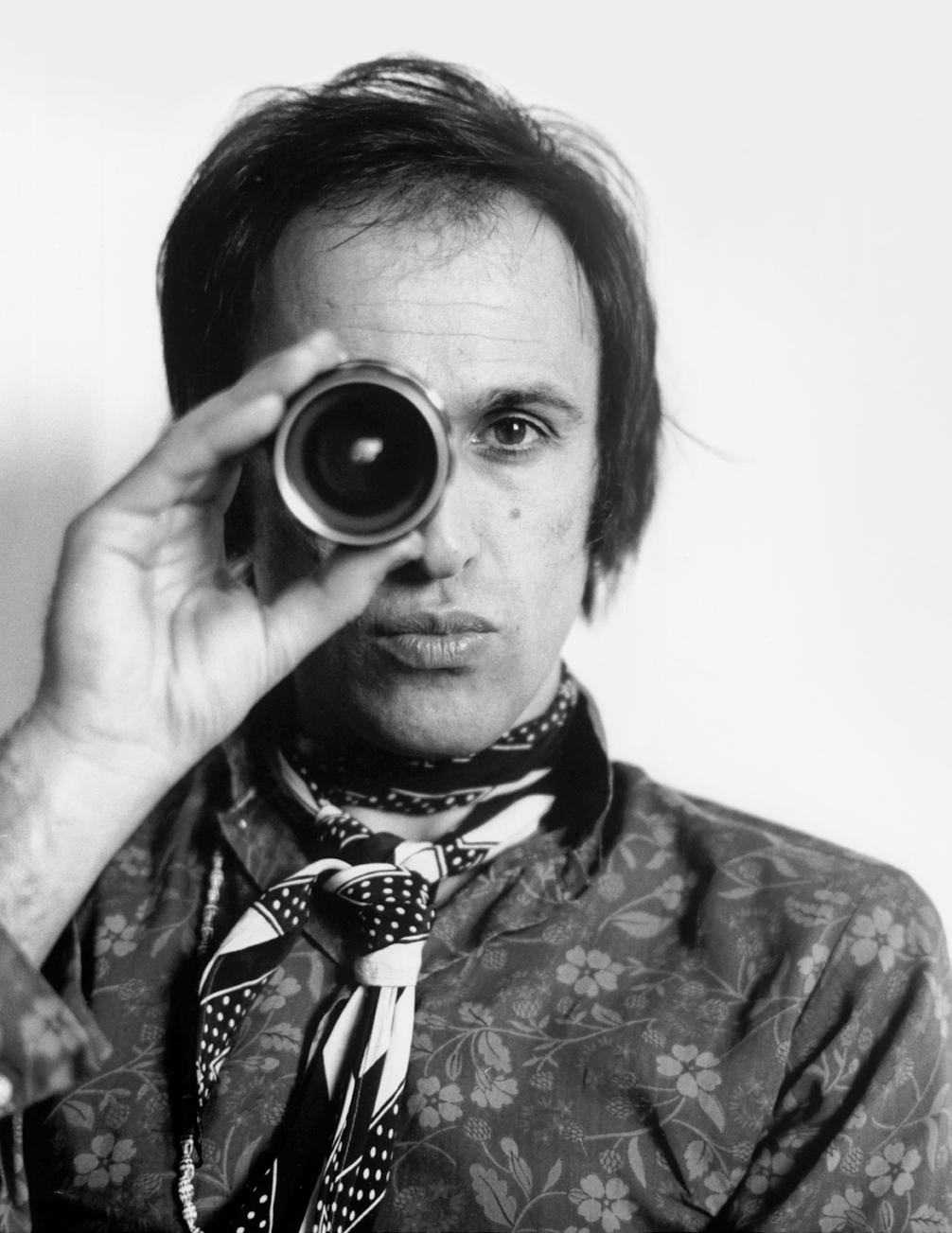
Amburgo è una di quelle città che si reinventa sempre. E il fermento c’è a tutti i livelli, dall’urbanistica alla cultura, anche indipendente. Abbiamo mappato il tessuto cittadino per comprendere in che modo riesce a produrre cultura dal basso in modo così efficace


Nel cuore del Nord Europa, affacciata sull’Elba, Amburgo è la città più amata dai tedeschi e non solo, con un’identità che fonde radici mercantili e spirito cosmopolita. Una città d’acqua: sotto l’asfalto e nei quartieri, scorrono i suoi canali. Navigabili, percorribili, attraversati da oltre duemila ponti, più di quelli di Venezia, Amsterdam e Londra messe insieme. Sin dal Medioevo, Amburgo è stata crocevia di merci e idee, punto d’incontro tra diversi popoli. Libera e anseatica – Freie und Hansestadt Hamburg, come ancora oggi recita il suo nome ufficiale – Amburgo non è mai appartenuta a un re né a un principe. La sua autonomia storica è un elemento fondativo: ha definito nei secoli il carattere pragmatico, fiero e indipendente dei suoi abitanti, abituati a navigare tra scambi, influenze esterne e cambiamenti di rotta. La porta del mondo, come viene spesso definita. Amburgo è una città che si reinventa costantemente: nei dock recuperati dell’HafenCity, nelle gallerie disseminate nei quartieri di St. Pauli o Altona. Il paesaggio urbano alterna memoria e utopia, con esperimenti di rigenerazione urbana che affiancano musei e hub per le industrie culturali. Ed è proprio in questo contesto tra radici e visioni future che si inserisce il nostro percorso. Un’indagine a più voci — tra spazi autogestiti e musei storici, architetture iconiche e aree post-industriali — per raccontare Amburgo come una città-laboratorio, in cui l’arte indipendente e la rigenerazione urbana dialogano con la complessità del presente.
Per orientarsi in questa città composita, iniziamo un percorso tra alcuni dei suoi quartieri più vivaci, dove si intrecciano pratiche artistiche, progetti architettonici e nuove forme di socialità. Dal multiculturalismo di St. Georg all’energia underground di St. Pauli, passando per le geometrie visionarie della HafenCity e le trasformazioni di Oberhafen, ogni tappa racconta un volto diverso dell’Amburgo contemporanea.
→ Il quartiere di St. Georg
La prima fermata è a pochi passi dalla stazione centrale, nel quartiere di St. Georg, il più colorato di Amburgo, dove culture, religioni, orientamenti sessuali e stili di vita diversi convivono pacificamente. St. Georg ospita due delle istituzioni culturali più importanti della città: i teatri Deutsches Schauspielhaus e l’Ohnsorg Theater. Il primo è il più grande teatro di prosa in Germania e presenta un programma prevalentemente sperimentale e internazionale. Un interessante hub creativo si trova al numero 66 della via Koppel, da cui prende il suo nome Koppel66: su tre piani si alternano 12 atelier di 16 artisti e artigiani, tra cui orafi, ceramisti, sarti e pittori. Fondata oltre quarant’anni fa come alternativa alla produzione di massa sempre più diffusa, seguendo il modello inglese delle Arts & Crafts.
→ I quartieri di St. Pauli e Karoviertel
Proseguendo il nostro percorso, giungiamo a St. Pauli, noto come quartiere a luci rosse e per il suo sbocco sul porto. Qui trovano sede anche piccoli spazi
SECONDO LA GALLERISTA ELENA CONRADI

Fondata nel 2008 con una mostra dell’artista Cordula Ditz, la Galleria Conradi ha costruito fin da subito un forte legame con Amburgo, pur mantenendo uno sguardo aperto verso l’esterno. Il suo programma curatoriale – incentrato su pratiche concettuali e videoarte – riflette connessioni e percorsi più che tendenze di mercato. “Non voglio essere solo una galleria tra tante in una metropoli globale”, racconta Elena Conradi. “Mi interessa che, tra cinquant’anni, qualcuno possa guardare le nostre mostre e riconoscere un’identità, un luogo” Ad Amburgo, racconta, ha imparato a diffidare delle formule vuote – come “l’arte riflette la società” – e a riconoscere il valore di posizioni critiche e laterali. Un esempio: il collettivo Galerie BRD, nato da giovani artisti della HFBK (Università di Belle Arti) come Katja Aufleger o Steffen Zillig, “guastafeste intelligenti con senso per l’estetica del futuro”. Ma Amburgo non è sempre facile: “Per gli artisti può essere difficile costruire reti solide. Molti professori della HFBK non vivono qui, e questo impoverisce il contesto. Dall’altra parte, chi sceglie di restare spesso apprezza questa vita ritirata”. Figura chiave è Thomas Baldischwyler, artista della galleria, instancabile attivatore di progetti e collaborazioni ad Amburgo e oltre. Come il gruppo Motto, recentemente tornato da Detroit e parte del fermento che attraversa Gängeviertel, Admiralitätstraße e altri snodi urbani vitali per la scena culturale. È proprio qui che si trovano gallerie indipendenti e studi, ma anche realtà affermate come Produzentengalerie, che affianca nomi internazionali e giovani talenti locali come Noemi Barbaglia e Paul Spengemann. O la Galleria Sfeir Semler, che rappresenta Sung Tieu, artista del padiglione tedesco alla prossima Biennale di Venezia. Eppure, conclude: “Ogni volta che torno in auto da Bruxelles e attraverso l’Elba, mi chiedo perché in una città così ricca e bella ci siano così poche gallerie di alto livello. Se fossi il coach della scena artistica amburghese, le prescriverei meno mentalità da fornitore di servizi e più passione per ciò che è difficile da comunicare”. Nonostante tutto, le istituzioni restano attente al contesto locale: dalla Kunsthalle – che ha recentemente acquisito opere di Cordula Ditz e Andrzej Steinbach – al Kunsthaus, al Kunstverein e al Museo di Arti Applicate che espongono regolarmente opere di artisti della galleria. “I luoghi espositivi di Amburgo osservano con intelligenza e continuità la propria scena artistica”
Oggi, molti degli ex spazi portuali e industriali di Amburgo sono stati trasformati in poli creativi e innovativi, segnando una delle più ambiziose operazioni di rigenerazione urbana d’Europa. Speicherstadt, HafenCity e Oberhafen ne sono gli esempi più emblematici.
SPEICHERSTADT: LA STORIA DEL PORTO
Con i suoi caratteristici edifici di mattoni rossi affacciati sui canali, Speicherstadt rappresenta il cuore storico del porto di Amburgo. Un tempo centro nevralgico del commercio internazionale, oggi è uno dei quartieri più suggestivi e vivaci della città, animato da musei e gallerie. Dal 2015, Speicherstadt, insieme al quartiere adiacente Kontorhausviertel — che include il celebre Chilehaus — è riconosciuta come patrimonio mondiale dell’UNESCO, definita “un eccellente esempio” di edifici e complessi che “simboleggiano periodi significativi della storia dell’umanità”. Il Chilehaus, uno degli edifici più imponenti della città, fu costruito negli Anni Venti per ospitare uffici di compagnie commerciali legate al commercio internazionale, in particolare con il Cile, da cui prende il nome. La sua caratteristica punta simile alla prua di una nave è diventata un’icona dell’architettura espressionista.
HAFENCITY: IL CANTIERE URBANO
Attraversando i numerosi ponti si raggiunge HafenCity, che combina tradizione e modernità in una simbiosi unica. Per secoli, il porto di Amburgo ha plasmato lo sviluppo della città anseatica. Il Sandtorkai fu inaugurato nel 1866 come il porto più moderno dell’epoca. Dopo oltre 100 anni, HafenCity sta prendendo il suo posto. I lavori sono iniziati nel 2003 e finora è stata completata metà degli edifici previsti nel piano generale. Proprio qui sorge il nuovo simbolo della città, l’Elbphilharmonie, con la sua incredibile architettura. Ancora sospesa invece è la vicenda della torre progettata da David Chipperfield, Elbtower, pensata come landmark contemporaneo sul porto e rimasta incompiuta per anni. Dopo controversie e battute d’arresto, si ipotizza una sua riconversione come sede per il futuro Naturkundemuseum Hamburg, segnando una nuova traiettoria per il progetto: da monumento alla speculazione a polo scientifico e culturale al servizio della città
OBERHAFEN: HUB CULTURALE
Proseguendo tra cantieri e progetti architettonici, si giunge all’ex polo logistico Oberhafen, oggi un esperimento urbano a cielo aperto. Gestito in collaborazione con la Hamburg Kreativ Gesellschaft, il quartiere ospita un vivace ecosistema creativo: laboratori cinematografici, studi di architettura, artigiani e spazi condivisi. Un tempo crocevia di merci, oggi è un polo di produzione culturale indipendente. Tra gli spazi più rappresentativi del quartiere c’è la Gleishalle, un’ex rimessa ferroviaria trasformata in contenitore culturale per performance ed esposizioni, oggi cuore pulsante dell’area. Poco distante, la Hanseatische Materialverwaltung custodisce un archivio inedito e condiviso di scenografie, oggetti di scena e materiali provenienti da teatri e produzioni cinematografiche della città: un progetto no-profit che promuove il riuso creativo e alimenta una rete di relazioni tra artisti, scuole, comunità e designer indipendenti. Siamo giunti al termine di questo affascinante viaggio in una città in continua evoluzione. Il nostro itinerario — e le voci raccolte lungo il percorso — restituiscono il ritratto di una città che non si limita a ridisegnare il proprio skyline: attraverso progetti che intrecciano architettura, socialità e inclusione creativa, Amburgo dimostra come la cultura possa diventare una leva concreta per ripensare il vivere urbano e immaginare nuove forme di convivenza.
L’Elbphilharmonie è un edificio di superlativi, dove l’architettura spettacolare si unisce a un’acustica straordinaria. Ospita tre sale da concerto, la Plaza – un’area pubblica panoramica – l’hotel “THE WESTIN” e 45 appartamenti privati esclusivi. La Plaza, accessibile a tutti, è uno dei cuori pulsanti della città, raggiungibile tramite la scala mobile curva più lunga del mondo che conduce a 37 metri d’altezza, offrendo una vista a 360° su Amburgo. Simbolo perfetto dell’incontro tra tradizione e modernità, la sala da concerto è stata progettata dagli architetti svizzeri Herzog & de Meuron. La combinazione di vecchi mattoni rossi – resti dell’ex magazzino Kaispeicher A, utilizzato fino alla fine del secolo scorso per conservare tè, tabacco e cacao – e la struttura moderna in vetro filigranato crea un effetto cristallo che cattura i riflessi del cielo, dell’acqua e della città. La facciata curva, composta da oltre mille pannelli di vetro sagomati e bombati, alcuni con speciali “occhi” concavi, è un capolavoro di design. L’Elbphilharmonie non è solo un capolavoro architettonico, ma anche il cuore della riqualificazione urbana di HafenCity che si estende anche ad altri quartieri, inclusi i futuri progetti sostenibili di Grasbrook, ancora in cantiere e affidati agli stessi architetti.

creativi indipendenti e il Grüner Bunker, un colosso di cemento nato come rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale, e che oggi ospita un giardino pensile con vista sulla città, spazi culturali, un hotel e diversi locali.
La gentrification ha reso attrattivo anche il vicino quartiere Karoviertel. Fino agli Anni Novanta era piuttosto decadente: qui studenti e residenti della classe operaia vivevano in case Art Nouveau mal tenute o nel parcheggio per roulotte Bambule, reso famoso per le contestazioni a seguito della sua chiusura all’inizio del 2000.
La street art sulle facciate e nei cortili della Marktstraße, Glashüttenstraße e dintorni crea una galleria urbana a cielo aperto. Una forma di arte partecipata che coinvolge la comunità locale, come il progetto Nukleus II dove artisti hanno collaborato con i residenti per intervenire negli spazi pubblici con murales collettivi.
L’ex macello, oggi sede di un ristorante e piccoli laboratori creativi, divide Karoviertel da Schanzenviertel. Addentrandosi in questo quartiere si giunge al Rote Flora, sulla Schulterblatt, che è da decenni un punto focale delle proteste sociali. In origine l’edificio ospitava la Gesellschafts- und Konzerthaus Flora (Casa della società e dei concerti Flora), inaugurata nel 1886. Qui si tenevano concerti, balli in maschera e incontri di pugilato. Negli Anni Ottanta alcuni residenti di sinistra alternativa svilupparono l’idea di un centro sociale e il Flora fu occupato. Ancora oggi, il Rote Flora è un centro culturale autonomo autoproclamato e fulcro di azioni politiche. Non lontano, la Haus 73 si distingue come un hub per artisti e musicisti, offrendo spazi per esposizioni, laboratori e eventi indipendenti. Un altro simbolo del quartiere è la Schanzenturm, l’ex torre idrica più grande d’Europa costruita su una collina. Nel 2007 è stata riconvertita in un hotel di lusso della catena Mövenpick.
in alto: Elbphilharmonie, photo Giorgia Losio
a sinistra: Thomas Baldischwyler, Force
The Hand Of Chance , with contributions and materials by Ingeborg Gbariel, Tatjana Danneberg, Lea Rohde, Matthias Meyer, Harald Cohen et al. Courtesy Galleria Conradi, 2024
ZONE FRANCHE: LA SCENA INDIPENDENTE AD AMBURGO
Lontano dai circuiti istituzionali, ad Amburgo si è consolidata nel tempo una rete eterogenea di spazi indipendenti, collettivi artistici e iniziative ibride che alimentano la vitalità culturale della città. Questi luoghi non solo offrono possibilità concrete di produzione e visibilità per artisti emergenti, ma rappresentano anche una forma di resistenza simbolica alle dinamiche della gentrificazione. Fra recupero di edifici dismessi, modelli cooperativi e pratiche partecipative, la scena indipendente amburghese continua a reinventarsi, mantenendo un forte legame con il tessuto urbano e le sue trasformazioni.
→ Frappant: arte in transito
Nato all’interno del grande complesso ex-industriale di Viktoria-Kaserne nel quartiere Altona, Frappant è oggi uno degli spazi indipendenti più dinamici della città. Il progetto si sviluppa in modo cooperativo, con studi condivisi, atelier, una sala espositiva e un fitto programma di mostre, talk, concerti e workshop. L’approccio è trasversale: arte visiva, performance, design, musica e attivismo si mescolano. Frappant offre anche ai diplomati dell’Università di Belle Arti un atelier per un anno con mostra finale. Lo spazio si autogestisce attraverso una cooperativa, un vero circolo culturale che gestisce anche il Kachelraum in un vecchio laboratorio che i precedenti inquilini – l’Istituto di biologia marina di Amburgo – gli hanno lasciato. Completamente rivestito di piastrelle, un incubo acustico, ma per il collettivo, in qualche modo, un ambiente perfetto imperfetto. Il modello di Frappant si fonda su collaborazione e condivisione, non solo tra artisti ma anche con il quartiere circostante.
→ Gängeviertel:
un laboratorio urbano autogestito Forse il più emblematico tra gli spazi indipendenti di Amburgo, il Gängeviertel è un intero micro-quartiere



nel cuore della città, salvato dalla speculazione immobiliare nel 2009 da un’azione collettiva di occupazione artistica. I Gängeviertel erano i quartieri labirintici di case a graticcio sopraelevate, che fino alla metà del XIX Secolo coprivano gran parte della città vecchia. Ospitavano portuali, braccianti, piccoli criminali e prostitute e la cattiva fama ha portato negli ultimi 150 anni alla progressiva demolizione di queste zone. Oggi quest’area è diventata un simbolo della resistenza culturale ad Amburgo: tra case a graticcio restaurate, murales, studi, cortili e laboratori, il Gängeviertel ospita mostre, concerti, proiezioni e dibattiti su arte e politica. Lo spazio è gestito da un collettivo aperto che promuove pratiche democratiche, condivisione delle risorse e inclusione sociale. Negli anni, ha ottenuto il riconoscimento istituzionale e il supporto pubblico, pur mantenendo una forte vocazione critica e indipendente. Oggi non è solo un centro culturale, ma anche un laboratorio urbano che riflette su forme alternative di abitare, produrre e partecipare.
UNA MAPPA IN EVOLUZIONE
DEGLI SPAZI INDIPENDENTI
Art Off Hamburg promuove proprio una mappatura
in alto a sinistra: Hamburg
Cruise Days 2023
© Mediaserver Hamburg
a destra: Frei Flaeche
Jupiter in basso: Massoumi
Boutique Art Fair
degli spazi indipendenti, con l’obiettivo di dargli una voce più forte. Il punto di partenza è stato la richiesta di maggiori finanziamenti pubblici per sostenere queste realtà, considerate fondamentali per il panorama artistico e culturale cittadino. Dalla periferia di Amburgo – Niendorf e Bergedorf – passando per Ottensen e Altona, nei quartieri vicini al centro di Schanzen-, Karolinen- e Gängeviertel, fino all’est con i quartieri di Barmbek, Hammerbrook, Rothenburgsort e Veddel, si estende una rete impressionante di 31 luoghi d’arte indipendenti. E ne fa parte anche la storica Admiralitätsstraße, sede di gallerie e del mitico Westwerk. Cresciuta nel corso di decenni, questa struttura alternativa ha dato forma a un sistema capillare e accessibile: in ex scuole, fabbriche, officine, container navali, caserme imperiali o locali commerciali si produce arte libera da pressioni commerciali, fruibile gratuitamente tutto l’anno. Insieme, questi spazi costituiscono una vera e propria infrastruttura culturale informale, dove sperimentazione, collaborazione e resistenza alle logiche di mercato creano un ecosistema prezioso, spesso fragile, ma capace di rigenerarsi. Una costellazione in movimento che racconta un’altra Amburgo informale e condivisa.

Nascosto tra le pieghe di un quartiere in rapido mutamento, dove oggi trovano sede un hotel di lusso, una clinica estetica e ristoranti di design, Westwerk resiste come un avamposto dell’arte indipendente. Infatti, da quasi quarant’anni, rappresenta uno dei presidi più attivi e longevi dell’arte indipendente ad Amburgo. Ne abbiamo parlato con Anja Ellenberger, membro del collettivo e curatrice.
Chi sono stati i fondatori di Westwerk?
Westwerk si considera un collettivo nato nel 1986 da un gruppo di persone creative che già allora utilizzavano gli spazi in Admiralitätsstraße. Già all’epoca la gentrificazione era un tema importante, e ha rappresentato uno dei motivi che hanno spinto alla nascita del progetto.
Come si è finanziato il progetto nel tempo?
Il nostro finanziamento di base per le mostre arriva tramite sovvenzioni dell’Autorità per la Cultura e i Media di Amburgo. Gran parte copre i costi di gestione dello spazio (energia, manutenzione). Inoltre, il nostro proprietario tiene molto a che gli edifici di sua proprietà possano essere messi a disposizione di artisti, gallerie, del Fleetstreet Theater e di altri progetti simili a prezzi ragionevoli. Dal 2018 facciamo parte dell’iniziativa ART OFF Ham-

burg, grazie alla quale i fondi per l’arte indipendente sono triplicati e da qualche tempo è previsto anche un contributo per i compensi artistici.
Tutti i membri possono curare progetti artistici?
Per far parte di Westwerk è necessario aderire all’associazione, ma non occorre avere uno spazio in loco. Siamo un collettivo autorganizzato: discutiamo e distribuiamo i compiti in riunioni periodiche. Un gruppo volontario si occupa della programmazione annuale, scegliendo tra le proposte che riceviamo o contattando direttamente gli artisti. La maggior parte dei membri non cura nel senso classico: affianca gli artisti come “patrocinatore”. Gli artisti curano quindi le proprie mostre. Io invece mi occupo della curatela vera e propria: sviluppo il concept, seleziono gli artisti, scrivo testi, progetto l’allesti-
a sinistra: Irit Hemmo, Bruchstellen II , Westwerk 2021, © Anja Ellenberger in basso: Hamburg Westwerk © Leo Schatzl, 2025
mento e cerco finanziamenti, se serve. Ovviamente, in un gruppo autogestito si dibatte molto e si lavora sempre per trovare compromessi.
Quante mostre ed eventi organizzate ogni anno?
Fino a 18-20 mostre. Se aggiungiamo concerti, letture e altri eventi, superiamo i 50 appuntamenti l’anno. Onestamente, è troppo: facciamo tutto su base volontaria, accanto ai nostri lavori. I concerti sono curati da un gruppo separato.
Come selezionate gli artisti?
Non abbiamo criteri fissi. Gli artisti devono però sapere che non possiamo offrire grandi supporti economici e che dovranno occuparsi personalmente di allestimento e sorveglianza, con l’aiuto dei nostri “padrini” interni.
Cosa ci racconti dell’utilizzo degli spazi e del programma di residenza? Westwerk è un’ex cartiera con studi, uffici, uno studio musicale e appartamenti. Non tutti i membri vivono o lavorano qui. Il nostro programma di residenza trimestrale è finanziato dalla città, che pubblica il bando e seleziona i candidati tramite una commissione. Gli artisti ospiti vivono e lavorano in un piccolo studio-appartamento, e al termine presentano il loro lavoro in un evento pubblico.
Come vedi il futuro di Westwerk?
Dipenderà da cosa vorranno farne i futuri proprietari e se condivideranno l’approccio attuale, rendendo possibile un uso culturale degli spazi a prezzi sostenibili.
Il 2026 sarà un anniversario importante, giusto?
Sì, festeggeremo i 40 anni. Ma vogliamo evitare l’effetto-museo: per questo il tema verrà affrontato in modo puntuale. Abbiamo lanciato un bando tematico aperto da cui verranno selezionati i progetti per l’anno. E naturalmente, ci sarà anche una festa.
GERMANIA
Grüner Bunker
KAROVIERTEL ST. PAULI
Westwerk
GalLerie Conradi
Galleria Melike Bilir
HAMBURG-MITTE
KUNSTMEILE E OLTRE: IL PANORAMA ARTISTICO DI AMBURGO
1 La Kunstmeile è un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni culturali: sei importanti musei di Amburgo uniti da una rete che promuove arte, dialogo e progettualità condivisa. Il direttore del progetto, Paul Grziwok, ci racconta alcune delle attività più significative: “Oltre a promuovere Amburgo come città d’arte, anche attraverso campagne mirate, Kunstmeile offre due biglietti cumulativi che permettono di visitare tutte e sei le sedi. Ma non è solo una questione di accessibilità: ci impegniamo anche a livello di contenuti, per valorizzare la collaborazione tra le istituzioni. Tra i progetti comuni, abbiamo pubblicato una guida condivisa su educazione e mediazione, realizzato interventi artistici nello spazio pubblico e collaborato con altre realtà culturali della città. Un esempio è il progetto 24 Flaggen, che porta nello spazio urbano 24 opere create appositamente da Than Hussein Clark, Özgür Kar e Ketuta Alexi-Meskhishvili per i pennoni che punteggiano il percorso della Kunstmeile: un segno visibile di presenza culturale e partecipazione artistica. Un altro obiettivo fondamentale è il rafforzamento della rete stessa: attraverso incontri regolari tra direzioni, team di marketing e uffici stampa, si costruiscono connessioni solide e una collaborazione costante tra istituzioni”. Non mancano le gallerie private, come la consolidata Conradi, fondata nel 2008 da Elena e Heiner Conradi, o la più giovane Galleria Melike Bilir, focalizzata sulla sperimentazione nell’arte contemporanea e nella performance. La galleria espone artisti internazionali emergenti e promuove il dialogo tra le arti visive e altri ambiti interdisciplinari, attraverso progetti indipendenti e collaborazioni. Gli artisti vengono selezionati attraverso la rete della gallerista e il lavoro di curatori esterni, in un processo dinamico che consente di scoprire costantemente nuove posizioni. Come ci racconta Melike Bilir, la scena indipendente ad Amburgo è vivace, anche se lo scambio tra questa, il mercato dell’arte e le istituzioni potrebbe essere più stretto. “Il vecchio modello del mercato dell’arte sta raggiungendo i suoi limiti”, osserva. “I costi aumentano, il pubblico cambia. Siamo alla ricerca di nuove strade. Il collezionismo deve tornare a nascere dalla curiosità. Il pubblico va ripensato. Anche il rapporto con gli artisti dovrebbe essere più aperto e flessibile”
Helphilarmonie
HAMBURGER KUNSTHALLE
2 Uno dei più importanti musei d’arte in Germania, la Kunsthalle di Amburgo, ospita una ricca collezione che spazia dal Medioevo al contemporaneo. Il complesso architettonico unisce armoniosamente tre edifici di epoche diverse, offrendo un percorso artistico attraverso secoli di storia. Adiacente alla Kunsthalle la Galerie der Gegenwart ospita la collezione d’arte contemporanea, con opere di artisti internazionali del XX e XXI Secolo. La struttura, progettata da Oswald Mathias Ungers, si distingue per il suo design minimalista e geometrico.
BUCERIUS KUNST FORUM
3 Il Bucerius Kunst Forum prende il nome da Gerd Bucerius, un importante avvocato, politico e mecenate tedesco, nonché uno dei fondatori del celebre settimanale Die Zeit. Ospita ogni anno quattro mostre con opere d’arte che spaziano dall’antichità ai giorni nostri. È un luogo di scambio e incontro in tutti i settori delle arti figurative.
SPEICHERSTADT
ST. GEORG
Deutsches SchauSpielHaus
DEICHTORHALLEN
4 Le Deichtorhallen di Amburgo sono dedicate all’arte contemporanea e alla fotografia. Con i loro tre edifici – Sala per l’arte contemporanea, Casa della fotografia e Collezione Falckenberg – in due sedi e una superficie espositiva di 10mila m², sono uno dei più grandi centri espositivi di questo tipo in Europa.
MUSEUM FÜR KUNST UND GEWERBE HAMBURG
5 Il Museo di Arti e Mestieri di Amburgo (MK&G) è uno dei più importanti centri europei dedicati al design. La sua variegata collezione abbraccia un arco temporale di 9mila anni, dal passato remoto fino ai giorni nostri. Numerose mostre, eventi e progetti offrono uno sguardo sull’evoluzione sociale e mettono in discussione il modo in cui è strutturato il mondo.
KUNSTHAUS HAMBURG + KUNSTVEREIN HAMBURG
6 Il Kunsthaus Hamburg è un centro dedicato all’arte contemporanea: uno spazio espositivo partecipativo, un luogo di produzione artistica e una piattaforma di discussione e riflessione sulla politica culturale. A fianco troviamo il Kunstverein che dal 1817 si dedica alla presentazione e alla divulgazione delle giovani posizioni artistiche del proprio tempo e funge da piattaforma per un confronto costruttivo sui nuovi percorsi nell’arte.
AD AMBURGO LA CULTURA
NON OCCUPA SOLO GLI SPAZI:
Lo dimostra il lavoro della Hamburg Kreativ Gesellschaft, un’agenzia cittadina che da anni accompagna la scena creativa locale offrendo spazi, connessioni e strumenti, ne abbiamo parlato con Jean Rehders, direttore della comunicazione. “Tutte le attività della Hamburg Kreativ Gesellschaft contribuiscono a rendere Amburgo più creativa e quindi più vivibile e attraente. In molti luoghi della città creiamo le condizioni fondamentali affinché i creativi possano svolgere il loro lavoro e sviluppare il loro potenziale. Mettiamo a disposizione spazi accessibili e utilizzabili a lungo termine per gli attori dell’industria creativa di varie dimensioni, dai liberi professionisti alle start-up fino alle aziende con più dipendenti. Negli ultimi 15 anni abbiamo sviluppato una competenza specifica nell’acquisizione di spazi adeguati e nell’utilizzo da parte di creativi. Per molti questo è il presupposto essenziale per poter svolgere il proprio lavoro a condizioni sostenibili. In questo modo contribuiamo a rendere possibile il lavoro creativo ad Amburgo. Mettiamo attivamente a frutto questa competenza nei processi di sviluppo urbano. Nell’Oberhafen, l’ex scalo merci ai margini del porto, stiamo sviluppando insieme alla HafenCity Hamburg GmbH un quartiere vivace con molteplici utilizzi: dalle gallerie, ai club musicali e agli studi di architettura, dai laboratori per la costruzione di scenografie e il fondo per il riutilizzo di elementi scenografici ‘Hanseatische Materialverwaltung’. Anche nella Speicherstadt, abbiamo promosso con il blocco M28 un luogo dedicato al lavoro creativo: qui si trovano aziende di realtà virtuale, ateliers condivisi, agenzie cinematografiche e, con SPACE, anche il nostro spazio di innovazione per aziende digitali e di contenuti. Nel bacino di contenimento delle acque a Hammerbrook abbiamo creato un’area dedicata alle arti figurative, agli ateliers e ai club. Luoghi come questi hanno un impatto che va ben oltre il loro contesto immediato: attraggono visitatori, rafforzano l’offerta culturale e possono stimolare l’inserimento di altre aziende. Mettiamo questa esperienza anche al servizio di nuovi progetti di sviluppo urbano, come la pianificazione del nuovo quartiere di Oberbillwerder o i processi di trasformazione come quello della futura stazione ferroviaria di Diebsteich. Lì attiveremo temporaneamente gran parte dell’ex centro di smistamento pacchi per usi creativi. Un’attenzione particolare è rivolta anche alla rivitalizzazione del centro città: con il programma Frei_Fläche, negli ultimi tre anni abbiamo realizzato oltre 125 utilizzi creativi temporanei in circa 90 spazi commerciali vuoti nel centro città. Anche l’ex Karstadt Sports è stato trasformato nel corso di tre anni, con il progetto Jupiter, in un grande magazzino creativo e in un luogo aperto alla cultura, al design e allo scambio. Progetti di questo tipo danno un impulso importante allo sviluppo sostenibile del centro città, offrendo una risposta al problema degli spazi vuoti, dell’uso monotono e del ritiro della vita urbana dai centri. Il nostro lavoro non solo è apprezzato all’interno di Amburgo, ma serve anche come modello sovraregionale per lo sviluppo urbano creativo”.
La capitale del Ghana ha una storia chiave per il Paese e per tutto il continente. Da centro del commercio di schiavi a simbolo di indipendenza, Accra si trova oggi preda di colonialismi vecchi e nuovi. E il suo sistema artistico ne risente. Vi raccontiamo le sue identità e le sue contraddizioni
di NICCOLÒ LUCARELLI
Affacciata sul Golfo di Guinea, poco al di sopra dell’Equatore, Accra non è certo una città per turisti. Capitale del Ghana, centro amministrativo, economico e culturale con quattro milioni di abitanti, ospita le sedi centrali di tutte le principali banche e società commerciali, la Biblioteca Nazionale, le agenzie assicurative, i grandi mercati all’aperto da cui proviene la maggior parte dell’approvvigionamento alimentare. Ma è anche, e forse soprattutto, una città di paradossi e contraddizioni, specchio di un Paese che cerca lo sviluppo e invece troppo spesso cade nella banalità dell’occidentalizzazione. Accra è una meta interessante per chi è interessato a capire l’Africa nei suoi splendori e nelle sue miserie; uno dei primi paradossi della città con cui ci si scontra, è che nonostante sia affacciata sul mare, non ha un lungomare né spiagge pulite, a causa del forte degrado ambientale che ancora la caratterizza.
Accra sorge nella zona equatoriale secca del Ghana, nel territorio dei Ga, un gruppo etnico ancora oggi dominante nella regione, ma che sembra provenire dalle rive inferiori del fiume Volta. Al suo arrivo, moli secoli fa, la pianura di Accra era punteggiata da lagune ricche di sale e fiumi ricchi di pesce; e queste due risorse, insieme all’agricoltura, divennero la base della prima economia locale. La futura città si sviluppò nel XV Secolo a partire da alcuni piccoli villaggi, in un regno la cui capitale era Ayawaso, oggi parte dell’area metropolitana moderna. Nel Seicento, britannici, olandesi e danesi svolgevano un intenso commercio di schiavi verso le piantagioni di cotone americane, da quella che all’epoca era nota come la Costa d’Oro (citata anche dai Rolling Stones nella celebre Brown Sugar), e nella prima metà del secolo costruirono i loro avamposti commerciali: gli olandesi eressero Forte Crèvecœur (dal 1868 noto come Forte Ussher. in onore del governatore Herbert Taylor Ussher dopo l’acquisto da parte dei britannici), mentre i britannici e i danesi costruirono rispettivamente il Forte James (attorno al quale si sviluppò Jamestown) e Forte Christiansborg.
ACCRA. LE DATE CHE CONTANO
1649 Gli olandesi erigono Fort Crèvecœur
1661 I danesi erigono Fort Christiansborg
1673 I britannici costruiscono Fort James
1822 Viene pubblicato ad Accra il Royal Gold CoastGazette and Commercial Intelligencer, primo quotidiano del Ghana
1877 Accra è la capitale della colonia britannica della Costa d’Oro
1883 NeilsWalwin Holm apre ad Accra il suo studio fotografico
1908 Costruzione della ferrovia fra Accra, all’epoca il porto più importante del Paese, e Kumasi, importante centro di raccolta del cacao ghanese
1923 Apre la Accra High School, prima scuola superiore della città
1947 Nasce la United Gold Coast Convention (UGCC), uno dei primi movimenti nazionalisti (4 agosto)
1948 Il sergente Fredrick Nii Adjei Adjetey viene ucciso dalla polizia coloniale durante una manifestazione di veterani (28 febbraio)
1954 Nasce il National Liberation Movement (19 settembre)
1957 Accra è la capitale del dominion del Ghana (6 marzo)
1960 Accra è la capitale della Repubblica del Ghana (1° luglio)
1980 La popolazione di Accra raggiunge un milione di abitanti
2007 Si corre ad Accra la prima edizione dell’Accra International Marathon
2014 Si insedia ad Accra la Missione ONU per affrontare l’emergenza Ebola

L’ARCHITETTURA IBRIDA DI ACCRA
L’arrivo degli europei portò i primi cambiamenti in architettura: prima, gli edifici tradizionali erano costituiti da telai in legno ricoperti di fango/argilla o strati pressati di fango/argilla e con un tetto di paglia o altro materiale; ma la presenza europea ispirò la nascita di uno stile ibrido, detto “afropeo”, che vide sorgere fra il XVII e il XVIII Secolo, soprattutto nel quartiere costiero di Jamestown, edifici in pietra, laterite e cemento; quest’ultimo materiale serviva a rendere le facciate lisce, in modo da poterle verniciare. Jamestown è particolarmente ricca di questi edifici, ma, come sta accadendo con il patrimonio architettonico coloniale di Dakar, questi monumenti vengono abbattuti dalla speculazione, o versano in condizioni di degrado; fra questi, Temple House, gli Hutton Mills e Adawso House. Fra gli edifici andati perduti, il Sea View Hotel, dove, alla fine del XIX Secolo, soggiornarono anche il giornalista britannico Henry Stanley e l’esploratrice Mary Kingsley. Quando abbattuti, questi monumenti sono sostituiti da anonimi edifici in vetrocemento, logori simboli di una modernizzazione standardizzata che uniforma e deforma il volto di tante città del mondo.
Per tutto il XVIII Secolo, Accra si mantenne fra le aree più importanti per il commercio di schiavi e oro sulla costa ghanese. Gli incentivi economici che spingevano le tribù a impegnarsi nel commercio di schiavi promuovevano un clima di illegalità e violenza, e lo spopolamento e la persistente paura della prigionia rallentarono lo sviluppo economico in gran parte dell’Africa occidentale, cosa di cui le popolazioni locali pagano ancora oggi le conseguenze. Nel 1874 gli schiavi della colonia vennero finalmente emancipati e nel 1877 Accra divenne la capitale della colonia inglese della Costa d’Oro; cominciò l’afflusso di amministratori britannici e coloni europei, per accogliere i quali, alla fine del XIX Secolo venne fondato Victoriaborg, situato nella zona orientale; la zona commerciale più attiva era invece Jamestown, soprattutto per la compravendita di cacao e olio di palma. Nacque il Distretto Centrale degli Affari, e con la ferrovia per Sekondi-Takoradi (cittadina sulla costa occidentale), Accra si sviluppò definitivamente come centro economico, mentre le attività produttive erano soggette alle restrizioni coloniali (una situazione simile a quella vissuta dall’India).
ACCRA NEL PRIMO NOVECENTO
La città fu ampliata nel 1908, a seguito di una delle ultime epidemie di peste che flagellò la regione; nella zona settentrionale venne costruito Adabraka, quartiere riservato agli indigeni, per alleviare i problemi di congestione nel sovraffollato centro cittadino. I regolamenti coloniali influenzarono l’assetto di Accra, perché fino al 1923 la legge imponeva una rigida separazione fra quartieri europei e africani, e tutti i nuovi edifici dovevano essere costruiti in pietra o cemento. A livello sociale, la Seconda guerra mondiale cambiò la demografia della regione, concentrando i lavoratori in poche grandi città costiere come Accra, Kumasi e Sekondi, e il governo coloniale lanciò un programma per far fronte alla carenza di alloggi; anche ad Accra, l’urbanizzazione conobbe nuovo im-
KANESHIE
LARTEBIOKORSHIE
MAMPROBI
I MUSEI E LE GALLERIE DI ACCRA. UNA MAPPA
MUSEO NAZIONALE DEL GHANA
1 Fondato il 5 marzo 1957 e riaperto nel 2022 dopo un restauro, è il principale custode del ricco patrimonio culturale nazionale. Le sue vaste collezioni spaziano dall’archeologia, all’etnografia e all’arte. Sebbene non tutte le tribù e le esperienze del Ghana siano rappresentate nella collezione, questa offre un’ottima panoramica del patrimonio e della cultura ghanese, nonché una narrazione esaustiva del passato e del presente del Ghana. La collezione permanente conserva abiti tradizionali, strumenti musicali, oggetti vari, gioielli, tessuti tradizionali, manufatti in legno e ceramica, maschere e statue in legno. C’è anche una collezione etnografica sui Paesi limitrofi. Il museo vanta anche un giardino di sculture che espone, tra le altre opere d’arte, statue a grandezza naturale di personaggi storici come Kwame Nkrumah, il primo presidente del Ghana.
MUSEO DELLA SCIENZA
E DELLA TECNOLOGIA
2 Aperto nel 1965, su iniziativa di due docenti dell’Università del Ghana che presentarono una proposta all’allora presidente Kwame Nkrumah, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sugli sviluppi passati e presenti nel campo della scienza e della tecnologia in Ghana. Sessanta anni più tardi, il museo vuole ancora ispirare i visitatori, in particolare i più giovani, a scoprire di più sulle scienze e sullo sviluppo tecnologico nel mondo che li circonda. Tra i pezzi della collezione permanente, figurano un cuore umano e un frammento di pietra lunare. Il museo ospita una biblioteca e offre attività didattiche per bambini.
Liberia Road
DU BOIS MEMORIAL CENTER FOR PAN-AFRICA CULTURE
3 Il memoriale sorge in quella che fu l’abitazione del sociologo statunitense William Edward Burghardt Du Bois che ha trascorso gran parte della sua esistenza nella lotta per l’emancipazione dell’uomo nero attraverso il panafricanismo. L’edificio rettangolare bianco e nero sorge al centro di un parco con alberi, fiori e un acquario. All’interno, la sala principale espone manoscritti, altri cimeli di DuBois e i ritratti di alcune celebrità del Ghana e dell’Africa. C’è anche una biblioteca con i testi di Du Bois e di altri grandi scrittori. Dichiarato monumento nazionale dal governo del Ghana, l’edificio conserva ancora oggi le urne cinerarie di Du Bois e della moglie Shirley.
22 First Circular Road
USHER
4 Costruito dagli olandesi nel 1649 con pietra locale ricavata dalle scogliere di Jamestown, e chiamato Fort Crèvecœur fino al 1868, inizialmente fu una base commercialeper lo scambio di armi da fuoco e polvere da sparo in cambio di avorio e oro. Ben presto, tuttavia, il commercio si concentrò sugli esseri umani. E oggi il forte, Patrimonio UNESCO, ospita il Museo degli Schiavi e il Centro Documentario: una storia della tratta raccontata attraverso gli strumenti per la schiavitù (ceppi, catene, ferri per la marchiatura, eccetera), dipinti e disegni sulla vita tradizionale ghanese, le mappe delle rotte commerciali del traffico di essere umani verso l’America. Una visita è quasi un dovere morale per capire le responsabilità dell’Europa verso l’Africa.
High Street, Atta Mills
1957 GALLERY
5 Sorge all’interno del Kempinski Hotel, nel quartiere di Ridge, e ha contribuito a lanciare artisti locali come AmoakoBoafo, Serge AttukweiClottey e Rita MawuenaBennisan, sulla scena internazionale. La galleria presenta regolarmente anche le opere di fotografi e artisti multimediali di fama internazionale come il newyorkese Lyle Ashton Harris e la londinese Phoebe Boswell.
66 Gamel Abdul Nasser Avenue
AMBA GALLERY
6 Fondata nel 1972 dal collezionista Amadu Baba, è uno spazio creativo multidimensionale, che offre uno scorcio sulla vasta collezione privata d’arte panafricana del fondatore, ma anche lo scopo di educare un pubblico eterogeneo sulla provenienza della storia dell’arte e del design africano. Per questo la galleria è una piattaforma per programmi specializzati e forum di discussione, collaborando con diverse gallerie, artisti, curatori, accademici ed esperti del settore africani.
Education Close, Barnes Road
pulso. Poi, dopo la guerra, i quartieri di Ridge e Cantonments furono progettati come complessi residenziali a bassa densità per gli europei, mentre i quartieri per l’immigrazione interna, come Nima e le aree circostanti, non conobbero piani regolatori, ma soltanto la forma caotica della baraccopoli.
LA RIVOLTA DEL MARZO 1948
Il 28 febbraio 1948 diverse centinaia di veterani del Reggimento della Costa d’Oro (uno fra i più decorati reparti militari africani) organizzarono una pacifica marcia verso Forte Christiansborg, residenza del governatore britannico, per chiedere il pagamento delle pensioni di guerra. Intervenne però la polizia coloniale, e il brigadiere britannico Colin Imray ordinò di sparare sui manifestanti, ma i poliziotti esitarono; in un impeto di rabbia, Imray imbracciò il fucile e sparò, uccidendo tre veterani, tra cui il sergente Fredrick Nii Adjei Adjetey, alla cui memoria esiste oggi un monumento in 28th February Road. In seguito a questi barbari assassinii, la gente di Accra scese nelle strade e la United Gold Coast Convention, uno dei primi movimenti nazionalisti ghanesi, guidò quella che fu una vera e propria rivolta durata cinque giorni e che coinvolse Accra e altre città: ci furono scontri armati e molte attività commerciali asiatiche ed europee furono saccheggiate. Tuttavia, con l’imposizione del coprifuoco e di altri, stringenti regolamenti di polizia, la rivolta fu domata entro il 5 marzo.
Una settimana più tardi furono arrestati per un mese i principali attivisti. Tuttavia, poiché non era più possibile ignorare la campagna di “azione positiva” avviata da Nkrumah, che prevedeva proteste non violente, scioperi e non cooperazione con le autorità, il governo coloniale istituì la Commissione Watson, che aprì la strada ai cambiamenti costituzionali che portarono, il 6 marzo 1957, all’unificazione della Costa d’Oro, della regione di Ashanti, dei Territori del Nord e del Togoland britannico in quello che divenne un unico dominio indipendente all’interno del Commonwealth britannico sotto il nome di Ghana, con la città di Accra come capitale. Con quell’atto, il Ghana fu il primo Paese subsahariano a dichiarare l’indipendenza. Divenuto Primo Ministro, Nkrumah volle celebrare l’orgoglio e il nazionalismo africani: nacque così Piazza dell’Indipendenza, che accoglie l’Arco dell’Indipendenza sormontato dalla stella nera, simbolo della liberazione dal giogo del colonialismo. Sulla parete campeggiano le iscrizioni “1957 d.C.” e “Libertà e Giustizia”.
ACCRA E I LUOGHI DELLA SUA CULTURA
Oltre ai forti coloniali, i principali luoghi d’interesse di Accra includono il Museo nazionale, la Ghana Academy of Arts and Sciences, gli Archivi nazionali e la Biblioteca centrale, il Teatro nazionale, l’Accra Centre for National Culture; ognuno di essi è un tassello del mosaico storico-culturale del Paese, e una visita aiuta a orientarsi nelle sue complesse vicende, non soltanto coloniali ma anche sociali. Passeggiando per la città, invece, fra i luoghi più piacevoli e insieme significativi, il Kwame Nkrumah Memorial Park: situato nel cuore della città, è intitolato al primo presidente del Ghana, e ospita al suo interno anche un museo che ne racconta la vita attraverso documenti, i suoi libri, i
Specchio delle sperequazioni che ancora affliggono l’umanità, e che schiacciano l’Africa sul fondo della Terra, la piaga del riciclaggio illegale dei rifiuti elettronici ad Accra. Fino al 2021, quando è stata finalmente chiusa, avveniva ad Agbogbloshie, allucinante discarica di dimensioni ciclopiche, che sorgeva su fiume Odaw, per la precisione sulla laguna Korle, nei pressi del centro di Accra, e della baraccopoli OldFadama; qui affluivano rottami automobilistici ed elettronici provenienti principalmente dal mondo occidentale, attraverso una rete di esportazione legale e illegale, e qui venivano illegalmente smaltiti.Setacciando tonnellate di rifiuti elettronici, bruciandoli per estrarne il rame e altri metalli, gli abitanti di Agbogbloshie vivevano, mangiavano, lavoravano avvolti in nubi di diossina e in precarie condizioni igieniche. Anche i bambini in età scolare trascorrevano ogni sera e ogni fine settimana a lavorare i rifiuti e a cercare metalli. In questo “villaggio” di baracche di legno prive di acqua e servizi igienici proliferavano violenza, spaccio di droga e prostituzione. Dal 2021 il governo ghanese ha posto fine a questa vergogna, ed è ora impegnato a ripristinare la salubrità e la bellezza della laguna. Il problema è che nuove Agbogbloshiestanno sorgendo lungo la costa del Ghana e in tante altre aree del Sud del mondo, e ognuna di esse è una chiara accusa all’atteggiamento dell’Occidente verso l’Africa e al funzionamento dell’economia circolare nel settore dell’elettronica, perché se è vero che un numero crescente di produttori sostengai principi di detta economia e promuova il riciclo, l’aumento delle discariche in Africa fa sospettare che dietro gli slogan ci sia ancora molta ipocrisia. Della quale fanno le spese la natura e le popolazioni africane.
camici che indossava da combattente per la libertà e persino la sua vecchia auto. Nei fine settimana, spesso si svolgono eventi culturali e spettacoli vari. Questo parco è l’unica oasi di verde pubblico della città, che soffre di uno spaventoso inquinamento a causa delle emissioni dei veicoli e dei roghi di rifiuti.
ACCRA, TRA DIVISIONI
E CONTRADDIZIONI
Scenario diverso, con strade pulite, parchi privati e piscine, nelle zone residenziali per i ricchi ghanesi o per i tanti stranieri che vivono ad Accra, questi ultimi quasi sempre bianchi. Come tante, troppe altre città africane, Accra è un coacervo di contraddizioni e sperequazioni, ma quello che colpisce, in senso negativo, è che non sembra esserci una vera via africana al progresso o comunque al miglioramento delle condizioni di vita: anche qui, modernizzare significa occidentalizzare; su questo presupposto, negli ultimi anni sono sorti in città locali notturni, ristoranti, caffetterie, alberghi, che sono repliche esatte dei noiosi e patinati ambienti che banalizzano tante città europee, statunitensi, emiratine, cinesi e giapponesi, dove si va per vedere gli altri e per farsi vedere, pesci in un acquario con l’illusione di essere squali del Pacifico. Ecco perché, paradossalmente, se si viene ad Accra in cerca di Accra e dell’Africa, si finisce per apprezzare i rumorosi e polverosi mercatini sui marciapiedi, quell’umanità indaffarata e autentica che abita gli “insediamenti informali”, che affolla i malridotti minibus chiamati trotto e le colorate feste tradizionali di proporzioni quasi bibliche; perché è in queste situazioni che si osserva e si conosce, per citare Karen Blixen, “l’Africa in corpo e sangue”, un’idea di vita in perenne armonia con il paesaggio e la natura, come la radice che cresce dove trova spazio o la gazzella che cerca l’acqua nella savana.

Accra è anche lo specchio di un continente ancora oggi depredato dall’avidità delle nuove potenze coloniali, che sono in gran parte quelle vecchie, cui si sono aggiunte la Cina (che in cambio di concessioni commerciali ha recentemente restaurato il porto di Jamestown), la Russia e l’Australia. E sono ancora da capire gli effetti della Association of China-Ghana Mining, una nuova conglomerata mineraria impiantata da aziende cinesi ad Accra lo scorso aprile, con lo scopo di approfondire la cooperazione tra le imprese minerarie cinesi e ghanesi, e promuovere sinergie tecnologiche sostenibili; da capire, appunto, se l’impegno verso pratiche industriali responsabili e sostenibili sarà onorato, oppure sarà l’ennesimo atto di neocolonialismo. Intanto, la tragica scomparsa, il 6 agosto 2025, del ministro dell’Ambiente Ibrahim Murtala Muhammed in un incidente in elicottero nella regione di Ashanti, ha posto fine al suo indefesso impegno contro l’estrazione illegale dell’oro.
in alto: Mercato di Osu, Accra. Photo Seyiram Kweku
Oggi, Accra è il terzo mercato immobiliare africano in più rapida crescita, preceduta solo da Nairobi e Lagos, nonostante l’inflazione e l’aumento del tasso d’interesse sui mutui. Il previsto aumento, nel medio periodo, della domanda di immobili di fascia medio-alta,

Al momento, il commercio di strada ad Accra è al centro di un piccolo caso sociale: l’affollamento quotidiano di commercianti e bancarelle improvvisate che si riversano sui marciapiedi della città rende quasi impossibile la circolazione pedonale, e causa difficoltà anche a quella degli autoveicoli. In questa giungla quotidiana che si potrebbe davvero chiamare d’asfalto, la lotta per lo spazio tra veicoli e persone si è trasformata in una sfida quotidiana. Per regolare questi mercatini informali e agevolare il traffico automobilistico e pedonale, l’Assemblea Metropolitana di Accra ha avviato un’operazione “di decongestione”, cercando di convincere i commercianti ad abbandonare pacificamente gli spazi; ma molti di loro, soprattutto donne, cercano di eludere i divieti, lamentando la mancanza di mezzi di sussistenza alternativi, con il risultato che scontri verbali e piccoli tafferugli sono all’ordine del giorno sui marciapiedi di Accra. Esistono tuttavia anche i mercati ufficiali, fra cui i più famosi sono quello di Makola, situato su Kojo Thompson Road, e quello di Osu, in Basel Street.
MAKOLA
Costruito nel 1924 (ma successivamente rimodernato), il più grande mercato all’aperto di Accra, Makola, è il cuore e l’anima della città, epicentro per lo scambio di beni e servizi, ma anche di relazioni e cultura. Come la zona di Colobane a Dakar, anche Makola è un mercato che trascende il normale spazio commerciale e si riversa letteralmente nelle strade circostanti, che inonda per chilometri di tessuti, pezzi di ricambio per auto, alimenti di ogni genere, gioielli artigianali, rimedi omeopatici, abiti, scarpe, sandali. Un incredibile mélange di persone di tutte le età, merci di tutti i tipi, suoni, colori, traffico di veicoli, carretti, biciclette, ciclomotori e occasionali animali. L’Africa nella sua bellezza urbana.
OSU
Una destinazione vivace e colorata nel cuore di Accra, celebre per la sua atmosfera vibrante, il cibo di strada e l’artigianato. L’atmosfera diventa particolarmente affascinante alla sera, con le bancarelle illuminate da centinaia di lanterne e candele, mentre la musica dal vivo riempie l’aria. Il mercato è un centro comunitario che mette in mostra le ricche tradizioni e il tessuto sociale di Accra. I visitatori possono anche godersi la vivace vita notturna con diverse opzioni di intrattenimento, tra cui spettacoli dal vivo e danze tradizionali, che arricchiscono l’esperienza. Mentre esplorate il mercato, non perdete l’occasione di provare bevande uniche come il sobolo (la tipica bevanda all’ibisco) o il vino di palma, che si abbinano perfettamente ai saporiti piatti locali.
soprattutto nelle zone centrali più prestigiose, sostiene quello dei prezzi; e se da un lato Accra continua ad attrarre acquirenti da tutto il mondo, dall’altro allontana il ceto medio-basso, che molto spesso vive in case d’affitto i cui canoni sono adesso insostenibili. La soluzione è l’esodo forzato in quartieri-baraccopoli, dove l’abitazione-tipo è un piccolo chiosco di legno, dalla superficie media di 5-6 metri quadrati, e almeno una finestra per la ventilazione. Gli allacciamenti alla rete elettrica sono quasi sempre “artigianali”, a volte anche illegali, con la conseguenza di essere inaffidabili e pericolosi. Inoltre, mancano spesso i servizi igienici, e i residenti si arrangiano con soluzioni improvvisate, certamente pratiche ma altrettanto certamente dannose per la salute. Uno degli insediamenti informali più grandi è Ayigbe Town, sorto attorno ai tralicci dell’alta tensione.
Dagli Anni Novanta si è cercato di attuare programmi per contrastare il deficit di alloggi e alleviare le difficoltà finanziarie di chi cerca casa; ma la credibilità del governo ha recentemente subito un duro colpo a causa della cattiva gestione di un importante progetto di edilizia popolare a Saglemi, alla periferia della Grande Accra; sono attualmente sotto processo per corruzione l’ex ministro delle risorse idriche, dei lavori pubblici e degli alloggi, Alhaji Collins Dauda, il
ALL’OMBRA DI MINARETI
E CAMPANILI, LA VITA AD
ACCRA SCORRE FEBBRILE MA
PACIFICA, PUR IN MEZZO ALLE
ALL’ONNIPRESENTE RISCHIO
DELL’OCCIDENTALIZZAZIONE
suo successore Kwaku Agyeman-Mensah, e tre funzionari. Anche per le inefficienze del governo, Accra rimane una città sottosviluppata, dove larghe fasce della popolazione non hanno accesso all’istruzione e ai servizi di base. Ma un aspetto sicuramente positivo di Accra, e del Ghana tutto, è la forte multiculturalità accompagnata dall’assenza di tensioni etniche o religiose; la città si “divide” fra cristiani e musulmani, ma la fede non è una discriminante. Meritano anzi una visita sia la Moschea Nazionale del Ghana (la seconda più grande dell’Africa occidentale, costruita nel 2012 in stile neo-ottomano, può accogliere 3mila fedeli nei suoi interni dalle vetrate colorate), sia la cattedrale anglicana della trinità, eretta nel 1894 su progetto di Aston Webb, le cui pareti in mattoni ricordano le chiese della campagna inglese. All’ombra di minareti e campanili, la vita ad Accra scorre febbrile ma pacifica, pur in mezzo alle difficoltà quotidiane e all’onnipresente rischio dell’occidentalizzazione.
Accra non è soltanto una grande città. È anche un luogo intriso di ancestrale spiritualità, che ospita importanti feste e celebrazioni cui partecipano grandi, allegre masse colorate, unite nell’orgoglio di essere ghanesi e in un rapporto di comunione con la natura e gli antenati.
HOMOWO
Celebrata dal popolo Ga in tutta la regione della Grande Accra, si tiene dalla fine di aprile a tutto il mese di maggio; la festa commemora una grande carestia che flagellò la regione in epoca precoloniale. Ad Accra, come nelle altre città e nei villaggi, si svolge con una suggestiva processione accompagnata da tamburi, canti e danze, il momento culminante della quale è il rito dell’offerta del kpokpei agli dèi e agli antenati per ottenere la loro protezione. Il kpokpei è un piatto a base di miglio cotto a vapore, al quale si aggiunge olio di palma e foglie di okro (una pianta della famiglia delle malvacee originaria dell’Africa orientale). Una delle usanze più singolari della festa è che da mezzogiorno alle 18 qualsiasi donna, indipendentemente dal suo status civile, dovrebbe accettare ogni abbraccio offertole dagli uomini che incrocia per strada.
ASAFOTUFIAM
È una festa annuale che si celebra il primo sabato di agosto ad Ada, 71 km a est di Accra, per commemorare le imprese guerriere degli antenati e i caduti sul campo di battaglia. A metà fra memoria storica e culto degli antenati, prevede l’esecuzione della Kpatsa (una danza locale), cerimonie di purificazione e un durbar dei capi tribali locali (il durbar è un rituale dai molteplici significati, in questo caso assume quello della celebrazione di eventi storici del passato e del mantenimento delle radici culturali dei clan).
KPLEDJOO
È un festival annuale che si svolge fra marzo e aprile. Promuove il recupero della laguna di Sakuma e la sostenibilità della tradizionale raccolta dei granchi. Infatti, cinque mesi prima della festa, entra in vigore un divieto temporaneo della pesca e della cattura di granchi nella laguna. Nel giorno della celebrazione, il sacerdote (o la sacerdotessa) a capo della laguna esegue sulle rive alcuni rituali propiziatori prima che i pescatori possano immergersi nelle sue acque.

Assistente Direttore del Ghana Museums and Monuments Board, Malik Saako Mahmoud risponde alle nostre domande, per raccontarci in che modo il patrimonio ghanese viene preservato e promosso.
Qual è la missione del Ghana Museums and Monuments Board?
Nato nel 1957, è il custode legale del patrimonio culturale del Paese, e ha lo scopo di è identificare, acquisire, preservare, documentare e promuovere tale patrimonio. Il GMMB gestisce nove musei e regolamenta l’esportazione e il commercio di antichità, inclusa la ricerca archeologica, attraverso il rilascio di permessi per tali attività. Inoltre, ai sensi dell’Art. 39 della Costituzione ghanese del 1992, il GMMB, per conto dello Stato, si impegna a preservare e proteggere i luoghi di interesse storico, compresi i siti UNESCO.
Avete programmi per studenti e bambini?
Il Dipartimento Educativo organizza in genere programmi di servizio scolastico per bambini dai 7 ai 15 anni. Occasionalmente, il dipartimento invita le scuole primarie del suo bacino di utenza a partecipare a vari programmi presso il Museo Nazionale del Ghana. Nel marzo 2024, studenti di arti visive
di alcune scuole superiori della Grande Accra sono stati invitati a esporre le loro opere in uno spazio dedicato all’interno della Galleria del Museo Nazionale del Ghana. L’obiettivo era infondere speranza e fiducia negli studenti riguardo al percorso professionale scelto, sottolineando al contempo l’importanza del coinvolgimento della comunità come aspetto chiave della sensibilizzazione museale del XXI Secolo. Questa iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico e incoraggiare la partecipazione alle attività museali.
Qual è il sostegno del governo alla cultura in Ghana?
Il Ghana Museums and Monuments Board fa capo al Ministero del Turismo, della Cultura e delle Arti Creative, e gestisce, per il 2025, un budget di 12,6 milioni di dollari con i quali sta realizzando significativi lavori di ristrutturazione e miglioramento delle varie fortezze antiche del Paese. In collaborazione con l’UNESCO, il governo sta sviluppando un piano di gestione di questi siti storici. Inoltre, il governo assicura lo sviluppo del personale del GMMB attraverso congedi per studio retribuiti, corsi e programmi online, consentendo loro di crescere professionalmente a beneficio della gestione del patrimonio culturale del Paese.

Le poche gallerie e gli spazi espositivi esistenti tendono a essere piccoli e difficili da avvicinare. Le istituzioni artistiche nazionali sono sottofinanziate e molte versano ora in condizioni deplorevoli. Per incoraggiare e sostenere l’attività dei giovani artisti, nel 2014 il professor Elikem Nutifafa Kuenyehia ha fondato il Kuenyehia Trust for Contemporary Art. Un tentativo di promuovere e migliorare l’arte contemporanea africana, lanciandola sul mercato locale e internazionale. Ne parliamo con lui.
Com’è nata l’idea del Trust e del Premio?
Nei primi Anni Duemila, ho sviluppato una passione per l’arte e ho iniziato a collezionare opere di artisti emergenti. La mia prima opera è stata un disegno a matita su acrilico che ho acquistato per soli 50 dollari. Tuttavia, dieci anni dopo, sono rimasto stupito nello scoprire che quel disegno si è rivelato essere il pezzo più prezioso della mia collezione, con qualcuno che mi aveva offerto 10mila dollari! In quel periodo, il mercato dell’arte africana era in forte crescita. Tuttavia, in Ghana, molti artisti di talento non ne beneficiavano Quindi ho fondato il KuenyehiaPrize,per incoraggiare i giovani artisti ghanesi a perseguire le proprie passioni. Sebbene il premio di 10mila dollari sia significativo, ciò che è ancora più importante è la formazione che offriamo agli artisti, li mettiamo in con-
tatto con collezionisti e appassionati d’arte, offrendo loro opportunità che altrimenti non avrebbero avuto.
Quali sono i risultati più importanti raggiunti in questi anni?
Molti degli artisti che abbiamo supportato hanno esposto le loro opere in importanti fiere d’arte come Art X Lagos, FNB Johannesburg Art Fair, e in vari eventi in Paesi come Stati Uniti, Spagna e Dubai. Abbiamo inoltre sviluppato il Creative Accelerator Programme, per aiutare gli artisti a sviluppare le proprie competenze nel trasformare la propria arte in attività imprenditoriali sostenibili. Attraverso il CAP, offriamo una formazione per costruire una carriera artistica di successo. Il nostro obiettivo è condividere le migliori pratiche provenienti da tutto il mondo e offrire ai nostri artisti un tutoraggio e una formazione su misura.
Quali sono le sfide che dovete affrontare ogni anno nell’organizzazione del Premio?
Una delle più urgenti è la persistente scarsità di sostegno finanziario. Pur essendo profondamente grati per i generosi contributi dei nostri donatori attuali, il loro sostegno, seppur significativo, ha una portata limitata. Senza finanziamenti adeguati, dovremmo ridurre i programmi, ritardare gli sforzi di sensibilizzazione della comunità e rimandare mostre o residenze artistiche che potreb-
bero avere un impatto culturale di vasta portata. Il divario tra le nostre ambizioni e la nostra capacità finanziaria continua ad aumentare, per questo stiamo cercando nuove opportunità di finanziamento e sviluppando strategie creative di raccolta fondi. Crediamo che il sostegno finanziario alle arti non debba essere visto come un lusso, ma come un investimento significativo per arricchire le comunità e mantenere vivo lo spirito creativo delle generazioni future.
Qual è il ruolo del governo nel sostenere l’arte e la cultura ghanese?
Nel corso degli anni, il governo ha dimostrato un certo riconoscimento delle arti come componenti vitali dell’identità nazionale, dello sviluppo economico e della diplomazia culturale. Un esempio significativo dell’intervento governativo è l’istituzione del Ministero del Turismo, della Cultura e delle Arti Creative, che ha svolto il ruolo di organismo centrale per il coordinamento delle politiche culturali e delle iniziative creative. In collaborazione con il Ghana Culture Forum, il Ministero ha recentemente ospitato una tavola rotonda che ha riunito leader culturali e responsabili politici per proporre strategie concrete per la crescita. Ma nonostante questi sforzi, il settore continua a fare i conti con una cronica carenza di finanziamenti, infrastrutture limitate e un’azione politica incostante.

Alle spalle, le vette della Cordigliera Cantabrica. Davanti, l’Oceano Atlantico.
Fu in questa terra di leggende e orgoglio che l’Alto Medioevo ebbe uno dei suoi sviluppi più fervidi.
Un racconto delle Asturie e del loro patrimonio che attraversa secoli e resistenze

Tra oceano e montagne, le Asturie sono custodite quasi come un segreto. Arrivare in questa regione, incastonata nel nord della penisola iberica e affacciata sul Mar Cantabrico, significa confrontarsi con una terra che non vuole apparire, ma piuttosto rivelarsi un passo dopo l’altro, come in una lunga e lenta camminata. Dopotutto, le Asturie non sono solo una tappa, ma anche l’origine storica del primo Cammino di Santiago, il Cammino Primitivo, uno dei tanti tesori religiosi di questa terra millenaria. Il nome ufficiale di questo luogo, Principato delle Asturie, rivela tanto il suo carattere politico quanto il suo orgoglio, le sue radici profonde e la terra ancestrale che lo nutre.
Una sola provincia, 10mila chilometri quadrati di estensione, un milione di abitanti. Questa comunità autonoma della Spagna settentrionale – comodamente raggiungibile con voli diretti su Oviedo da Roma, Milano e Venezia – non si chiama “Principato” così per dire: c’è una vera e propria linea di successione al trono, così come c’è un principe, o – nel caso attuale – una principessa. Sua Altezza Reale Leonor di Borbone-Spagna, primogenita dell’attuale sovrano spagnolo Sua Maestà Filippo VI, nonché già Infanta di Spagna. Per comprendere l’importanza del titolo che fa capo alle Asturie è però necessario fare un passo indietro, e ripercorrere brevemente la storia di questo Principato, che un tempo era Regno, e oggi è uno degli angoli più incontaminati della Spagna.
LUOGO DALL’ANIMA ANCESTRALE
Sebbene la storia delle Asturie sia legata all’avanzata verso sud dei regni cristiani della Penisola Iberica, come vedremo più avanti, questa terra porta testimonianze di epoche molto più antiche: le pitture rupestri sparse in tutta la zona presentano espressioni artistiche risalenti al Paleolitico. Ad oggi, sono stati scoperti 15 siti archeologici con pitture rupestri, splendide testimonianze della vita e dell’arte dei nostri antenati, vissuti più di 35.000 anni fa. Più della metà di queste grotte e ripari sono oggi visitabili e cinque di esse sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Facciamo un salto in avanti di diverse decine di migliaia di anni: fu sotto Augusto, dal 29 a.C. al 19 a.C., che la regione fu protagonista di una prolungata operazione di annessione da parte del nascente Impero Romano. Una conquista che non fu portata a termine senza difficoltà: in quelle che divennero note come Guerre Cantabriche, gli Asturiani condussero una guerriglia che costrinse le legioni romane a intraprendere diverse campagne. Quattro secoli dopo, le invasioni barbariche raggiunsero anche la Spagna settentrionale, dove il regno visigoto avrebbe infine stabilito la sua egemonia.

DALLA CADUTA DEI VISIGOTI ALLA FONDAZIONE DEL REGNO DELLE ASTURIE
Nel 711, in seguito a conflitti legati al trono visigoto, il generale berbero Tariq ibn Ziyad attraversò lo stretto che oggi, in arabo, porta il suo nome: Jabal Tariq, noto a noi come Gibilterra. Le truppe berbere conquistarono sorprendentemente la penisola in tre anni, portando con sé anche la loro religione: l’Islam. È superfluo ricordare quanto preziosa fu l’influenza islamica per l’architettura e la cultura spagnola durante il loro dominio. Tuttavia, il cristianesimo non scomparve del tutto. Le Asturie, protette dalle alture dei Monti Cantabrici (che con i Picos de Europa, raggiungono i 2.600 metri), divennero un baluardo cristiano, un luogo in cui organizzare una resistenza religiosa e politica senza precedenti.
Comincia così una vicenda culminante in un episodio simbolico per la storia spagnola. Il condottiero asturiano Pelayo riuscì, insieme alle sue truppe, ad attirare i soldati musulmani a Covadonga, vincendoli tra gole spettacolari e fitti boschi. Una vittoria che non fu solo militare, ma divenne – anche per la leggendaria apparizione della Vergine Maria – mito fondativo e trovò eco nella conquista della città di Gijón/Xixón. Da quella scintilla nacque il Regno delle Asturie, gui-
in alto: Mirador del Fitu.
Photo Camilo Alonso, Courtesy Turismo Asturias
a destra: Testa di cavallo, Grotta di Tito Bustillo. Courtesy Turismo Asturias
dato proprio da Pelayo, che costituì il primo regno peninsulare a proporre un’alternativa al Califfato Omayyade. Ancora oggi, il santuario di Covadonga è un luogo di pellegrinaggio, e i boschi che lo circondano conservano la memoria di un evento che continua a definire l’immaginario collettivo spagnolo.
NASCITA, FIORITURA E CADUTA DEL REGNO DELLE ASTURIE
Comincia così, per le Asturie, un periodo di fioritura politica, spirituale e artistica. Dopo Pelayo e suo figlio Favila (morto in una prova di valore contro un orso), fu Alfonso I a prendere in mano il destino delle Asturie, facendo avanzare l’operazione di conquista territoriale verso la Galizia (a ovest) e verso la valle del Duero (a sud). Un’espansione portata avanti anche da suo figlio Fruela. A Fruela si deve il primo insediamento regale a Oviedo/Uviéu: fu qui che, tra la fine dell’VIII e l’inizio del IX Secolo, suo figlio Alfonso II “il Casto” trasferì la corte (dopo che lo zio, re Silo, l’aveva spostata a Pravia dalla sua sede originale di Cangas de Onís). Il regno di Alfonso II, così come quello dei suoi discendenti Ramiro I e Ordoño I fu segnato da guerre e la conquista, che raggiunge l’apice con re Alfonso III per poi sfaldarsi ed essere spartito tra i suoi figli, a seguito di lotte dinastiche. Il regno, che aveva raggiunto il massimo della sua estensione territoriale comprendendo gran parte dell’odierna Spagna settentrionale. Si conclude così la centralità politica

Se pensate che sia l’Alto Medioevo a fare delle Asturie un luogo antico, vi sbagliate e non di poco. Se le chiese e le città spiccano alla luce del sole, il tesoro più ancestrale delle Asturie si nasconde sottoterra, nelle cavità dei monti che caratterizzano il paesaggio di questa regione. È l’universo dell’arte rupestre asturiana, uno dei patrimoni più preziosi d’Europa, in cui l’essere umani ha lasciato le sue prime tracce di pensiero simbolico e di bellezza. Nelle Asturie, l’arte rupestre ha una particolarità rara: la concentrazione e la qualità dei suoi siti. In pochi chilometri si trovano alcune delle testimonianze più straordinarie del Paleolitico superiore, cinque delle quali riconosciute dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. Non si tratta di un insieme casuale di pitture, ma di un corpus coerente, diffuso tra le valli e le scogliere del nord, che racconta un dialogo, lungo decine di migliaia di anni, tra l’uomo e la roccia.
La grotta di Tito Bustillo, a Ribadesella, è forse la più emblematica. Scoperta nel 1968, è un labirinto di stanze e corridoi dove si susseguono oltre 100 rappresentazioni di cavalli, renne, bisonti e figure femminili stilizzate. I rossi e i neri delle pitture, ottenuti con minerali macinati e mescolati con
della regione nella determinazione del futuro spagnolo: dal Regno delle Asturie (che poi nel XIV Secolo divenne principato), lo scettro passò al Regno di León, poi a quello di Castiglia e León, che si unificò a quello di Aragona con il matrimonio tra i "Re Cattolici" Ferdinando II d'Aragona e Isabella I di Castiglia, nel 1492: il primo vero seme della Spagna moderna.
grassi animali, colpiscono per la loro vividezza policroma. Inoltre, nella cosiddetta “Camera delle Vulve”, i segni curvilinei e le forme allusive testimoniano la nascita di un linguaggio simbolico che parla di fertilità, di vita e di mistero.
Più a oriente, quasi sospesa sull’oceano, la grotta di El Pindal è localizzata in un promontorio a picco sulla scogliera di San Emeterio: sulle sue pareti cavalli, bisonti, un raro mammut e perfino un pesce tracciato con linee delicate si rincorrono nell’incontro non solo geografico, ma anche artistico tra terra e acqua. Un patrimonio risalente a un’epoca compresa tra i 13mila e i 18mila anni fa e visitabile solo nei primi 300 dei suoi 600 metri complessivi.
A Candamo, nella Grotta della Peña, le figure sembrano fluttuare nella penombra, e l’effetto della luce sulla roccia accentua la sensazione di trovarsi davanti a un teatro. È la grotta più occidentale d’Europa con arte paleolitica, e le sue incisioni sono state interpretate secondo codici magico-rituali. Ci sono poi luoghi meno noti ma altrettanto intensi, come la Grotta di El Buxu, nei pressi di Cangas de Onís, dove ai lavori parietali si aggiungono preziosi ritrovamenti di arte mobile, come una scultura di uccello scolpita a partire dalla zanna di un orso delle caverne. Le pitture e le incisioni rupestri sono anche in questo caso caratterizzate da motivi zoologici e geometrici, spesso di ardua interpretazione. Oggi molte di queste grotte non sono accessibili liberamente: l’umidità, il respiro umano e la luce possono danneggiare irrimediabilmente i pigmenti. Ma nelle Asturie si è trovato un equilibrio raro tra tutela e divulgazione. I centri interpretativi, come il Parque de la Prehistoria di Teverga, permettono di vivere l’esperienza sensoriale della grotta senza toccare l’originale, con ricostruzioni fedeli e racconti che restituiscono il silenzio, la paura e la meraviglia dei primi artisti.
ARRIVARE IN QUESTA REGIONE
SIGNIFICA CONFRONTARSI CON
UNA TERRA CHE NON VUOLE
Se il maggiore rilievo storico delle Asturie è circoscrivibile certamente al periodo altomedievale, la vita nella regione proseguì piuttosto floridamente anche nei secoli successivi. Con l’arrivo del mais dalle Americhe, la popolazione crebbe, raggiungendo i 100mila abitanti nel XVI Secolo. Un numero decuplicato nel corso dei secoli, grazie anche dalla progressiva industrializzazione della regione a partire XIX Secolo: l’estrazione del carbone e l’industria siderurgica e navale furono centrali per lo sviluppo delle Asturie moderne, affiancando alla storia, al patrimonio e al paesaggio un nuovo progresso economico, coerentemente con il resto del Paese. Lo testi-
APPARIRE, MA PIUTTOSTO
RIVELARSI UN PASSO DOPO L’ALTRO
moniano istituzioni come il MUMI - Museo de la Minería y de la Industria de Asturias a El Entrego, che racconta con rigore e passione la storia di uomini e donne che hanno reso le Asturie uno dei principali motori industriali della Spagna.
Siamo alla fine di questa storia tanto profonda da risultare necessariamente parziale su queste pagine. La scoperta delle Asturie e delle sue bellezze, dopotutto, non poteva prescindere dal racconto del suo patrimonio più prezioso, un patrimonio antico ma ancora vivo: la Storia. E non una storia qualunque, ma quella di uno dei periodi europei più interessanti e meno conosciuti, che proprio qui, tra l’Atlantico e la Cordigliera Cantabrica, ha avuto uno dei suoi più fertili sviluppi. E di cui conserva come testimonianza il più importante e coerente complesso architettonico altomedievale d’Europa. Un patrimonio, l’arte preromanica asturiana, che è stato riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
LUOGHI DEL PREROMANICO
GROTTE RUPESTRI (VISITABILI)
A VEIGA/VEGADEO
GRANDAS DE SALIME
Superficie: 10.604 km2
Numero di abitanti: 1.018.706
Densità di popolazione: 96,07 ab./km²
Numero di comuni: 78
Vetta più alta: Torrecerredo 2648 m NAVIA
Santianes de Pravia
Grotta di La Peña
San Pedro de Nora
Abrigo di Santo Adriano
Santo Adriano de Tuñón
Grotta di El Conde
Santa Cristina de Lena
AVILÉS
OVIEDO/UVIÉU
San Salvador de Valdediós
San Andrés de Bedriñana
GIJÓN/XIXÓN San Salvador de Priesca
Santiago de Gobiendes
Grotta di Tito Bustillo

Scopri di più sulle Asturie
Grotta di El Buxu
Santa María del Naranco e San Miguel de Lillo
Santa María de Bendones
CANGUES D'ONÍS/ CANGAS DE ONÍS COVADONGA/CUADONGA
Berducedo Grandas de Salime
Puerto del Acebo
Bourres Pola de Allande
Salas Tinéu
Grau/ Grado
Grotta di El Pindal
A Caridá A Veiga/ Vegadeo
San Tirso de Abres
Villamouros
Outur/ Otur
Oviedo/Uviéu
CAMMINO DI SANTIAGO PRIMITIVO
Muros de Nalón
Gijón/ Xixón Avilés
Casquita
CAMMINO DI SANTIAGO COSTIERO
Ribadesella/ Ribeseya
Bustlo Llanes Priesca
Avilés, Gijón/Xixón e Oviedo/Uviéu sono le tre città principali delle Asturie, ognuna con la propria personalità. A breve distanza l’una dall’altra e ben collegate tra loro (è possibile spostarsi facilmente in auto, treno o autobus), le tre città compongono un paesaggio urbano accogliente, caratteristico e con un presente intenso quanto il loro passato. Gijón/Xixón e Avilés, per il loro carattere marinaro e portuale, hanno le caratteristiche tipiche della zona costiera, mentre Oviedo/Uviéu – capitale del Principato – è una città dell’entroterra, circondata da nobili e storiche colline e montagne.
OVIEDO/UVIÉU
La Cattedrale di San Salvador
Parte proprio da qui, dalla chiesa costruita da Alfonso II sulle rovine di quella voluta da suo padre Fruela I “il Crudele”, il nostro itinerario. La Cattedrale di San Salvador, nel cuore del centro storico, è molto più di ciò che appare: se dall’esterno l’aspetto gotico – con un’imponente torre di 80 metri – ci proietta già alla metà del secondo millennio d.C., è nelle sue parti più nascoste che possiamo rintracciare l’anima altomedievale di questo edificio, nonché un sito dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco. Stiamo parlando della Camera Santa, la maggiore sopravvivenza della chiesa di epoca preromanica nella nuova Cattedrale: situata tra il braccio meridionale del transetto e un lato del chiostro, la Camera Santa era destinata ad accogliere le reliquie del Regno, compito a cui adempie tutt’ora.
Il Museo di Belle Arti delle Asturie Oltre 15mila pezzi della maggiore arte spagnola moderna e contemporanea: da Goya a Picasso, da El Greco a Miró. Basta questo (e non è poco) per giustificare la visita alle collezioni del Museo di Belle Arti delle Asturie. Il museo, inaugurato nel 1980, si dota di ben 4500 metri quadrati di spazio espositivo distribuito in tre edifici centro storico di Oviedo/Uviéu: il Palacio de Velarde (1765), la Casa de Oviedo-Portal (1660) e una nuova struttura completata nel 2015, su progetto di Francisco Mangado. Qui pittura, scultura, incisione, disegno, fotografia e arti applicate trovano spazio, raccontando l’arte e la creatività spagnola dal XVI Secolo in avanti.
GIJÓN/XIXÓN
Spiaggia di San Lorenzo
Gijón/Xixón è una città affacciata sul mare e quella di San Lorenzo è la sua spiaggia urbana più frequentata. Bagnanti, surfisti, velisti... il volto più marittimo delle Asturie nella sua città più popolosa. È il promontorio di Cimavilla a dominare il centro cittadino: qui nacque il villaggio di pescatori che fu la base fondante di questa città, dove convivono un profondo rispetto per la tradizione e una vivace vita urbana, cosmopolita e contemporanea.
Laboral – Città della Cultura
Questo imponente complesso costruito negli Anni Cinquanta e progettato da Luis Moya, è stato concepito come una grande città ideale – autarchica e chiusa in se stessa, dotata persino di una fattoria di 100 ettari – dove formare generazioni di figli di operai come professionisti altamente qualificati. Costruito secondo gli ideali dell’architettura classicista, il cuore di questa città ideale è la grande piazza centrale, attorno alla quale sono disposti la magnifica chiesa, la torre, il teatro e gli edifici amministrativi. Attorno alla piazza si dispongono poi le altre strutture, tra cui spiccano i capannoni diafani costruiti per i laboratori di formazione professionale. Oggi è una grande Città della Cultura aperta a tutti.
Centro Niemeyer
L’ultima grande opera dell’architetto brasiliano Oscar Niemeyer (Rio de Janeiro, 1907 –2012) è un centro culturale sito nel cuore cittadino di Avilés. Inaugurato nel marzo 2011, dopo nemmeno 15 anni è riuscito a diventare un simbolo architettonico della città, famoso in tutto il mondo. Con i suoi 4mila metri quadrati di spazio espositivo, il Centro Niemeyer ospita mostre d’arte aperte alla cittadinanza, mentre il suo auditorium è spesso sede di proiezioni, spettacoli, concerti ed eventi di respiro internazionale.



nella pagina a fianco: Strade di Oviedo.
Photo Noe Baranda. Courtesy Turismo Asturias
Laboral - Ciudad de la Cultura, Gijon. Photo Noe Baranda, Courtesy Turismo Asturias
Centro Niemeyer, Avilés. Courtesy Turismo Asturias
a destra: Santa Maria del Naranco. Photo Benedicto Santos. Courtesy Turismo Asturias
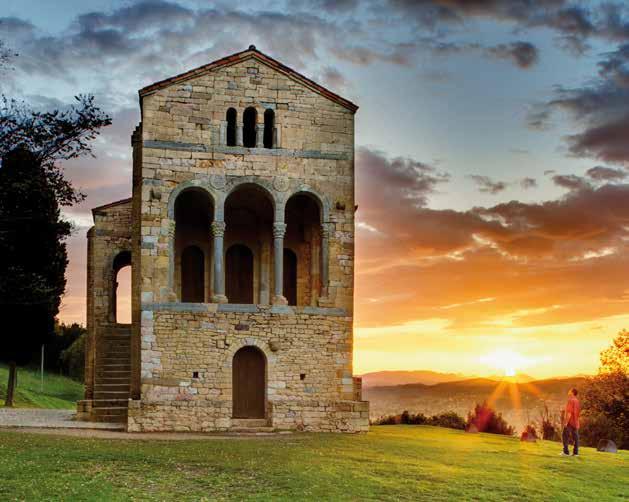
L’ALTO MEDIOEVO NELLE ASTURIE E LA SUA ARTE.
3 LUOGHI DA NON PERDERE
La nascita e lo sviluppo del Regno delle Asturie tra VIII e X Secolo diede anche impulso all’arte e all’architettura locale. Questo periodo è ricordato, infatti, per essere uno tra i più fervidi della cultura asturiana, tanto da offrire interessanti esempi dello stile preromanico. Sembra oggi impossibile, guardando queste opere, che il Medioevo fosse stato additato come epoca buia: i siti preromanici asturiani dimostrano maestria e padronanza tecnica e intellettuale, riscontrabili nell’architettura, nella pittura, nella scultura, nella lavorazione di oro e argento. L’insieme di questi siti è considerato il gruppo più completo e omogeneo di architettura altomedievale dell’Europa Occidentale, grazie ad un alto grado di conservazione e alla grande concentrazione geografica, che oggi permette di compiere agilmente tour omnicomprensivi. Ecco quali sono i luoghi da non perdere.
→ COVADONGA
Quale miglior punto di partenza se non il luogo di nascita del Regno delle Asturie? Pur senza resti architettonici preromanici, Covadonga ha rappresentato l’inizio di tutto. Oggi è il santuario mariano più importante della Spagna e il cuore del primo parco nazionale spagnolo: i Picos de Europa (costituito ufficialmente nel 1918). Cultura, natura e anche sport (grazie alla gara ciclistica Vuelta a España e alla salita ai laghi di Covadonga) hanno reso questa località un punto di riferimento assoluto per chi desidera conoscere le Asturie e la Spagna.
→ MONTE NARANCO
Poco fuori da Oviedo/Uviéu, e con un panorama privilegiato sulla città, il Monte Naranco ospita due degli edifici più significativi per il preromanico asturiano: Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo. Se sulla funzione del primo edificio si hanno ancora oggi diversi dubbi (fu una chiesa? Un palazzo?), il secondo aveva certamente una funzione
ecclesiastica. Entrambi emergono dal paesaggio come rivelazioni: completamente immerse nella rigogliosa natura del Monte Naranco, visitarle significa entrare in una dimensione in cui architettura e paesaggio, storia e ambiente, umano e mondo si fondono in un tutt’uno. Una sensazione sottolineata ulteriormente dalla evidente ricerca di un rapporto tra esterno e interno veicolato dall’iconico colonnato di Santa Maria del Naranco, che crea ambienti ibridi e confonde le categorie del dentro e del fuori. Entrambi gli edifici furono eretti sotto il regno di Ramiro I (790-850), e sono testimoni della grande fioritura artistica di questo periodo. Ancora oggi intricati bassorilievi, affreschi, motivi floreali e animali decorano gli ambienti e gli esterni dei siti. Un luogo impossibile da dimenticare.
→ VILLAVICIOSA
Questa città, conosciuta da tutti i pellegrini del Cammino di Santiago, ospita nei suoi dintorni una sorprendente concentrazione di chiese preromaniche del IX-X Secolo, ovvero l’ultima fase di questa effervescenza stilistica. Le chiese di San Salvador de Priesca e San Andrés de Bedriñana, ma soprattutto quella di San Salvador de Valdediós, sono luoghi di primo piano per chi vuole comprendere il preromanico asturiano, le sue evoluzioni e le sue ibridazioni che portarono poi all’arte romanica. San Salvador de Valdediós, detta anche “El Conventín”, è considerata l’ultima grande opera preromanica. Voluta da re Alfonso III, fu costruita nella valle che oggi viene chiamata Valdediós (“Valle di Dio”), per la sua amenità. Furono i monaci cistercensi residenti nel monastero adiacente (Santa Maria de Valdediós, XIII Secolo) a chiamarla così. La grande sintesi stilistica di San Salvador anticipa caratteristiche tipiche del romanico europeo, come la presenza del portico allungato e chiuso a volta.
Venezia
Ca’ Pesaro
Galleria Internazionale d’Arte Moderna
15.11.2025 – 01.03.2026
capesaro.visitmuve.it
In collaborazione con ARCHIVIO GASTONE NOVELLI, ROMA
Gastone Novelli, Il re delle parole, 1961, tecnica mista su tela, cm 220x330, Museo del Novecento, Milano “Copyright Comune di Milano – tutti diritti di legge riservati” - Foto Luca Carrà
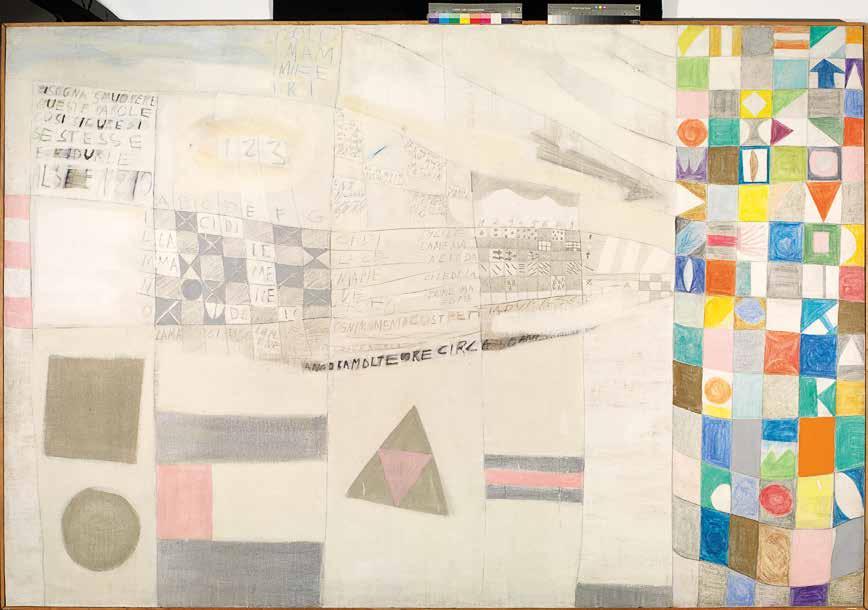
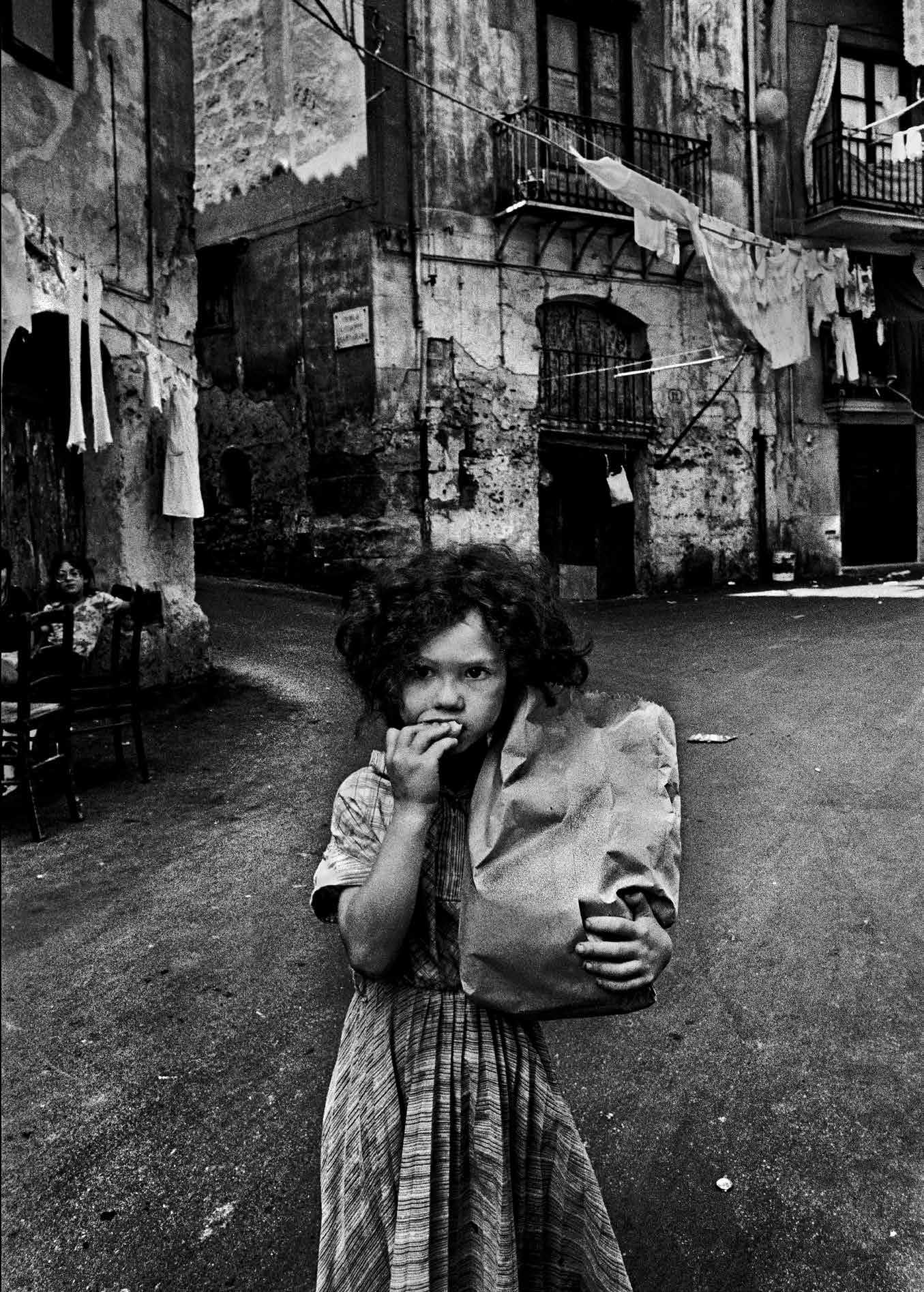
Livia Montagnoli
L’impegno e l’arte, l’attivismo politico e la necessità di mostrare la realtà, come segno di un’adesione piena alla vita e a tutte le sue spigolature. La scomparsa di Letizia Battaglia, nel 2022, non ha fatto altro che rinsaldare il mito di una delle fotografe tra le più grandi del nostro tempo. E la mostra in scena al Museo Civico San Domenico di Forlì, curata da Walter Guadagnini, ne ripercorre l’intero percorso creativo attraverso fotografie, libri, giornali e riviste provenienti dal suo archivio, testimoniando la varietà dei suoi interessi e la continuità del suo impegno civile.
Perché Letizia Battaglia – classe 1935, palermitana – è stata ben più che “una fotografa della mafia”, sebbene farsi cronista di ciò che succedeva nella sua città, con particolare impegno a partire dal 1974, quando con Franco Zecchin diede vita all’agenzia L’informazione fotografica, la portò in prima linea a documentare l’ingerenza di Cosa Nostra a Palermo, testimone della graduale crescita del potere mafioso in città: “Bisognava fotografare ciò che volevano i giornali: la scena del delitto, i poliziotti, i magistrati, i parenti, la disperazione, gli svenimenti delle donne, la rabbia degli uomini”, scriverà Zecchin molti anni dopo (nel libro Letizia Battaglia. Sulle ferite dei suoi sogni, di Giovanna Calvenzi, Milano 2010).
UNA GRANDE MOSTRA ITINERANTE. DALLA
La retrospettiva LETIZIA BATTAGLIA. L’opera 1970-2020, che arriva per la prima volta in Italia dopo le tappe francesi a a Tours e Arles, si propone, dunque, di andare oltre, presentando al pubblico una retrospettiva completa che espone oltre 200 fotografie, soffermandosi tanto sull’impegno professionale e civile di Battaglia, quanto sulla sua vita privata. Ideata e prodotta da CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia con il museo Jeu de Paume di Parigi, e con la collaborazione dell’Archivio Letizia Battaglia, la mostra sarà visitabile a Forlì fino all’11 gennaio 2026, dopo il debutto del 2024 proprio al Jeu de Paume di Tours e la recente tappa estiva al festival internazionale Rencontres d’Arles nel 2025. E che ad accogliere il progetto in Italia sia proprio Forlì non è casuale: in città, infatti, la fotografa palermitana tenne, nel 2021, uno dei suoi ultimi workshop per giovani fotoreporter.

Il percorso procede in ordine cronologico e tra le sale si dipana il mondo di Letizia Battaglia, dai ritratti ironici e irriverenti degli inizi alle vittime della mafia – tra cui Piersanti Mattarella colto subito dopo l’attentato che lo uccise – dalle proteste di piazza alla vita tra le mura di un ospedale psichiatrico, dalle feste religiose alle bambine di Palermo. E, ancora, in una delle sezioni conclusive, gli scatti raccolti in viaggio, nei periodi trascorsi fuori dall’Italia. È una fotografia d’azione, quella di Letizia Battaglia, “nata dal binomio parola-immagine, pensata per raggiungere lo spettatore nella via più diretta possibile”, spiega Guadagnini nel catalogo della mostra, edito da Dario Cimorelli. Un approccio che, nel 1985, le valse lo W. Eugene Smith Award, riconoscimento alla fotografia umanista. L’allestimento forlivese propone anche materiale inedito: fotografie mai esposte prima, copie originali delle riviste con cui Battaglia ha collaborato o che ha contribuito a fondare, e il docufilm Amore amaro, che racconta la sua visione del mondo. E poi le stampe originali provenienti dall’Archivio Letizia Battaglia di Palermo: numerose opere vintage e moderne stampe a getto d’inchiostro su carta Hahnemühle Baryta, realizzate dal suo storico stampatore. Con didascalie e titoli redatti da Battaglia stessa o dall’archivio.
La figura, il ruolo e l’arte di Letizia Battaglia sono stati omaggiati negli ultimi anni da numerosi progetti e mostre. Qual è l’obiettivo di questa corposa retrospettiva? Quali le sue peculiarità? Il principio di base si trova in una frase della stessa Battaglia, “io ho cercato la vita, la morte era un incidente che non cercavo, ero obbligata a fotografare e lo facevo. Quello che
Fino all’11 gennaio
LETIZIA BATTAGLIA.
L’OPERA 1970 – 2020
A cura di Walter Guadagnini
Museo Civico San Domenico
P.le Guido da Montefeltro, 12 - Forlì mostrefotograficheforli.it

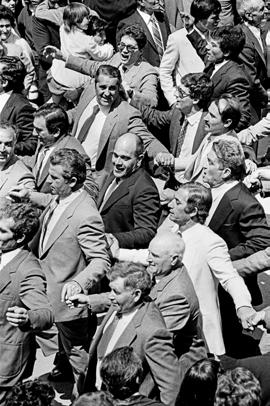
A Forlì lo spettatore troverà anche molti materiali inediti, di cosa si tratta?
La prima parte, quella degli esordi, sarà una vera sorpresa per molti: si vede una Letizia Battaglia alle prime armi, ancora divisa tra giornalismo scritto e fotogiornalismo, che insieme al compagno Santi Caleca fotografa divertenti scenette pseudoerotiche destinate a quella stampa, come ABC o Le Ore, che toccava temi di grande impatto sociale nei primi Anni Settanta, dal divorzio all’aborto, dalla pillola ai costumi sessuali, attraverso un linguaggio diretto e provocatorio. Anche nella parte finale della mostra, quella dedicata ai viaggi dopo gli Anni Novanta si trovano molte immagini inedite, che evidenziano la coerenza dello sguardo della Battaglia, sempre alla ricerca del rapporto umano diretto con i suoi soggetti, spesso individuati nelle pieghe della società, sia essa quella dell’Unione Sovietica sia quella dell’Egitto o degli Stati Uniti.
Perché la fotografia di Letizia Battaglia è in grado di parlarci ancora (e sempre) con un linguaggio così contemporaneo?
a sinistra: Letizia Battaglia, Rosaria Schifani, vedova dell'agente di scorta Vito, ucciso, insieme al giudice
Giovanni Falcone, Francesca Morvillo ed i suoi colleghi
Antonio Montinaro e Rocco Dicillo. Palermo, 1992
© Archivio Letizia Battaglia in alto: Letizia Battaglia, Via Calderai, Palermo, 1991
© Archivio Letizia Battaglia in basso: Letizia Battaglia, Domenica di Pasqua. La tradizionale corsa in cui gli uomini seguono il Cristo Risorto. Ribera, 1984, © Archivio Letizia Battaglia
facevo di mia volontà erano le esposizioni contro la mafia per le strade, ma la cronaca nera l’ho fotografata perché il giornale mi mandava. Ed è stato un bene. Io, di mio, ho sempre cercato la vita: tante foto di amori, di abbracci e baci, di bambine e bambini, di coppie, di vecchie meravigliose”. Battaglia non amava la definizione di “fotografa della mafia” che le era stata attaccata, ma è chiaro che è una parte ineludibile del suo percorso, ed è ben visibile in mostra. Ma c’è tutta la parte vitale della sua fotografia che ha volutamente lo stesso peso. Un’altra caratteristica è senza dubbio quella di presentare numerosi vintage e di evidenziare il lato militante della sua esperienza, dall’entrata in politica all’attività editoriale.
Abbiamo aperto la mostra il giorno dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci: purtroppo l’attualità ci dice che fare informazione su determinati argomenti rimane un mestiere rischioso e il coraggio straordinario dimostrato da Letizia Battaglia vale ancora oggi da un lato come esempio, dall’altro come monito per non abbassare la guardia. Inoltre c’è un linguaggio fotografico unico, la capacità di passare dalla durezza quasi insostenibile di certe immagini alla dolcezza infinita di altre. E non è così facile realizzare autentiche icone come La ragazza col pallone o il ritratto di Rosaria Schifani, quelle immagini condivise – ben prima dell’avvento di internet e dei social – che riescono a parlare a chiunque, e a condensare al loro interno tantissimi significati, tantissimi livelli di lettura. È la contemporaneità dei classici.
RODNEY SMITH / ROVIGO

Marta Santacatterina
Da Palazzo Roverella di Rovigo si affacciano, per la prima volta in Italia, le fotografie raffinate, ironiche e surreali di Rodney Smith. Nato a New York nel 1947 e scomparso nel 2016, questo artista ha saputo imprimere su pellicola composizioni che lasciano intuire un’aspirazione a un mondo ideale e una ricerca profonda sul significato della vita. Smith infatti fu uno studioso di teologia e filosofia e in parallelo si formò fotograficamente con Walker Evans; tra i suoi riferimenti si annoverano anche Anselm Adams, Margaret Bourke-White, Henri Cartier-Bresson, oltre a registi cinematografici – Alfred Hitchcock, Terrence Malick e Wes Anderson – e a grandi interpreti del cinema muto, come Buster Keaton, Charlie Chaplin e Harold Lloyd: tutto concorse a riempire un bagaglio visivo che Rodney Smith tradusse in scatti distintivi, magnetici, dal rigore formale ineccepibile, tanto che vi si riconosce spesso lo schema della sezione aurea, quella “divina proporzione” che fin dall’antichità sta alla base dell’armonia.
Le oltre cento opere esposte offrono una panoramica sulla ricerca di Smith e si dispongono all’interno di un allestimento elegante ed

efficace, caratterizzato da pareti dai colori tenui sulle quali fanno capolino, in punti strategici, particolari in gigantografia di altre foto. Le stampe selezionate per la mostra, proposte sia grandi sia in piccoli formati e prevalentemente in bianco e nero (“non c’è niente per me come l’oscurità e la sfolgorante intensità del bianco e nero”, dichiarò l’autore), sono raggruppate in sezioni che riflettono le principali tematiche della poetica del newyorkese: l’incipit è dedicato proprio alla proporzione aurea e alle leggi matematiche che sottendono le composizioni; seguono i focus sull’essenzialità degli spazi dell’esistenza,
Fino al 1° febbraio
RODNEY SMITH.
FOTOGRAFIA TRA REALE E SURREALE
A cura di Anna Morin
Palazzo Roverella Via Laurenti 8/19, Rovigo palazzoroverella.com
sul confine tra sfera umana e celeste in cui si collocano i personaggi – “non si sa se spiccano il volo o se cadono” scrive in catalogo la curatrice Anne Morin – e non può mancare l’approfondimento sul sottrarsi delle figure alla condizione di corpi pesanti: in bilico, innaturalmente inclinati, per i modelli di Smith non valgono le leggi della gravità e a ben guardare nemmeno quelle del tempo, che è invenzione degli uomini, mentre l’eternità appartiene al divino: nelle riprese tutto è cristallizzato, non ci sono ombre né indizi per dedurre periodi e stagioni. L’ultimo nucleo accorpa i paesaggi, anch’essi restituiti tramite forme perfette e archetipiche che esistono al di là del nostro mondo fisico.
La mostra è quindi permeata da un’atmosfera sospesa, in cui visioni poetiche e umoristiche narrano un mondo immaginario, sempre “leggermente fuori portata, oltre l’esperienza quotidiana, ma decisamente non impossibile”, ha affermato Rodney Smith che si definiva un “ansioso solitario” e trovava evidentemente conforto catturando immagini equilibrate, piene di grazia, in grado di “riconciliare il quotidiano con l’ideale” .
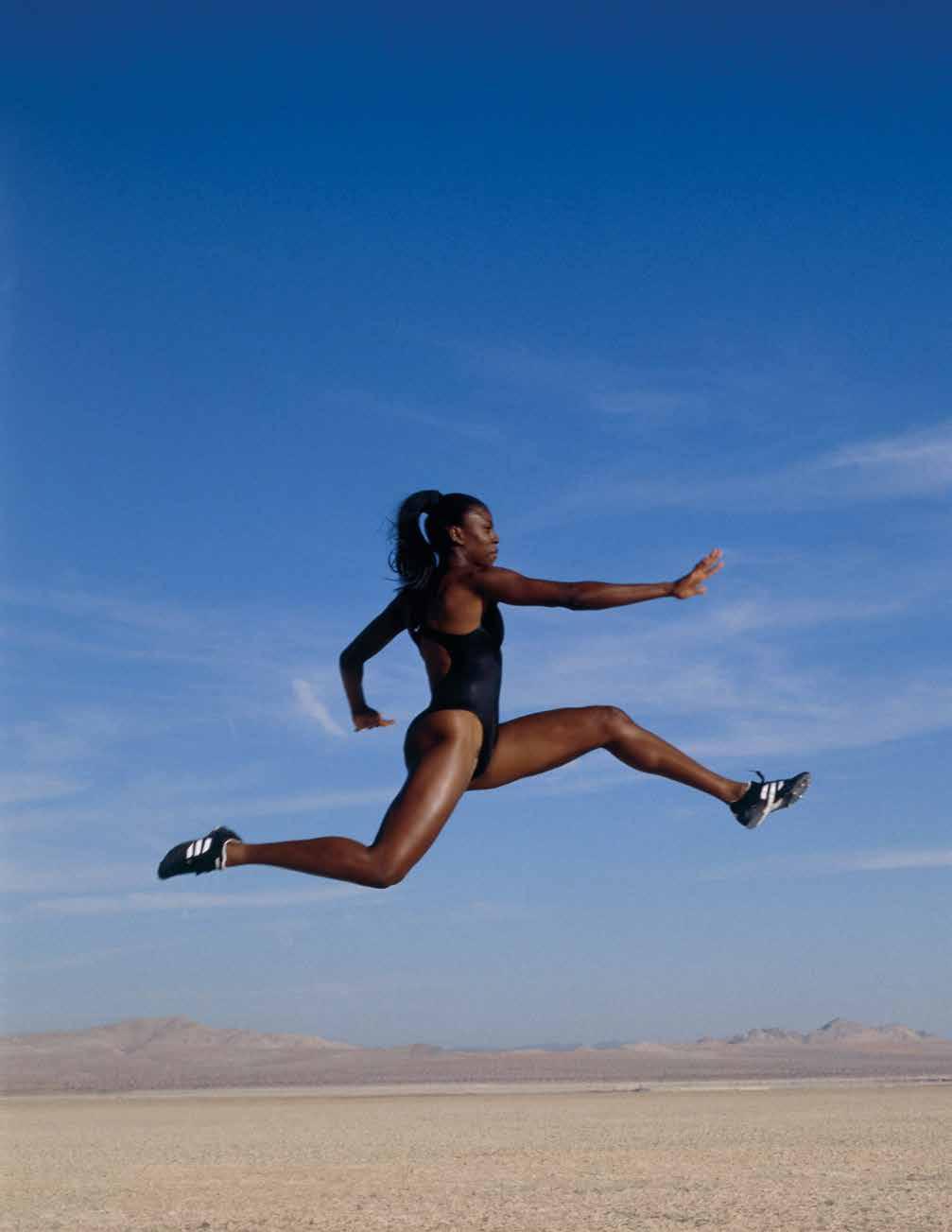
VILLA MANIN / PASSARIANO
Emma Sedini
La cornice raffinata del palazzo costruito a cavallo tra Seicento e Settecento di Villa Manin a Passariano di Codroipo (in provincia di Udine) inaugura una nuova era nella sua lunga storia espositiva. In sintonia con un passato che l’ha vista mutare e ingrandirsi nel tempo, il completamento dei lavori dell’Esedra di Levante consegna al pubblico un inedito spazio ultramoderno, con elevatissimi
standard di sicurezza adatti ad ospitare capolavori dal valore inestimabile. Un degno capitolo inaugurale è la mostra che ne animerà le sale da ottobre ad aprile 2026. Un lungo periodo, sì, ma certo necessario per permettere di fruire a pieno di questa esposizione così speciale. Confini da Gauguin a Hopper. Canto con variazioni: titolo sintetico, che nasconde sei sezioni che vanno ben oltre i confini temporali frapposti tra questi due artisti. Courbet, Monet, Van Gogh, i grandi maestri delle xilografie giapponesi. E si
potrebbe proseguire per righe e righe di inchiostro. Come introduzione di questa grande mostra basta dire ancora solo il nome del curatore: Marco Goldin. Chi si ricorda il suo illustre passato di eventi esponenziali ha già inteso di cosa si tratta.
Fatte queste premesse, passiamo ai numeri: 136, 50 e 43. 136 le opere, di una buona cinquantina di artisti, provenienti da 43 istituzioni

italiane, europee e internazionali. Cifre che stabiliscono l’ordine di grandezza della mostra ospitata nell’Esedra di Levante, parte - anzi, evento di punta - di di GO! 2025& Friends, programma di iniziative collaterali al palinsesto per Gorizia Capitale Europea della Cultura. Il percorso espositivo sviluppato da Goldin con la sua Linea d’ombra invita il pubblico ad attraversare i decenni clou dell’arte moderna e del Novecento, mettendo sotto la lente i “confini”. Un tema versatile, multiforme, che tocca e trascende vari ambiti già nel significato stesso della parola. Un tema che, però, sa anche essere di graffiante attualità, considerando gli eventi storici parte di tutto il nostro contemporaneo. Dopo un incipit a cavallo tra i due secoli con Rothko e Kiefer accostati a Courbet e Monetun assaggio che mescola le idee e fornisce alcune chiavi di lettura da portare con se nel prosieguo - si passa subito al cuore del discorso. Il confine è trattato in termini di introspezione, di autoritratto, di sguardo nel profondo di se


stessi a caccia di turbamenti, paure e desideri sopiti. Munch, Gauguin, Van Gogh, Hodler, Kirchner. Una sequenza di nomi da immaginare snocciolarsi sulle pareti. Poi la galleria di ritratti: Courbet, Manet, Degas, Renoir, Modigliani, Bacon, Giacometti.
Cambiando sfumatura, ci si sposta sulla natura e sul rapporto tra questa e l’uomo. A raccontarlo è la grande pittura americana novecentesca, si cita ad esempio Hopper, come quella europea con i due casi eterogenei di Segantini e Matisse.
La narrazione continua raccogliendo un gruppo di artisti che fanno della loro pittura un mezzo fortemente simbolico ed espressivo di sé e della propria personale visione dell’attimo di realtà. Parliamo certamente dell’Impressionismo di Monet, unito agli altri grandi attesissimi Van Gogh, Gauguin, Cézanne e Bonnard. Il confineper rimanere in tema - tra lascito ottocentesco e nuove tendenze, così ricco di sperimentazione artistica e stilistica. Quinta sezione, Goldin la dedica al “lontano”. Subito la mente va dove sorge il sole, nell’Oriente più affascinante delle stampe giapponesi. Visto il loro ruolo centrale come fonte iconografica e di tecnica per molti dei maestri appena visti, non potevano mancare in mostra. La selezione prevede opere di Utamaro, Eisen, Hokusai, Hiroshige (e non solo), tratti da un’unica collezione privata. Corpus che fa da preludio al grandioso finale dell’ultimo capitolo, diffuso in tutto il pianterreno dell’Esedra. Qui il confine è esplorato nelle sue varianti di elementi naturali. Montagne, quelle provenzali di Cézanne e le Alpi svizzere di Segantini. Mare: freddo e impetuoso con William Turner, dolce e mediterraneo con Monet. I cieli variano dai colori inquietanti di Munch alle

rapide pennellate di Pissarro, mentre un ampio spazio è dedicato alle ninfee, di cui non serve citare il protagonista. Ancora non è stato citato il romantico del paesaggio più sublime - affascinante e spaventoso a un tempo - Caspar David Friedrich. È con il suo ricordo di immensità che si esce dalla mostra, colmi di stupore dopo aver ripercorso in poco capitoli su capitoli di grande storia dell’arte.
VILLA MANIN:
400 ANNI DI STORIA E ARTE
Situata a Passariano di Codoripo, in Friuli-Venezia Giulia, Villa Manin nasce nel XVII Secolo come traccia tangibile del potere dell’omonima famiglia. I lavori proseguono fino alla prima metà del Settecento, vedendo contribuire all’opera gli architetti Giuseppe Benoni, Domenico Rossi, Giovanni Ziborghi e Giorgio Massari. È quest’ultimo, celebre architetto neoclassico dell’epoca, a disegnare un “belvedere” affacciato con cinque finestre sul fronte dell’edificio e altrettante sul retro, verso il parco. Chiuso da un timpano, slancia la facciata verso l’alto, conducendo fino alle statue di coronamento, che si uniscono a quelle delle barchesse e del cortile d’onore. Negli anni, la Villa rivela la sua indole mutevole: nasce come casa padronale, per poi divenire sede di rappresentanza ed ampliarsi a comprendere una cappella, cortili,
piazze e un grande giardino all’italiana. Oggi è un prestigiosissimo spazio dedicato all’arte e alla cultura. In fin dei conti, l’arte è nelle corde di Villa Manin fin dagli inizi: il citato architetto Domenico Rossi vi raccoglie infatti numerosi artisti, tra cui Louis Dorigny, parigino, che affresca nel 1708 una delle sale adibita a spazio di rappresentanza, creando un grande cerchio centrale con il Trionfo della Primavera. Lo accompagnerà Giuseppe Torretti, con le sue opere nella cappella di S. Andrea.
Dimenticata per anni, in disuso, dopo importanti lavori di ristrutturazione l’Esedra di Levante risorge come nuovo spazio espositivo modernissimo, con i più alti standard di sicurezza che la rendono adatta a ospitare progetti di elevato valore. La sua riapertura testimonia la rivincita della Pubblica Amministrazione, che è riuscita a dare un futuro a questo luogo, anche a seguito dei fallimenti del primo tentativo di restauro degli Anni Novanta. L’obiettivo è quello di rendere l’Esedra uno spazio attivo, vivo e dinamico. Nutrirla di idee che le permettano di diventare un centro culturale pronto ad accogliere manifestazioni artistiche di livello internazionale, nonché turisti da tutto il mondo. Come ha evidenziato l’Assessore regionale
Mario Anzil, la ristrutturazione rappresenta un importante investimento pubblico che coinvolge tutto il territorio, con la volontà di fare di questo spazio un baluardo della programmazione espositiva regionale. La grandiosa mostra inaugurale è dunque un assaggio di quello che il pubblico potrà fruire qui prossimamente.
Fino al 12 aprile
CONFINI DA GAUGUIN A HOPPER. CANTO CON VARIAZIONI
A cura di Marco Goldin
Villa Manin
Stradone Manin 10, Passariano (Udine) villamanin.it lineadombra.it



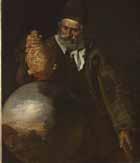
Helga Marsala
Nella Grecia classica era il termine che indicava la sfera dell’”educazione”, ovvero quel processo alla base della costruzione dell’individuo virtuoso e della sua integrazione nel tessuto cittadino: paideia non come erudizione, ma come formazione umana profonda, al servizio di una comunità che provava così a contenere conflitti interni e scissioni. Dalle arti su cui vegliavano le muse fino alla ginnastica, in una sintesi armonica tra corpo e spirito, il fanciullo seguiva padri, maestri e pedagoghi per diventare un adulto sano e consapevole. La lettura di Omero e dei poeti lirici era, in questo quadro, fonte di conoscenza e ispirazione morale.
SCRITTURA E CONOSCENZA:
LA MOSTRA A MODENA
Al concetto di paideia, cornice ideale dei Dialoghi di Platone, si ispirava la 25esima edizione del Festival della Filosofia, tenutasi a settembre 2025 tra Modena, Carpi e Sassuolo. Un campo di studi sterminato, il cui perno resta quella dimensione della parola e quella volontà di trasmissione del sapere, declinate nei millenni fra tradizione orale e pratica della scrittura. Nasce in questa cornice la mostra “Il tempo della scrittura. Immagini della conoscenza dal Rinascimento a oggi”, a cura di Stefania De Vincentis, da un’idea di Francesca Cappelletti, prodotta e ospitata da La Galleria BPER di Modena. Un viaggio tra iconografie del passato e del presente, ispirate alla rappresentazione della conoscenza e ai suoi strumenti d’elezione: libri, documenti, iscrizioni, testi sacri, pagine che diventano sigilli tra anime o strumenti d’elevazione in cui cercare il senso di sé e delle cose. E ancora volti che incarnano l’esercizio del pensiero e della ricerca, il rapporto tra cultura e politica, e poi la religione come racconto biblico, ascolto della parola divina, investigazione spirituale e filosofica.
LE OPERE DELLA PINACOTECA DI BPER
Mostra contenuta, ma che va dritta al punto, a partire proprio dalla corporate collection di BPER, da cui arriva un nucleo di opere a tema. Intenso Il pianto di Giacobbe (1615 ca.) di Giacomo Cavedoni, ritratto dell’anziano patriarca con gli occhi colmi di lacrime, che in mano stringe la tunica del figlio insanguinata (inconsapevole del tranello organizzato dai fratelli del ragazzo, azzannati dall’invidia, i quali avevano

in realtà venduto Giuseppe a dei mercanti). In primo piano s’impongono un libro aperto e un cartiglio con la citazione biblica “Jacob ait, tunica filii mei est”, quasi a imprimere sul foglio il dolore dell’uomo dinanzi alla presunta prova. Intrisa di drammatico realismo, la tela è un bell’esemplare di quel teatro popolare che per Cavedoni, formatosi con i Carracci, era spazio di narrazione: la scrittura si fa qui incarnazione del pathos e dello strazio, e insieme memoria dei testi sacri, con la loro eredità di miti, simboli, parabole, visioni. È invece la mitologia classica ad ispirare il raffinato Clio. Musa della storia (1640) di Jean Boulanger, raffigurazione di una delle 9 muse, figlie di Zeus e di Mnemosine: figura di riferimento per i poeti e gli aedi, che dei grandi personaggi e dei
popoli del passato cantavano le gesta, Clio prendeva il nome dal verbo greco “κλέω”, traducibile con “rendere famoso”, “celebrare”. Boulanger tratteggia il volto con un misto di dolcezza e di fierezza, assegnandole il tradizionale corredo iconografico: gli occhi contemplativi e seri, dei libri accanto, una corona d’alloro sul capo e in mano una tromba, simbolo della fama.
La Madonna con bambino di Luigi Amidani, del 1610, e quella più tardiva di Alessandro Mazzola (di datazione incerta), identificano nel gesto della lettura e nell’immagine di un libro – presumibilmente il Vecchio Testamento – l’affettuoso scambio tra Maria e Gesù, nella missione educativa della madre e nella curiosità di quel figlio che incarnava già la potenza della parola sacra, racchiusa nelle stesse Scritture.

Fino all’8 febbraio
IL TEMPO DELLA SCRITTURA. IMMAGINI DELLA CONOSCENZA
DAL RINASCIMENTO A OGGI
A cura di Stefania De Vicentis (da un’idea di Francesca Cappelletti)
La Galleria BPER
Via Scudari 9, Modena lagalleriabper.it
a sinistra: Giovanni Francesco Barbieri detto Guercino, San Girolamo che sigilla una lettera, (dettaglio), 1618 circa in alto: Il tempo della scrittura, veduta dell'allestimento. In primo piano: Pietro Ruffo, Constellation Globe, 2024
Prestigiosi i prestiti da altre collezioni, come il Busto di Minerva (XVII Secolo) di ambito romano, proveniente dalla Galleria Borghese di Roma, rappresentazione marmorea della dea romana della Sapienza: a lei si attribuì anche l’invenzione della filatura e della tessitura, fin nell’antichità associate metaforicamente al flusso generativo della scrittura. Le fa eco Amore minacciato da Minerva, attribuito a Giulio Romano, una tempera su tavola del ‘500 giunta dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma - Palazzo Barberini. Da qui arriva anche il San Girolamo che sigilla una lettera (1618 ca.), splendido olio su tela del Guercino, un omaggio al Santo che realizzò la Vulgata, prima traduzione accurata e ufficiale della Bibbia in latino,
approvata da Papa Damasio I e accompagnata dall’elaborazione di un vero e proprio metodo. Aspetto fondamentale per la trasmissione della conoscenza, l'arte della traduzione dei testi dischiude un universo complesso, fatto di enorme responsabilità e di ricerca ininterrotta.
MEZZAQUI E RUFFO:
ARTE E PAROLA SECONDO DUE
ARTISTI CONTEMPORANEI
Con un salto temporale, la mostra apre una parentesi sul contemporaneo, inserendo nel percorso due artisti italiani entrati nelle collezioni di BPER: due opere di Sabrina Mezzaqui, acquisite in occasione di Arte Fiera 2025, e un gruppo di lavori di Pietro Ruffo, protagonista del Padiglione Venezia alla Biennale Arte 2024. Subito riconoscibile la cifra di Mezzaqui, da sempre impegnata in una ricerca visiva che ruota intorno alla parola e alla scrittura: scorrendo la sua vasta produzione, arrivano tutta la grazia, la delicatezza, la misura, lo spessore e il respiro di chi ha intercettato una lingua propria per restituire la misteriosa compenetrazione tra immagine e parola. Così è per Lettere (2010), che ricama con un filo le parole di Heidegger dedicate al senso dell’essere come puro abbandono al fluire dei giorni e come apertura all’altro; e così è per Segni (2009), libro d’artista le cui pagine non sono abitate da lettere e da frasi, ma da stormi di gabbiani in volo: brevi cieli di carta, solcati da trame che assomigliano a scritture superiori.
Ed è come riscritto con un immaginifico alfabeto visivo il Constellation Globe (2024) di Ruffo, un mappamondo in legno rivestito da figure d’ispirazione fantastica e mitologica: inchiostro e intagli su carta intelata, per mescolare bestiari, divinità, eroi, stralci di epica e di cosmologia, dal grande atlante della memoria e della cultura occidentale.
Fino all’11 gennaio 2026, negli spazi di Palazzo Martinengo di Villagana, sede di BPER a Brescia, è in corso la mostra Fabrizio Dusi. Le parole degli altri, personale dell’artista, a cura di Giorgia Ligasacchi e con la collaborazione di Ester Candido. Un sodalizio, quello con Dusi, che si rinnova dopo la mostra del 2023 negli spazi di BPER Private Cesare Ponti, a Milano, e dopo la collaborazione per il progetto speciale con il Liceo Classico e linguistico Muratori-San Carlo di Modena. Spiega Ligasacchi: “L’uniformità linguistica può apparire ‘dorata’, ma nasconde spesso la perdita della diversità, dell’ascolto, del significato profondo. È in questo spirito che la mostra rilegge la Torre di Babele non come condanna, ma come metafora di una pluralità che, se accolta, costruisce senso e valore, anziché frammentarlo”.
Il tema del volto entra in scena con un dialogo diretto tra antico e contemporaneo. Da un lato una testa antica di Alessandro Magno (I-II Sec. d.C.) montata su un busto secentesco, ancora un prestito della Galleria Borghese che mette a fuoco il ruolo del ritratto rispetto alla celebrazione del potere e all’esaltazione di valori civili e morali: una funzione modificatasi nel corso della storia, originata nel culto degli antenati, evolutasi attraverso rappresentazioni di natura ideale e in età ellenistica giunta a un naturalismo che interpretava concretezza e unicità dell’individuo.
Sul fronte opposto, la serie dei Sei Traditori della Libertà di Ruffo (2009-10) è una raccolta di anti-ritratti dei filosofi Helvetius, Rousseau, Saint Simon, De Maistre, Fichte e Hegel, che nel 1952 il filosofo e politologo britannico Isaiah Berlin – durante una celebre serie di conferenze – descrisse come “cattivi maestri”, in relazione a un nucleo controverso e irriducibile del loro pensiero. Nelle teorie di questi giganti egli riscontrava il fondamento delle ideologie illiberali del ‘900. I ritratti di Ruffo prendono forma grazie all’assemblaggio di piccole libellule ritagliate, fissate con dei chiodi: un insetto tradizionalmente accostato ai concetti di libertà e di fragilità diventa particella immobile di simulacri di carta, direttamente connessi a un’idea dispotica del mondo.
E così tutta la complessità dell’avventura del sapere – prodotto, trasmesso, accolto, custodito, tradito, espanso, in certi casi temuto e ostacolato – si dà lungo il percorso come inesauribile trama di conquiste e di conflitti, di codificazioni e interpretazioni. Immagine potente di ogni civiltà, scolpita da infinite lingue e molteplici linguaggi, lungo la linea irregolare della storia.
JEFF WALL / TORINO

Valeria Radkevych
Le fotografie di Jeff Wall (Vancouver, 1946) dichiarano apertamente la propria finzione, ma è in questa trasparenza che risiede la loro sincerità. Nulla è improvvisato, eppure ogni immagine resta aperta, come un pensiero in atto. La messa in scena non maschera la realtà: la rivela, ricostruendola con la precisione di chi osserva per comprendere. Da oltre quarant’anni Wall esplora le tensioni del quotidiano muovendosi tra pittura, cinema e fotografia. Le sue opere, spesso di grande formato e illuminate dall’interno, trasformano episodi comuni in tableaux di intensità teatrale, dove la luce diventa linguaggio e la visione esercizio di riflessione.
Alle Gallerie d’Italia – Torino, museo di Intesa Sanpaolo dedicato alla fotografia, la mostra Jeff Wall. Photographs, curata da David Campany, riunisce ventisette opere provenienti da musei e collezioni internazionali. Il percorso attraversa il lavoro di Wall dagli anni Ottanta fino alle opere più recenti, restituendo la complessità di una ricerca che ha trasformato la fotografia in un linguaggio dell’immaginazione e della coscienza.
L’esposizione si apre con il trittico I giardini / The Gardens (2017), opera che introduce da subito molti dei principi fondanti della poetica di Wall. Tre grandi pannelli disposti in sequenza raccontano un gruppo di figure immerse in un paesaggio verde, dove la natura appare insieme
reale e costruita. Le scene, girate nei giardini di Villa Silvio Pellico a Moncalieri, seguono un ordine temporale scandito da tre titoli: Appunto / Complaint, Disappunto / Denial, Diffida / Expulsion order. L’opera, nel suo insieme, suggerisce l’idea di una narrazione sospesa, che non si lascia decifrare completamente ma invita a contemplare il modo in cui un’immagine può articolare tempo, memoria e presenza. Da questo inizio, la mostra si sviluppa come un fluire di situazioni e riflessioni visive, dove le opere dialogano tra loro in un continuo spostamento di senso. I celebri lightbox retroilluminati presentano una chiave stilistica che appartiene all’artista dagli Anni Ottanta mutuata dal linguaggio pubblicitario. Qui la luce interna trasforma la fotografia in un oggetto visivo
pulsante, sospeso tra pittura e schermo cinematografico. Accanto a queste opere iconiche, una selezione di stampe a colori e in bianco e nero mostra il progressivo raffinarsi del suo linguaggio formale.
Tra i lavori esposti figurano alcuni capolavori ormai canonici: The Thinker (1986), reinterpretazione in chiave contemporanea del Pensatore di Rodin; After “Invisible Man” by Ralph Ellison, the Prologue (1999–2000), omaggio al romanzo di Ellison sulla condizione afroamericana; e Morning Cleaning, Mies van der Rohe Foundation, Barcelona (1999), in cui l’architettura modernista diventa scena per un gesto umile e quotidiano. Queste opere, apparentemente lontane tra loro, condividono un tratto essenziale: mettono in questione l’atto stesso del vedere. Come sottolinea David Campany, “Wall aveva sviluppato modi di lavorare che sospendono le pretese di verità documentaria della fotografia, senza però negarle del tutto. È in questa sospensione che la fotografia diventa pensabile.” Il curatore racconta di aver osservato un gruppo di studenti visitare la mostra torinese: “Erano lenti, concentrati, affascinati. Un artista o un curatore non possono chiedere di più”.
LA FOTOGRAFIA CHE PENSA
Concepite come un insieme coerente, le opere esposte delineano una visione compatta e completa del lavoro di Jeff Wall. In ogni fotografia convivono la precisione formale e l’ambiguità percettiva, la chiarezza della costruzione e l’opacità del significato. Le sue immagini non illustrano un tema, ma aprono uno spazio di riflessione. Non sono destinate a mostrare l’evento quanto a suggerire il suo possibile sviluppo.
Una delle opere più emblematiche in questo senso è After “Invisible Man” by Ralph Ellison, the Prologue (1999–2000), ispirata al celebre incipit del romanzo di Ralph Ellison. In una stanza sotterranea illuminata da centinaia di lampadine, un uomo vive immerso in una luce abbagliante, circondato da oggetti disordinati. È un’immagine che parla di visibilità e invisibilità, di conoscenza e accecamento. La moltiplicazione delle fonti luminose non produce trasparenza, ma eccesso: il protagonista è esposto a una luce che lo isola, più che rivelarlo. Wall ricrea la scena come una visione iperreale, costruita nei minimi dettagli, dove la finzione diventa mezzo per interrogare la condizione dello sguardo contemporaneo sulla società e i suoi costrutti.
Con Morning Cleaning, Mies van der Rohe Foundation, Barcelona (1999), l’artista sposta l’attenzione dallo spazio interiore a quello architettonico. L’immagine mostra un uomo che, all’alba, pulisce le vetrate del celebre padiglione di Mies van der Rohe. L’architettura visionaria, simbolo di razionalità, e trasparenza

modernista, è avvolta da una luce opaca; dietro il vetro, la scultura femminile di Georg Kolbe, normalmente visibile nel bacino d’acqua, è occultata dal vetro insaponato. La pulizia come un gesto più semplice e sincero, trasforma il monumento in un luogo di sospensione. Ciò che dovrebbe essere visibile viene temporaneamente cancellato, e la trasparenza modernista si rovescia in schermo. Il monumento si umanizza, attraversato dalla presenza di chi ne cura la sopravvivenza. La fotografia restituisce dignità all’invisibile, a quel lavoro silenzioso che sostiene la permanenza della forma. Nelle opere più recenti, come Maquette for a monument to the contemplation of the possibility of mending a hole in a sock (2019) e Sunseeker (2021), la tensione tra visione e pensiero assume una dimensione più intima. Entrambe ritraggono una figura femminile sola, immersa in uno spazio di concentrazione e silenzio. Nel primo caso, una donna anziana
Fino al 1° febbraio
JEFF WALL. PHOTOGRAPHS
A cura di David Campany
Gallerie d’Italia
Piazza San Carlo, Torino
gallerieditalia.com
osserva un calzino tra le mani, come se riflettesse sul gesto di rammendarlo: un’azione minima che diventa tema di contemplazione e inaspettata consapevolezza. Nel secondo, una donna rivolge il volto verso il sole, lasciando che la luce avvolga il suo corpo, in un equilibrio tra presenza e dissolvenza. In entrambe le immagini, il linguaggio è trattenuto, sostituito da una densità muta. Wall traduce la quiete in tempo visivo, definibile.
Questa riflessione sul tempo trova una forma più esplicita in un trittico Staircase and Two Rooms (2022). In un interno circondato da pareti bianche e da una scala che taglia diagonalmente la scena, figure isolate occupano spazi diversi, come se abitassero momenti distinti. Nulla accade, eppure la fotografia suggerisce simultaneamente un prima e un dopo. Le stanze, con le loro aperture, costruiscono un campo visivo multiplo, dove l’occhio si muove tra piani e soglie, come in un montaggio invisibile. Wall traduce il tempo in architettura: ogni spazio è una porzione di durata, ogni figura una possibilità narrativa da scoprire.
Dall’abisso luminoso di After “Invisible Man” al vetro opaco di Morning Cleaning, fino ai gesti trattenuti di Maquette e Sunseeker e all’interno scandito di Staircase and Two Rooms, si dispiega la continuità di un pensiero visivo che non smette di interrogare il modo in cui le immagini producono senso. La fotografia, per Wall, non è un atto di registrazione, ma di costruzione: un modo per rendere visibile il processo stesso della percezione.
In un’epoca che consuma le immagini alla velocità dello schermo, il suo lavoro restituisce allo sguardo la durata, il silenzio e l’ambiguità Ogni fotografia richiede tempo, non per essere capita, ma per essere vissuta.
Ludovica Palmieri
Èallestita davvero bene la mostra con cui il Nakanoshima Museum of Art di Osaka, dopo 25 anni riporta all’attenzione del pubblico Koide Narashige (Osaka, 1887–1931), uno dei principali artisti yoga, ovvero pittori giapponesi in stile occidentale, dell’era moderna. La retrospettiva, organizzata in collaborazione con il Fuchu Art Museum di Tokyo, costruita secondo un criterio cronologico, è articolata in un percorso che, in quattro sezioni e due nuclei tematici, tra disegni, bozzetti, lavori su vetro rovesciato e toccanti nihonga (pitture in inchiostro su carta in stile giapponese), racconta la parabola creativa di un artista talentuoso, versatile, aperto alle influenze e alle novità, venuto a mancare troppo presto, a soli 43 anni, a causa di una malattia cardiaca cronica.
Le numerose opere, oltre 180, che compongono l’esposizione, tra nature morte, ritratti, vedute di città, nudi femminili, attestano le brillanti capacità pittoriche di Narashige, coltivate con perseveranza nonostante le iniziali difficoltà; prima ad accedere al Dipartimento di Pittura Occidentale alla Tokyo Fine Arts School, poi a far accettare i suoi quadri alla Mostra d’Arte del Ministero dell’Educazione. Criticità in parte dovute al suo background di provenienza, una famiglia di commercianti di Osaka ma, nel contempo, superate grazie allo stesso. Fu proprio nel cuore caotico e contraddittorio della città giapponese che il giovane sviluppò il suo spiccato senso estetico, forgiato dall’atmosfera grottesca, bizzarra e volgare del quartiere a luci rosse, movimentata del Dōtonbori e ingentilito dall'aria elegante e raffinata dei quartieri alti. Narashige intuì precocemente e con risolutezza le potenzialità dell’olio, riuscendo a coniare uno stile yoga prettamente nipponico, non più mera imitazione della pittura occidentale. Del resto le qualità delle sue opere: padronanza del medium pittorico; nonchalance nell’alternanza di generi, stili e tecniche; maestria nell’uso dei colori, caratterizzati da una gamma cromatica e tonale decisa, per lo più accesa e variopinta ma sempre calibrata, gli valsero anche in vita prestigiosi riconoscimenti. Nel 1915, subito dopo la laurea, il dipinto Montagne all’inizio dell’estate (1915) fu selezionato per la seconda mostra dell’Istituto
Giapponese d’Arte Restaurato; nel 1919 vinse il Premio Chogyu, con N’s Family alla 6ª Esposizione Nika – esposto in mostra - e, l’anno seguente, il rilevante Premio Nika, con il Ritratto di Oume (1920), con cui divenne anche membro dell’Associazione Nika. Ma fu il breve viaggio in Europa a determinare la radicale metamorfosi nella sua pittura, dietro e dentro la quale c’è ben più della sola perizia tecnica.
L’Europa, in cui viaggiò per 5 mesi, tra il 1921 e il 1922, fu un’esperienza dirimente per la crescita artistica e umana di Narashige, perché fu proprio toccando con mano l’Occidente che riuscì a
Fino al 24 novembre
KOIDE NARASHIGE: ALLA RICERCA DELLA PITTURA
A OLIO PER I GIAPPONESI
Nakanoshima Museum of Art 4-3-1 Nakanoshima, Kita – ku, Osaka, Giappone nakka-art.jp



“separarsene”, sviluppando uno stile totalmente personale. Ritrovandosi nel vecchio continente a cavallo tra le due guerre, oltre ad ammirare i maestri della tradizione, entrò in contatto con uno scenario in fermento, in cui imperversavano passioni e avanguardie. Un clima di rinnovamento che si respira nelle opere dell’artista, capace di assorbirne la lezione, reinterpretandola in maniera efficace, senza alcuna pedanteria. In particolare, mentre prima l’influsso occidentale era più di forma che di sostanza, caratterizzato ancora da un impasto di colori alla sodosha e da riferimenti per lo più figurativi, come si nota nella N’s Family, autoritratto di famiglia, in cui appare una natura morta alla Cézanne e un libro di dipinti di Hans Holbein; dopo il viaggio in Europa passò a uno stile più fluido connotato da una piena comprensione del medium che, diluito e stratificato, restituiva a pieno tutta la sua trasparenza e luminosità. Con questo stile l’artista divenne celebre, specialmente per i nudi femminili, genere prediletto, in cui si percepiscono evanescenti come tracce oniriche, traslate attraverso elementi personali e culturali, le memorie di Modigliani e Matisse. Una tempére culturale, quella occidentale degli Anni ‘20, di cui in mostra rende ragione l’ultima sala del percorso che, attraverso una selezione di opere coeve di matrice o fattura europea, tra cui un notevole Modigliani, offre al pubblico materia per un concreto e costruttivo confronto.
Come anticipato Narashige è diventato celebre per i suoi nudi, tanto da essere nominato Rafu no Narashige, Narashige dei nudi. Genere a cui si dedicò dopo il ritorno dall’Europa e, specialmente, con il trasferimento nel 1926 a Ashiya. Rispetto alla consueta concezione del genere, Narashige ha codificato una propria forma di nudo, proponendo un’inedita idea di bellezza femminile, dalla sensualità endemica e manifesta ma mai aggressiva, volgare o arrogante. Le donne in Narashige non sono solo modelle o geishe ma persone con una storia e un’identità, esplicate attraverso le loro fisicità che le rende concrete, uniche e accentuate dall’allargamento dell’inquadratura alla quotidianità circostante. Attraverso pochi tratti il pittore traccia una narrazione che diventa racconto, come se ogni dipinto fosse il portato di un rapporto. Le linee scorrevoli modellano i corpi attraverso una serie di curve, senza indugiare sui dettagli, verso una semplificazione via via più marcata, una stilizzazione, i cui esiti, data la prematura scomparsa, rimarranno per sempre a noi preclusi. Anche nell’incarnato, lavorato con una miscela di colori estranea ai nudi occidentali, bianco, rosso chiaro e verde pallido mescolati nel giallo, l’artista ottenne risultati strabilianti, con tonalità brillanti per una texture calda e decisamente viva.
Il percorso racconta la partecipazione di Narashige alla vita culturale del Paese, con l’adesione
all’Associazione Nika; nel 1923 a quella Artistica di Osaka. E, soprattutto, con la fondazione, nel 1924, insieme Nabei Katsuyuki, Kunieda Kinzo e Kuroda Jutaro, dello Shinanobashi Yoga Kenkyusho di Osaka. Istituto in breve diventato un punto di riferimento per l’insegnamento della pittura occidentale nell’area del Kansai prebellico, come testimoniato anche dal numero e dal livello delle opere di giovani pittori presenti nella sezione dedicata all’eredità artistica del maestro. Non manca uno spaccato sulla sua coeva attività come teorico e alla redazione della rivista d’arte Marronnier; nonché il racconto del suo trasferimento, nel 1926, ad Ashiya in uno studio concepito ad hoc in stile occidentale dall’amico architetto Sasagawa Shin’ichi, che lo liberò dal disagio di dover produrre dipinti a olio in una stanza in stile giapponese.
Una mostra approfondita e scrupolosa, seppur concepita per una fruizione per lo più localein quanto carente di un apparato didascalico in inglese - che raccontando anche l’uomo oltre l’artista mette chiaramente in luce come, al di là dell’indiscutibile maestria tecnica, ciò che ha consacrato Narashige all’alveo della storia dell’arte è la pulsante e intensa umanità delle sue opere. Qualità che deriva da una cura, un’attenzione e un calore nella resa dei soggetti fuori dal comune; da una sottile, quasi impercettibile, autoironia nel rappresentarsi; da una sincera e per nulla affettata tenerezza nell’evocare non solo momenti di vita vissuta ma anche capolavori europei, come quelli sui bellissimi nihonga, straordinari pezzi di bravura dalla disarmante semplicità.

Monumentali, avvolgenti, costringenti e allo stesso tempo leggeri, aperti, “porosi”: i grovigli di filo rosso o nero di Chiharu Shiota (Osaka, 1972) mettono in discussione la percezione e gli stati d’animo degli spettatori. Queste spettacolari installazioni sono ora protagoniste (assieme a una selezione di fotografie, sculture e disegni), dell’ampia retrospettiva con la quale il MAO di Torino ripercorre l’evoluzione dell’artista. E sono il punto di partenza del nostro colloquio con lei.
INTERVISTA A CHIHARU SHIOTA
Nei suoi lavori sembra di cogliere una precisa simbologia, non solo nell’intrico di fili ma anche negli oggetti che questi contengono. Può darci qualche delucidazione in merito?
In molti casi utilizzo oggetti che sono appartenuti a qualcuno come valigie, scarpe, sedie,
abiti che contengono la memoria e le storie delle persone che li hanno usati. Mentre realizzo le mie opere, l’idea è quella di “tessere” i ricordi contenuti in questi oggetti, che fungono da “sostituto” di una persona che non c’è più. Quando utilizzo una sedia vuota o vestiti, scarpe, valigie vuote, non lo faccio per la simbologia dell’oggetto in sé, ma perché sono elementi personali, parte della routine quotidiana di qualcuno. Sono cose che le persone hanno maneggiato quotidianamente e penso che avessero un significato, per loro.
La reazione nei confronti delle sue installazioni oscilla tra due poli: vengono percepite come bozzolo amniotico o come “prigione”. Come si relaziona con queste percezioni? Qual è la sua esperienza dei suoi stessi lavori? È vero, alcuni spettatori trovano i miei lavori inquietanti, altri invece semplicemente belli, maestosi. Penso che l’arte contemporanea sia per
Fino al 28 giugno
CHIHARU SHIOTA: THE SOUL TREMBLES
A cura di Mami Kataoka e Davide Quadrio MAO – Museo d’Arte Orientale Via San Domenico, 11 Torino maotorino.it
a sinistra: Chiharu Shiota, Accumulation - Searching for the Destination, 2014/2019, Suitcase, motor and red rope, Dimensions variable, Installation
a destra: Chiharu Shiota Uncertain Journey, 2016/2019, Metal frame, red wool, Dimensions variable, Installation
definizione soggettiva e che ci siano molti modi per guardarla e viverla. Se prendi cento persone, ognuna avrà sensazioni, punti di vista, opinioni diverse. A mio parere il fascino dell’arte contemporanea risiede proprio nel fatto che non fornisce una risposta univoca e nella sua capacità di far percepire alle persone che ogni individuo è differente da tutti gli altri. Naturalmente, la mia esperienza dei miei lavori è molto diversa da quella del pubblico. È il mio lavoro, appunto, e sono coinvolta nel processo di creazione. Lo guardo dal mio punto di vista professionale, mi concentro sulla sua realtà concreta e anche su come potrò evolvere con la successiva installazione che realizzerò. Non ho mai considerato le mie installazioni come un insieme complessivo, né mi pongo l’obiettivo di realizzare una prigione o un bozzolo, per usare le sue parole. Quel che faccio è semplicemente disegnare col filo nell’aria. Guardo ogni singola linea di filo e la rete di connessioni che si crea, anziché concentrarmi su una visione dell’intera stanza: per me si tratta in un certo senso di una moltitudine.
Quale bilancio trae da una retrospettiva come quella del MAO, che mette a confronto svariati anni di creazione? Come legge la sua evoluzione artistica?
Quando creo, penso solo a completare l’opera in corso. Guardando il mio lavoro degli ultimi vent’anni, però, riesco a vedere il contesto relativo al momento in cui le opere sono state realizzate, le sensazioni che ho provato all’epoca.
Mi sono trasferita a Berlino quasi trent’anni fa e ho inconsapevolmente interiorizzato la scena artistica di questa città, il che ha influito sui miei lavori. Ad esempio, ho utilizzato delle finestre provenienti dall’ex Berlino Est e ho riflettuto sulle idee di muro e di confine. Guardare i miei lavori con occhio retrospettivo mi ha insomma consentito di capire meglio quale tipo di artista sono e quali sono le influenze che hanno dato forma alla mia opera.
La memoria è uno dei suoi temi fondamentali. Come vede questo concetto nella situazione odierna? Viene considerato e “sfruttato” al meglio? Oppure viene trascurato o banalizzato?
La memoria è un punto importantissimo nei miei lavori. So chi sono perché ho i miei ricordi. Ma l’esistenza umana è “nebulosa”. Poniamo il caso che perdessi i miei ricordi e quelli di qualcun altro entrassero nel mio cervello: penserei, erroneamente, di vivere la vita di quella persona. Ma se poi i neuroni che controllano la memoria si riconnettessero e i miei ricordi risorgessero, realizzerei di essere me stessa. Posso parlare solo per me, non della situazione generale del concetto di memoria. Per me è un modo per “confermare” l’esistenza e uno strumento importante per realizzare la mia arte.
È ancora rilevante oggi la provenienza di un artista? Più nello specifico, è caratterizzante aver vissuto sia in Oriente che in Occidente,

Oltre alla mostra torinese ospitata dal MAO, l’appuntamento col pubblico italiano di Chiharu Shiota si rinnova anche a Milano. Apre infatti il 19 novembre nello spazio Agorà del Mudec (via Tortona 56, www. mudec.it), e rimarrà visibile fino al 28 giugno, un’altra sua grande e spettacolare installazione. Intitolata The moment the snow melts, è composta da una coltre di fili pendenti dal soffitto del museo, all’interno dei quali si trova una sorta di memoriale collettivo. Tra i fili fluttuano infatti fogli di carta che riportano una miriade di nomi, a rappresentare le svariate persone care in un momento della nostra vita che poi si allontanano o scompaiono per diversi motivi. Si compone così una sorta di “nevicata” di memorie, come indica il titolo del lavoro: lo scioglimento della neve come il momento in cui qualcosa finisce ma rimane impresso, una riflessione sull’intensità e allo stesso tempo sulla precarietà che caratterizza inevitabilmente i rapporti umani. L’opera di Chiharu Shiota è il preludio di un progetto espositivo intitolato Il senso della neve, che inizierà al Mudec nel mese di febbraio del 2026 e adotterà un taglio artistico, scientifico, antropologico e storico, cogliendo lo spunto delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.
oppure l’idea di “incontro delle due culture” è una retorica riduttiva? In questo senso, ha un significato particolare esporre al Museo d'arte Orientale?
L’individualità di qualsiasi artista influisce fortemente sulle sue creazioni e il background fa parte dell’individualità. Nel caso di un’artista come me, che si basa molto sulla propria esperienza personale, è stato naturale realizzare diverse opere riguardanti il mio background e le domande che mi pongo in proposito. Essere nata in Oriente per poi spostarmi e studiare in Occidente (vivo in Germania ormai da trent’anni, più della metà della mia vita) mi ha aiutato a capire meglio la mia identità e a vedere l’Oriente stesso con maggiore chiarezza. Quando sono in Germania mi manca il Giappone, e viceversa. In entrambi i Paesi mi sento a casa, e mi mancano entrambi i miei Paesi. Credo che tutti coloro che vivono in una nazione differente da quella in cui sono nati possano condividere questa sensazione. Non è qualcosa che puoi superare razionalmente, è una questione che rimane parte della tua realtà giorno dopo giorno, allo stesso tempo significativa e banale. La mostra al MAO mi ha permesso di vedere come la cultura asiatica viene spiegata e presentata al pubblico occidentale.
RUTH ASAWA / NEW YORK
Beatrice Caprioli
Le sculture sospese di Ruth Asawa (Stati Uniti, 1926-2013), tessute nello spazio con un unico filo metallico intrecciato in continuità, invitano a uno sguardo ravvicinato: variabili nella forma, calibrate sul corpo, seguono logiche organiche e modulari in una sequenza di volumi concentrici che si sovrappongono e compenetrano. Ogni opera è al tempo stesso il risultato delle sue parti e parte di un insieme più ampio: la produzione complessiva dell’artista, educatrice e attivista di origine nippo-americana, che dal 19 ottobre abita gli spazi del Museum of Modern Art di New York. L’appuntamento newyorkese rappresenta la seconda tappa di una mostra itinerante inaugurata al San Francisco Museum of Modern Art e destinata a viaggiare al Guggenheim Bilbao (marzo–settembre 2026) e alla Fondation Beyeler di Riehen/Basilea (ottobre 2026–gennaio 2027).
Ruth Asawa: A Retrospective celebra il centenario della nascita dell’artista e costituisce la prima grande esposizione museale volta a restituire in maniera esaustiva tutte le dimensioni della sua pratica. Oltre a presentare un’attenta selezione delle celebri sculture aeree, per cui Asawa è nota al grande pubblico, la retrospettiva approfondisce la dimensione sociale e partecipativa del suo lavoro: fontane, murales, progetti educativi per la comunità che hanno animato la San Francisco degli anni Sessanta. Video, fotografie e modelli ne raccontano la genesi, dalle prime fasi ideative alle realizzazioni più iconiche, come Andrea a Ghirardelli Square (1968), San Francisco Fountain a Union Square (1973) e Aurora all’Embarcadero (1986). Parallelamente alla sua attività creativa, Asawa si è dedicata intensamente alla formazione dei giovani, promuovendo iniziative come l’Alvarado Arts Workshop e contribuendo alla nascita di una scuola superiore dedicata alle arti, che oggi porta il suo nome.
SPAZIO
Nel corso di una carriera durata non meno di sei decenni, Asawa ha costruito un vasto repertorio di opere (sculture, disegni, dipinti, grafica e altro ancora) che, nel loro insieme, testimoniano un’indagine costante sulle possibilità

Fino al 7 Febbraio
RUTH ASAWA: A RETROSPECTIVE
Museum of Modern Art di New York 11 West 53 Street, Manhattan moma.org
in alto: Ruth Asawa, Untitled (S.390, Hanging Tied-Wire, Double-Sided, Center-Tied, Multi-Branched Form with Curly Ends), 1963. Filo di rame, 50,8 × 50,8 × 50,8 cm. Black Mountain College Museum + Arts Center, dono di Rita Newman. © 2025 Ruth Asawa Lanier, Inc., Courtesy: David Zwirner.
in alto a destra: Ruth Asawa alla mostra Ruth Asawa: A Retrospective View, San Francisco Museum of Art, 1973. Ph. Laurence Cuneo. © 2025 Ruth Asawa Lanier, Inc., Courtesy: David Zwirner. in basso a destra: Ruth Asawa, Untitled (S.398, Hanging Eight-Lobed, Four-Part, Discontinuous Surface Form within a Form with Spheres in the Seventh and Eighth Lobes), c. 1955. Filo di ottone, filo di ferro e filo di ferro zincato, 265,4 × 36,8 × 36,8 cm. The Museum of Modern Art, dono di Alice e Tom Tisch, 2016. © 2025 Ruth Asawa Lanier, Inc., Courtesy: David Zwirner.
della forma, l’impatto del gesto nello spazio, la ricerca dei materiali e, più in generale, dello stesso fare arte. L’artista rivendica infatti lo spazio quale elemento attivo della composizione, tanto all’interno quanto all’esterno dell’opera. “Una linea,” osservava, “può racchiudere e definire lo spazio lasciando che l’aria resti aria”. Una riflessione, questa, che trova riscontro nel primo saggio critico dedicato agli aspetti formali della sua opera, firmato da Gerald Nordland, curatore della grande retrospettiva di metà carriera organizzata al San Francisco Museum of Art nel 1973 (fig.3). Nordland individua in Asawa una chiara sensibilità costruttivista nella concezione della composizione bidimensionale, trasposta poi con coerenza nelle sue sculture intrecciate in rame, ottone, ferro e acciaio. La trama metallica, compatta e al tempo stesso trasparente, rivela le possibilità pressoché infinite di un materiale semplice come il filo. Asawa lo lavora secondo una tecnica di derivazione artigiana

appresa durante un viaggio in Messico nel 1947, costruendo la struttura con una sequenza di anelli concatenati, secondo il metodo tradizionalmente impiegato nella realizzazione dei cesti: “la mia curiosità fu stimolata dall’idea di dare forma strutturale alle immagini dei miei disegni. Quelle forme nascono dall’osservazione delle piante, della spirale del guscio di una lumaca, della luce che attraversa le ali degli insetti […]”. La sua pratica si traduce così “in una rete tessuta, non dissimile a quella della maglia medievale. Un unico filo continuo: forme che contengono forme interne, eppure tutte le forme restano visibili (trasparenti)”, e dove anche la presenza immateriale dell’ombra “rivela un’immagine esatta dell’oggetto”.
L’attenzione scrupolosa che l’artista nutre per lo spazio e per i materiali attraverso cui esplorarlo è germogliata al Black Mountain College, piccola istituzione sperimentale di arti liberali del North Carolina, che avrebbe esercitato un’influenza straordinaria sulla vita culturale degli Stati Uniti nel secondo dopoguerra. Ispirato agli ideali utopici del movimento pedagogico progressista, il College poneva le arti visive e performative al centro dell’educazione umanistica, nella convinzione che esse fossero essenziali alla formazione di cittadini consapevoli e attivamente partecipi della vita democratica. Il metodo fondeva i principi artigianali

del Bauhaus con una pratica educativa basata sull’interdisciplinarità, sulla discussione collettiva e sulla sperimentazione, valori che sarebbero divenuti centrali nella ricerca di Asawa. L’artista si iscrisse a Black Mountain nell’estate del 1946 ed entrò in dialogo con personalità
quali Josef Albers, Merce Cunningham e Buckminster Fuller. Le lezioni di Albers in particolare, dedicate al colore e al design, furono per lei decisive: Asawa riconobbe in lui non solo il maestro che le trasmise l’arte del disegno, ma soprattutto colui che le affinò lo sguardo, “allenando l’occhio ad anticipare la matita”.
LA DANZA NELLE OPERE
SU CARTA DI RUTH ASAWA
Le opere su carta realizzate in quegli anni, oggi esposte al MoMA, mostrano composizioni curvilinee segnate profondamente anche dall’esperienza dei corsi di danza frequentati con Cunningham e, successivamente, con Elizabeth Schmitt Jennerjahn, entrambi formatisi con Martha Graham a New York. La danza, intesa come studio del corpo nello spazio, ebbe un impatto diretto sul lavoro dell’artista: le esercitazioni fondate sulla relazione tra luce, suono e movimento le rivelarono come il gesto potesse tradursi in pura energia visiva. Da queste esplorazioni nacque un principio generativo che condusse Asawa, nei primi anni Cinquanta, alla celebre serie delle continuous form within a form: sculture in trama metallica che impiegano lo spazio negativo come matrice generativa della forma. La logica del segno — una linea che curva, si duplica, si avvolge — diviene così architettura di un linguaggio tridimensionale radicalmente nuovo, nel quale la compenetrazione dei volumi introduce una spazialità permeabile fondata sulla trasparenza e sull’interrelazione dei piani, come avviene in Untitled (S.535, Hanging Five-Lobed Continuous Form within a Form with Spheres in the First and Fourth Lobes and a Teardrop Form in the Third Lobe) (1951) (fig.1), ora esposta nelle sale del MoMa .
Il linguaggio delle continuous forms si è rivelato nel corso degli anni una chiave di lettura fertile per comprendere l’ampiezza del progetto artistico di Asawa. Ed è proprio a partire da questa consapevolezza che, a distanza di tempo, la sua opera ha conosciuto un’importante rivalutazione critica e istituzionale. La retrospettiva del MoMA si inserisce infatti in un più ampio processo di valorizzazione, volto a riconoscere il ruolo cruciale che l’artista ha rivestito nella storia dell’arte del secondo dopoguerra. Questo interesse ha avuto un punto di svolta nel 2013 con la mostra Ruth Asawa: Objects and Apparitions, curata da Jonathan Laib presso Christie’s New York — la prima presentazione newyorkese dell’artista dopo cinquant’anni. Laib ha poi proseguito questo percorso di riscoperta nel ruolo di Senior Director presso la galleria David Zwirner, che dal 2017 ha assunto la rappresentanza esclusiva dell’archivio Asawa, avviando un’importante attività di promozione internazionale. Il riposizionamento nel canone contemporaneo ha trovato ulteriore conferma nella partecipazione alla 59ª Biennale di Venezia, dove un gruppo delle iconiche sculture aeree sono state incluse nella mostra The Milk of Dreams curata nel 2022 da Cecilia Alemani.
FONDATION CARTIER / PARIGI

Bianca D’Ippolito
La nuova Fondation Cartier pour l’art contemporain apre le porte il 25 ottobre negli antichi Grands Magasins du Louvre Per l’inaugurazione, 600 opere tra le circa 4500 raccolte dall’istituzione dal 1984 saranno presentate nei 7000 mq di spazi espositivi completamente ripensati dal maestro dell'architettura contemporanea Jean Nouvel. Scopriamo i dettagli con Béatrice Grenier, co-curatrice della mostra inaugurale e direttrice dei progetti strategici e internazionali della Fondation.
L’apertura della nuova sede della Fondazione è stata attesa per anni con grande interesse. Quali sono le principali novità?
La nuova sede in Place du Palais-Royal rappresenta un’evidenza geografica, ma le implicazioni vanno oltre. Trovarsi nel cuore di Parigi, su una delle più antiche piazze pubbliche, di fronte al Louvre comporta per l’istituzione una nuova consapevolezza della propria responsabilità culturale. Ci si interroga su cosa mostrare, come programmare, in che modo dialogare con la città e con nuovi pubblici. La Fondation Cartier entra in un edificio esistente, reinterpretandolo attraverso un dispositivo
museografico radicale progettato da Jean Nouvel: cinque piattaforme mobili e modulabili che permettono di ridefinire lo spazio a ogni mostra. Ciò implica che ogni esposizione parte dalla domanda “quale architettura per quale progetto?”, mettendo in discussione l’idea tradizionale di scenografia come narrazione lineare. L’esperienza proposta diventa costruita su volumi e prospettive, aprendo la strada a nuove forme di lettura e di fruizione delle opere.
Da quello che racconta, emerge chiaramente come il gesto architettonico di Jean Nouvel sia inseparabile dall’identità della Fondation Cartier.
Sì, assolutamente. Negli Anni Novanta, il celebre edificio in vetro e acciaio del XIVesimo arrondissement era stato concepito come una sorta di scatola meteorologica immersa in un giardino, capace di dialogare con le variazioni di luce e clima, e con la biodiversità circostante. Questo contesto aveva orientato la programmazione verso una riflessione profonda sul rapporto tra natura e cultura umana. Anche oggi l’architettura resta una condizione imprescindibile, ma assume un peso ancora maggiore. La domanda è diventata: come può la Fondation evolversi in un contesto storico e
patrimoniale, e superare il dispositivo espositivo utilizzato per oltre trent’anni? È stata una riflessione adottata sia dall’istituzione che per Jean Nouvel, che ha risposto con grande libertà creativa. Il nuovo progetto nasce dal desiderio di rispettare lo spirito storico e culturale dell’edificio — costruito per la prima Esposizione universale e parte integrante della modernizzazione haussmanniana — e al tempo stesso di introdurvi una nuova dimensione espositiva. Inserire una “macchina” modulare con 5 piattaforme mobili in una struttura in pietra significa proseguire la storia della modernità parigina della seconda metà dell’Ottocento, con tutto l’immaginario legato all’Esposizione universale e alle sue innovazioni meccaniche.
La mostra inaugurale presenterà 600 opere di oltre 100 artisti che hanno segnato la storia della Fondation dal 1984. Come si è formata questa collezione e come si è trasformata nel corso di quarant’anni? È molto interessante osservare come la Fondation Cartier abbia costruito la propria collezione, perché il suo modello è piuttosto singolare nel panorama delle istituzioni culturali. Fondata nel 1984 senza un fondo preesistente, la Fondation ha scelto di costituire la collezione direttamente attraverso la sua programmazione. Invece di adottare una politica di acquisizioni autonoma, ha commissionato opere agli artisti nel contesto delle mostre organizzate nei suoi spazi, acquisendole poi per la propria raccolta. La collezione ha dunque un doppio statuto, da un lato riflette quarant’anni di arte contemporanea recente, dall’altro rappresenta un archivio vivo della storia e dell’evoluzione della programmazione dell’istituzione, ancora giovane. Per questa esposizione inaugurale ci siamo chiesti come restituire le linee di forza di questa storia attraverso un ritratto della collezione stessa. Il titolo scelto, Exposition générale, rimanda alla storia dell’edificio, che per oltre 150 anni ha ospitato un grande magazzino dove si organizzavano le cosiddette “esposizioni generali” (grandi eventi dedicati alle novità commerciali, domestiche e tecnologiche, spesso accompagnati da pubblicazioni e cataloghi) ma riflette anche l’interazione tra programmazione e collezione, suggerendo l’idea di una “collezione di esposizioni”.
Quali sono stati per lei i principali obiettivi e le sfide di questa mostra inaugurale?

Era importante mostrare come la Fondation ha affrontato temi cruciali come l’ecologia e il cambiamento climatico, esplorando il modo in cui queste questioni entrano nella pratica artistica contemporanea. Allo stesso tempo, l’obiettivo era anche prefigurare le direzioni future della programmazione con l’interesse per la scienza e i mondi tecnologici e il loro ruolo nell’immaginario contemporaneo, l’attenzione per l’architettura e l’urbanistica, la valorizzazione dei saperi artigianali, così come l’impegno degli artisti nei confronti dell’ambiente.
Quali sono i progetti internazionali in corso e in che modo la Fondation Cartier afferma oggi la propria presenza sulla scena globale?
La Fondation Cartier si definisce al tempo stesso parigina e internazionale per natura. Fin dalle origini, uno degli obiettivi principali è stato costruire collaborazioni capaci di generare un’intelligenza curatoriale globale. Oggi un’istituzione ha la responsabilità di riconoscere che non possiede da sola tutte le conoscenze e non può essere completamente autonoma nel definire cosa sia la creazione contemporanea. La creazione di partnership internazionali nasce proprio dal desiderio di ampliare questa intelligenza collettiva e di attivare dialoghi con pubblici che forse non visiteranno mai la Fondation Cartier a Parigi. Attraverso progetti condivisi con istituzioni di Sydney, Miami, Shanghai e altre città, la Fondation instaura conversazioni con contesti diversi, riportando poi a Parigi conoscenze e prospettive che arricchiscono la sua programmazione.
In un mondo interconnesso, in cui le scene locali non esistono più nella loro forma isolata, questi partenariati permettono di partecipare a una cultura ormai planetaria e di rendere l’arte

contemporanea accessibile a un pubblico ampio. Più che moltiplicare le sedi fisiche, l’obiettivo è costruire una costellazione di partner chiave con cui mantenere un dialogo costante.
Cosa può raccontarmi della Fondation Cartier a Milano?
Da diversi anni collaboriamo con la Triennale, e torniamo ora con una mostra dedicata ad Andrea Branzi, figura centrale della scena radicale italiana e protagonista di primo piano nella storia della Fondation Cartier, che gli aveva già dedicato una personale nel 2008 commissionandogli due importanti opere. Branzi, teorico
estremamente prolifico, ha avuto un ruolo fondamentale anche nella definizione del concetto stesso di museo del design.
La mostra milanese sarà la sua più grande retrospettiva dopo la sua scomparsa nel 2023 e sarà allestita secondo un progetto concettuale e scenografico firmato da Toyo Ito. Si tratta di un evento di grande rilievo, che consolida anni di collaborazione con la Triennale e rafforza la vocazione della Fondation Cartier a esplorare i campi del design e dell’architettura — temi che sono anche al centro dell’identità della Triennale stessa.
Oltre all’esposizione, che resterà aperta per un lungo periodo, è previsto un articolato programma di conferenze e simposi, nonché un ciclo di conversazioni organizzate durante il Salone del Mobile in suporto alle dimensione discorsiva e di ricerca che accompagna questo progetto.
Cosa spera per questo nuovo capitolo della Fondation?
Spero che ogni mostra diventi un’occasione per ripensare, in modo dinamico e innovativo, il ruolo stesso di un’istituzione culturale nel nostro tempo. Pur non essendo formalmente un museo, la Fondation Cartier vuole proporre un modello culturale capace di mettere costantemente in discussione le proprie forme e funzioni
Tutte le iniziative per i primi quarant’anni di Fondation Cartier
a sinistra e in alto: La Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2 place du Palais-Royal, Paris. ©
/ ADAGP, Paris, 2025.
Vue d’exposition.

Santa Nastro
Un progetto ad ampio respiro con quattro anni di gestazione alle spalle è quello dedicato a Fra Giovanni da Fiesole, noto ai più come Beato Angelico. A curare l’intero marchingegno espositivo proposto da Palazzo Strozzi e dal Museo di San Marco è un team di curatori composto da Carl Brandon Strehlke, Curatore emerito del Philadelphia Museum of Art, con Stefano Casciu, Direttore regionale Musei nazionali Toscana, e Angelo Tartuferi, già Direttore del Museo di San Marco per una mostra che solo nella prima settimana di apertura ha raggiunto le 10mila presenze. Frutto di anni di lavoro, il progetto, spiegano Luigi De Siervo e Arturo Galansino (rispettivamente Presidente e Direttore di Palazzo Strozzi) ha restituito al pubblico “in un contesto unitario oltre centoquaranta opere tra dipinti, sculture e miniature, provenienti da più di settanta prestigiosi musei, biblioteche e collezioni italiane e internazionali, tra cui il Louvre,
Fino al 25 gennaio BEATO ANGELICO
A cura di Carl Brandon Strehlke e Stefano Casciu
Palazzo Strozzi
Piazza Degli Strozzi, Firenze Museo di San Marco
Piazza San Marco, Firenze palazzostrozzi.org
la Gemäldegalerie di Berlino, il Metropolitan Museum di New York, lo Städel Museum di Francoforte, la National Gallery di Washington, il Philadelphia Museum of Art, gli Uffizi, i Musei Vaticani, la Alte Pinakothek di Monaco, la Thyssen-Bornemisza Collection, il Rijksmuseum di Amsterdam, ma anche da numerose chiese e istituzioni territoriali di grande valore storico e culturale”.
La grande mostra su Beato Angelico giunge per la prima volta a Firenze 70 anni dopo l’imponente esposizione dei Musei Vaticani e del Museo di San Marco per il cinquecentenario dalla morte dell’artista (Roma, 1455). Nato Guido di Piero nel 1395 a Vicchio di Mugello, prende il nome di Fra Giovanni da Fiesole. L’appellativo di “Angelico” gli fu conferito da Giorgio Vasari ne Le Vite (anche se alcuni documenti del 1469 in ambito domenicano già lo riportano con questo nome), grazie all’aura spirituale che pervadeva tutte le sue opere, mentre la beatificazione
giunge nel 1982, per volere di Giovanni Paolo II. Quella che Arturo Galansino definisce “un’impresa straordinaria”, ha tra gli altri meriti di inserire l’artista frate domenicano, nella cornice dei coevi, immergendo le sue opere tra i lavori di Lorenzo Monaco, alla quale bottega Beato Angelico si formò prima di prendere i voti, Masaccio, Filippo Lippi, Lorenzo Ghiberti e Luca della Robbia, del quale l’esposizione presenta uno splendido busto.
“Ha partecipato Beato Angelico alla rivoluzione? Con questa mostra intendiamo affermare che sì, Fra Giovanni vi ha partecipato”. Così Carl Brandon Strehlke, richiamandosi alla scrittrice Elsa Morante e intendendo “la rivoluzione delle arti durante il Rinascimento”, introduce l’esposizione, nata grazie a una collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura. Si parte dagli esordi dell’artista (“un elemento non secondario della sua grandezza che inoltre ne rimarca la diversità rispetto a Masaccio, come nota Tartuferi), con un focus importante al Museo di San Marco che documenta quello che forse è il momento più controverso nella storia dell’artista. Prima di essere frate (prenderà i voti nel 1420) Angelico è pittore, consolidandosi come maestro tardo gotico per poi diventare il campione del Rinascimento fiorentino che tutti conosciamo, con un’opera innovativa che comunque affonda le radici nella tradizione giottesca. Il Museo di San Marco, che tutti conoscono come il “museo di Beato Angelico” racconta “una fase centrale e identitaria del percorso artistico del frate pittore” per dirla con Casciu, accennando inoltre, al percorso che ha portato “il convento domenicano, tra Ottocento e Novecento, ad assumere per vari passaggi una configurazione museale dapprima fortemente

incentrata sulle memorie domenicane; poi quasi monografica intorno alla figura di Beato Angelico; e oggi articolata e diversificata secondo una visione più ampia e complessiva del monumento (incluse le aree non musealizzate) e delle sue collezioni artistiche”. Ma l’esposizione non dimentica di raccontare le grandi committenze, gli incontri, l’esperienza romana dell’artista, quella forse più difficile da ricostruire anche per l’assenza di molte opere. Beato Angelico si sposta infatti nella Capitale nel 1445 per volere di Papa Eugenio IV e dipinge successivamente la Cappella Niccolina in Vaticano, diventando ufficialmente un artista papale. L’attualità delle opere di Angelico e dei coevi viene riconfermata dall’allestimento, che oltre a salvaguardarne la monumentalità e la sacralità in un assetto totalmente museale, ne evidenzia la freschezza nella disinvoltura con cui

le sale di Strozzi passano da opere contemporanee a quelle realizzate da un maestro di questo calibro. Ad accogliere il pubblico è la Pala Strozzi che vede insieme operare Monaco e Beato Angelico in un impianto maestoso. Di pochi anni più tardo è il Giudizio Universale, nel quale l’uso dell’oro e del fondo blu impreziosiscono un racconto complesso e articolato. I colori brillanti, l’uso della foglia oro, la lezione dell’arte amanuense della miniatura sono tra le cifre stilistiche dell’artista.
Coinvolgente e commovente nella tessitura del racconto è la Pala di San Marco o la teoria dei volti di Cristo con gli occhi rossi, inumiditi dalle lacrime e dalla sofferenza – tra questi il noto Cristo come Re dei Re della Cattedrale di San Francesco di Livorno. E ancora a stupire sono i grandi crocifissi, intagliati e monumentali come opere contemporanee di Monaco o Pesellino, e gli affreschi del Museo di San Marco, di fondazione medicea e realizzato da Michelozzo, che mostrano la capacità di Beato Angelico di utilizzare senza dubbio diversi strumenti e supporti pittorici. “Questa mostra”, spiega Stefano Casciu, “è fondamentale da un punto di vista scientifico, ampiamente documentato dal catalogo aggiornatissimo edito da Marsilio. Racconta gli sviluppi più recenti della ricerca nel periodo giovanile dell’artista, ma ha anche offerto l’occasione di realizzare ben trenta tra restauri e manutenzioni straordinarie, inoltre indagini diagnostiche che hanno permesso di ricomporre molte opere e di far capire come dipingeva Angelico. E ancora come erano composte le tavole medicee e come si connettevano tra loro, quale era l’ordine esatto delle predelle anche attraverso lo studio del legno e delle venature, con tecniche sofisticate. Sono contributi scientifici che rimarranno nella storia dell’arte”.

Alessandra Mammì
Purtroppo non sappiamo (né mai sapremo) se la Fantastica 18ma Quadriennale immaginata da Luca Beatrice fosse veramente quella che ora vediamo al Palazzo delle Esposizioni
O se invece nelle intenzioni del presidente prematuramente scomparso, sarebbe stata più immaginifica, sorprendente e provocatoria, così come l’aveva descritta nelle conferenze stampa di anticipazione. Era infatti allora che aveva annunciato l’omaggio alla Quadriennale del 1935, quella che celebrava le arti di regime di un fascismo nel suo momento di gloria. La rievocazione di quella edizione fu vista (anche da chi scrive) come un gesto di adesione al progetto culturale inaugurato dalla nuova cultura di destra per sottrarre le arti del ventennio dalla “damnatio memoriae”, fermandosi un attimo prima delle leggi razziali e della dichiarazione di guerra.
Anche Fantastica fin dal titolo doveva suonare come un risveglio, un superamento delle convenzioni e delle abitudini visive a cui il sistema dell’arte ci ha abituato. Un progetto non molto diverso dallo spirito del suo padiglione italiano per la Biennale veneziana del 2009 dal titolo
Collaudi che partiva da una volontà di rottura dalla ingombrante eredità poverista per fare il punto su una “nuova figurazione italiana”. Un presupposto interessante anche se poi la mostra fu visivamente poco omogenea, gli artisti troppi e troppo diversi fra loro e non convinse né la critica né la giuria. Forse, memore dei limiti di quell’esperimento, Beatrice sarebbe riuscito questa volta a contenere la bulimia visiva e a rendere più fantastica che fantasmagorica questa esposizione.
Purtroppo invece la scelta dei cinque curatori diversi per generazione e formazione, di temi eterogenei che si sovrappongono senza nessuna concatenazione, di un progetto architettonico dello studio BRH+ che cerca di far compenetrare le diverse sezioni riuscendo solo ad accavallarle e a complicare i passi del visitatore, non rende facile la lettura di questa Quadriennale dove la presenza di molti buoni artisti non basta a salvarne la sua natura Frankenstein fatta di cinque corpi (sei con la mostra storica) troppo diversi per tema, scelte curatoriali e scrittura visiva.
Ed ecco che all’ingresso siamo accolti dall’immensa installazione scultorea di Giulia Cenci
(Secondary Forest inizialmente concepita per l’High Line di New York) che introduce la sezione di Francesco Bonami senza però permetterci di proseguire il percorso al suo interno. Bisogna scegliere come negli indovinelli della Sfinge, se dirigersi a sinistra ed entrare nelle stanze Senza titolo di Francesco Stocchi o a destra, nelle perlopiù distopiche visioni sul Corpo incompiuto di Alessandra Troncone
Tendenzialmente si opta per Stocchi attirati da una meravigliosa macchina celibe di Arcangelo Sassolino: la testa di una scavatrice che mimando i movimenti di un animale aggredisce con i suoi artigli il pavimento di cemento… È la star di questa sezione alla quale Stocchi citando come esempio la mostra dei Surrealisti del 1938, non ha voluto dare titolo in nome di un metodo che punta a un’esperienza immersiva e di una curatela che si pone come coreografia di un atto creativo collettivo.
Concettualmente “senza titolo” appare anche la sezione di Bonami che rimanda al pubblico il compito di trovare analogie o connessioni fra i tanti (soprattutto pittori) nomi scelti

per questa sua mostra. Tutti artisti sotto i cinquant’anni e senza alcun apparente legame fra loro. L’Autoritratto invece è il filo rosso scelto da Luca Massimo Barbero e in tempi di disturbo narcisistico epidemico, risulta un oggetto interessante da indagare. Peraltro Barbero usa un dispositivo di lettura bifronte per rivelare la duplicità o la molteplicità dei sé di ogni artista qui presente. Il primo esempio sono due rarissime immagini di un quadro di Lucio Fontana che nel recto scrive “Io sono un santo” e nel verso “Io sono una carogna”. Purtroppo anche qui (a parte un’isola che premia il sempre intelligente lavoro di Vedova Mazzei), il senso di dispersione prevale.
Le due sezioni tematicamente più compatte sono quelle firmate da Alessandra Troncone e Emanuela Mazzonis di Pralafera. La prima è un’indagine su “quel che resta del corpo” che dopo un viaggio fra metamorfosi e mutazioni, corpi non conformi, entità fluide, braccia robotiche (tra cui si segnalano l’installazione di Agnés Questionmark e i video terapeutici di Federica di Pietrantonio) culmina in Lifeweave di Emilio Vavarella, un’opera/ processo che rende possibile trasformare il Dna di ogni visitatore in un intreccio di filamenti che producono un arazzo per ognuno ovviamente diverso.

L’ultima sezione del percorso, (ultima solo logisticamente perché in realtà è la più innovativa e interessante) firmata dalla Mazzonis ha un titolo Il tempo delle immagini che non premia la complessità del percorso e della domanda di partenza: di fronte all’inondazione di selfie, meme screenshot, gif, reel, stories cosa resta della fotografia e della sua possibilità di catturare almeno una parte della realtà? La risposta si snoda qui in immagini e storie che partono

Fino al 18 gennaio
A cura di Francesco Bonami, Luca Massimo Barbero, Emanuela Mazzonis, Alessandra Trontone e Francesco Stocchi
Palazzo delle Esposizioni
Via Nazionale 194, Roma quadriennalediroma.org
18° Quadriennale d’arte, Fantastica, Palazzo Esposizioni Roma, 11 ottobre 2025 - 18 gennaio 2026, veduta dell’allestimento della sezione curata da Francesco Stocchi.
Nella foto in alto a sinistra: opere di Luca Bertolo, Arcangelo Sassolino, Valerio Nicolai, courtesy Fondazione La Quadriennale di Roma, Fotografia
Agostino Osio - Alto Piano
Nella foto a fianco: opere di Lulù Nuti, Valerio Nicolai, Luca Bertolo, Martino Gamper, Pietro Roccasalva, Arcangelo Sassolino, courtesy Fondazione La Quadriennale di Roma, Fotografia Agostino Osio - Alto
Piano
Nella foto in alto: l’opera di Giulia Cenci, courtesy Fondazione La Quadriennale di Roma, Fotografia
Agostino Osio - Alto Piano
dall’idea di fotografia per trascenderla in ogni opera. Dal ritratto della madre cameriera che Eleonora Agostini compone attraverso un moltiplicarsi di dettagli sul suo corpo, sui gesti e sugli spazi quotidiani, alla storia di uno zio scomparso in Nuova Zelanda che porta Giulia Parlato a confrontarsi con un territorio più immaginato che visto, fino alla cruda documentazione sul centro chirurgico in Sierra Leone con cui Massimo Grimaldi, da anni collaboratore di Emergency, riesce attraverso slide motion a unire reportage e narrazione fortemente emotiva. E di materia fotografica è fatto anche l’ingresso alla sezione dove Giovanni Ozzola riprende la volta a crociera del convento fiorentino di San Marco dove è esposta l’Annunciazione del Beato Angelico, e la ricopre con la riproduzione di un cielo stellato colto nell’istante in cui dalla notte si passa all’ora blu che precede l’alba.
Ed eccoci all’ultima tappa. La rievocazione della II Quadriennale del 1935 a cura di Walter Guadagnini. Allestita nel secondo piano, lungo il ballatoio, la tanto attesa ricostruzione, in realtà non c’è. Ci sono quadri e sculture del 1935, alcuni anche bellissimi, ma niente a che vedere con quella Esposizione inaugurata da Mussolini, immortalata dai filmati del Luce e soprattutto documentata dal catalogo che si può facilmente trovare nell’archivio on line. In questa formula edulcorata non troveremo il Polittico fascista (Guerra. Rivoluzione. Giovinezza) di Gerardo Dottori, né i ritratti in pittura e scultura del Duce, o la belligerante sezione firmata da Marinetti e divisa fra Vita fascista e Aeropittura
Niente di tutto questo appare nelle scelte di Guadagnini, depauperate di ogni intento provocatorio, ma anche della verità storica che accompagnò l’evento. Qui ci si limita a un generico confronto generazionale fra l’arte dei “maestri” e quella dei “giovani” tra cui anche un trentenne Carlo Levi, che proprio nel corso di quella esposizione fu arrestato e mandato al confino in quanto antifascista.
Quindi persino la mostra che, comunque la si consideri, era un focus del progetto culturale di Luca Beatrice, finisce per risolversi in una innocua e debole galleria di quadri belli del 1935
Un altro atto mancato di una edizione che alla fine non riesce a darci un vero panorama dell’arte italiana, né omologato né alternativo al sistema. Una mostra fatta di sei piccole mostre firmate da curatori che non dialogano fra loro. Una rassegna piena di bravi artisti, ma priva di un contesto che riesca a rafforzarli.
ILARIA D'UVA

Marta Santacatterina
Nel lontano 1959 un giovane curioso inventò la prima audioguida italiana, dando poi vita alla società D’Uva. Oggi l’azienda ha ampliato la sua attività, ma raccontare il patrimonio culturale e le mostre attraverso parole, musica, immagini ed esperienze è ancora una delle sue mission principali, come ci spiega Ilaria D’Uva, Chief executive officer e figlia del fondatore.
Giovanni D’Uva è conosciuto come il padre delle audioguide: ci racconta la storia di questa invenzione?
Tutto è cominciato nel 1959, mio padre aveva 19 anni e davanti a una vetrina di monete al Museo del Bargello di Firenze, un bambino chiese alla mamma cosa fossero; lei si rivolse a mio padre, che poté rispondere solo: “Sono dei fiorini”. In quel momento si rese conto che serviva uno strumento per rispondere alle curiosità dei visitatori. Inventò allora una macchina dotata di una cornetta del telefono e la propose ai musei fiorentini, che però la rifiutarono; riuscì invece a installare le prime audioguide fisse nel Duomo di Milano. Molti anni dopo, nel 1997, l’azienda introdusse le audioguide portatili al Colosseo e da allora la nostra azienda si è posizionata come leader in questo settore.

Che funzione dovrebbe avere un’audioguida di una grande mostra?
L’audioguida deve raccontare il contenuto della mostra, ma soprattutto deve emozionare. Non bisogna infatti riempire il visitatore di informazioni (le date, i nomi, gli stili, gli artisti minori), ma guidarlo in un’esperienza emotiva. È un aspetto su cui noi puntiamo tantissimo.
Quali devono essere le caratteristiche principali dell’audioguida?
Prima di tutto deve essere precisa, i suoi contenuti vanno sempre verificati, soprattutto se si usa l’intelligenza artificiale. L’audioguida inoltre dev’essere elegante, cioè bisogna selezionare molto bene quel che si vuole raccontare, e infine dev’essere coinvolgente: la voce, il racconto, le musiche, le pause devono sopperire alla mancanza di gestualità, di sguardi, di dialogo di una guida in carne e ossa. Questo è importantissimo, altrimenti diventa noiosa.
Come si progetta un’audioguida?
Innanzitutto si discute con l’organizzatore della mostra per la parte contrattuale, perché la tendenza è pagare poco questo servizio. Poi si determinano le tempistiche necessarie per elaborare un pensiero creativo, fare sopralluoghi, selezionare le voci più adatte. Quindi si dialoga con il curatore - anche se spesso riscontriamo un certo snobismo intellettuale verso le audioguide da parte di chi cura le mostre - perché il contenuto deve interpretare il suo pensiero; molto spesso lo coinvolgiamo anche per spiegare il progetto espositivo in prima persona. Quando si costruisce il contenuto, inoltre, va prestata grande attenzione ai flussi dei visitatori per non rischiare di affollare le sale. Una volta pronta, l’audioguida andrebbe provata in mostra per capire se funziona, se occorrono dei tagli e se i riferimenti alle opere sono chiari: a tal proposito vanno evitate le indicazioni ambigue, come “alla vostra destra”, ed è cruciale il ruolo di una segnaletica esplicita che consenta di leggere a distanza il numero che rimanda al contenuto.
Avete sperimentato anche le app, ma di recente siete tornati all’audioguida tradizionale: perché?
Usiamo ancora le app e le videoguide, oltre ai totem digitali, le radioguide per i gruppi e altri strumenti, ma in realtà l’audioguida tradizionale si è rivelata più efficace e più apprezzata dal pubblico: usare un’app sullo smartphone comporta vari passaggi e soprattutto scarica la batteria del dispositivo. A proposito di tecnologie, invece, stiamo sviluppando un progetto molto sofisticato che, grazie all’AI, profilerà il visitatore in maniera inclusiva, creando contenuti declinati sulle caratteristiche dell’utente, ad esempio per età, provenienza, eventuali disabilità… Ma per ora non posso svelare altro!
in alto: una visitatrice mentre ascolta un'audioguida a sinistra: Ilaria D'Uva
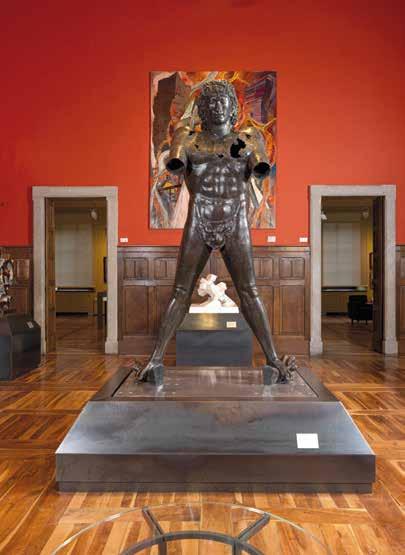


MILANO
Dal 11 novembre al 19 settembre
CHIHARU SHIOTA
THE MOMENT THE SNOW MELTS
MUDEC – Museo delle Culture www.mudec.it
Fino al 17 maggio
LA BELLEZZA E L'IDEALE.
LA COLLEZIONE CANOVA DI BANCA
IFIS E LA PINACOTECA VIAGGIANTE
Pinacoteca di Brera pinacotecabrera.org
Fino al 15 febbraio
NAN GOLDIN – THIS WILL NOT END WELL
Hangar Bicocca pirellihangarbicocca.org
Fino all'11 gennaio
LEONORA CARRINGTON
Palazzo Reale palazzorealemilano.it
TORINO
Fino al primo febbraio
JEFF WALL. PHOTOGRAPHS
Gallerie d'Italia
Piazza San Carlo, Torino gallerieditalia.com
Fino al 28 giugno
CHIHARU SHIOTA: THE SOUL TREMBLES
MAO – Museo d'Arte Orientale maotorino.it
Dal 31 ottobre al 10 maggio
LAURE PROUVOST | ELECTRIC DREAMS
OGR Torino ogrtorino.it
Dal 29 ottobre al 22 marzo
ENRICO DAVID – DOMANI TORNO
Castello di Rivoli – Museo d'Arte Contemporanea castellodirivoli.org
Dal 27 ottobre al primo febbraio
PUSH THE LIMITS 2
Fondazione Merz fondazionemerz.org
Dal 28 ottobre all'8 marzio
NEWS FROM THE NEAR FUTURE
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo fsrr.org
Fino al primo febbraio
FERNAND LÉGER! YVES KLEIN, NIKI DE SAINT PHALLE, KEITH HARING…
Reggia di Venaria lavenaria.it
MODENA
Fino all’8 febbraio
IL TEMPO DELLA SCRITTURA.
IMMAGINI DELLA CONOSCENZA
DAL RINASCIMENTO A OGGI
La Galleria BPER lagalleriabper.it
FIRENZE
Fino al 25 gennaio
BEATO ANGELICO
Palazzo Strozzi
Piazza Strozzi palazzostrozzi.org
Fino al 6 gennaio
CLEMEN PARROCCHETTI. IRONIA RIBELLE
Palazzo Medici Riccardi musefirenze.it
NAPOLI
Fino al 10 febbraio
JIM DINE – ELYSIAN FIELDS
Castel Nuovo – Maschio Angioino
Dal 20 novembre al 22 marzo
DONNE NELLA NAPOLI SPAGNOLA.
UN ALTRO SEICENTO
Gallerie d'Italia – Napoli gallerieditalia.com
UDINE
Fino al 12 aprile
CONFINI DA GAUGUIN A HOPPER.
CANTO CON VARIAZIONI
Villa Manin villamanin.it
VENEZIA
Fino al 2 marzo
MANI – FATTURA:
LE CERAMICHE DI LUCIO FONTANA
Collezione Peggy Guggenheim guggenheim-venice.it
Fino al 6 gennaio
ROBERT MAPPLETHORPE/
MAURIZIO GALIMBERTI
Le stanze della Fotografia lestanzedellafotografia.it
Fino al 4 gennaio
TATIANA TROUVÉ
LA STRANA VITA DELLE COSE
Palazzo Grassi pinaultcollection.com
ROVIGO
Fino al primo febbraio
RODNEY SMITH.
FOTOGRAFIA TRA REALE E SURREALE
Palazzo Roverella palazzoroverella.com
FORLÌ
Fino all'11 gennaio
LETIZIA BATTAGLIA.
L'OPERA: 1970 – 2020
Musei Civici di San Domenico mostrefotograficheforli.it
ROMA
Fino al 18 gennaio
LA 18ESIMA QUADRIENNALE
Palazzo delle Esposizioni palazzoesposizioniroma.it
Fino al 3 maggio
TESORI DEI FARAONI
Scuderie del Quirinale
Via Ventiquattro Maggio 16 scuderiequirinale.it
Fino al 1° marzo
LE FIABE SONO VERE...
STORIA POPOLARE ITALIANA
Museo delle civiltà museodellecivilta.it



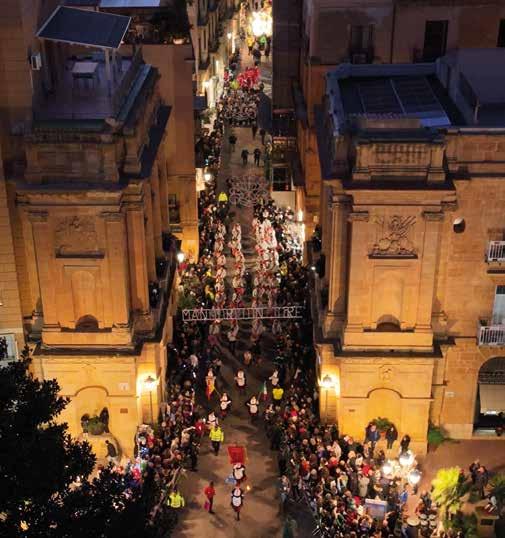


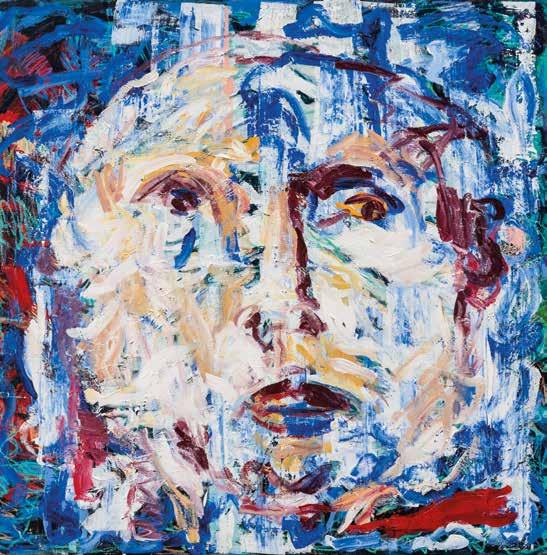
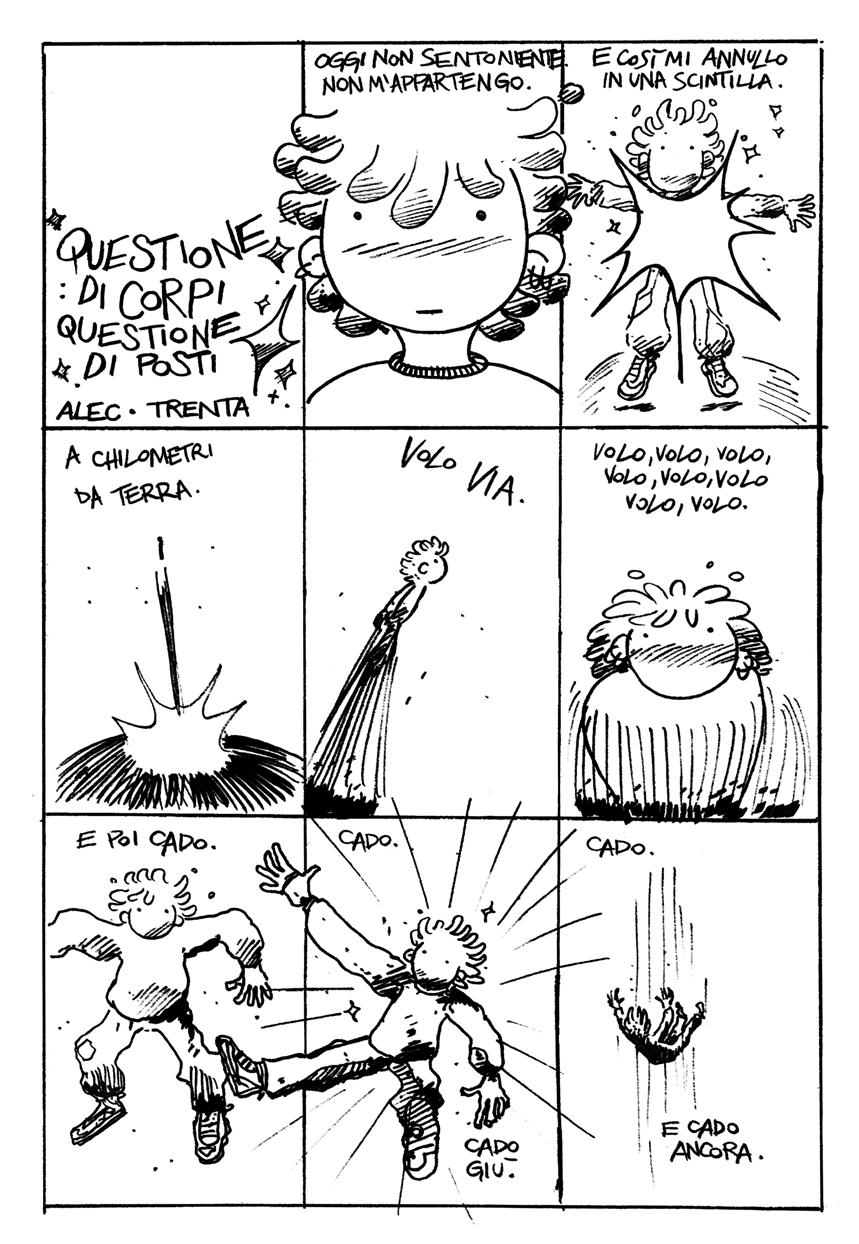

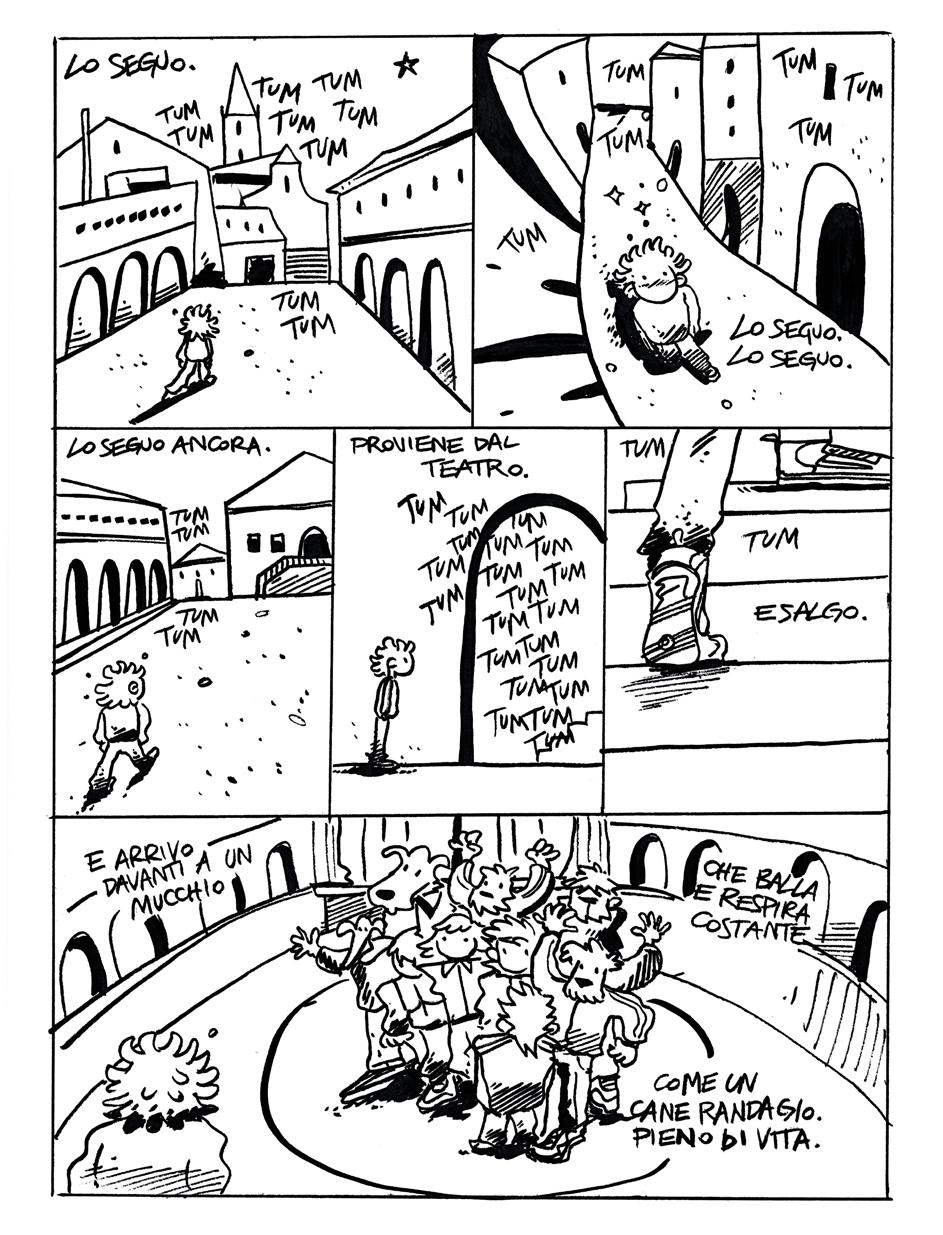
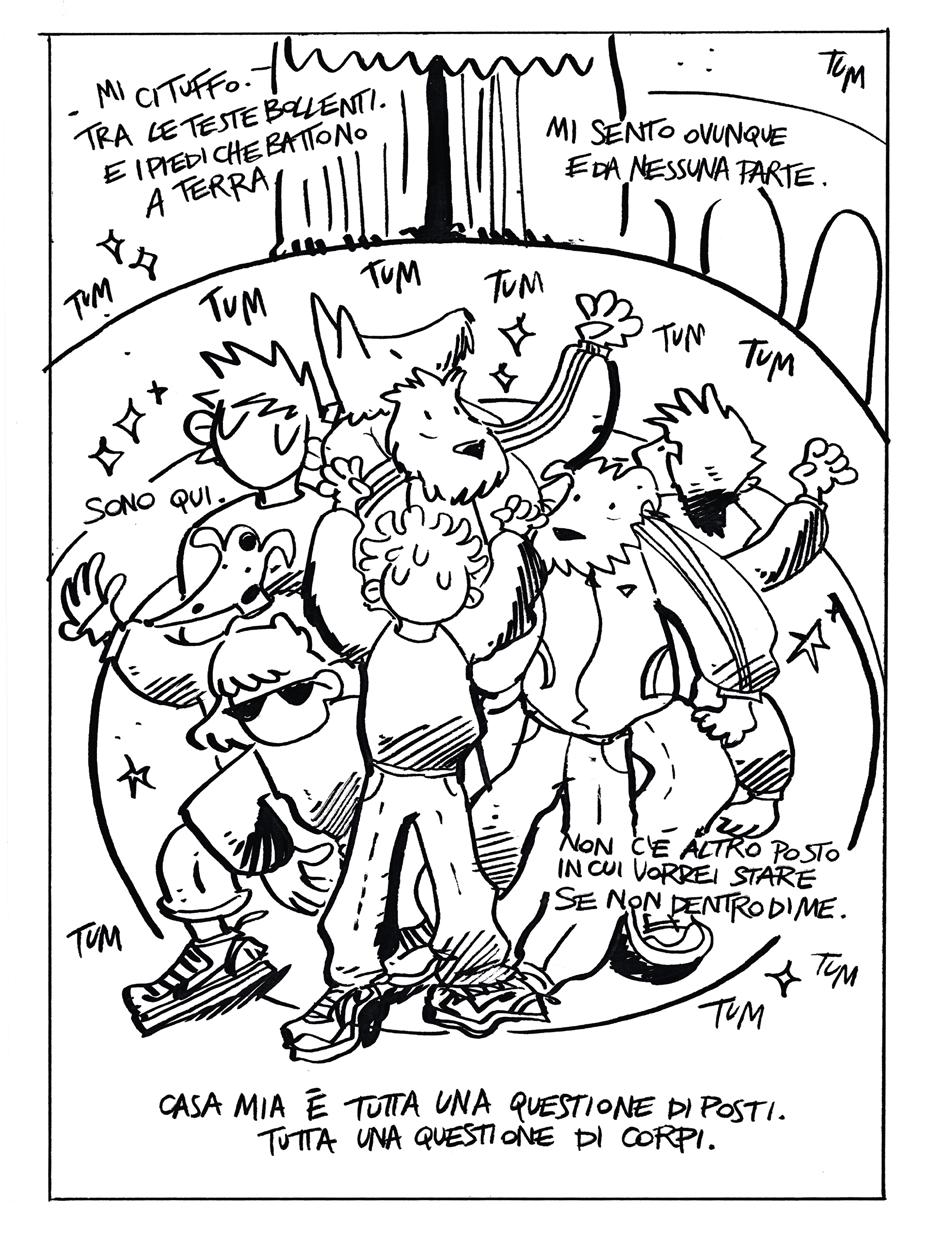
Cosa si può fare per sviluppare una maggiore coscienza di genere e, in generale, sensibilizzare tutti verso una maggiore consapevolezza? Si parla inoltre di vietare nelle scuole l’educazione alla sessualità anche nelle scuole medie: si tratta di un tema culturale? Ne abbiamo parlato con 9 artiste, curatrici e docenti

EVA COMUZZI
CURATRICE E DOCENTE
Negli ultimi anni, in Italia, ho visto molte artiste, curatrici e direttrici ricoprire ruoli importanti nel mondo dell’arte. Mi auguro che questo sia sintomo di cambiamenti importanti e sia sempre frutto del merito, e non di un equilibrio imposto. Credo profondamente che l’educazione alla sessualità sia oggi un tema culturale urgente proprio perché questa crescente autorevolezza femminile genera, in molti uomini, un senso di smarrimento, come se il loro potere venisse messo in discussione. Parlare di sessualità significa anche questo, costruire consapevolezza, rispetto, dialogo. Come curatrice e docente, cerco di farlo ogni giorno, attraverso le mostre, le lezioni, i confronti, e soprattutto cercando di “camminare le mie parole” con coerenza tra ciò che penso, dico e faccio.

STEFANIA RISPOLI CURATRICE
Nel nostro settore c’è una maggiore inclusività di genere rispetto anche a pochi decenni fa, ma ancora persiste una forte polarizzazione dei sessi. Inoltre, il sistema dell’arte non è avulso dal resto della società, quindi dalla politica, dal linguaggio e dalla cultura del lavoro, dove è più evidente che tanta strada resta ancora da percorrere. Penso che l’educazione affettiva sia un diritto di tutte le persone e come tale non debba essere negato ma anzi tutelato fin dall’età dell’infanzia. Imparare ad amare e rispettare il proprio corpo e quello altrui, i suoi confini e le sue peculiarità è alla base della crescita di ogni essere umano ed è certamente, come tutto quello che concerne l’educazione e la conoscenza, un tema culturale. Credo che si possa sempre fare qualcosa e la cronaca di questi giorni purtroppo ce lo ricorda. Abbiamo tanti strumenti per farlo, ognuno nel suo ruolo, e soprattutto tanta voce per poter raggiungere una platea ampia. Il primo passo è prendere posizione.

CURATRICE E DOCENTE
Credo che il primo passo per sviluppare una maggiore coscienza di genere sia prestare attenzione al linguaggio: le parole che usiamo costruiscono realtà, definiscono ruoli, includono o escludono. Nominare correttamente, usare un linguaggio inclusivo e consapevole è già un atto politico e culturale. Ritengo che sia necessario integrare nei programmi scolastici, nei testi, nelle mostre la storia e le opere delle donne e delle minoranze, rendendo visibile ciò che per troppo tempo è rimasto ai margini. È fondamentale creare spazi di dialogo, mostre e percorsi educativi che valorizzino la pluralità dei punti di vista e mettano in discussione stereotipi radicati. Ma – e so di dire una cosa impopolare – bisogna prestare attenzione alla modalità in cui si racconta il lavoro, ad esempio, di un’artista per evitare di cadere in quella che io definisco la “ghettizzazione di genere” e cioè ridurre tutto quello che riguarda l’universo femminile in una mera questione di genere. C’è ancora molto da fare in tal senso: serve continuità, coraggio e la volontà di cambiare le narrazioni, perché la parità non si misura solo nei numeri, ma anche nel modo in cui raccontiamo il mondo e diamo voce a chi non l’ha mai avuta.

PAOLA UGOLINI
CURATRICE
In Italia nel microcosmo dell’arte contemporanea c’è parità di genere, ma è difficile parlare di parità quando le strutture sociali rimangono immutate e quando le stesse donne che arrivano a ricoprire posizioni di potere sono così imbevute di patriarcato da diventarne le zelanti ancelle. La questione dell’educazione alla sessualità nelle scuole è sia politica che culturale. È inquietante che ministre, ministri e genitori pensino che ci sia qualcosa di sbagliato nell’insegnare alle medie e al liceo l’educazione sessuale quando già dagli 11 anni gli adolescenti sono in balia delle sirene dei social e del sesso estremo di YouPorn. Oggi i sondaggi ci parlano

di un mondo giovanile confuso e insicuro in cui l’amore diventa gelosia, possesso e controllo, ovvero, il contrario di ciò che dovrebbe essere. I femminicidi sono il risultato della mancanza di educazione affettiva e ogni donna uccisa è la prova del fallimento di una società sessuofobica e ancora profondamente maschilista.
PAMELA DIAMANTE ARTISTA
Credo che, quando parliamo di genere, non dovremmo isolarlo, ma adottare una lente intersezionale, poiché è inevitabilmente connesso a classe, etnia e disabilità. Siamo ancora lontani da una reale equality+ e il mondo dell’arte italiana, pur consapevole, spesso strumentalizza questi temi riducendoli a tendenze per artisti e puro washing di istituzioni e collezionisti. L’educazione scolastica riflette la società; invece, di eliminare l’educazione sessuale, sarebbe necessario contrastare bullismo e discriminazioni, promuovendo un’educazione emotiva e di genere che aiuti cittadine e cittadini a crescere consapevoli, empatici e rispettosi delle differenze. Dopo un lungo percorso di consapevolezza ho compreso che posizionare la propria identità su assi intersezionali è un atto politico che aiuta la società a riconoscere le soggettività. Come donna, lesbica e meridionale, ho intrapreso un profondo cammino di autocoscienza per affermare e rivendicare la mia identità anche attraverso la mia pratica artistica.

VIRGINIA ZANETTI
CURATRICE, ARTISTA E DOCENTE
Per sviluppare una maggiore coscienza di genere e una più ampia consapevolezza, l’arte, come pratica e come didattica, ha un ruolo cruciale. Come docente, insisto sull’importanza di integrare nei programmi di studio le artiste donne e le teorie femministe e queer, offrendo modelli alternativi e una storia dell’arte non univoca. Come artista e curatrice, il mio lavoro si focalizza sulla relazione, l’alterità e la costruzione di un “noi” non patriarcale e antispecista. Credo nell’arte come transfert sociale e spazio vivente, capace di creare pratiche relazionali e azioni performative collettive che sfidano i confini e invitano all’ascolto reciproco, fondamentale per riconoscere e valorizzare le diversità. Il progetto Estuario project space e piattaforme come il Laboratorio del Futuro, di cui sono stata co-fondatrice, mirano proprio a innescare un dialogo tra intellettuali e cittadini sui temi urgenti della contemporaneità, inclusa la parità. È nell’azione congiunta di critica, educazione e pratica artistica che possiamo sperare di incidere profondamente sul tessuto culturale e sociale.
REVERIE ARTISTA
Non c’è parità, né equità, né equilibrio nel mondo. Se ci fossero, non saremmo nel mondo ma sulla luna, sotto le leggi di un’altra gravità. Siamo abituatǝ a lottare per i nostri diritti. Non dico che sia giusto — dico solo che è la norma. E sono stufa che lo sia anche nell’arte. Perché poi si arriva all’assurdo: che una donna etero artista non ab-

bia niente per cui lottare, e debba soltanto stare zitta. Io ho tanto da dire. Come tuttǝ. Paradosso: abbiamo tuttǝ un corpo che ci accomuna, e lo difendiamo contro i mulini a vento del governo, dei giudizi, di chi dimentica di essere umano. Eppure, neghiamo alle nuove generazioni la possibilità di conoscerlo davvero. La sessualità è una necessità anche per chi la rifiuta: quanti occhi possiamo chiudere al mondo nello stesso istante? Sognavo spesso di diventare cieca e di nuotare con gli occhi in un mare di latte. Scusate i miei riferimenti sempre al cibo — ma il corpo, come l’incontro con l’altro, fanno parte di me. Siamo ciechi, sordi, e urliamo tuttǝ all’unisono. Secondo voi, si capirà qualcosa? Cambierà qualcosa? Spoiler: no. Continueremo a vivere nella confusione, a fare figli e confusione anche nella nostra intimità, senza conoscerci davvero. E alla fine ci sarà sempre qualcuno che ti chiederà: “hai raggiunto la felicità?”. Perché non gli hanno mai insegnato cosa significa.

ELENA EL ASMAR ARTISTA E DOCENTE
Ho sempre creduto che l’artista non sia un creativo ma un creatore. Concedendosi la possibilità di immaginare la complessità del mondo attraverso una foglia, un particolare taglio di luce, un segno, un materiale, ed esercitando poi questa forma di emancipazione del reale attraverso il proprio lavoro, l’artista crea strade e varchi e luoghi di risonanza in cui riconoscersi e riconoscere l’altro. In questo continuo allenamento alla libertà può accadere una vera rivoluzione ovvero quella che passa per il sé per costruire ogni volta un rinnovato “noi”. Le cosiddette forme di liberazione imposte forzatamente dall’alto spesso servono solo a sostituire uno slogan con un altro, così è necessario che l’esercizio alla curiosità per ciò che ci è poco familiare, o sconosciuto, sia continuamente alimentato affinché la complessità delle identità che compongono il mondo diventi una ricchezza anziché un limite. È in questo dare spazio che può nascere un cambiamento profondo, silenzioso ma potente.

ELVIRA VANNINI
CRITICA D’ARTE
E DOCENTE
Quello dell’arte è un sistema di dominio che non nasconde la sua matrice coloniale, capitalista e ciseteropatriarcale. La consapevolezza che l’incertezza e la precarietà preparano il terreno a chi perpetua la violenza di genere, come guerra contro corpi e vite dissidenti, riguarda anche il sistema culturale. Cos’è che maschera la centralità del patriarcato come pilastro dell’edificio di tutti i poteri? Nell’accademia, nello spazio domestico così come nelle istituzioni artistiche, o per la strada, l’ostacolo maggiore è portare la questione del patriarcato dal margine al centro del discorso pubblico, a cominciare dall’introduzione dell’educazione sessuo-affettiva e al consenso, in tutte le scuole di ordine e grado, perché queste dinamiche tossiche si riproducono sin dall’adolescenza. Se non si rovesciano i rapporti di forza tra genere, capitale e lavoro, non servono a niente le politiche di equità e inclusione, occorre mettere in discussione le gerarchie economiche e sociali dell’art washing
MASSIMILIANO TONELLI

Sono stato alla Biennale di Istanbul, sono riuscito a guardare tutta la mostra, tutte le sedi, anche quelle più recondite. La rassegna era convincente, coerente, alcune opere spettacolari e coinvolgenti. I temi erano quelli che vanno per la maggiore negli ultimi anni, quelli sui quali gli artisti più intellettuali, approfonditi e sofisticati tendono a misurarsi maggiormente. Le diversità, le migrazioni, il lavoro, lo sfruttamento. Grazie al lavoro degli artisti tutto risultava molto chiaro, ma non posso dire lo stesso delle didascalie: se fosse stato per quelle non ci avrei capito nulla.
Ho pensato che la colpa fosse del mio pessimo inglese, ma diamine si tratta di una lingua tutto sommato agevole da capire e non ho avuto mai troppi problemi a cavarmela. Ma questa volta proprio non riuscivo a seguire il filo.
Qualche giorno dopo ero a Londra, alla Tate, a vedere una grande mostra sull’arte contemporanea della Nigeria. I temi erano grossomodo gli stessi, le opere erano forse meno esplicite, ma lì invece le didascalie mi hanno aiutato e molto. Erano chiare, cristalline, comprensibili sia a chi non mastica bene l’inglese sia a chi non mastica bene l’arte e il suo mondo.
Siamo a fine 2025 e ci sono ancora due tipologie di istituzioni culturali. Quelle che ancora parlano ad un preciso ristrettissimo target e adottano un linguaggio in codice (il critichese, o l’artese) e quelle invece che si fanno carico di spiegare e accogliere. Spesso le prime sono proprio quelle che si riempiono la bocca di inclusione e poi però comunicano in maniera incomprensibile.
Vincere la battaglia del coinvolgimento oggi – in un ecosistema basato sul concetto di notifica e quindi di distrazione – è una sfida complicatissima, se musei e mostre non la colgono a pieno continueranno a perdere appeal a favore di altri dispositivi. E invece molte istituzioni e molti organizzatori lo stanno comprendendo e, dopo anni di sensibilizzazione, si percepisce una sempre maggiore attenzione verso questo tema ormai protagonista nei corsi di formazione e nei percorsi didattici che portano a diventare curatori e operatori dei musei.
Ci si sta impegnando moltissimo per capire come sarà il rapporto tra museo e pubblico nel futuro, quali mediazioni bisognerà inserire nella partita, quanto impatto avrà la tecnologia, l’intelligenza artificiale. Si ragiona su mostre immersive e sulla realtà virtuale. Ma una buona parte di visitatori sarebbe già molto soddisfatta e appagata trovando semplicemente una didascalia scritta bene, chiara, semplice, comprensibile anche a chi per la prima volta entra in uno spazio dedicato all’arte. Capace magari anche di incuriosire e di far venire la voglia di approfondire. Senza annoiare e soprattutto senza farti sentire inferiore e inadeguato come è successo a me lo scorso settembre a Istanbul.
CHRISTIAN CALIANDRO
In base alla enshittification descritta dallo scrittore di fantascienza canadese Cory Doctorow, il processo di degradazione progressiva delle piattaforme digitali non è frutto di un difetto strutturale, ma piuttosto sulla base di un piano ben preciso che ha a che fare con l’estrazione ultima del valore: è il caso paradigmatico, per esempio, della parabola di Twitter-X, prima e dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk. Questo processo porta alla ‘morte’ per esaurimento/svuotamento della piattaforma.
Questo termine-concetto (inventato e introdotto tre anni fa) si può estendere e applicare utilmente a tutta una serie di altri campi, compresi ovviamente quelli dell’arte e della cultura. Fa parte infatti dell’esperienza comune e condivisa il fenomeno di una apparente enshittification che ha riguardato e riguarda –con lodevoli e notevoli eccezioni, che però classicamente non fanno che confermare la regola – oggetti singoli e intere aree come musica, design, letteratura, serie tv. Lo schema è sempre quello: si inizia con alta qualità dei servizi e dei contenuti, per poi assistere a un declino generale prima lento, poi sempre più rovinoso. Una volta agganciati i clienti, sembra che la loro soddisfazione non sia più la priorità, ma che si pensi di far ingoiare loro qualunque cosa (e il termine-concetto stesso di “contenuto”, introdotto non moltissimo tempo fa in ambito culturale, che cosa rappresenta se non la definitiva equivalenza-equiparazione di ogni opera ad ogni altra, del cinepanettone al film d’autore, del film di supereroi alla distopia raffinata, della commedia dozzinale al gangster-movie innovativo? Il rettangolino – verticale o orizzontale – è sempre lo stesso, ha sempre le medesime dimensioni – e che noi ne scegliamo uno piuttosto che un altro, o che non ne scegliamo nessuno rimanendo per mezza serata a scartabellare in maniera sempre più sconsolata per la piattaforma non fa alcuna differenza: è esattamente lo stesso. Ora, certamente arte e cultura sono una parte importante, essenziale della nostra vita; ma gli effetti della enshittification si fanno molto più preoccupanti e inquietanti se guardiamo ad altri ambiti, come la società, la politica, l’economia. E, soprattutto, il linguaggio, che in fondo è l’infrastruttura più rilevante, e delicata, della nostra vita collettiva. Non possiamo non aver fatto caso, una volta o l’altra, a quanto il linguaggio sia andato incontro a un processo di iper-semplificazione che è stato rapidissimo e molto, molto profondo. E che lo diventa, a quanto parte, sempre di più. Anche per questo, come per tantissimi altri aspetti, occorre rivolgersi a George Orwell e al suo capolavoro-testamento, 1984: nel 1948, aveva immaginato e anticipato ciò che poi si è puntualmente realizzato in forme magari diverse nell’aspetto, ma terribilmente corrispondenti (negli Anni Ottanta e Novanta del Novecento era di moda deridere lo scrittore inglese, additando quanto il contesto fosse diverso da quello descritto nel romanzo; oggi, mi sembra, non ride quasi più nessuno: non ci

sono Oceania, Eurasia ed Estasia – come del resto non c’è Panem, se è per questo – ma non manca poi molto…).
Lo schema è sempre quello: si inizia con alta qualità dei servizi e dei contenuti, per poi assistere a un declino generale prima lento, poi sempre più rovinoso
Credits Silvia Camporesi, 2025
In particolare, la neolingua del Socing descritta in modo particolareggiato nell’Appendice è quella già largamente in uso nelle nostre società, con il suo essere programmata per costringere ad adottare un’interpretazione della realtà e solo quella, e all’impossibilità concreta di vedere altrimenti, di pensare altrimenti: “Il lessico della neolingua era articolato in modo da fornire un’espressione precisa e spesso molto sottile per ogni significato che un membro del Partito volesse correttamente esprimere, escludendo al tempo stesso ogni altro significato, compresa la possibilità di giungervi in maniera indiretta. Ciò era garantito in parte dalla creazione di nuovi vocaboli, ma soprattutto dall’eliminazione di parole indesiderate e dalla soppressione di significati eterodossi e, possibilmente, di tutti i significati secondari nelle parole superstiti. (…) la libertà politica e intellettuale non esisteva più neanche come concetto e mancava pertanto una parola che la definisse. A prescindere dall’eliminazione di vocaboli decisamente eretici, la contrazione del lessico era vista come un qualcosa di fine a se stesso, e non era permessa l’esistenza di una parola che fosse possibile eliminare. La neolingua non era concepita per ampliare le capacità speculative, ma per ridurle, e un simile scopo veniva indirettamente raggiunto riducendo al minimo le possibilità di scelta” (George Orwell, Appendice. I princìpi della neolingua, in 1984, Mondadori, Milano 2013, p. 308). Anche qui, direi che praticamente ci siamo.
Una recente peregrinatio per la Penisola Iberica mi ha consentito di (ri)vedere alcuni dei più importanti musei spagnoli. Musei che, nel complesso, fanno un’ottima impressione, a livello di spazi espositivi, allestimento e illuminazione delle opere, apparati comunicativi; e che forniscono molteplici spunti di riflessione, in particolare a chi, provenendo da un altro Paese, può trovare somiglianze e differenze con il panorama museale della propria terra. Alcuni spunti riguardano il rapporto dei musei con il pubblico e il modo in cui le istituzioni accolgono e disciplinano l’afflusso di visitatori.
Quando si parla di pubblico dei musei ci si riferisce spesso ai turisti, e quando si pensa ai turisti su suolo spagnolo si pensa subito a Barcellona, città tra le più interessate dal fenomeno dell’overtourism, come hanno dimostrato le veementi proteste di una parte della popolazione nei confronti dei forestieri. Arrivando nel capoluogo catalano in piena estate ci si aspetta di trovarsi in una città sotto assedio; ma non è proprio così.

L’accesso gratuito è una cosa splendida quando è sempre tale; quando non si paga solo in determinate circostanze può generare un affollamento che pregiudica la piacevolezza della visita
Per carità, di turisti ce ne sono parecchi, ma (come sempre accade, e forse qui più che altrove) sono distribuiti in maniera assai diseguale. Le architetture di Antoni Gaudí sono prese d’assalto, la Sagrada Familia è un immane termitaio brulicante; il resto del patrimonio artistico e monumentale è fruibile in maniera ben più ragionevole, o addirittura è assurdamente trascurato. I musei che punteggiano il meraviglioso Montjuïc – dal ben fatto Museo Archeologico allo strepitoso Museu Nacional d’Art de Catalunya –vedono un afflusso di visitatori da contenuto a gestibile (complice anche la posizione lievemente defilata della collina); un museo imperdibile, specie per chi ama la scultura medievale,
Courtesy Mo(n)stre
quale è il Museu Frederic Marès, è snobbato dalle folle. Si trova in pieno Barri Gòtic, accanto alla cattedrale, e ha per giunta un costo di accesso modesto (4,20 euro il biglietto intero!), eppure quando l’ho visitato, mentre tutto intorno si svolgeva l’incessante processione di viandanti e infuriavano Quattro Stagioni e Gipsy King, ero praticamente l’unico visitatore. Una solitudine che infonde sentimenti contrastanti: il dispiacere per chi gestisce un museo così bello e per chi si perde tanti tesori, ma anche una sfrenata goduria per la possibilità di bearsi delle sale in santa pace. Ancor più rilevante dell’offerta museale di Barcellona è quella di Madrid, che trova nel Museo del Prado la sua gemma più sfolgorante. Al Prado non si possono scattare foto. Una scelta decisamente in controtendenza, che ha i suoi pro e i suoi contro. L’esperienza della visita ne risulta nettamente migliorata: specie in quei punti del percorso espositivo nei quali la folla è più fitta, come davanti a Las Meninas o al Giardino delle delizie, la possibilità di fotografare genererebbe il caos, come avviene in tanti altri grandi musei. D’altra parte, il Prado mette a disposizione in rete le foto ad alta risoluzione di tutte le sue opere. È vero, tuttavia, che queste ottime foto vanno benissimo per i dipinti, ma nel caso delle sculture si può aver bisogno di dettagli che le im-
magini in rete non restituiscono, o ancora c’è chi può aver necessità di foto degli allestimenti o del pubblico stesso. Qualche deroga al divieto sarebbe dunque benvenuta. Ma come concederla in maniera non troppo laboriosa? Un’idea potrebbe essere quella di accordare automaticamente il permesso di fotografare ai soci ICOM, piccolissima porzione dei visitatori che lavora in ambito museale o fa ricerche su temi legati ai musei; forniti all’ingresso di un adesivo di riconoscimento, scatterebbero in modo sensato, senza disturbare.
Altra caratteristica peculiare di alcuni musei spagnoli è l’entrata gratuita per tutti nelle ultime due ore di apertura (ad esempio, al Prado, dalle 18 alle 20). L’iniziativa è senz’altro da approvare, nell’ottica di un più ampio accesso alla cultura. L’accesso gratuito è tuttavia una cosa splendida quando è sempre tale; quando non si paga solo in determinate circostanze può generare un affollamento che pregiudica la piacevolezza della visita (ne sappiamo qualcosa in Italia, con le domeniche gratuite). Soprattutto dove è consentito scattare fotografie, l’improvviso afflusso di frotte di visitatori provoca un crollo della qualità della visita: le sale fino a poco prima tranquille sono gremite di gente che si scatta selfie, di bambini in posa davanti alle opere, a beneficio degli obiettivi dei telefoni di chi li ha generati. Così mi è successo alla nuova Galleria delle Collezioni Reali: a due ore dalla chiusura si è sentito un tumulto provenire dall’ingresso, come se l’intero popolo spagnolo venisse a reclamare le teste dei propri sovrani. Preoccupato, ho chiesto lumi a un’addetta alla sorveglianza, che sconsolata mi ha detto: “Ora è gratuito”. Le teste di Felipe e Letizia, per fortuna, erano salve; ma la magia che aveva sino ad allora contraddistinto la mia visita era destinata, almeno in parte, a dissolversi.
ANGELA VETTESE
Alcune mostre di grande impatto visivo aperte quest’estate hanno riportato l’attenzione sulla nozione e la pratica del cosiddetto “cinema espanso”, una definizione proposta da Gene Youngblood nel 1970 per definire il modo in cui l’arte visiva aveva iniziato a usare le immagini in movimento. Penso a esposizioni quali quella di Isaac Julien a Palazzo Te di Mantova, dove dieci schermi riproducono lo stesso film dentro un ambiente di specchi: ogni spettatore crea il suo montaggio. Penso alla mostra presso la Fondazione Prada di Milano in cui Alejandro G. Iñárritu espone il backstage di un suo film, cioè gli spezzoni di girato inutilizzati, proiettati da macchine affascinanti. Ricordo il film di astrazioni digitali caleidoscopiche, composto da Gerhard Richter e visto quest’estate alla Fondazione Beyeler. Rammento le composizioni di schermi che raccontano le stagioni, quadrangoli di fogliame in parte coerenti tra loro e in parte no, create da David Hockney e viste nella sua retrospettiva presso la Fondation Louis Vuitton di Parigi. Per quanto il cinema da sala sia stato importante anche per l’uso artistico delle immagini in movimento, è evidente che esistono differenze fondamentali che solo da una ventina d’anni hanno iniziato a essere studiate davvero. Se la narrazione in stile Hollywood o Bollywood risponde a regole di durata dettate dal commercio, il cinema espanso è raramente animato da una sceneggiatura romanzata, perché spesso non racconta una storia: ha ereditato dalla pittura, soprattutto astratta ma non solo, la capacità di puntare sugli aspetti meramente percettivi e su composizioni innovative. Il contenuto è veicolato attraverso l’evocazione assai più che attraverso il racconto esplicito dei fatti. A volte si presenta come documentario, a volte come raccolta di spezzoni dimenticati, spesso montati quasi a caso o con il nastro adesivo, come faceva Gianfranco Baruchello Non dovremmo dimenticare la tradizione che sta dietro a tutto questo, oramai lunga un secolo. Nel 1924 il film Entr’acte, concepito da Francis Picabia e René Clair per uno spettacolo di danza svedese, sviluppa con un balzo nell’assurdo e immaginifico le premesse poste dal pioniere Georges Méliès all’inizio del Novecento. L’utilizzo di 360 proiettori puntati sul pubblico aiutava lo straniamento e iniziava la commistione tra gli stimoli del film e quelli di altri mezzi, come appunto una luce accecante che stimola lo spettatore. Nel 1925, Lazlo Moholy-Nagy proiettò su una superficie semisferica tre film contemporaneamente. Nel 1927, Oskar Fischinger e Abel Gance avevano creato la prima situazione a schermi multipli, con tre film da proiettare su tre superfici contemporaneamente. Inutile continuare qui con una storia che è stata scritta da molti, e che è stata rivista, nei suoi sviluppi recenti, dal bel libro che ripete il titolo del primo citato, Expanded Cinema, agli studi sull’arte immersiva di cui il cinema espanso è una parte essenziale agli studi sul documentario. Più di cent’anni dopo le dichiarazioni dei manifesti

Il cinema espanso è raramente animato da una sceneggiatura romanzata, perché spesso non racconta una storia: ha ereditato dalla pittura, soprattutto astratta ma non solo, la capacità di puntare sugli aspetti meramente percettivi e su composizioni innovative
Sueño Perro , Instalación
Celuloide di Alejandro
G. Iñárritu, Fondazione
Prada, Milano, 2025. Foto
DSL Studio, Delfino Sisto
Legnani e Melania Dalle
Grave
futuristi e le conseguenti sperimentazioni, la tradizione che viene dalla pittura fa raramente a meno delle immagini in movimento. Altri momenti aurorali come Chelsea Girls di Andy Warhol (1966), fatto di immagini casuali prese all’hotel Chelsea di New York e proiettato su due schermi, o le prime riprese di performance come quelle del mondo Fluxus o di Yoko Ono e Carolee Schneemann (entrambe 1964) mostrano come le neoavanguardie abbiano ripreso quelle premesse e abbiano posto le basi per la fluidità della relazione tra performance, appunto, e immagine filmica. Anche quadri all’apparenza molto tradizionali, come quelli della giovane Adelisa Selimbašić, (Karlsruhe, 1996), per non citare i soliti noti della pittura superstar del mercato, nascono fondamentalmente da still di video. Nel panorama italiano, tra gli artisti che meritano maggiore attenzione ci sono nomi, come quelli di Valentina Furian o di Emilio Vavarella, ancora visibili alla Quadriennale di Roma, che hanno lavorato al limite tra cinema sperimentale e cinema-cinema. Anche nella vita quotidiana, del resto, una chat su di un social è divertente quanto più ci scambiamo filmati oltre che testi e immagini fisse. Se dobbiamo aderire alla definizione di un mondo “liquido”, per usare il linguaggio di Zygmunt Bauman, nulla più del cinema espanso e delle sue derivazioni può tradurlo in azione artistica capace di fotografare uno Zeitgast.
MARCELLO FALETRA
Nel 1982 Jean Genet ospite dei fedayn a Beirut fu testimone dell’immane massacro fatto contro il campo profughi palestinese di Sabra e Chatila, tra il 16 e il 18 settembre. Duemila morti tra donne, bambini e uomini, per mano delle milizie cristiano-maronite libanesi controllati da Ariel Sharon, il quale in un’intervista rilasciata allo scrittore Amos Oz nel 1982 non si preoccupava di definirsi “giudeo-nazista”, e orgogliosamente affermava: “Ancora oggi sono disposto a offrirmi volontario per fare il lavoro sporco per Israele, per uccidere quanti Arabi è necessario, per deportarli, per espellerli e bruciarli...”. Oggi i suoi successori sono alla fine del “lavoro sporco”.
“La stampa europea”, osservava Genet “parlava del popolo palestinese con sufficienza, perfino con disprezzo”, come accade di vedere ancora oggi, quando ipocritamente classificano tutti i palestinesi come terroristi. Recatosi a Chatila il giorno dopo il massacro vede un campo disseminato di corpi spappolati: “Il primo cadavere che ho visto era un uomo di cinquanta o sessant’anni. Doveva avere avuto una candida corona di capelli, ma uno squarcio gli aveva aperto il cranio. Parte della materia cerebrale nerastra era per terra, a lato del capo”. La descrizione quasi fotografica del massacro rende il testo di Genet (Quattro ore a Shatila) uno dei documenti più impressionanti di quell’eccidio.
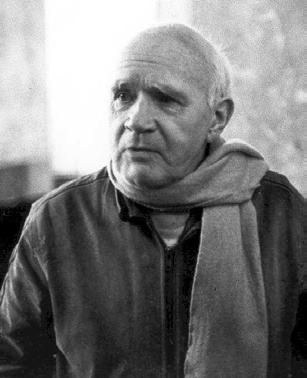
Per Genet, non si trattava di dare una forma estetica all’esperienza storica, ma di far precipitare questa nella storia
Come le fotografie di guerra, il suo report, si fa testimonianza di un presente senza scadenze. Una scrittura dell’estremo, che non simula la violenza, ma la vede e cerca le parole per dirla. Per Genet, non si trattava di dare una forma estetica all’esperienza storica, ma di far precipitare questa nella storia. La scrittura in questo caso non è un’opinione su un fatto, ma la rottura con l’opinione in quanto tale. Un massacro non è opinabile! La pornografia dell’orrore nella sua testimonianza emerge in ogni parola: “Non l’avevo notato. Le dita delle mani erano stese a
Jean Genet. Courtesy International Progress Organization
ventaglio e le dieci dita erano state tranciate come da cesoie per giardino. Ridendo come giovani e cantando allegramente, probabilmente i soldati si erano divertiti a scovare e a usare quelle forbici”. Il 29 gennaio 2024 Hind Rami Iyad Rajab, una bambina di appena sei anni, dopo l’assassinio dei suoi parenti sotto i suoi occhi, è stata a sua volta deliberatamente assassinata con 335 colpi mentre chiedeva aiuto da un democratico carro armato israeliano. Di fronte all’orrore la parola “bellezza”, così sventagliata oggi da ogni parte, è un’offesa – un cinico gadget estetico. Spesso le fotografie di guerra necessitano di una didascalia che li contestualizzi (luogo, data, nomi, ecc.), ma in questo caso la scrittura, con le sue fredde descrizioni, è già documento. Genet suggerisce che la scrittura può descrivere cose che la fotografia non coglie, infatti: “La fotografia non coglie le mosche, né l’odore bianco e greve della morte; e neppure dice che per proseguire bisogna saltare da un cadavere all’altro”. Il supplizio dei morti, la loro estrema nudità spappolata, ostentata come uno scalpo, diventa l’oscena cornice allucinatoria di un modo di concepire l’altro (i palestinesi in questo caso). “Guerra alla guerra” recitava il titolo di un libro di Ernst Friedrich del 1924, e questa guerra alla guerra, scrive Genet, ha visto un protagonista fondamentale, le
donne. “Più ancora degli uomini, più dei fedayan in battaglia, le donne palestinesi sembravano forti abbastanza da sostenere la resistenza e accettare le novità di una rivoluzione... Sguardo diretto che sapeva sostenere gli sguardi degli uomini, rifiuto del velo, capelli offerti alla vista, voce senza incrinature”. Oggi non è diverso. Impietosa, gran parte della stampa europea e oltre oggi, di fronte al genocidio in atto, non è più impudica, ma ha l’impudenza dei profanatori, l’arroganza del boia. E le piazze strapiene di gente d’ogni categoria, che recentemente hanno protestato contro il genocidio in corso dei palestinesi, hanno dichiarato apertamente, a viso nudo, da che parte stare nella storia presente; non ostante avvertimenti e minacce, che dai politici al governo rimbalzavano sui quotidiani con insulti e fandonie. D’altra parte, la domanda di impostura incoraggia l’offerta di falsi documenti, come quello che vedrebbe la Flotilla finanziata da Hamas. Edward Said, più di trent’anni fa (Dire la verità), ha scritto che l’unica possibilità che gli intellettuali hanno (e gli artisti sono degli intellettuali) è di contrastare con le immagini e la scrittura ciò che viene fatto passare per norma – buoni-cattivi, democratici-terroristi...
Impietosa, gran parte della stampa europea e oltre oggi, di fronte al genocidio in atto, non è più impudica, ma ha l’impudenza dei profanatori, l’arroganza del boia
Un frammento di Novalis – ripreso da Beuys che non lo cita – dice che ogni uomo dovrebbe essere artista. Oggi, forse, il contrario sarebbe meglio. Resta il fatto che oggi ai palestinesi una terra propria gli è negata. “Fa parte della morale non sentirsi mai a casa propria”, scriveva il filosofo Adorno durante il suo esilio in un passo dei Minima Moralia. Espressione che potrebbe essere estesa a tutti i palestinesi sottoposti alla deportazione forzata o provocata dal terrorismo sionista, contro cui Hannah Arendt (sionista pentita) già nel 1942 non risparmiò giudizi di fascismo.
ANNA DETHERIDGE
Un po’ alla volta l’immagine del popolo palestinese si è saldata con le immagini dell’annientamento di Gaza, ridotta in macerie, le migliaia di morti, i bambini uccisi, il dolore, trasmessa dagli schermi di tutto il mondo milioni di volte. Come se si fosse finalmente giunti a quell’ultimo cielo dopo il quale non ci sono più orizzonti verso i quali gli uccelli possano volare, per citare il grande poeta Mahmud Darwish (AlBirwa. 1941 – Houston, 2008).
Le parole del poeta, cantore della Resistenza palestinese, oggi appaiono tristemente profetiche riguardo il tragico destino di un popolo ridotto a corpi sofferenti senza voce e senza volto, diventati “scarti umani”. Delegittimazione e umiliazione fanno parte del processo di negazione della dignità delle persone e dei loro diritti. Cancellando la voce della vittima, il carnefice rende ancora più tragico il suo annientamento. La costruzione di un’immagine nel complesso mondo mediatico odierno, che sia veritiera o no, ha il potere di ridefinire ciò che si è, sostituendo il reale con ciò che appare anche se rappresenta soltanto un determinato momento storico.
Cancellando la voce della vittima, il carnefice rende ancora più tragico il suo annientamento
Se l’identità di un popolo è sempre e comunque legata a un territorio, il paradosso dell’identità palestinese è che non ha contorni geografici certi. “Esistiamo davvero?” si chiede il grande intellettuale palestinese Edward Said in conversazione con Salman Rushdie molti anni fa. Quali prove abbiamo? E chi è l’Altro da noi?
Nel 1980 Edward Said insieme al fotografo svizzero Jean Mohr pubblica un libro intitolato After the Last Sky, Palestinian Lives, che costituisce un ritratto collettivo della vita quotidiana di un popolo sparso tra diversi luoghi del Medio Oriente, la Giordania, Siria, Libano, Cisgiordania e Gaza. In quel libro testi e immagini si confrontano alla pari, si alternano formando un dialogo tra le emozioni e i ricordi personali dell’autore e i ri-
tratti di vita quotidiana di donne, bambini e anziani colti dalla sensibilità del fotografo, ancorati al vissuto delle persone. Un testo di divagazioni costellato di piccoli scorci, come il profumo del caffè mentre sibilano i missili, e di annotazioni a margine. Una sorta di testimonianza a futura memoria pervasa da un senso della perdita, come il commento di Said sul futuro che non verrà certo dal passato, e che ad ogni crisi diventa più costrittivo e minaccioso. Nel complesso gioco tra immagine e realtà, la verità e le narrazioni si rincorrono; quelle immagini traumatiche di Gaza hanno risvegliato le coscienze assopite di molti popoli, persino degli europei. Ma le immagini non solo incidono su come vediamo il mondo; ci assomigliano, raccontano le nostre ossessioni, narcisismi, paure e debolezze. Come ha scritto Said in un saggio, l’icona dell’arabo con il fucile è una delle tante metafore identitarie, costruita in gran parte in Occidente, in grado di produrre profezie che si autoavverano e che qualificano irrimediabilmente l’Altro da noi
Ma dietro le immagini resta il destino di un popolo che continua a non avere né voce né volto, che continua a essere narrato da altri, dal potere mediatico, da una parte politica cresciuta a dismisura, finanziata dall’esterno e dal nemico. Mentre la
domanda di Said resta senza risposta. Come possono i palestinesi oggi diventare protagonisti del proprio destino? E chi potrà mediare il dialogo se a parlare ci saranno soltanto coloro con interessi propri nemmeno più nascosti?
Le immagini non solo incidono su come vediamo il mondo; ci assomigliano, raccontano le nostre ossessioni, narcisismi, paure e debolezze
Edward Said, Jean Mohr. After the Last Sky
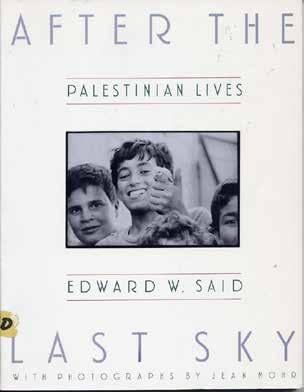
Come insegna chi ha passato la propria vita ad assistere le vittime, sempre più numerose, dei traumi da guerre, razzismo e violenze di ogni genere, la cura richiede non medicinali ma condizioni di realtà: una certa misura di giustizia e bellezza. Una giustizia riparatrice perché siamo tutti figli della paura e la ragione serve per confrontarla e superarla. Se per una parte la furia di Israele può essere spiegata con la paura, l’incapacità di domarla, il disordine che ha provocato avranno conseguenze e tempi lunghi. Per quanto riguarda la bellezza che cura nel profondo, non possiamo rassegnarci a vivere il nostro futuro dietro mura sempre più alte, perseguitati da mostri e fantasmi.
Ricostruire vuol dire curare, imparare a vivere accanto al nemico, dentro gli scenari che ci costruiamo con le nostre mani. Nel Poema della Terra, Darwish parla di un cantore che lo visitava di notte e che di giorno svaniva:
Il cantante canta
del fuoco e di forestieri
Era sera
e il cantante canta
E lo interrogano perché canti?
Lui risponde
Perché canto
Gli perquisiscono il petto
Ma trovano solo il suo cuore
Perquisiscono il suo cuore
Trovano solo la sua gente
Perquisiscono la sua voce
Ma trovano solo la sua tristezza
Perquisiscono la sua tristezza
Trovano solo la sua prigione
Perquisiscono la sua prigione
Trovano solo se stessi, in catene.
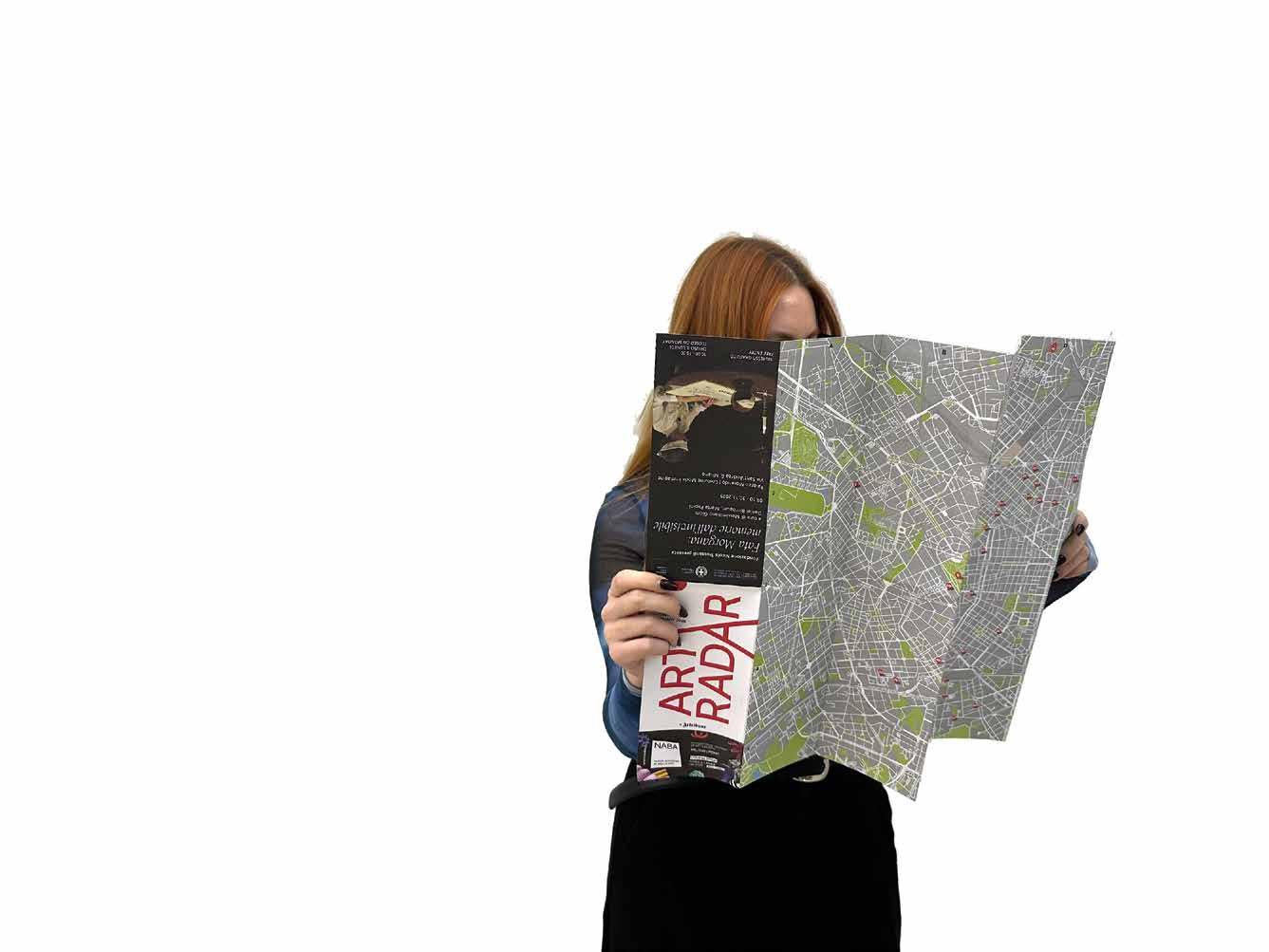


December 5 - 7, 2025

