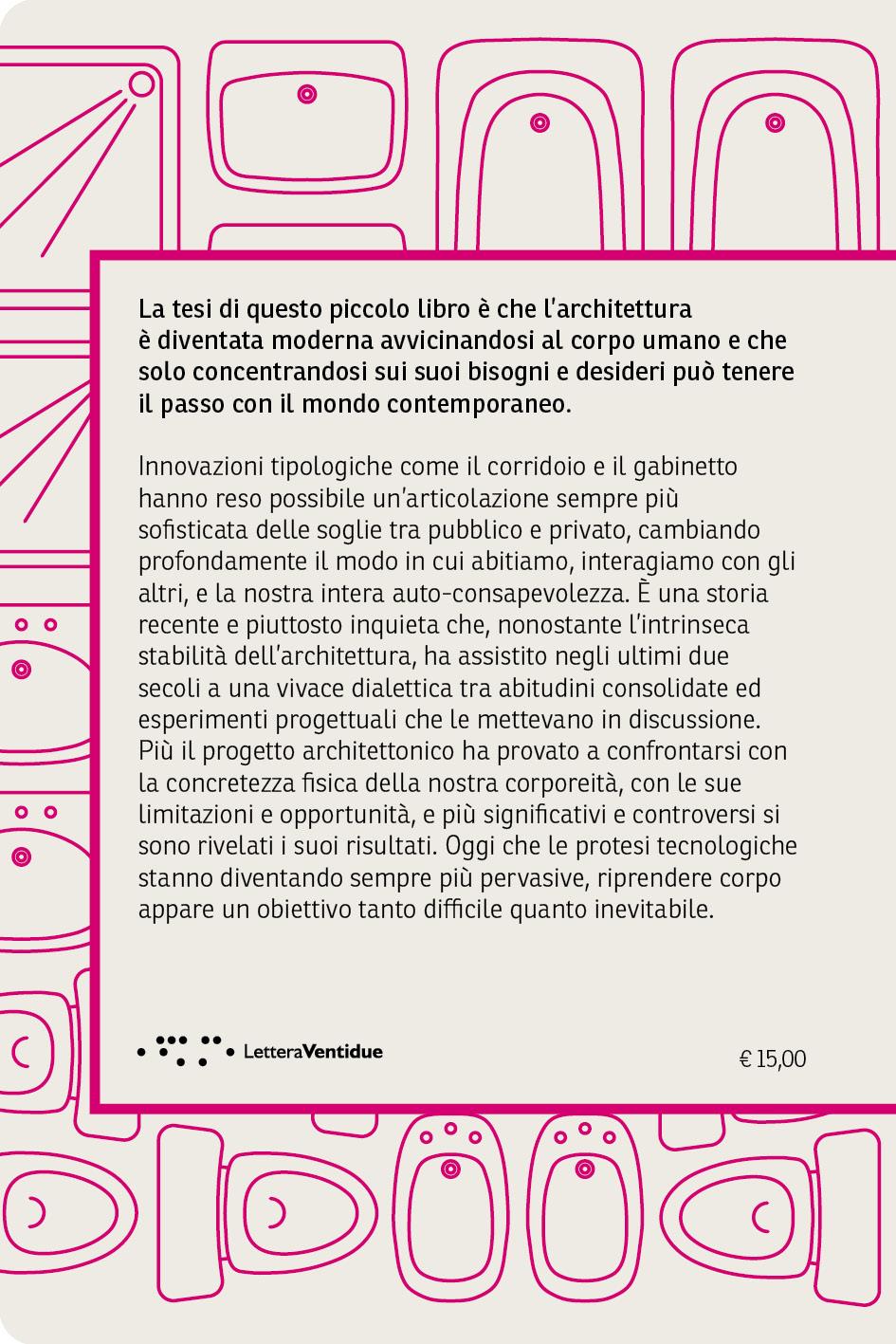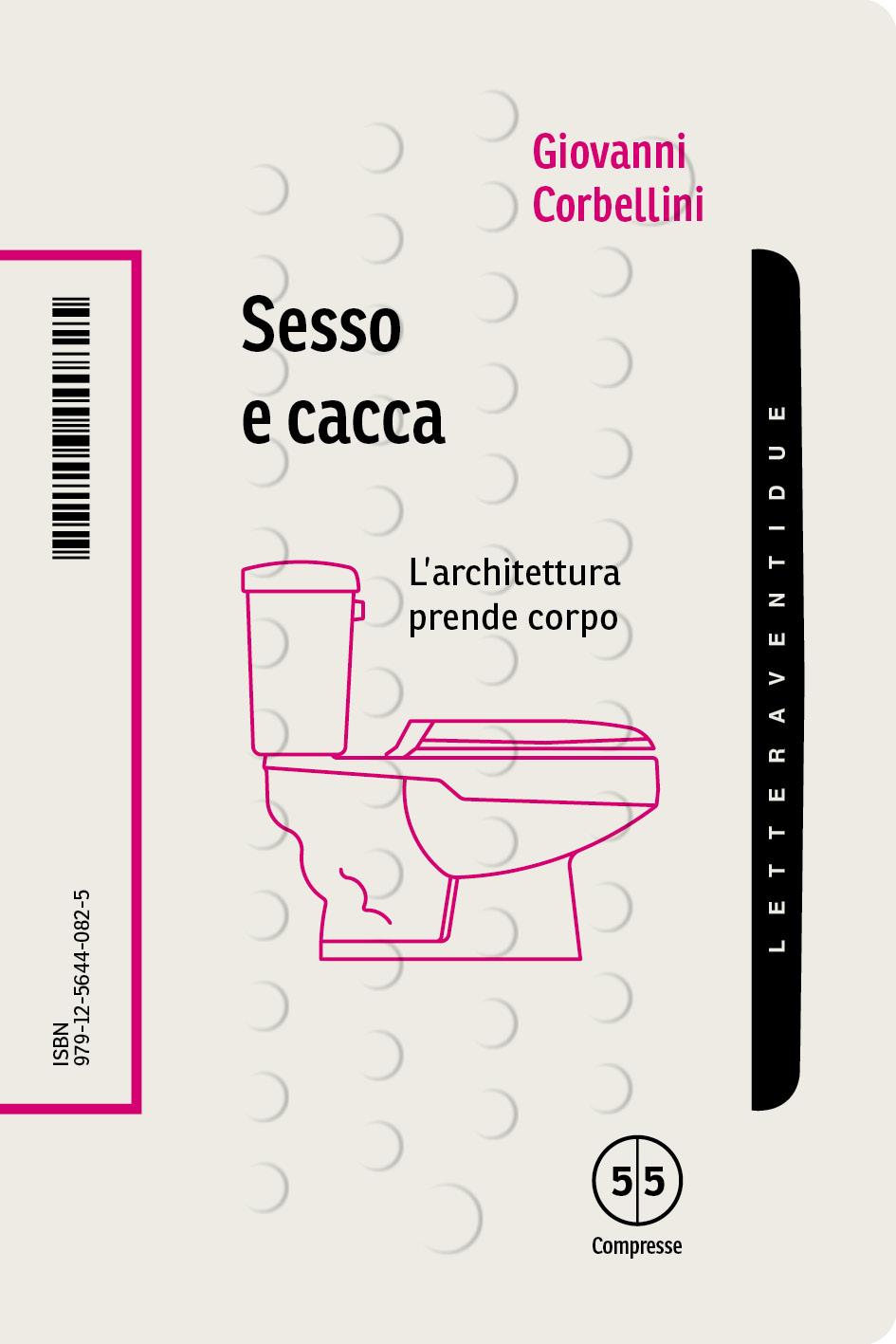
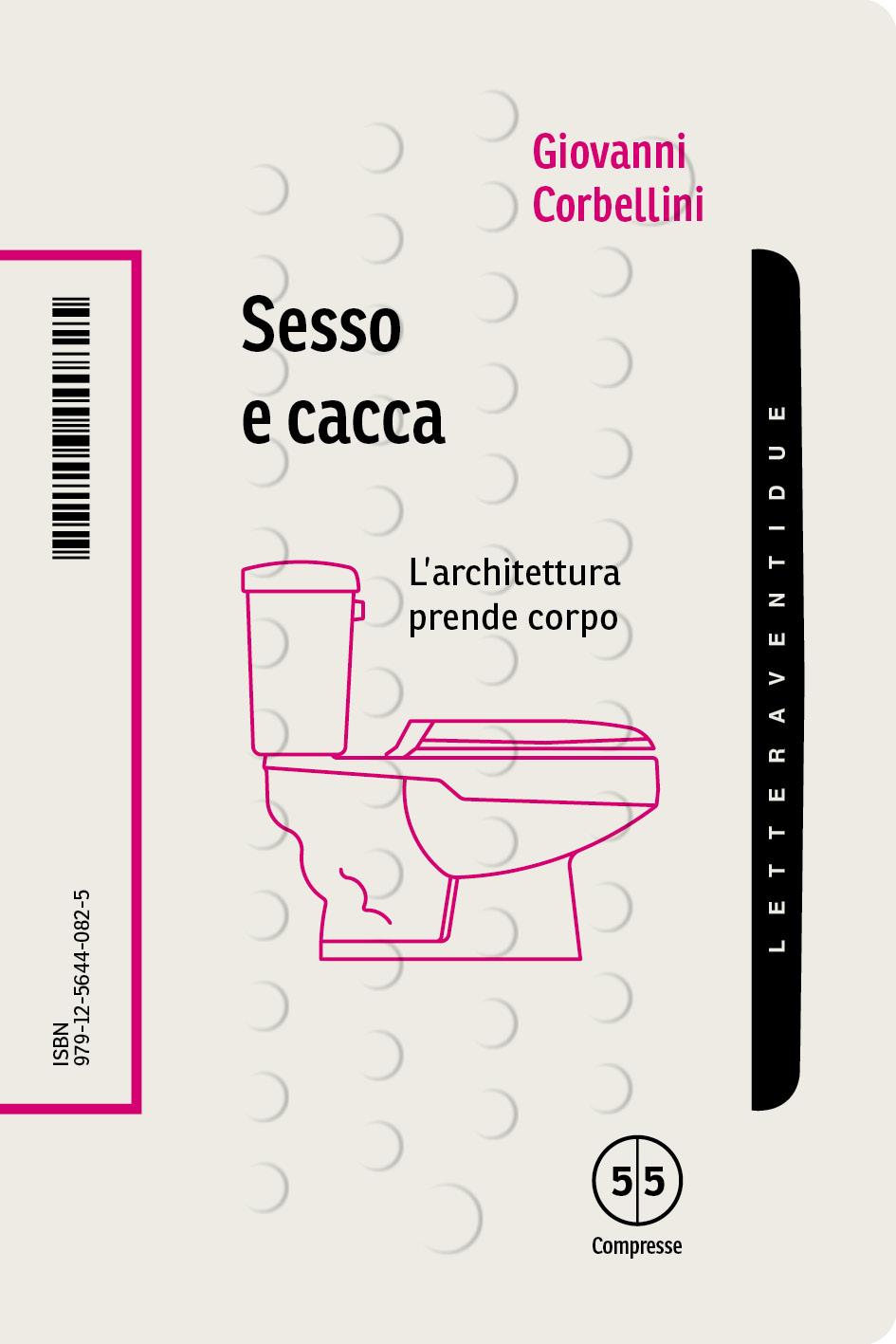
Titolo Indice
Biopolitica

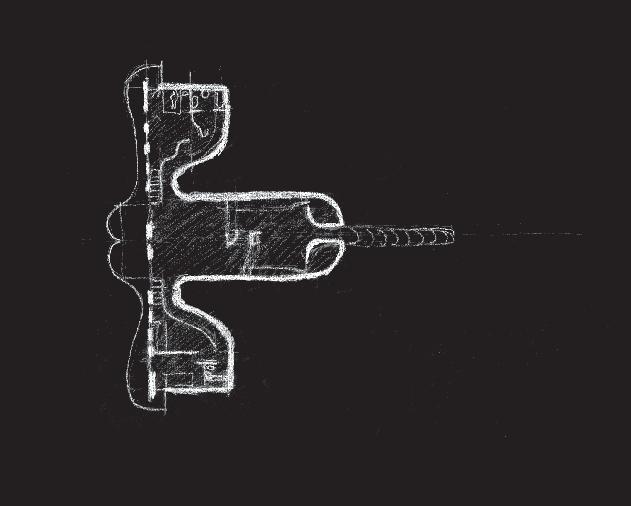
Anche se scindere l’uomo dalla natura appare oggi “artificioso”, insostenibile e pericoloso per il pianeta, le due categorie continuano a fornire strumenti utili a trattare una vasta varietà di fenomeni, inclusi quelli architettonici1. Ci aiutano, ad esempio, a inquadrare sia la nostra relazione con il mondo che, più introspettivamente, a sondare la natura umana, dove tale opposizione prende la forma del dualismo cartesiano tra mente e corpo.2 Definita “schizofrenica” da Edgar Morin3, questa ulteriore separazione risulta di nuovo goffa e semplicistica quando si tratta di cogliere la complessità del reale. Per rappresentare e manipolare quest’ultima, tuttavia, non possiamo fare a meno che affidarci alla goffaggine della semplificazione4. Siamo abituati a pensa-
1. “In their desire to overcome what they perceive as false dichotomies, such as the opposition between nature and culture, some social science theorists –Bruno Latour and his followers in particular – tend to forget how instrumental these dichotomies remain for professionals like architects and engineers, as well as for their clients. Nature conveys usually mixed feelings of unfamiliarity and intimacy. Indeed, humans claim to be distinct from nature, all the while recognizing that they largely belong to it”. Antoine Picon, The materiality of architecture, University of Minnesota Press, Minneapolis 2020, p. 14.
2. René Descartes, Les passions de l’âme, Henry Le Gras, Paris 1649
3. Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, Esf, Paris 1990.
4. “Les systèmes complexes, sièges de causalités circulaires et de phénomènes récursifs et enchevêtrés qui les rendent largement instables, imprévisibles et donc difficilement contrôlables, ont vampirisé notre représentation du monde vu comme une irruption et un nœud de crises permanentes”. Sophie Chassat, Complexité. Critique d’une idéologie contemporaine, Fondation pour l’innovation politique, Paris 2023. Per un’analisi delle implicazioni filosofiche legate alla dicotomia corpo/mente, anche in confronto ad alcune questioni politiche, vedi Léa Barbisan, Eccentric bodies. From phenomenology to marxism. Walter Benjamin’s reflections on embodiment, in “Anthropology & materialism”, 2017, numero speciale, Discontinuous infinities, https://journals.openedition.org/am/803.
re la mente come la caratteristica che ci rende umani, autocoscienti, mentre associamo alla nostra corporeità esigenze, sentimenti, comportamenti, patologie e impulsi che tendono a sfuggire volontarietà e controllo, facendo venire alla superficie la nostra componente più selvatica. Questo conflitto segna profondamente le pratiche del progetto che, seguendo l’evoluzione della cultura, oscillano frequentemente nel riferirsi all’uno o all’altro termine, ben sapendo che l’apollineo emerge negli approcci più dionisiaci e viceversa.
Recentemente, anche grazie alla crescente integrazione con la tecnologia e i fenomeni di dematerializzazione e virtualizzazione a essa connessi, il corpo è diventato una delle questioni più controverse e dibattute, dentro e fuori il nostro campo disciplinare. Gli esseri umani contemporanei sono il prodotto di un processo millenario di potenziamento protesico. Gli strumenti tecnici, e l’architettura tra essi, caratterizzano la nostra specie, almeno quanto il linguaggio. Tutto, dalla nascita alla morte, è oggi mediato da dispositivi che si interpongono tra la realtà delle cose e l’esperienza che ne facciamo5. Di conseguenza, il coinvolgimento del corpo tende a scomparire dietro a interfacce sempre più sofisticate, al punto che la prospettiva di una sostituzione delle nostre migliori facoltà intellettuali da parte delle applicazioni
5. Marshall McLuhan, Understanding media. The extensions of man, Sphere Books, London 1967, ha inquadrato il fenomeno ad ampio raggio. Per uno sguardo più specificamente progettuale, vedi il recente Beatriz Colomina, Mark Wigley, Are we human? Notes on an archaeology of design, Lars Müller, Zürich 2016-18.
Prendere corpo


Come sottolineato da Manfredo Tafuri, l’urbanistica di Le Corbusier risulta schematica e ingenua in confronto alla sua architettura, capace di parlare del “multiversum metropolitano in modo assai più ricco e problematico”24. Quest’ultimo è uno spazio conflittuale, in cui lo sfruttamento biopolitico di popoli e risorse da parte dei processi di modernizzazione è complementare alla promessa della modernità di liberazione dai vincoli “naturali” di terra, famiglia, età, genere, religione, fame, salute25. L’architettura rispecchia e media questa e altre contraddizioni contemporanee, producendo esperimenti spesso più progressivi e sofisticati delle ideologie che li hanno sostenuti. Ad esempio, mentre la normalizzazione modernista aspirava a uniformare tutto, scartando tutto ciò che non era conforme allo standard per ottenere incrementi
24. Manfredo Tafuri, “Machine et memoire”. The city in the work of Le Corbusier, in The Le Corbusier archive, a cura di H. Allen Brooks, Garland, New York 1982-84, vol. 10, ed. it. “Machine et memoire”. La città nell’opera di Le Corbusier, 1984, in H. Allen Brooks (a cura di), Le Corbusier 1887-1965, Electa, Milano 1987, p. 241.
25. La dialettica tra modernità e modernizzazione è l’obiettivo specifico del molto celebrato saggio di Marshall Berman, All that is solid melts into air. The experience of modernity, Simon and Schuster, New York 1982: “In the twentieth century, the social processes that bring this maelstrom into being, and keep it in a state of perpetual becoming, have come to be called ‘modernization.’ These world-historical processes have nourished an amazing variety of visions and ideas that aim to make men and women the subjects as well as the objects of modernization, to give them the power to change the world that is changing them, to make their way through the maelstrom and make it their own. Over the past century, these visions and values have come to be loosely grouped together under the name of ‘modernism.’ This book is a study in the dialectics of modernization and modernism.” p. 16.
e cacca
di efficienza ed economie di scala, lo sviluppo tecnologico che ha innescato comincia a produrre un ampliamento delle possibilità in una diversa direzione. I manuali generalisti – anche le successive edizioni del Neufert – estendono così i loro schemi antropometrici ad altre categorie, bambini, donne, anziani, persone con disabilità, sia seguendo gli sviluppi politici e sociali che anticipandoli. Le tavole antropometriche interattive e adattabili proposte da Humanscale, rieditate nel 2017, mostrano come l’attitudine verticale modernista a imporre una “normalità” non può fare a meno di negoziare con le spinte dal basso che la criticano26. Le varie migliaia di parametri interconnessi che si possono ottenere ruotandone i selettori portano a una sorta di standardizzazione proliferativa: un ossimoro che ritrae fedelmente l’inevitabile impegno del progetto a tenere insieme generico e specifico, la medietà dei “Joe”, “Joe junior” e “Josephine”, disegnati da Alvin Tilley per Henry Dreyfuss negli anni cinquanta, con la loro variazione dimensionale27.
Un aspetto del primo Modulor può rappresentare una mossa nella medesima direzione. La sua altezza, una cifra tonda di un metro e settantacinque, era maggiore della media francese del tempo e, come tale, non riconducibile a immediati obiettivi pratici. Le Corbusier prese inizialmente sé stesso come modello, optando
26. Niels Diffrient, Alvin R. Tilley, Joan C. Bardagjy, Humanscale, progetto di Henry Dreyfuss associates, Mit press, Cambridge Mass. 1973-74. 27. Henry Dreyfuss, Designing for people, Simon and Schuster, New York 1955.
Porno

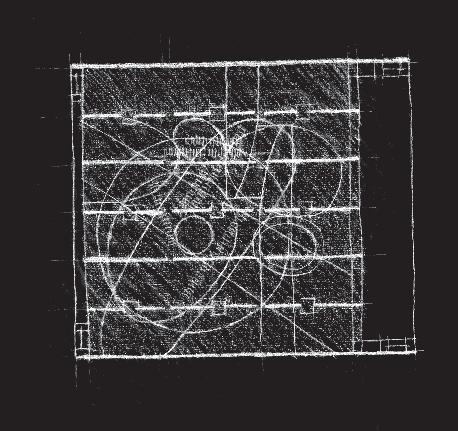
La manipolazione divertita delle perversioni dei maestri – la sindrome di controllo di Loos, il distacco autistico di Mies, la libidine esibizionista di Corbu – e dei loro esiti progettuali è solo una faccia della medaglia. Koolhaas, com’è noto, è arrivato all’architettura dopo aver praticato il giornalismo e scritto per il cinema, svolgendo entrambe le attività con un’attenzione specifica al sesso. Di fatto, un’inchiesta giornalistica in quattro puntate sul “Sesso nei Paesi Bassi” è stata l’ultimo lavoro per l’“Haagse Post”, un settimanale di costume, prima di dare le dimissioni nel 1967. Parallelamente, ha fatto parte del gruppo di ricerca cinematografica 1, 2, 3 enz, il cui membro più attivo era l’amico di scuola Rene Daalder. Insieme hanno scritto
De blanke slavin (La schiava bianca, 1969, diretto dallo stesso Daalder), un film ad alto budget su alcune ragazze assunte come infermiere che finiscono in un bordello africano. Sebbene sembri una trama porno, il film mostra chiaramente il retroterra avanguardista degli autori e la loro attitudine disincantata. È stato un flop clamoroso124. Alla fine, Koolhaas ne userà alcuni fotogrammi espliciti per illustrare la sezione dei bagni di Exodus, la sua tesi, dove i “prigionieri volontari” si denudano, letteralmente e metaforicamente, e partecipano a un interscambio erotico e collettivo di 124. Su Koolhaas prima di diventare architetto, vedi Bart Lootsma, Koolhaas, Constant and Dutch Culture in the 1960s, in “architecturaltheory.eu”, 4 settembre 2007, https://stichtingconstant.nl/system/files/2007%20Koolhaas%2C%20 Constant-Architecturaltheory.eu__0.pdf.
e cacca
esibizionismo e seduzione. Il genere, nelle sue declinazioni soft e hard, comunque lo attraeva: mentre studiava a Londra ha collaborato con Daalder su una sceneggiatura per Russ Meyer, il poeta hollywoodiano della sexploitation famoso per le protagoniste ipersessuate, impavide e supermaggiorate dei suoi film125.
Diventando un architetto, Koolhaas porta questo sguardo oltre all’anticipazione dell’esperienza sulla quale progettisti – e critici – solitamente fanno affidamento e che, in materia di sesso, prende la forma di fantasie erotiche proiettate sui comportamenti abitativi. Riesce così a innestare direttamente nel processo di progetto, nella sua concezione, interpretazione e comunicazione, un’immaginazione corporea stratificata, rendendola uno strumento operativo.
Delirious New York, insieme ai molteplici riferimenti al corpo, presenta sulla sovraccoperta della prima edizione un dipinto di Madelon Vriesendorp che raffigura una tresca tra grattacieli (l’Empire State e il Chrysler sorpresi a letto dall’Rca Building, e il preservativo è uno sgonfio Goodyear blimp). Corpi nudi sono dappertutto in S, m, l, xl, il libro che ha fatto dell’olandese una star internazionale. Un’immagine di Marina Abramovich e Ulay illustra ad esempio il progetto di Oma per il concorso del parco della Villette (Parigi, 1982)126.
125. Il soggetto del film, piuttosto profeticamente per gli anni sessanta, prevede un futuro in cui tutto, compresi gli attori, sarà sostituito da materiali generati dai computer. Ibidem.
126. Koolhaas et al., S, m, l, xl, cit., p. 920.
Sesso e cacca


Altri fenomeni intricati e contraddittori incombono all’orizzonte. La coabitazione fra adulti nelle economie avanzate è cresciuta visibilmente nelle ultime decadi come conseguenza della maggiore precarietà del passaggio dall’adolescenza alla vita autonoma. Oggi è difficile mettere su famiglia: i costi dell’abitare nelle metropoli stanno schizzando alle stelle; il tempo del lavoro si espande nell’ubiquità digitale; la sicurezza lavorativa sta evaporando. Tutto sembra appiattito sul presente. Il mercato segue e insieme alimenta queste dinamiche, vendendo accesso ai servizi piuttosto che il possesso di cose. Gli sviluppi tecnologici, dalla smart city alle applicazioni di dating intensificano l’uso del tempo individuale e delle infrastrutture esistenti, come gli algoritmi di compressione dei dati, e si integrano con l’offerta di spazi temporanei per la vita e il lavoro132. Emerge così una tendenza alla densificazione capsulare: introversa, adattiva e basata sul letto, un elemento primario che è allo stesso tempo intensamente individuale e un prodotto di massa. “I giovani”, rileva Jack Self, “condividono sempre più case per famiglie,
132. Jeremy Rifkin, The age of access, Penguin, London 2000, ha anticipato la situazione che stiamo vivendo. James Scott, direttore operativo di The Collective, una start-up dedicata al co-living sostiene che, “As we decouple the function of living from the physical location […], we will move to a model of subscription homes or providing living as a service. […] I don’t have possessions anymore, I’m all about experiences and it’s high time that our workspaces and living spaces caught up”. Jessica Mairs “In the future we will all be homeless” says co-living entrepreneur, in “dezeen”, 15 luglio 2016, https://www.dezeen. com/2016/07/15/in-the-future-we-will-all-be-homeless-says-co-living-entrepreneur-the-collective-james-scott-housing/.
trasformando tutti gli spazi comuni (i soggiorni, a volte persino i bagni) in celle individuali. La pressione a condividere questi spazi con estranei ha raggiunto una scala tale da spingere le persone a passare più tempo da sole nelle loro stanze. Per la prima volta, nel 2014 il letto ha superato il divano come mobile più usato della casa britannica”133. La parabola modernista dello scapolo – eroe nietzschiano degli esperimenti di Mies, agente mutante del manhattanismo koolhaasiano –sembra precipitare in una vita monacale: “poco o niente sesso, niente figli, monolocali in un residence o piccole celle in una casa condivisa. L’architettura del monastero si riflette oggi in ogni alloggio”134. Le relazioni interpersonali ne subiscono l’influenza in modi complessi.
Da un lato, le persone stanno perdendo interesse nel sesso. Persino in Francia, il paese simbolo dell’erotismo nell’immaginario collettivo, le statistiche dipingono una pratica in declino135. Dall’altro lato, il poliamore
133. “Young people increasingly share homes built for families, converting all common spaces (living rooms, sometimes even bathrooms) into one-room cells. At such a large scale, this pressure to share spaces with strangers is driving individuals to spend more time alone in their rooms. For the first time ever, in 2014 the bed overtook the sofa as the most used piece of British household”. Jack Self, Work on, work on, but you’ll always work alone, in “The architectural review”, 1 febbraio 2016, https://www.architectural-review.com/essays/workon-work-on-but-youll-always-work-alone, traduzione dell’autore.
134. “If we consider the statistics on how we live today, we seem to be returning to a monastic form of life: little or no sex, no children, one-room apartments in a closed complex, or little cells in a shared house. The architecture of the monastery is today reflected in every dwelling”. Ibidem, traduzione dell’autore
135. Una recente ricerca francese rileva che “L’activité sexuelle enregistre un recul sans precedent depuis une quinzaine d’années”. Étude Ifop 2024, https://www. ifop.com/publication/la-sex-recession-les-francais-font-ils-moins-lamour/.