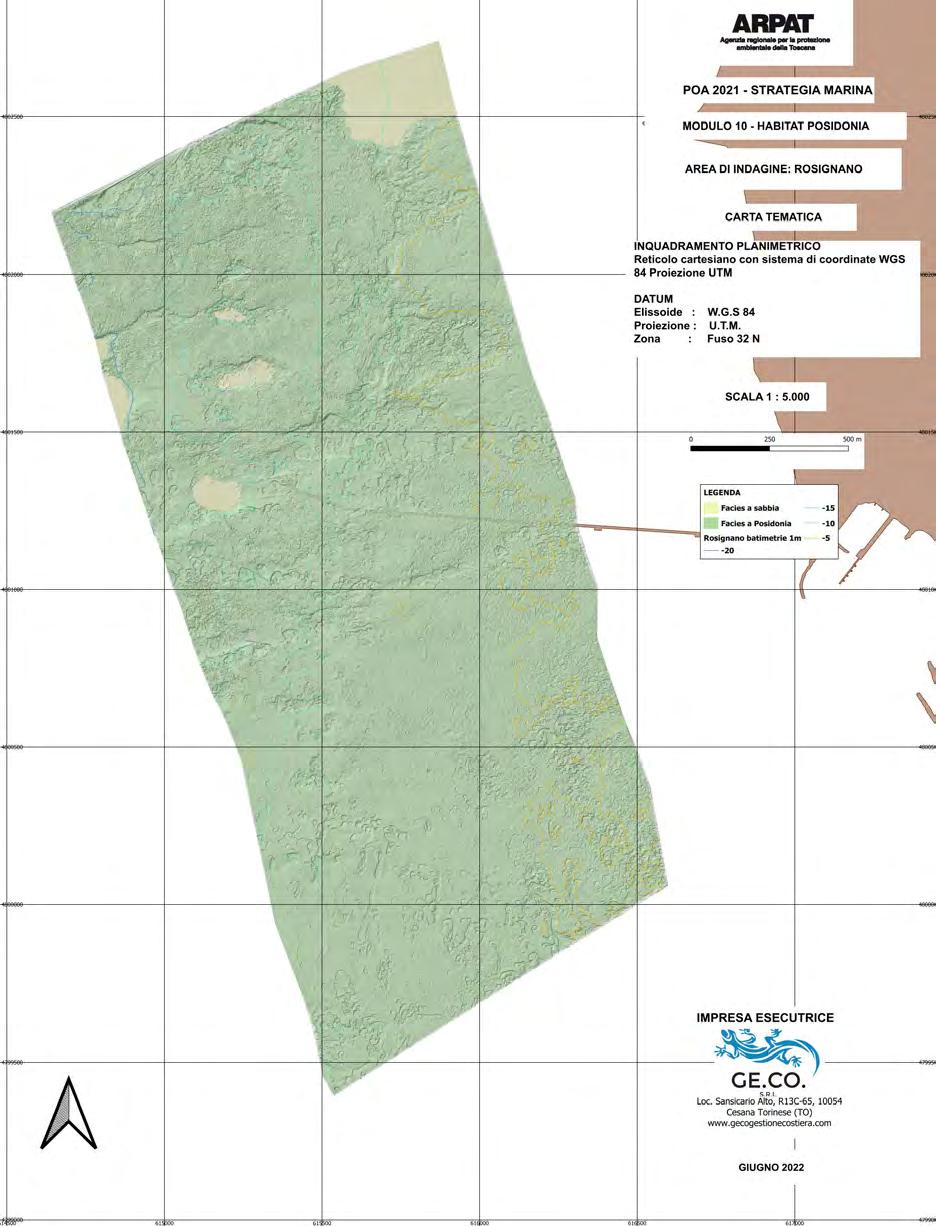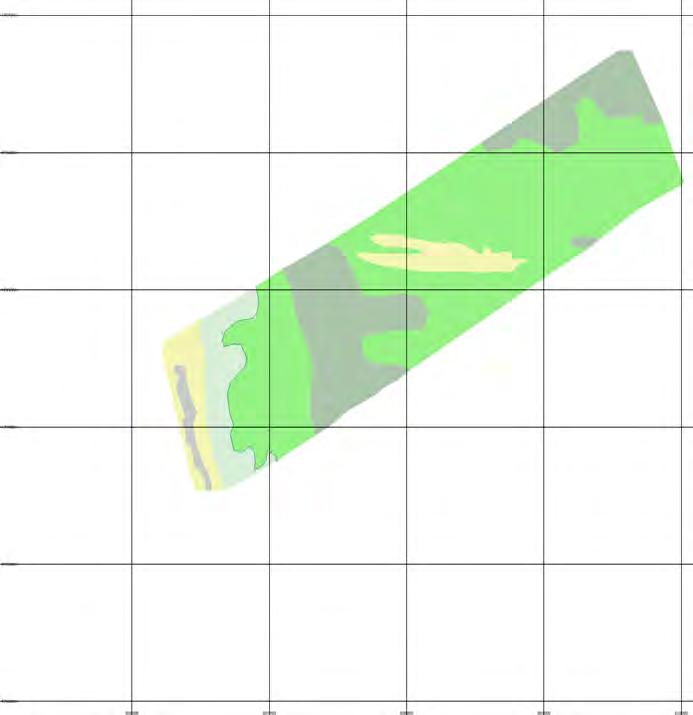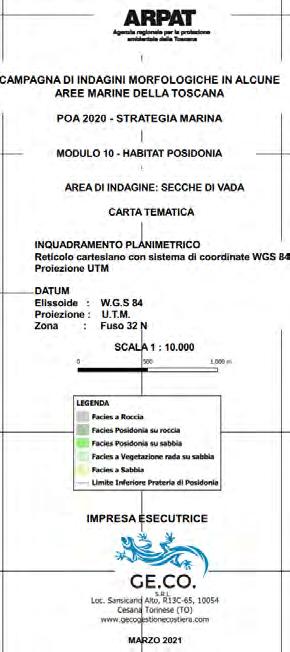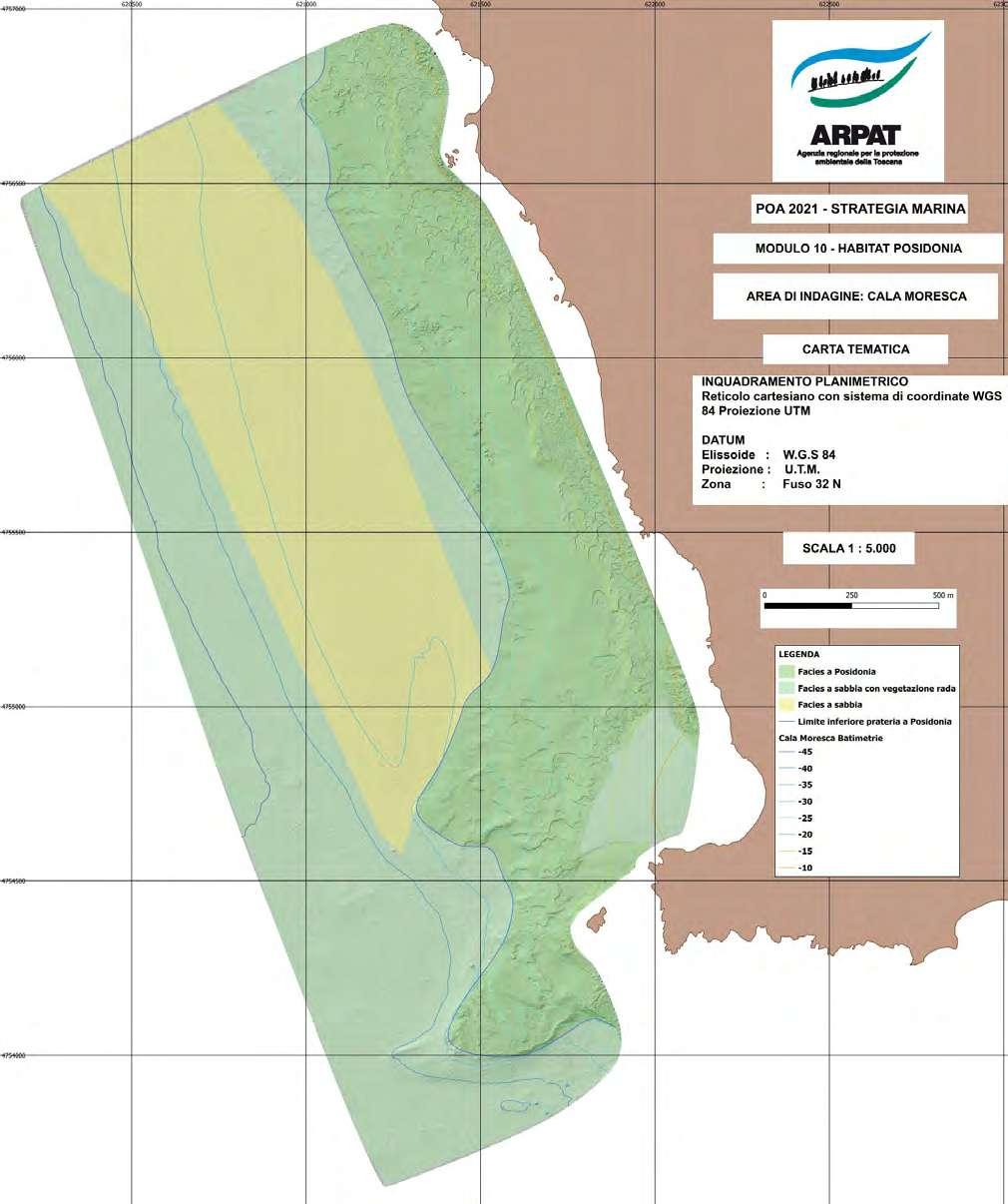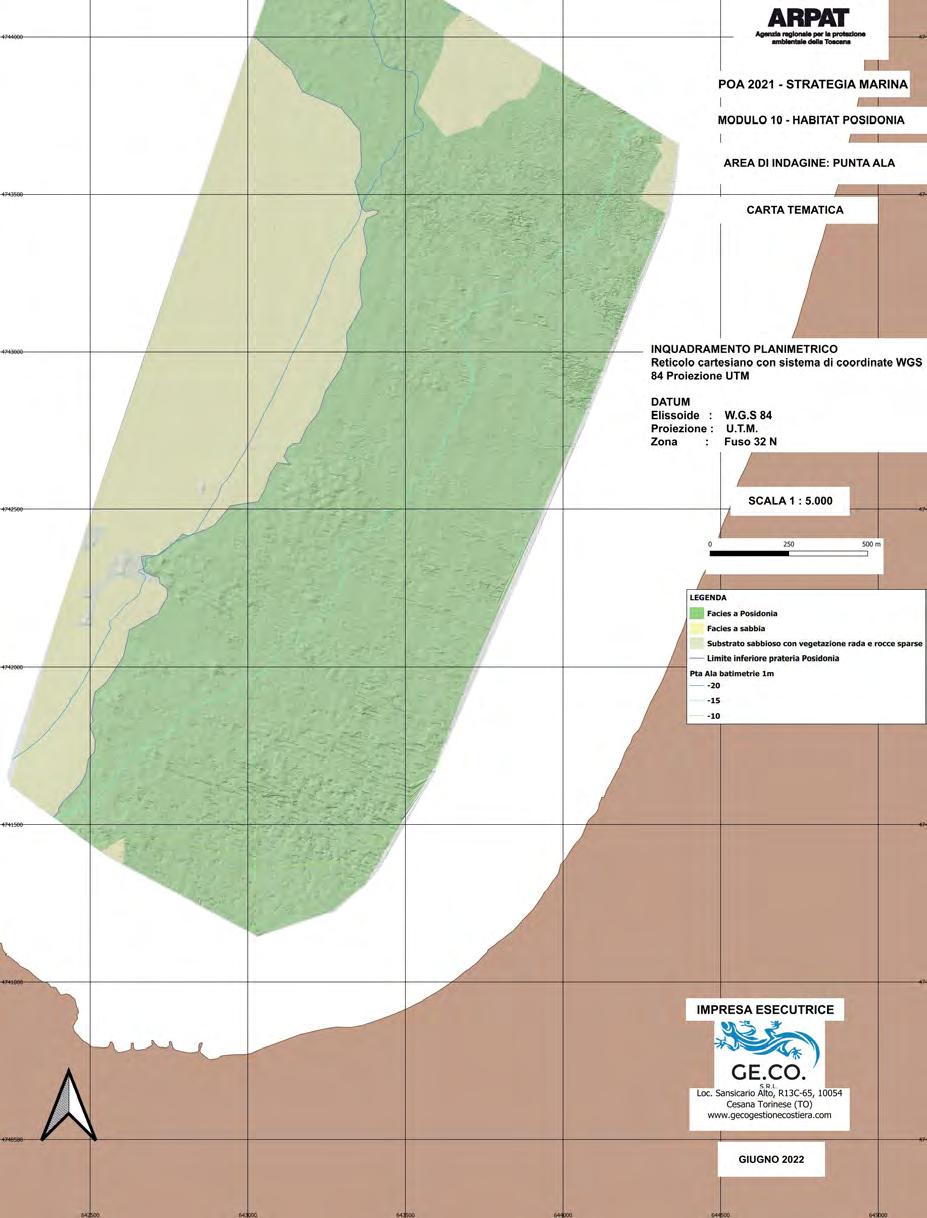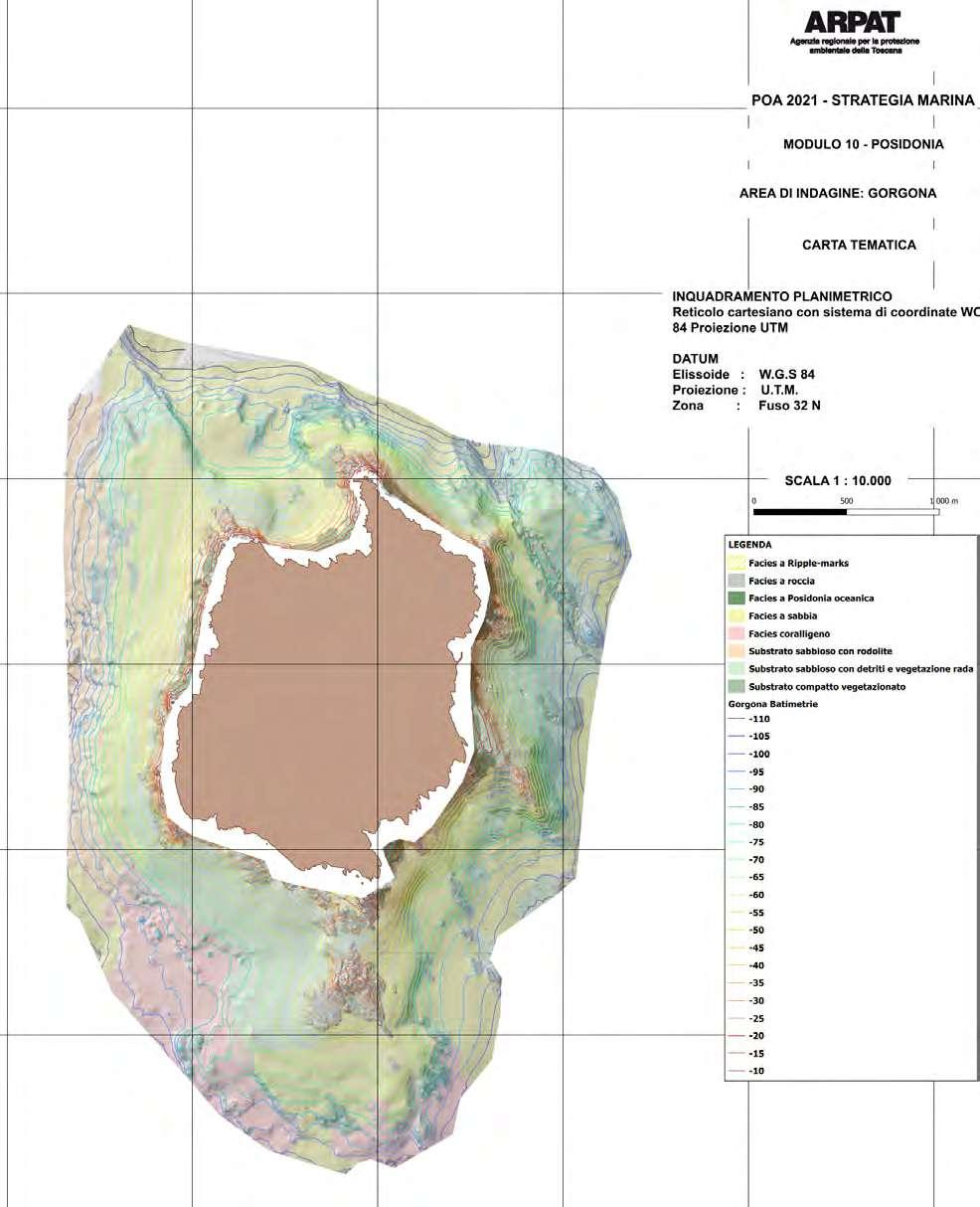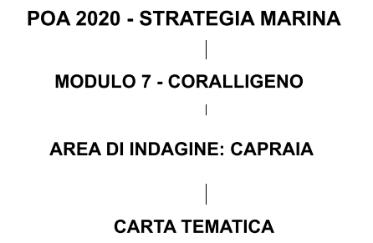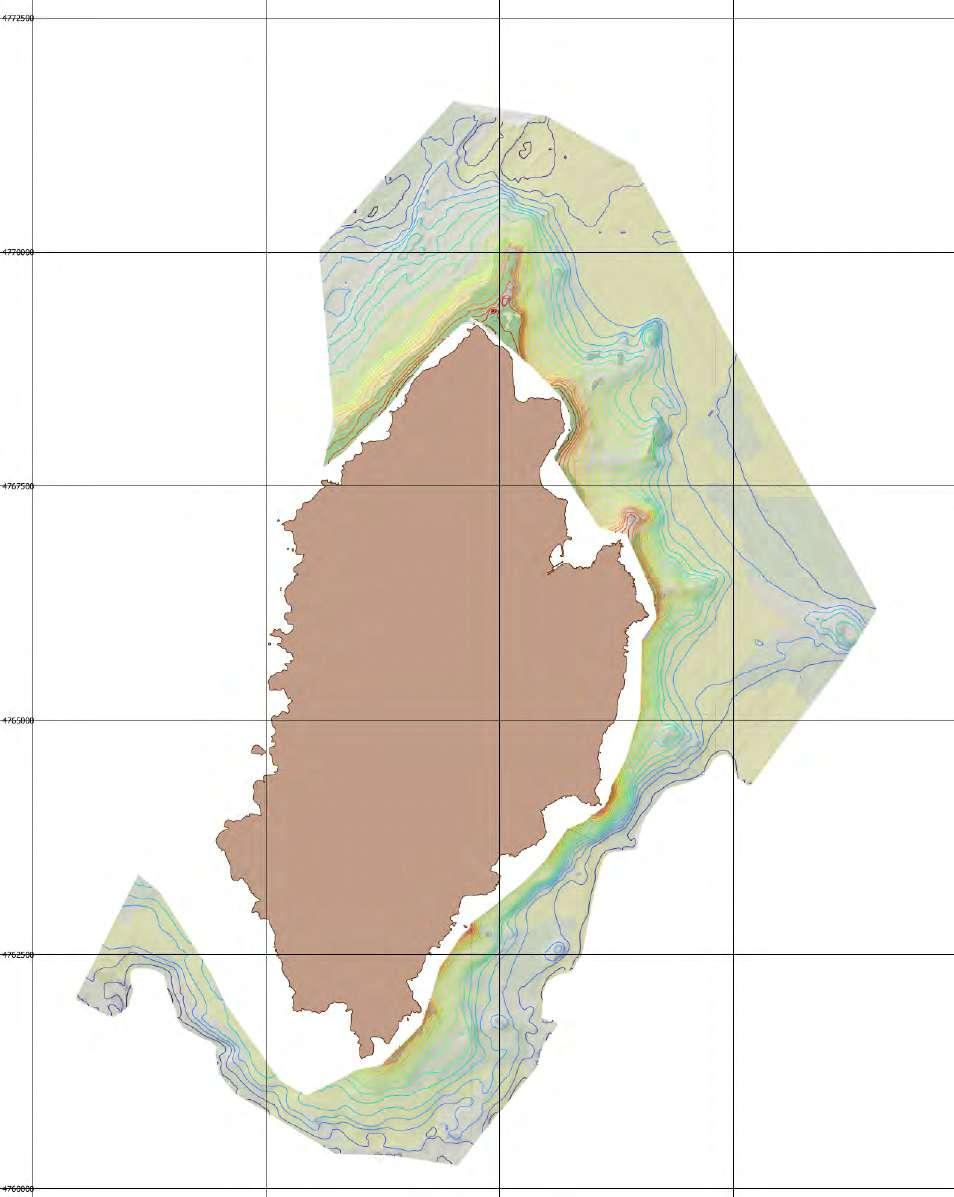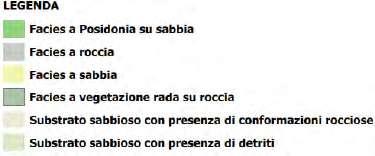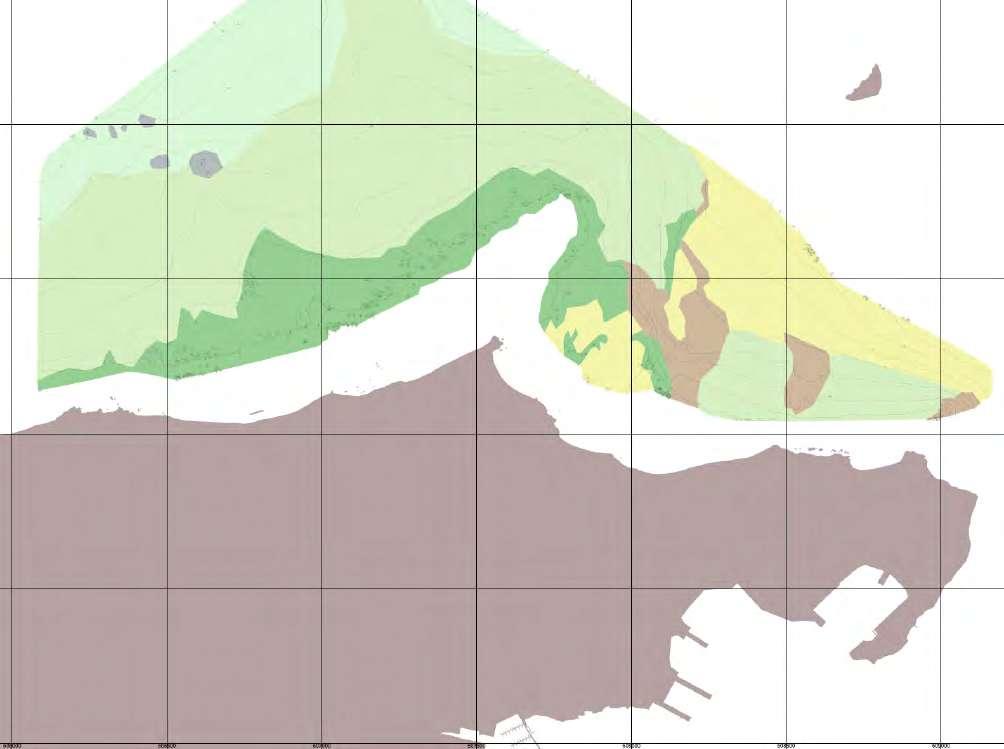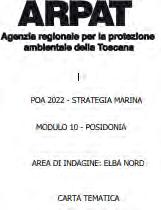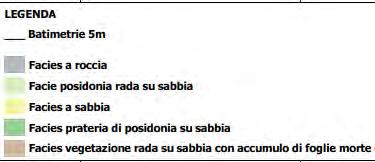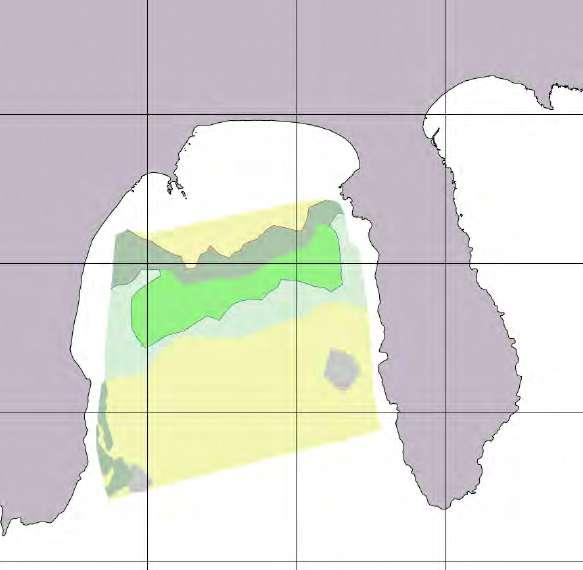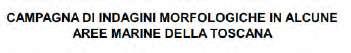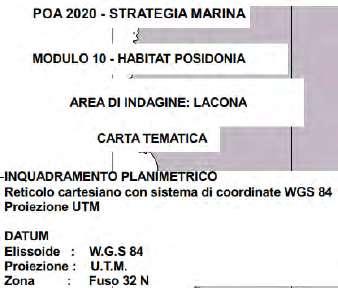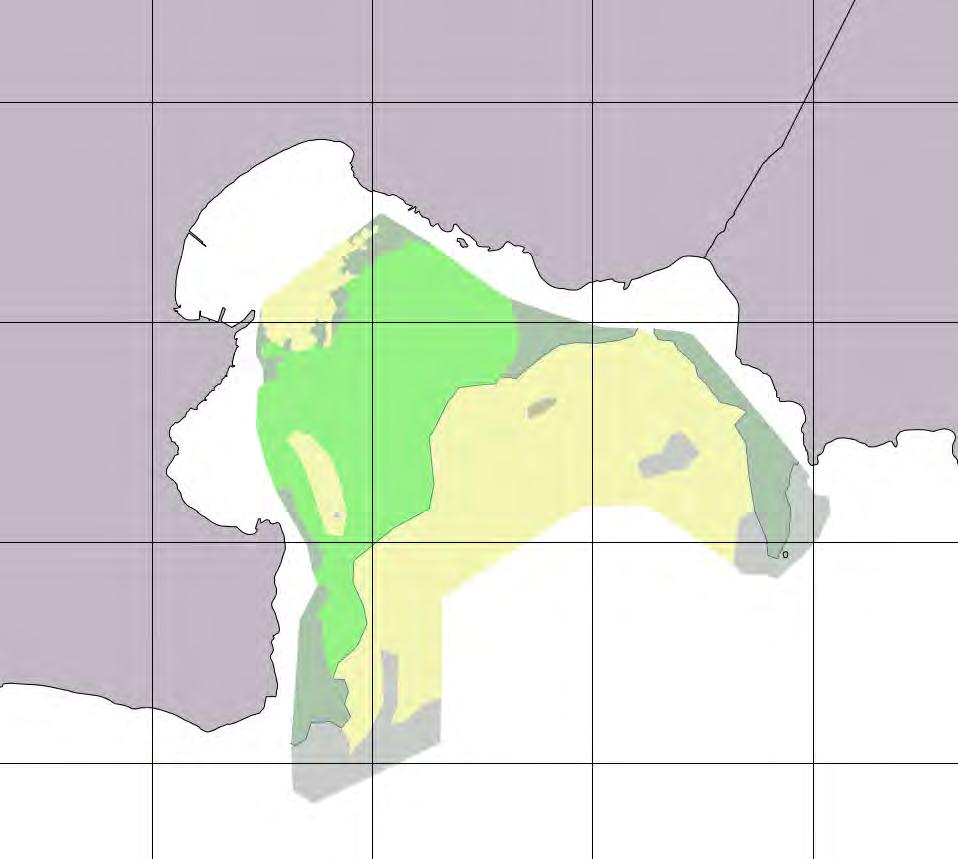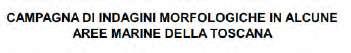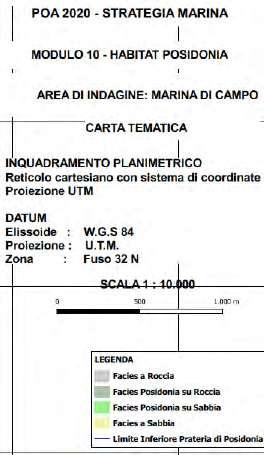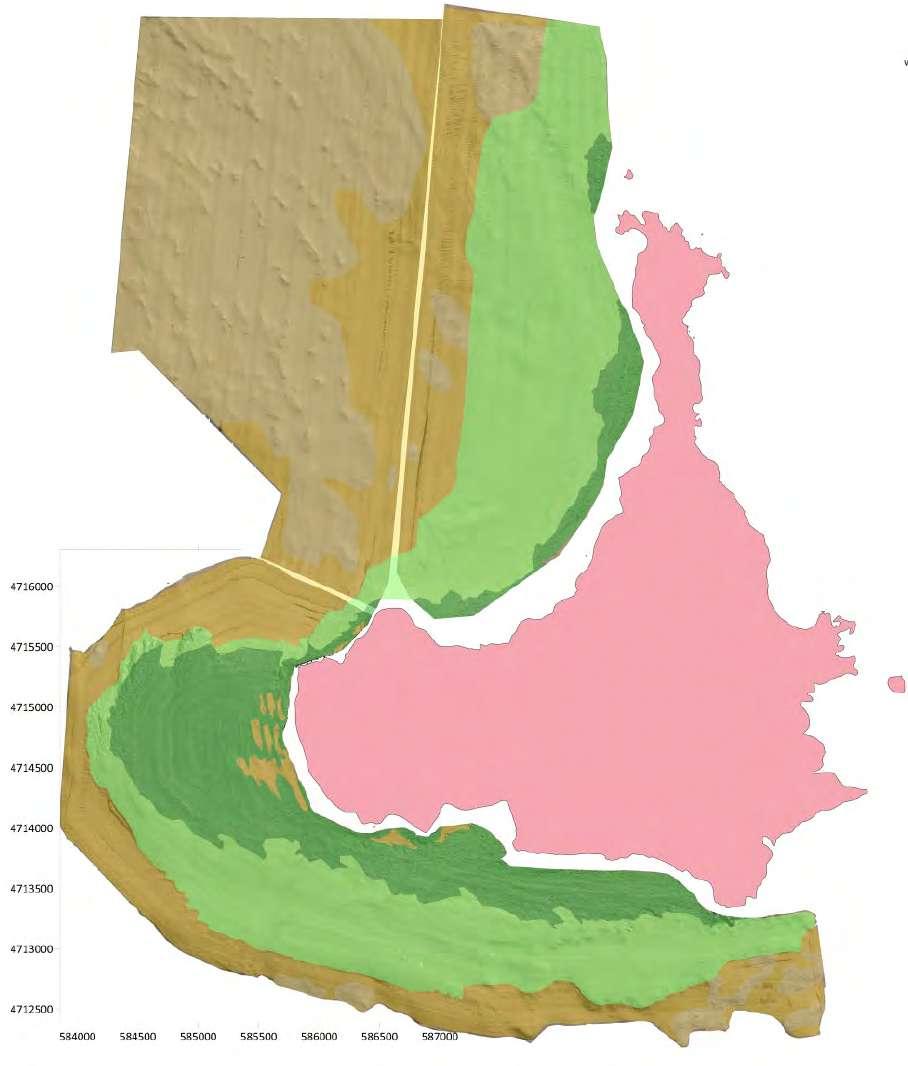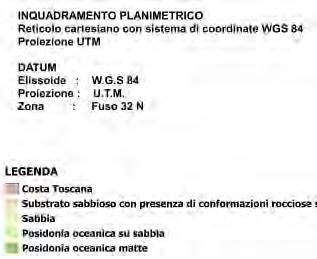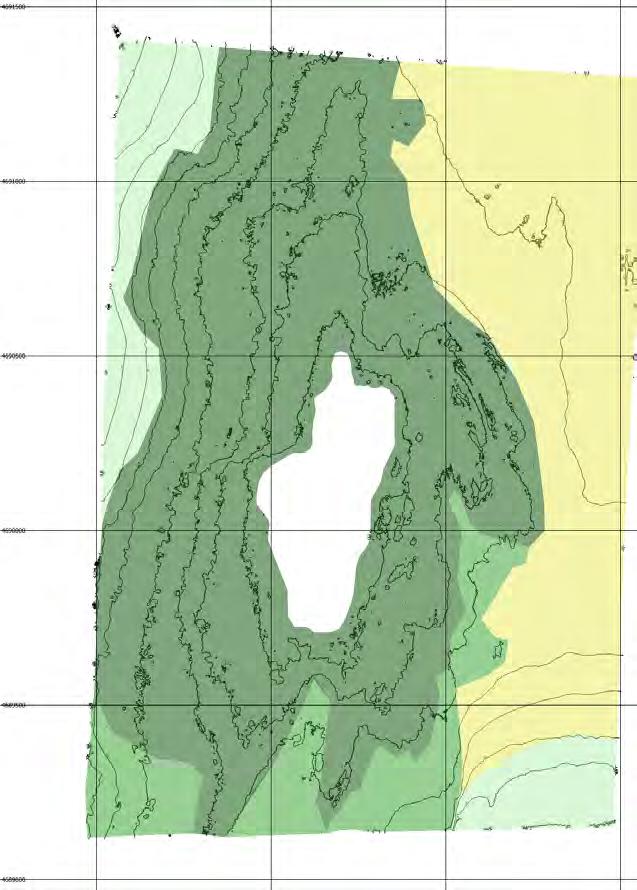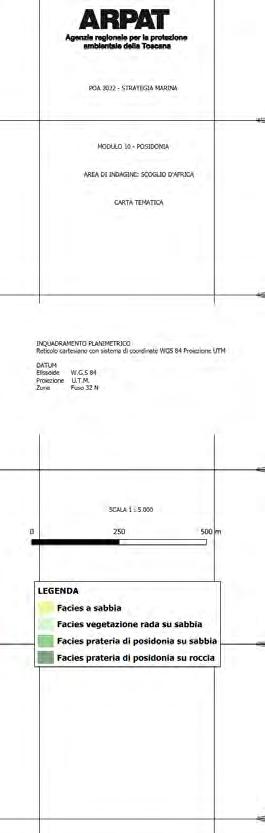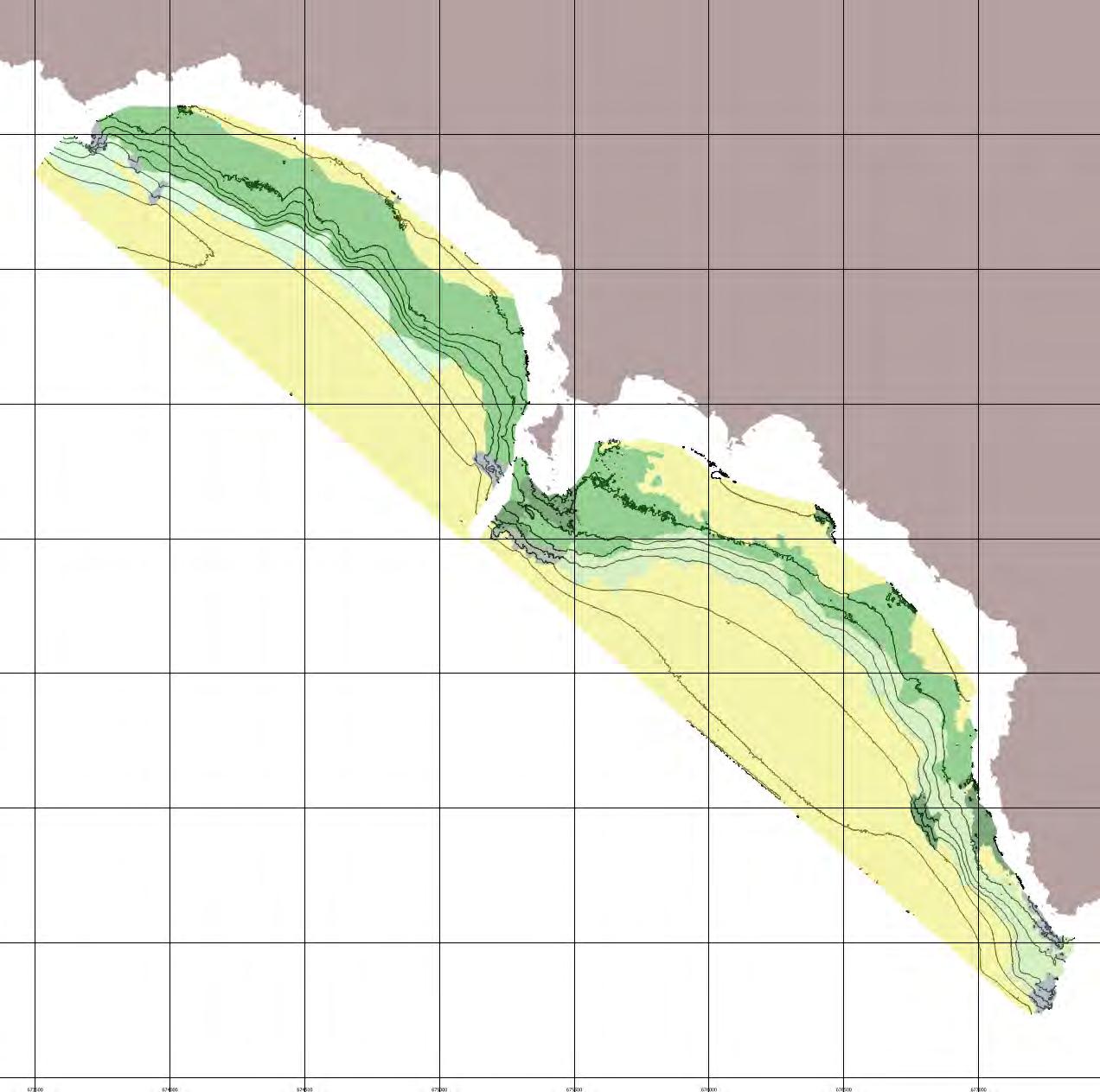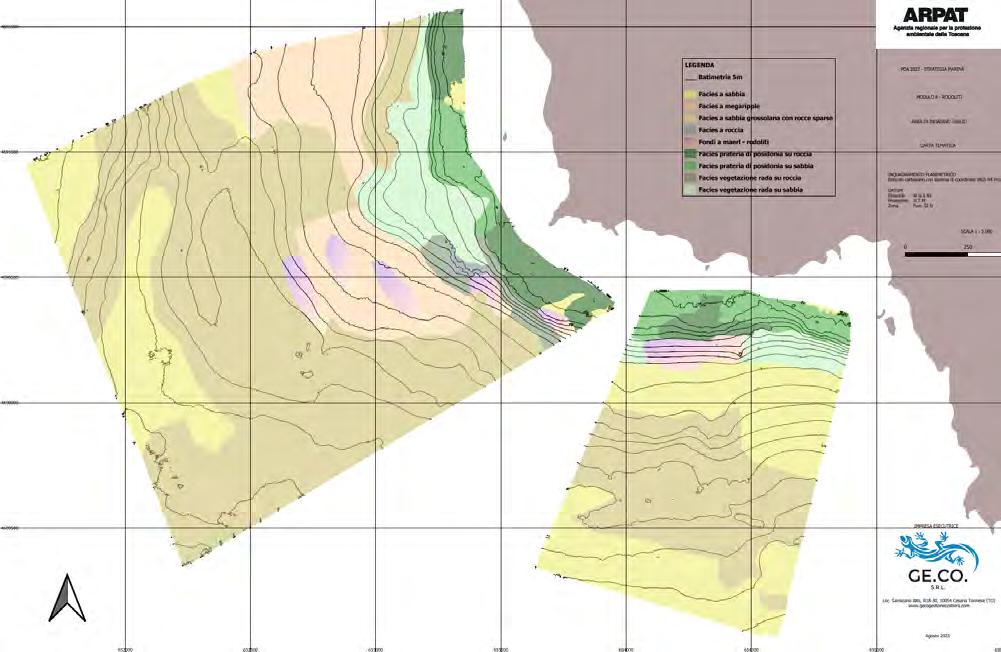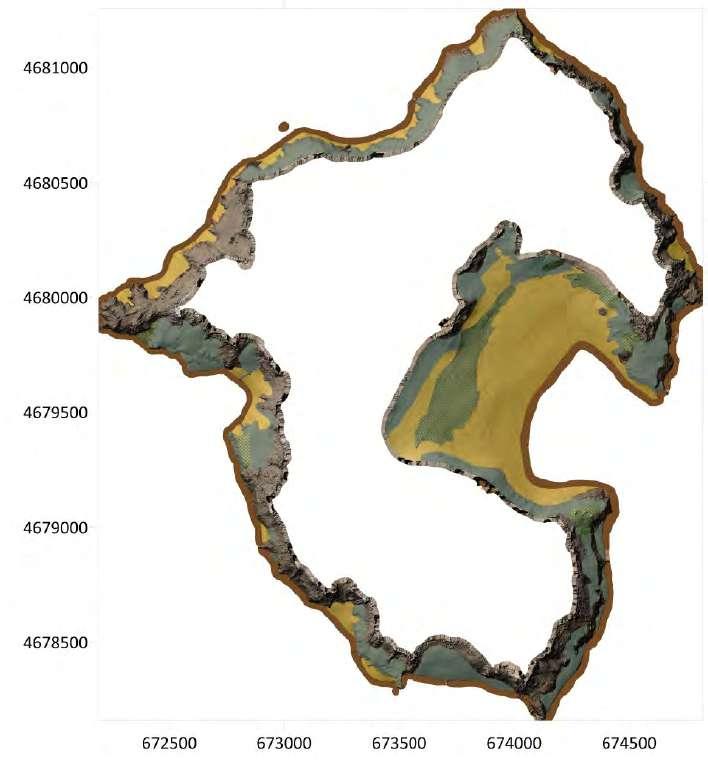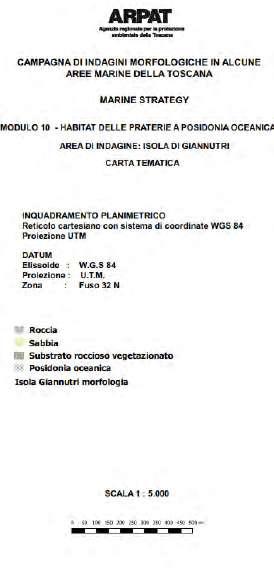2022-2024



2022-2024


Firenze, 2025
2022-2024
Il monitoraggio delle acque marino costiere della Toscana nel triennio 2022-2024
Autori: Antonio Melley, Daniela Verniani - ARPAT, Settore Mare
Referenti su singole tematiche
Fitoplancton: Daniela Verniani - ARPAT, Settore Mare
Macrozoobenthos: Ornella Bresciani, Giulio Busoni, Arcangela Pavia - ARPAT, Laboratorio Area Vasta Costa, U.O. Biologia
Posidonia oceanica: Cecilia Mancusi, Giacomo Marino, Andrea Nicastro, Ilaria Dalle Mura - ARPAT, Settore Mare
Macroalghe: Enrico Cecchi, Michela Ria - ARPAT, Settore Mare
Coralligeno: Enrico Cecchi, Andrea Nicastro - ARPAT, Settore Mare
Si ringrazia tutto il personale che ha effettuato i sopralluoghi, i campionamenti e tutte le analisi previste dal programma di monitoraggio delle acque marino costiere della Toscana
Copertina e editing: ARPAT, Settore Comunicazione, informazione e documentazione Immagine di copertina: ARPAT

ARPAT 2025
Errata corrige - 01/12/2025 pag. 103: aggiornata tabella 59, colonna "Biota e pesci" pag. 111: aggiornata tabella 63, colonne "Chl" e "TRIX"
Lo stato ecologico descrive la qualità delle acque integrando gli elementi di qualità biologica (EQB: biomassa fitoplanctonica, macroalghe, Posidonia oceanica e macrozoobenthos) con quelli chimico-fisici a sostegno (indice trofico TRIX) e con le sostanze chimiche non prioritarie nelle acque (tabella 1/B D.Lgs. 172/2015). Sulla base dei dati 2022-2024, quindi, lo stato ecologico delle acque costiere della Toscana risulta elevato in 6 corpi idrici costieri (37,5%), buono in 6 corpi idrici costieri (37,5%) e sufficiente in 4 corpi idrici costieri (25%). Il raddoppio di quelli in stato ecologico sufficiente (da 2 nei trienni precedenti) evidenzia un certo peggioramento attribuibile soprattutto a quanto rilevato sulle praterie di Posidonia oceanica, dato che passano da 1 a 3 con un PREI sufficiente.
Stato ecologico
Lo stato chimico dei medesimi corpi idrici viene determinato in base alla presenza di sostanze chimiche nelle acque e nel biota (tabella 1/A del D.Lgs. 172/2015), distinguendo tra stato buono ed il “mancato conseguimento dello stato buono” o non buono. Le concentrazioni dei contaminanti chimici nelle diverse matrici (acqua, pesci e molluschi) nel triennio 2022-2024 hanno determinato uno stato chimico non buono nelle acque marino costiere della Toscana, in particolare a causa di superamenti degli standard di qualità ambientale (SQA) nel biota (pesci e mitili)
Stato chimico
In merito si ricorda che monitoraggio dell’acqua si effettua 6 volte l’anno per singolo corpo idrico e si considerano (quasi sempre) le concentrazioni medie annuali (CMA), mentre il biota viene campionato 1 volta l’anno ed è sufficiente un solo valore superiore al SQA per definire lo stato chimico non buono. Esaminando in dettaglio le sostanze che hanno portato alla classificazione dello stato chimico non buono nei corpi idrici costieri della Toscana nel triennio 2022-2024 si rileva quanto segue:
• concentrazioni >SQA di mercurio e PBDE nei pesci (biota) in tutti i corpi idrici;
• superamenti nei pesci (biota) di esaclorobenzene (HCB) in 4 corpi idrici, dei DDT in 2 corpi idrici, di PFOS in Costa del Serchio e di diossine e composti diossina simili in Costa di Rosignano;
• superamenti nelle acque di alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in 4 corpi idrici e nei mitili (biota) all’Isola d’Elba;
• superamenti nelle acque nelle acque del mercurio in 3 corpi idrici, del nichel e del tributilstagno e relativi composti (TBT) in 2;
• Costa di Rosignano è il corpo idrico con il maggior numero di sostanze >SQA (5 nei pesci ed il mercurio nelle acque), alcune delle quali (mercurio e HCB) sono in aumento nello strato superficiale dei sedimenti
In definitiva, lo stato chimico non buono in tutti i 16 corpi idrici marino costieri della Toscana è stato determinato da valori superiori a quelli di riferimento (SQA) rilevati nel 17% (45 su 272) dei campioni analizzati nel triennio 2022-2024 per la matrice acqua e nel 73% (32 su 44) per il biota (pesci e molluschi).
La Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE (Water Framework Directive - WFD), recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 30/2009 (per le acque sotterranee), ha istituito un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque introducendo un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, sia dal punto di vista ambientale sia a livello amministrativo-gestionale. La Direttiva persegue obiettivi ambiziosi quali prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo dello stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine, delle risorse idriche disponibili. Inoltre, si propone di:
• proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici;
• incrementare la protezione delle acque superficiali e sotterranee;
• procedere attraverso un’azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità;
• rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia;
• raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque superficiali e sotterranee e mantenere, dove già esistente, lo stato elevato.
La Direttiva stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la tutela delle acque a livello di “distretto idrografico”, cioè un’area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. In ciascun distretto idrografico gli Stati Membri devono adoperarsi affinché vengano effettuate analisi delle caratteristiche, degli impatti provocati dalle attività umane e valutazioni di tipo economico sull’utilizzo delle risorse idriche. Per ogni distretto, deve essere predisposto un programma di misure (Piano di Gestione) che tenga conto delle analisi effettuate e degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva, con lo scopo ultimo di raggiungere uno “stato buono”.
Per stabilire lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici e valutare il raggiungimento del buono stato ambientale, devono essere attuati programmi di monitoraggio, che il D.Lgs. 152/2006 attribuisce alle Regioni. Il monitoraggio rappresenta uno strumento necessario per conoscere lo stato della risorsa idrica, fornire un supporto alla pianificazione territoriale, prevedere azioni di risanamento e verificarne nel tempo l’efficacia. Le Regioni, per le attività di monitoraggio ambientale dei corpi idrici, si sono affidate, in genere, alle proprie ARPA ed ARPAT, per conto della Regione Toscana, svolge da sempre tale compito.
Come detto, il monitoraggio deve consentire la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici ed i decreti attuativi del D.Lgs. 152/2006 hanno individuato le modalità con cui effettuare questa valutazione. In particolare, il D.M. 56/2009 ha definito i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento e, nell’Allegato 1, le modalità per il monitoraggio dei corpi idrici individuando gli elementi qualitativi per la classificazione. Con il successivo D.M. 260/2010 sono stati stabiliti i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali da effettuare al termine del ciclo di monitoraggio. Questo secondo decreto, a seguito dell’emanazione della Decisione della Commissione europea 2018/229/UE, ha subito modifiche riguardanti i valori di delimitazione delle classi di qualità.
La classificazione dei corpi idrici costieri viene determinata in base allo “stato ecologico” ed allo “stato chimico” (Figura 1):
• lo stato ecologico è dato dagli esiti dei monitoraggi degli elementi di qualità biologica (EQB), di qualità fisico-chimica a sostegno e degli inquinanti specifici non appartenenti all’elenco di priorità (tabella 1/B del D.Lgs. 172/2015);
• lo stato chimico è determinato dai risultati delle analisi delle sostanze chimiche condotte su acqua e biota in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 172/2015 e, per la Toscana, alla DGRT 264/2018.
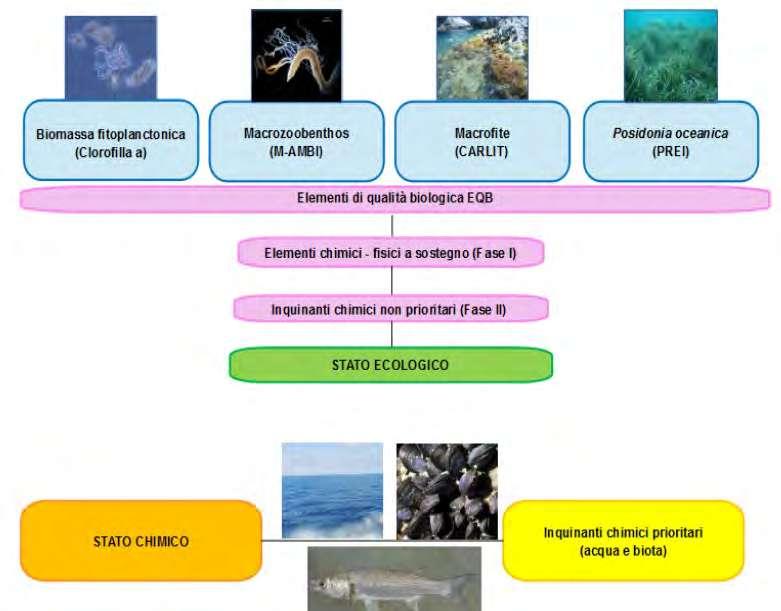
I rilevamenti per lo stato ecologico e chimico (monitoraggi) si diversificano per matrici, parametri, indici, frequenze, ecc., ma i risultati devono essere sempre confrontati con i valori di riferimento stabiliti dalle norme per determinare una classe di qualità.
La classificazione dello stato ecologico viene determinata al termine di un ciclo triennale di campionamenti per il monitoraggio operativo ed i diversi elementi di qualità biologica (EQB) devono essere confrontati con i valori di riferimento, espressi in concentrazione o direttamente come Rapporto di Qualità Ecologica (RQE), cioè il rapporto (tra 0 e 1) tra il valore misurato e quello previsto dal D.M. 260/2010 e ss.mm.ii.
Lo stato ecologico del corpo idrico è attribuito in base alla classe più bassa dei diversi EQB, eventualmente modificata dai dati di altri parametri così come elencato di seguito:
• classe più bassa risultante dall’incrocio degli EQB
• FASE I - integrazione tra gli elementi biologici e fisico-chimici a sostegno
• FASE II - integrazione con i dati degli inquinanti chimici non prioritari
Gli elementi di qualità biologica per le acque marino costiere italiane sono il macrozoobenthos (o macroinvertebrati bentonici), le angiosperme (Posidonia oceanica), le macrofite (macroalghe) e la biomassa fitoplanctonica.
1.3.1 Macrozoobenthos
Il macrozoobenthos comprende tutte le specie di invertebrati di dimensioni superiori a 0,5mm, cioè visibili a occhio nudo (macroinvertebrati), che vivono in stretta relazione con i fondali (bentonici) degli ambienti acquatici, sia marini che di acque interne.
Il macrozoobenthos è un anello essenziale della catena alimentare marina: molte specie di invertebrati bentonici si alimentano di fitoplancton (filtratori) e sono a loro volta fonte di nutrimento per un gran numero di specie di pesci ed altri organismi marini, svolgendo un importante ruolo di collegamento fra la produzione vegetale e i livelli trofici superiori. Inoltre, le specie che si nutrono di detrito (detritivori) sono fondamentali per la decomposizione della sostanza organica, che agevola il processo di mineralizzazione da parte dei batteri ed il riciclo degli elementi. Infine, la maggior parte delle specie bentoniche vive all’interno della sabbia ed il continuo movimento degli animali, solitamente nei primi 20 cm di spessore, contribuisce a ossigenare la sabbia, favorendo l’insediamento di altre specie.

Le specie più abbondanti e frequenti sono anellidi, molluschi, crostacei e, in misura minore, echinodermi, ma la distribuzione varia sensibilmente nel tempo e nello spazio, in funzione del ciclo vitale e, soprattutto, dei parametri chimico-fisici che definiscono l’habitat: disponibilità di materia organica, regime idrodinamico, dimensione e tipo di sedimenti presenti, influenzati, a loro volta, dalle condizioni meteomarine.
Di conseguenza, la composizione di queste comunità è molto variabile, anche in assenza di particolari stress ambientali: l’inquinamento delle acque e la modifica della costa dovuta alla realizzazione di opere di difesa costiera, di porti e porticcioli, ecc. possono determinare alterazioni particolarmente importanti, talvolta con conseguenti effetti negativi anche su una scala più ampia. Essendo, quindi, particolarmente sensibili alle pressioni antropiche, gli invertebrati bentonici vengono considerati dei buoni bioindicatori, in grado di fornire informazioni integrate sullo stato dell’ambiente, anche sul lungo periodo.
Nelle acque costiere del Mediterraneo vengono presi in considerazione i macroinvertebrati di fondo mobile, cioè quelli che abitano i fondali marini costituiti da sedimenti di natura prevalentemente fangosa e/o sabbiosa, che sono quelli più comuni nella fascia costiera. In Toscana, sono stati monitorati, in particolare, i popolamenti macrozoobentonici di fondo prevalentemente sabbioso (sabbia ≥75%), cioè quelli generalmente presenti entro un miglio nautico dalla costa (limite delle acque marino costiere).
Ogni corpo idrico viene esaminato con cadenza triennale: la fase di campionamento prevede il prelievo, tramite strumenti come la benna Van Veen (volume di 18 litri e superficie di presa di circa 0,1 m2), di 3 campioni (repliche). Il sedimento viene, quindi, sottoposto ad analisi granulometrica 1 e del contenuto in carbonio organico totale (TOC), mentre gli organismi, dopo setacciatura, vengono fissati con etanolo al 75% ed avviati al laboratorio.
In seguito, mediante stereomicroscopio si suddividono gli organismi nei principali taxa animali (sorting), che vengono raccolti in differenti contenitori per essere, poi, sottoposti ad analisi tassonomica fino al livello di specie, quando possibile.
I dati sono elaborati mediante l’utilizzo del software AMBI 6.0 (AZTI’s Marine Biotic Index) per il calcolo degli indici AMBI (Borja et al., 2000) e M-AMBI o Multivariate AMBI (Muxika et al., 2007). L’AMBI è un indice che suddivide le varie specie in 5 gruppi in base alla loro sensibilità dalle specie più sensibili che non sopportano minimi livelli di inquinamento (GI) a specie opportunistiche, estremamente tolleranti ad apporti organici (GV):
Gruppo (G)
Tipo di specie
I sensibili
II sensibili/tolleranti
III tolleranti
Gruppo (G)
Tipo di specie
IV opportuniste (primo ordine)
V opportuniste (secondo ordine)
Il valore dell’indice AMBI va da 0 (comunità bentoniche non soggette ad alcun tipo di disturbo) a 6 (comunità fortemente alterate e sottoposte a un disturbo estremo).
Per i macroinvertebrati bentonici si applica l’Indice M-AMBI, una evoluzione dell’indice AMBI integrato con l’Indice di diversità di Shannon-Wiener ed il numero di specie (S), elaborando
1 La suddivisione del sedimento in classi dimensionali (granulometria) dei fondali marini è utile per confrontare i risultati delle analisi sui popolamenti di macrozoobenthos e sulla prateria di posidonia, a parità di composizione percentuale: ghiaia (granuli con diametro > 2mm); sabbia (diametro tra 2 e 0,0625 mm); peliti (diametro < 0,0625 mm)
le suddette 3 componenti con tecniche di analisi statistica multivariata: il valore dell’M-AMBI varia tra 0 ed 1 e corrisponde al RQE (Tabella 1).
Tabella 1: limiti di classe per l’EQB macroinvertebrati bentonici nei corpi idrici costieri
RQE (M-AMBI)
≥ 0,81
Stato ecologico
Elevato
0,80 - 0,61 Buono
<0,60
Sufficiente
Le angiosperme sono piante “superiori”, ma solo poche specie vivono sui fondali marini (fanerogame marine). Nel Mar Mediterraneo sono rappresentate principalmente dalla Posidonia oceanica, una pianta vascolare endemica di questo bacino, ma sono presenti, con caratteristiche e importanza molto diverse, altre specie come Cymodocea nodosa, Zostera marina, Nanozostera noltii e Halophila stipulacea
La posidonia, come tutte le angiosperme, è una pianta dotata di radici, foglie, fusto, fiori e frutti e colonizza i fondali soprattutto sabbiosi, in una fascia generalmente compresa entro i 40 metri di profondità in base alla trasparenza delle acque, costituendo spesso delle vere “praterie” sottomarine, uno tra i popolamenti più studiati e più rappresentativi del piano infralitorale del Mediterraneo.
Le praterie di posidonia (posidonieti) sono un vero e proprio ecosistema con fondamentali funzioni ecologiche (produzione di ossigeno e sostanza organica, assorbimento della CO2 dall'atmosfera, deposito di nutrienti, creazione di microhabitat e incremento della biodiversità, ecc.) e di difesa della fascia costiera (attenuazione dell’idrodinamismo costiero, stabilizzazione dei fondali sabbiosi e delle dune, protezione delle spiagge, ecc.). Inoltre, la sua notevole sensibilità ad ogni perturbazione naturale o artificiale in atto nell’ambiente la rende un ottimo indicatore biologico per determinare la qualità delle acque marine costiere.
Il successo evolutivo di questa pianta, in un ambiente instabile e dinamico come il fondale sabbioso, è legato alla contemporanea crescita dei fusti (rizomi) in orizzontale e in verticale. I rizomi orizzontali (plagiotropi) ancorano la pianta al fondale tramite radici lignificate e sono quindi responsabili dell’espansione laterale delle praterie, mentre i rizomi verticali (ortotropi) ne compensano il progressivo insabbiamento, dovuto al continuo apporto di sedimenti.
La struttura a terrazzo che ne deriva (“matte”) agisce come una trappola per la sabbia, tanto da proteggere il fondale dalla forza erosiva delle onde. La crescita verticale della matte è tuttavia estremamente lenta, stimata attorno a 1 cm/anno, fatto che rende particolarmente difficoltoso il recupero biologico dopo eventuali eventi di stress. I rizomi presenti sul margine superiore della matte sviluppano i fasci fogliari, che contengono gruppi di 6-7 foglie, lunghe fino a 1 metro.



Il monitoraggio delle praterie di P. oceanica prevede che vengano identificate 2 stazioni (unità di osservazione o “transetto”), una a circa 15 m di profondità (intermedia) ed una sul limite inferiore, dove i biologi subacquei effettuano una prima serie di misure e stime su:
• tipo di substrato (roccia, sabbia, matte, misto), ricoprimento (percentuale di substrato ricoperto dalle piante di P. oceanica o di matte morta) e continuità della prateria;
• presenza (%) di altre fanerogame (Cymodocea nodosa) e/o di alghe invasive (Caulerpa racemosa, C. taxifolia);
• misure (opzionali) di intensità della luce e della temperatura;
• profondità e tipo di limite ed eventuale scalzamento dei rizomi (solo limite inferiore).
Per quanto riguarda, poi, la densità dei fasci fogliari, cioè la conta dei fasci fogliari su una superficie standard di 40X40 cm:
• nella stazione intermedia vengono definite 3 aree, di 400m2 circa ciascuna e distanziate di 10m tra loro, in ciascuna delle quali effettuare 3 misure (repliche) per un totale di 9 repliche di ogni stazione;
• lungo un transetto orizzontale (di circa 50-60 metri) in corrispondenza del limite inferiore, si effettuano 6 repliche.
In ogni prateria vengono anche prelevati campioni di sedimento nella stazione a 15m per successive analisi granulometriche e fasci ortotropi di P. oceanica (6 in ogni area per la stazione intermedia e 6 in totale per il limite inferiore) che vengono misurati (in laboratorio) e analizzati per:
• parametri lepidocronologici (produzione, peso, lunghezza, età del rizoma e altro);
• parametri morfometrici (lunghezza, larghezza, superficie delle foglie adulte, intermedie e giovanili, ecc.);
• biomassa fogliare e degli epifiti, espressa in peso.
A partire dal 2020, poi, sulla base dell’aggiornamento delle schede metodologiche 2 per il Programma di monitoraggio previsto dalla Strategia Marina (D.Lgs. 190/2010), è stato deciso di individuare 3 unità di osservazione su una superficie di 3 km2 di prateria. In pratica, quindi, per ogni prateria di P. oceanica monitorata in Toscana è stata definita 1 area di 3 km2, all’interno della quale sono state individuate 3 stazioni intermedie e 3 del limite inferiore, triplicando le misure e le analisi sopra previste (Figura 4).
2 SNPA, Schede metodologiche utilizzate nei programmi di monitoraggio del secondo ciclo della Direttiva Strategia Marina (D.M. 2 febbraio 2021), Pubblicazioni tecniche SNPA, 2024
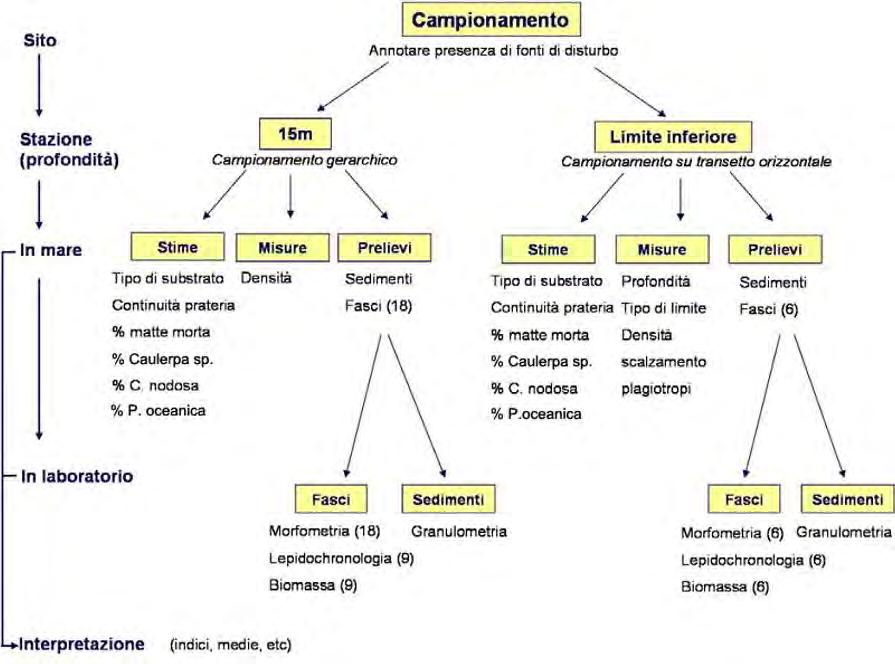
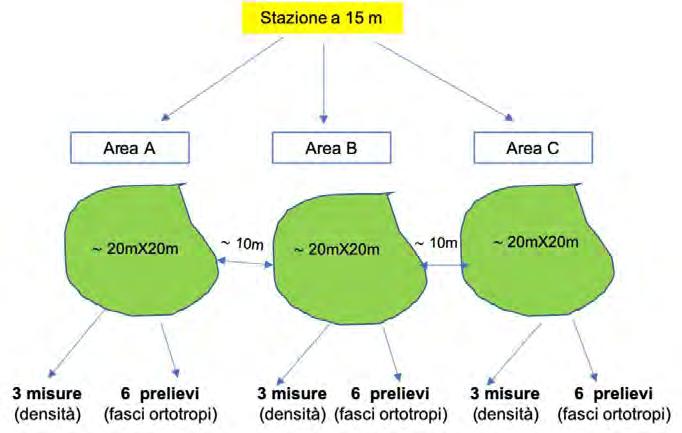
4: schema di campionamento per l’indagine delle praterie a P. oceanica
Come per il macrozoobenthos e le macrofite, il monitoraggio di ogni prateria viene effettuato una volta ogni 3 anni ed il giudizio di qualità ecologica è espresso mediante il PREI (Posidonia Rapid Easy Index), un indice che integra gli effetti di differenti impatti antropici
(immissioni di inquinanti nelle acque e/o nei sedimenti, alterazioni fisico-morfologiche del tratto costiero, ecc.).
L’indice PREI viene calcolato elaborando i dati di 4 parametri nella stazione intermedia della prateria in esame (superficie e densità fogliare, biomassa fogliare e degli epifiti) e profondità e tipologia del limite inferiore, confrontandoli con i valori di riferimento di una prateria indisturbata e stabiliti dalla Tabella 4.3.1/e del D.M. 260/2010 (Tabella 7), sulla base della seguente equazione:
RQE= (RQE’+0,11) / (1+0,10)
dove RQE’= [Ndensità + Nsup.fogl. + Nbiomasse + Nlim.inf.] /3,5
e Ndensità = rapporto tra valore misurato e di riferimento della densità fogliare nella stazione intermedia
Nsup.fogl. = rapporto tra valore misurato e di riferimento della superficie fogliare nella stazione intermedia
Nbiomasse = rapporto tra la biomassa degli epifiti e la biomassa fogliare nella stazione intermedia, sottratto all’unità e moltiplicato per 0,5
Nlim.inf. = rapporto tra la profondità misurata del limite inferiore, alla quale va aggiunto il valore lambda (λ) per il tipo di limite (0 = stabile; 3 = progressivo; -3 = regressivo), e quella di riferimento, dopo aver sottratto a entrambe la profondità minima del limite inferiore indicativa di cattive condizioni (12 m), cioè =
Il risultato finale del PREI non fornisce un valore assoluto, ma direttamente il rapporto di qualità ecologica (RQE) suddiviso in 5 classi: lo stato cattivo corrisponde ad una recente non sopravvivenza di P. oceanica, ovvero, alla sua scomparsa entro cinque anni.
Tabella 2: limiti di classe per l’EQB angiosperme nei corpi idrici costieri e relativo Stato Ecologico
RQE (PREI)
Stato ecologico ≥ 0,775
0,774 - 0,550
0,549 - 0,325
0,324 - 0,100
<0,100
Elevato
Buono
Sufficiente
Scarso
Cattivo
1.3.3 Macrofite
Le macrofite marine sono alghe pluricellulari (macroalghe), ben visibili a occhio nudo, aderenti ad un substrato roccioso e, insieme alle piante acquatiche (posidonia, ecc.), svolgono un ruolo importante per l’ossigenazione delle acque e la produzione di sostanza organica. In base al tipo di pigmento fotosintetico dominante sono suddivise in alghe verdi,
brune e rosse e ciascun gruppo di specie è distribuito lungo fasce diverse di profondità, fino a circa -150 m.

Le specie utilizzate nel monitoraggio marino sono quelle che vivono nella fascia litorale in cui si ha un’alternanza di emersione e immersione, dovuta all’escursione di marea e all’azione del moto ondoso (zona intertidale). Questa fascia di confine tra gli habitat marini e terrestri è quella più sensibile alle pressioni antropiche e nel Mediterraneo va da 20 cm sopra il livello medio del mare fino a circa -50 cm di profondità.
Ciascuna specie ha uno specifico intervallo di tollerabilità ai diversi fattori ambientali (luce, umidità, salinità, temperatura, ecc.) e cambiamenti drastici possono stravolgere gli equilibri di tutta la comunità macroalgale, alterando la composizione in specie.
In condizioni di equilibrio ambientale, su scogliere a forte pendenza ed elevato moto ondoso, la fascia subito al di sopra del livello medio del mare è normalmente colonizzata da alcune specie di alghe, dette corallinacee, il cui accrescimento determina la formazione di strutture simili a veri e propri marciapiedi costieri, denominati “trottoir”. Nei nostri mari, le specie dominanti di queste strutture sono Lithophyllum byssoides e Lythophyllum trochanter
La zona sommersa delle scogliere è invece normalmente dominata da varie specie di alghe brune appartenenti al genere Cystoseira che crescono in modo fitto e rigoglioso, creando fasce di vegetazione molto dense, alte fino a 40 cm (cistoseireti).
Oltre alla produzione primaria ed all’ossigenazione delle acque (organismi fotosintetizzanti), le macroalghe, insieme al fitoplancton, sono fonte di nutrimento per molte altre specie, soprattutto di pesci e crostacei, ma possono avere anche un ruolo “strutturale”, formando un complesso di microhabitat diversi, che forniscono riparo dalle correnti e dai predatori a molti animali di piccole dimensioni. I cistoseireti e i trottoir sono, quindi, ambienti marini con un grado di biodiversità molto elevato, ma estremamente sensibili alle perturbazioni antropiche (urbanizzazione, scarichi, opere costiere, ecc.) e, come tali, sono degli ottimi bioindicatori.
Tabella 3: descrizione delle comunità di macroalghe litorali e rispettivi Sensitivity Level (SL) associati Categoria
Trottoir (concrezioni a marciapiede) Trottoir di Lithophyllum byssoides (L. trochanter e Dendropoma 3) 20
popolamenti a Cystoseira
C. brachycarpa/ crinita/ elegans Popolamenti a C. brachycarpa/crinita/elegnas 20
Cystoseira in zone riparate Popolamenti a C. barbata/foniculacea/humilis/spinosa 20
C. amentacea/mediterranea 5 Cinture continue a C.amentacea/mediterranea 20
C. amentacea/mediterranea 4 Cinture quasi continue a C.amentacea/mediterranea 19
C. amentacea/mediterranea 3 Popolamenti abbondanti a C.amentacea/mediterranea 15
C. amentacea/mediterranea 2
Per la valutazione dello stato ecologico sulla base dell’EQB macrofite nei corpi idrici costieri, viene utilizzato l’indice CARLIT (CARtografia LITorale) che considera le comunità di macroalghe presenti nella fascia intertidale delle scogliere rocciose. Questo indice si basa sul principio secondo cui, all’aumentare delle perturbazioni antropiche, alcune specie di macroalghe, definite “sensibili”, tendono a scomparire e a essere sostituite da specie con livelli di tolleranza crescenti allo stress ambientale.
In realtà, nel CARLIT non vengono prese in considerazione tutte le specie ma solo le cosiddette “associazioni” vegetali, ossia gruppi di specie che mostrano un livello simile di
3 Formazioni organogene tipiche della Sicilia e di altre regioni dell’Italia meridionale
4 In caso di presenza di rare piante isolate di Cystoseira amentacea/mediterranea, si annota anche la comunità dominante (valore di sensibilità risultante: valore medio)
tolleranza alle condizioni ambientali e che solitamente crescono insieme in una determinata zona. Tali associazioni possono essere individuate in modo abbastanza rapido, anche a distanza (direttamente da un’imbarcazione, ad esempio), grazie alla presenza di una o più specie caratteristiche, dominanti per numero o dimensioni.
Il piano di campionamento può essere “continuo” o “a settori” e ad ogni unità minima di campionamento (50 m) viene assegnato un livello di Sensibilità (SL), in base alla presenza di associazioni vegetali a particolare valenza ecologica, alla rarefazione della vegetazione a Cystoseira spp. (Tabella 3), perché le specie appartenenti al genere Cystoseira sono molto sensibili alle variazioni (unica eccezione Cystoseira compressa considerata più tollerante) e la loro presenza è associata ad una elevata qualità ecologica (SL massimi).
I rilievi vengono svolti una sola volta nel triennio di monitoraggio, a una distanza di circa 34 metri dalla riva, ma in certi casi può essere necessario avvicinarsi a nuoto alla riva o effettuare dei piccoli prelievi, per un’analisi più dettagliata.
La media pesata dei valori di sensibilità della vegetazione (SL), in funzione della lunghezza della costa, corrisponde a un Valore di qualità ecologica (VQE) che viene confrontato con quello di riferimento per la regione mediterranea, ottenendo il RQE, che, a sua volta determina lo stato ecologico di questo EQB (Tabella 4).
Tabella 4: limiti di classe per l’EQB macroifite nei corpi idrici costieri e relativo Stato Ecologico
RQE (CARLIT)
Stato ecologico
Il fitoplancton rappresenta la parte vegetale del plancton, cioè di quell’insieme di organismi non autonomi nel movimento che fluttuano nelle acque e sono trasportati dalle correnti. La componente vegetale, composta da alghe unicellulari e batteri fotosintetici, è in grado di produrre sostanza organica a partire da sostanze inorganiche disciolte utilizzando come fonte di energia la radiazione solare (fotosintesi). Questi microrganismi sono i principali produttori di ossigeno negli ecosistemi marini e stanno alla base della rete trofica.

6: esempio di popolamento fitoplanctonico osservato al microscopio ottico
Il monitoraggio del fitoplancton comprende due tipi di valutazione: l’analisi quali-quantitativa delle specie che lo compongono e la stima della biomassa prodotta, calcolata in base alla quantità di clorofilla-a presente in superficie. La clorofilla a (chl-a) è, infatti, un pigmento determinante per la fotosintesi clorofilliana e la sua concentrazione nelle acque è direttamente correlata alla quantità di microalghe presenti e alla produzione primaria di sostanza organica di tutto l’ecosistema marino. Per ciascun corpo idrico vengono quindi analizzati:
• la composizione in specie del fitoplancton o in gruppi tassonomici superiori;
• la densità di ciascuna specie o gruppo (numero di cellule per litro);
• la biomassa fitoplanctonica misurata come concentrazione di clorofilla a (mg/m3).
Parte delle analisi viene svolta direttamente dall’imbarcazione, tramite un’apposita sonda multiparametrica (batisonda CTD) in grado di registrare, alle diverse profondità, sia il contenuto in clorofilla a sia i valori di temperatura, salinità, torbidità, pH e ossigeno disciolto. In superficie, vengono raccolti anche campioni d’acqua per le successive analisi di laboratorio: concentrazioni dei nutrienti (vedi par. 1.3.6), identificazione delle specie di fitoplancton presenti e stima della loro densità numerica. Sia le misure tramite batisonda CTD che i prelievi delle acque superficiali vengono eseguiti in tutte le stazioni di monitoraggio con frequenza bimestrale.
L’analisi dei campioni di fitoplancton viene effettuata utilizzando il metodo di Utermöhl, con volumi di sedimentazione in genere di 25ml (raramente e solo per le stazioni di Nettuno e Fiume Morto sono usate camere da 10ml) ed i conteggi delle cellule sono state condotti sulla base delle norme UNI EN 15204 del 2006 e UNI EN 15972 del 2012. Il popolamento
fitoplanctonico, sulla base di una prima classificazione tassonomica 5, viene suddiviso in 3 principali categorie, calcolando anche la relativa abbondanza (cell/L):
• diatomee (phylum Bacillariophyta);
• dinoflagellati (phylum Myzozoa, superclasse Dinoflagellata);
• altro fitoplancton: fitoflagellati e non, appartenente a vari phyla (Cyanobacteria, Chlorophyta/Charophyta, Cryptophyta, Ochrophyta, Haptophyta, Euglenophyta e Cercozoa) o di inquadramento tassonomico indeterminato, principalmente della classe dimensionale del nano-fitoplancton (2-20μm), che spesso può rappresentare una frazione elevata della popolazione microalgale totale.
Sebbene ciascun indicatore (composizione, abbondanza o densità e biomassa) sia in grado di fornire informazioni sullo stato ecologico delle acque marine, la classificazione dei corpi idrici viene effettuata soltanto in base ai valori di clorofilla a (paragrafo C.2.2.1 del D.M. 260/2010).
Sulla base delle concentrazioni di clorofilla a (chl-a) rilevate in 1 anno di monitoraggio, dopo aver normalizzato i singoli dati tramite Log-trasformazione, viene calcolato il 90°percentile. Se in un corpo idrico vi è più di una stazione di monitoraggio, lo stato di qualità sarà dato dalla media dei dati delle stazioni che lo compongono. Alla fine del monitoraggio operativo triennale, il valore da attribuire al corpo idrico è dato dalla media dei 3 valori annuali.
Tali valori (annuali e media triennale) vengono confrontati con quelli riportati dalla tabella 4.3.1/a del D.M. 260/2010 per la specifica tipologia di corpo idrico costiero (in Toscana sono tutti compresi nel “macrotipo 3”) che definiscono le 3 classi del Rapporto di Qualità Ecologica (RQE) e, quindi, dello Stato Ecologico basato su questo EQB (Tabella 5).
Tabella 5: limiti di classe per l’EQB Fitoplancton nei corpi idrici costieri di macrotipo 3 (valore di riferimento 0,9 mg/m3 di chl- a) e relativo Stato Ecologico
Biomassa fitoplanctonica (mg/m3 di chl a)
Stato ecologico
≤ 1,1 ≥ 0,8 Elevato
1,1 - 1,8 0,8 - 0,5 Buono > 1,8 <0,5
Sufficiente
5 Per la tassonomia del fitoplancton si fa riferimento a quanto riportato nel sito www.algaebase.ORG
1.3.5
Per quanto non previsto tra gli EQB utilizzabili per la valutazione dello stato ecologico (D.M. 260/2010 e ss.mm.ii.), il coralligeno, insieme alle praterie di P. oceanica, è uno degli habitat più ricchi di specie e, quindi, di biodiversità del mar Mediterraneo, tanto da essere inserito nel monitoraggio della strategia marina 6 (D.Lgs 190/2010) ed ARPAT da molti anni ha sviluppato specifiche competenze ed esperienze su questo popolamento.
Il coralligeno è una struttura permanente formata dalla stratificazione di alghe incrostanti (in gran parte alghe rosse) che crescono accumulando carbonato di calcio e aragonite sulla parete cellulare (biocostruzione) e, quando muoiono, le generazioni successive crescono sul loro scheletro calcificato, formando molti strati sovrapposti e cementati tra loro che, in casi eccezionali e in tempi molto lunghi, possono raggiungere il metro di spessore. Attraverso l’azione demolitrice di fattori ambientali ed organismi (biodemolitori) si creano sistemi eterogenei di cavità e fessure che rendono queste strutture ideali per lo sviluppo di un gran numero di altri organismi sia animali che vegetali, rendendo così questo ecosistema eterogeneo e ricco di biodiversità. Inoltre, molte specie di pesci, molluschi e crostacei vengono attratte dalla disponibilità di anfratti riparati e siti per la deposizione delle uova, oltre che dalla ricchezza di cibo ed il coralligeno svolge una funzione importante come area nursery e zona di crescita per forme giovanili.
Sebbene possano crescere anche sui fondali detritici (coralligeno di piattaforma), le formazioni coralligene sono tipiche dei fondali rocciosi (coralligeno litorale), ma entrambi i due tipi occupano una fascia di profondità compresa tra -25 e -150 m, in base alla trasparenza delle acque ed alla morfologia del fondale. Le condizioni ottimali sono temperatura bassa e costante, luminosità ridotta e idrodinamismo moderato, che impedisca un’eccessiva sedimentazione.


Figura 7: esempi di popolamenti a coralligeno: strato sottobasale e basale (a sinistra) e superiore (a destra)
In una formazione coralligena ben strutturata si distinguono almeno 4 strati:
• sottobasale: piccole cavità interne alla roccia che contengono organismi biodemolitori in grado di dissolvere chimicamente il carbonato di calcio (spugne e bivalvi perforanti);
• basale: cavità e fessure fra gli scheletri calcarei delle alghe morte, dove vivono molte specie di biodemolitori meccanici (piccoli molluschi, anellidi, spugne, sipunculidi);
6 Habitat Coralligeno – Modulo 7
• intermedio: alghe calcificate viventi e altri organismi biocostruttori (sclerattinie, briozoi, serpulidi, foraminiferi, ecc.), è quello più ricco di specie;
• superiore: specie biocostruttrici a portamento eretto (gorgonie, madrepore e corallo rosso) e da alghe e idrozoi che crescono sulle loro superfici calcaree.
Il coralligeno ha un ruolo determinante nel ciclo del carbonio ed è un buon bioindicatore, perché particolarmente sensibile alle alterazioni ambientali, come l’innalzamento delle temperature e l’acidificazione degli oceani (cambiamenti climatici) o l’eutrofizzazione e l’eccessivo tasso di sedimentazione, che alterano la disponibilità di luce per la fotosintesi delle alghe di fondo, oltre agli impatti della pesca a strascico e a reti fisse.
Sulla base di rilievi bati-morfologici dei fondali (utilizzando strumentazione subacquea quale Multibeam, Side Scan Sonar, ROV), sono state individuate le zone a coralligeno: in ogni area gli operatori subacquei hanno definito 3 siti di indagine (distanti non meno di 500 m l’uno dall’altro) e per ciascun sito 3 “plot” (A1, A2, A3), cioè 3 superfici di 4 m2 distanti l’uno dall’altro qualche decina di metri dove vengono acquisiti 10 campioni fotografici (repliche) 7 di 0,2 m2 ciascuno (0,5 m × 0,4 m circa) per un totale di 30 foto per sito. Per ogni immagine così ottenuta deve essere successivamente valutata la copertura (%) dei principali taxa e/o dei morfotipi (gruppi morfologici) animali e vegetali (macroalghe) e dell’eventuale sedimento, mucillagine o cavità presenti.
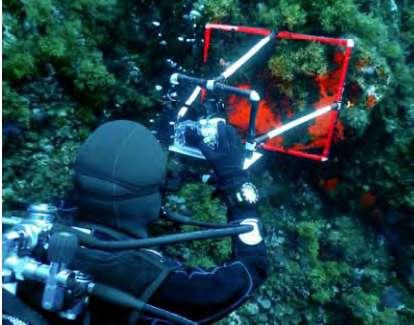

Figura 8: esempio di campionamento fotografico (plot) dei popolamenti a coralligeno di parete (a sinistra) e di foto in fase di elaborazione (a destra)
Per valutare la qualità ecologica dei popolamenti a coralligeno in Toscana si utilizza l’indice ESCA 8 (Ecological Status of Coralligenous Assemblages) che si basa su 3 descrittori ecologici:
• sensibilità al disturbo (Sensitivity Level, SL): ad ogni gruppo o taxon è stato associato un valore di SL da 1 a 10 che deve essere rapportato alla copertura media di quel taxon/gruppo tra tutti i campioni fotografici di uno stesso sito (30) e sommato a quello di tutti gli altri taxa/gruppi presenti;
7 tramite fotocamera digitale con una risoluzione minima di 15 megapixel
8 Gennaro P., Piazzi L., Cecchi E., Montefalcone M., Morri C., Bianchi C.N. (Eds.), 2020. Monitoraggio e valutazione dello stato ecologico dell’habitat a coralligeno. Il coralligeno di parete. ISPRA, Manuali e Linee Guida n.191/2020
• diversità dei popolamenti (diversità α), cioè la media dei taxa/gruppi presenti tra tutti i campioni fotografico del sito;
• eterogeneità fra popolamenti (diversità β): attraverso una tecnica di analisi multivariata (Permutational Dispersion Analysis) si valuta la variabilità della composizione e abbondanza in specie tra i 30 campioni fotografici.
Il valore ecologico così ottenuto (Ecological Quality Values) in un sito per ciascun descrittore (EQVSL, EQVα, EQVβ) viene confrontato con quelli di riferimento per ottenere 3 EQR (Ecological Quality Ratio): la media tra i 3 EQR (EQRSL + EQRα + EQRβ), rappresenta l'EQR finale di ciascun sito, suddiviso in 5 classi di qualità ecologica (Tabella 6).
Tabella 6: classificazione ecologica del coralligeno sulla base dell'indice ESCA
0.81-1.0 Elevato
0.61-0.80
0.41-0.60
0.21-0.40
0-0.20
Buono
Sufficiente
Scarso
Cattivo
• Sensitivity Level (SL) =540
• diversità alpha (α) = 15
• diversità beta (β) = 0,2
1.3.6 Elementi chimico fisici a sostegno (Fase I)
Una volta analizzati gli elementi biologici e calcolati i loro indici, si procede ad assegnare una prima classificazione che dovrà essere confermata o modificata dagli elementi di qualità fisico-chimica (FASE I) e, successivamente, dagli inquinanti chimici non prioritari (FASE II). Gli elementi di qualità fisico-chimica delle acque marino costiere (temperatura, salinità, ossigeno disciolto, nutrienti, ecc.) concorrono alla definizione dello stato ecologico stesso, mentre gli elementi idromorfologici (regime correntometrico, esposizione moto ondoso, profondità e composizione del substrato) sono utilizzati solo per migliorare l’interpretazione dei risultati.
La temperatura e la salinità contribuiscono alla definizione della densità dell’acqua di mare e, quindi, della stabilità della colonna d’acqua, sulla quale è basata la tipizzazione dei corpi idrici costieri che condiziona la tipo-specificità delle metriche e degli indici utilizzati per la classificazione degli EQB.
I dati relativi a temperatura, salinità, ossigeno disciolto, pH e clorofilla a, come detto (par. 1.3.3) vengono rilevati tramite sonda multiparametrica: l'acquisizione dei dati, effettuata con un passo di un metro, permette di evidenziare stratificazioni termiche, saline e stadi di anossia o ipossia che possono verificarsi sul fondo.
9 I valori di riferimento per l’indice ESCA attualmente utilizzati in Toscana sono stati calcolati sui popolamenti a coralligeno dell’Isola del Giglio nell’inverno 2011
Inoltre, in ogni stazione, viene misurata la trasparenza tramite “disco Secchi” per valutare la presenza di particellato che potrebbe limitare la penetrazione della luce solare e, di conseguenza, influire sulla biomassa fitoplanctonica.
Infine, ad una quota superficiale (0,5m) vengono prelevati dei campioni di acqua per l’analisi dei nutrienti, cioè delle principali sostanze azotate, fosforate e silicati, che servono per lo sviluppo della biomassa fitoplanctonica:
• azoto totale (N-tot) e le sue forme inorganiche disciolte dell’azoto nitroso o nitriti (NNO2), nitrico o nitrati (N-NO3) e ammoniacale (N-NH3), la cui somma (DIN = Dissolved Inorganic Nitrogen), viene utilizzata nel calcolo dell’indice trofico TRIX;
• fosforo totale (P-tot), utilizzato nel calcolo dell’indice trofico TRIX e ortofosfato (PPO4), componente direttamente assimilabile da parte del fitoplancton.
Al fine di misurare il livello produzione primaria (fotosintetica) degli ambienti marino costieri e per segnalare eventuali criticità (eutrofia, distrofia) viene utilizzato l’indice trofico TRIX, che si basa su una combinazione di ossigeno disciolto (produzione fotosintetica), clorofilla a (biomassa fotosintetica) e nutrienti (sostanze necessarie per lo sviluppo del fitoplancton), la cui formula è riportata di seguito.
TRIX = (Log (Chl-a •│OD%│ • DIN • Ptot) - (-1,5))/1,2 dove
Chl-a = Clorofilla “a” in µg/L
DIN = azoto solubile in µg/L
P tot = fosforo totale in µg/L
OD% = percentuale di ossigeno disciolto rispetto alla saturazione (100%) ad una determinata pressione e temperatura dell’acqua
Il giudizio espresso per ciascun EQB deve essere coerente con il limite di classe di TRIX: in caso di stato ecologico “buono” il corrispondente valore di TRIX deve essere minore della soglia macrotipo-specifica, che, nel caso delle coste toscane, è uguale a 4,0. Considerando che il monitoraggio degli elementi chimico fisici è annuale, alla fine di un triennio verrà attribuito al corpo idrico il valore medio dei 3 TRIX ottenuti durante il ciclo di monitoraggio.
1.3.7 Inquinanti chimici non prioritari (Fase II)
In base alle conoscenze del territorio e alle pressioni ambientali, ARPAT, in accordo con la Regione Toscana, ha selezionato le sostanze non prioritarie da cercare nelle acque costiere toscane (Tabella 10), sulla base dell’elenco riportato nella tabella 1/B del D.Lgs. 172/2015. Questi analiti vengono controllati in tutti i corpi idrici toscani con frequenza bimestrale, al pari del fitoplancton e degli elementi chimico fisici a sostegno.
Al termine di ogni anno, viene calcolata la concentrazione media per ognuna di queste sostanze in ciascun corpo idrico con le seguenti approssimazioni:
• quando il valore analitico è inferiore al limite di quantificazione della metodica analitica (LOQ), viene usata la metà del LOQ (punto 13, par. A.2.8, D.M. 260/2010);
• quando il 90% dei risultati analitici di uno stesso anno è inferiore al LOQ, il risultato è riportato come “minore del limite di quantificazione” (punto 14).
La media annuale così elaborata viene confrontata con i corrispondenti SQA (Tabella 1/B D.Lgs. 172/2015) e, per la classificazione dello stato ecologico al termine di un triennio di
monitoraggio, si utilizza il valore più elevato delle 3 medie annuali. Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino più stazioni, si considera lo stato ecologico peggiore.
La valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici viene effettuata sulla base della tabella 4.5/a del D.M. 260/2010, come modificata dal D.Lgs. 172/2015:
• stato elevato = media annuale dei metalli minore dei valori di fondo e media annuale delle altre sostanze ≤ LOQ;
• stato buono = media annuale minore o uguale a SQA;
• stato sufficiente = media annuale superiore a SQA.
1.4
Dato che, come visto (par. 1.1) uno degli obiettivi principali della Direttiva Quadro 2000/60/CE è la progressiva riduzione dell’inquinamento delle acque, è stata predisposta a livello comunitario una prima lista di sostanze inquinanti particolarmente impattanti sulla qualità degli ecosistemi acquatici, a causa della loro diffusione, abbondanza e persistenza nell’ambiente e della possibilità di interferire con la salute umana.
Tali sostanze, a seconda dell’importanza e del livello di rischio associato, sono state indicate come “prioritarie” (P), “pericolose prioritarie” (PP) e “altre” (E) nelle tabelle del D.Lgs. 152/2006. Il primo elenco di 33 sostanze della direttiva 2008/105/UE è stato successivamente aggiornato dalla direttiva 2013/39/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. 172/2015, che ha aggiunto 12 nuovi inquinanti (prodotti fitosanitari, biocidi, sostanze industriali e sottoprodotti di combustione).
Per ciascuna di queste sostanze il D.Lgs. 172/2015 prevede “ai fini della classificazione delle acque superficiali” il rispetto di Standard di qualità ambientale (SQA), espressi come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA) e/o come media annuale (SQA-MA), “nella colonna d'acqua e nel biota”.
Un corpo idrico è classificato in buono stato chimico se soddisfa, per le sostanze dell'elenco di priorità, tutti gli standard di qualità ambientale fissati nella tabella 1/A (o 2/A se la classificazione viene fatta sulla matrice sedimento).
In tutti i corpi idrici costieri della Toscana vengono effettuati campionamenti bimestrali delle acque superficiali (annuali per biota e sedimenti) per sottoporli alle analisi chimiche delle sostanze della tabella 1/A del D.Lgs. 172/2015. Come per gli inquinanti non prioritari (par. 1.3.7), al termine di ogni anno, viene calcolata la concentrazione media per ognuna di queste sostanze in ciascun corpo idrico con le seguenti approssimazioni:
• quando il valore analitico è inferiore al limite di quantificazione della metodica analitica (LOQ), viene usata la metà del LOQ (punto 13, par. A.2.8, D.M. 260/2010);
• quando il 90% dei risultati di uno stesso anno è inferiore al LOQ, il risultato è riportato come “minore del limite di quantificazione” (punto 14, par. A.2.8, D.M. 260/2010).
La media annuale così elaborata viene confrontata con i corrispondenti SQA (Tabella 1/A D.Lgs. 172/2015) e, per la classificazione dello stato chimico al termine di un triennio di monitoraggio, si utilizza il valore più elevato delle 3 medie annuali. Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino più stazioni, si considera quella con lo stato chimico peggiore.
Un corpo idrico è classificato in buono stato chimico se soddisfa, per le sostanze dell'elenco di priorità, tutti gli standard di qualità ambientale fissati nella tabella 1/A (o 2/A se la classificazione viene fatta sulla matrice sedimento).
L’obiettivo era quello di raggiungere il buono stato chimico delle acque entro il 2021 per le prime 33 sostanze ed entro il 2027 per le 12 sostanze introdotte dal D.Lgs. 172/2015.
Per quanto riguarda i livelli di riferimento delle diverse sostanze chimiche, dato che dai primi anni di monitoraggio marino (2010-15) era stata rilevata una costante presenza di alcuni metalli in concentrazioni superiori agli SQA in gran parte delle acque costiere toscane, la Regione ha chiesto ad ARPAT di verificare se vi fossero fattori di arricchimento naturale ed eventualmente di definire quali fossero i valori di fondo in acqua e sedimenti 10
10 Punto 7 del paragrafo A.2.8 dell’Allegato 1 alla parte III del D.Lgs. 152/2006
I risultati dello “Studio per la definizione dei Valori di Fondo naturale nei sedimenti e nelle acque marino costiere” 11 sono stati recepiti con DGRT 1273/2016, prima, e DGRT 264/2018, in via definitiva, modificando gli SQA per cadmio e mercurio nelle acque (tabella 1/A) e nei sedimenti (Tabella 2/A) e per nichel e piombo (tabella 1/A) in molte delle stazioni di monitoraggio dei corpi idrici costieri della Toscana (Tabella 8).
Tabella 8: valori di fondo naturali nelle acque costiere della Toscana (da All. B alla DGRT 264/2018)
Nella Tabella 9 sono riportate le sostanze prioritarie che vengono ricercate da ARPAT nella matrice acqua, secondo quanto riportato nella tabella 1/A del D.Lgs. 172/2015.
Come accennato, il D.Lgs. 172/2015, viste le difficoltà tecniche di raggiungere i livelli minimi di concentrazioni stabilite per i metodi analitici (LOQ) 13 nel caso di molte sostanze e le caratteristiche di scarsa idrosolubilità, ha previsto la ricerca di alcune di queste sostanze anche all’interno di organismi marini (biota). In particolare, sono state indicate 2 principali tipologie di animali marini da sottoporre ad analisi chimiche: pesci e molluschi o gasteropodi.
11 https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/studio-per-la-determinazione-dei-valori-di-fondonaturale-nei-sedimenti-e-nelle-acque-marine-costiere/attachment_download/pubblicazione
12 Per l’ubicazione delle stazioni e del relativo corpo idrico costiero vedi par. 1.5
13 SNPA, Linea guida per la scelta dei metodi di analisi di sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2000/60/CE – Linee Guida SNPA 20/2019
La matrice biota viene monitorata con cadenza annuale e le analisi eseguite (Tabella 10) sono quelle indicate dalla tabella 1/A del D.Lgs. 172/2015, ad eccezione di alcuni contaminanti, quali esabromociclododecano (HBCDD), eptacloro e eptacloro epossido, per i quali attualmente non si dispone di risorse strumentali ottimali.
Tabella 9 : inquinanti chimici monitorati nella matrice acqua dei corpi idrici costieri della Toscana N. Sostanza 14 Num. CAS N. Sostanza Num. CAS
1 alacloro (P) 15972-60-8 18 esaclorocicloesano (PP) 608-73-1
2 antracene (PP) 120-12-7 19 isoproturon (P) 34123-59-6
3 atrazina (P) 1912-24-9 20 piombo e composti (P) 7439-92-1
4 benzene (P) 71-43-2 21 mercurio e composti (PP) 7439-97-6
5 difenileteri bromurati (PP) 32534-81-9 22 naftalene (P) 91-20-3 2
6 cadmio e composti (PP) 7440-13-9 23 nichel e composti (P) 7440-02-0
6 bis tetracloruro di carbonio (E) 56-23-5 24 nonilfenoli (4-nonilfenolo) (PP) 84852-15-3
8 clorfenvinfos (P) 470-90-6 25 ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'tetrametilbutil)- fenolo)) (P) 140-66-9
9 clorpirifos-clorpirifos etile (P) 2921-88-2 26 pentaclorobenzene (PP) 608-93-5
9 bis aldrin (E) 309-00-2 27 pentaclorofenolo (P) 87-86-5 dieldrin (E)
(E)
(E) 465-73-6
9 ter DDT totale (E)
(P)
12 di(2-etilesil)ftalato - DEHP (P)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
17 esaclorobutadiene (PP)
Per questo particolare tipo di monitoraggio (biota), le specie animali sono individuate sulla base delle “Linee guida” di ISPRA 15 e si deve applicare la normalizzazione di tutti i dati disponibili rispetto al livello trofico dell’organismo considerato ed in funzione del contenuto lipidico e di peso secco dei diversi taxa. In Toscana sono stati selezionati, per i molluschi
14 Le sostanze contraddistinte dalla lettera P e PP sono, rispettivamente, le sostanze prioritarie e quelle pericolose prioritarie individuate ai sensi delle direttive 2008/105/CE e 2013/39/UE, quelle contraddistinte dalla lettera E sono le sostanze incluse nell'elenco di priorità dalle "direttive figlie" della 76/464/CE.
15 ISPRA, Linee guida per il monitoraggio delle sostanze prioritarie (secondo D. lgs 172/2015). Manuali e Linee Guida, n. 143, 2016, scaricabile dal link https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/MLG_143_16.pdf
bivalvi (livello trofico 2), le telline (Donax trunculus) per i corpi idrici Costa del Serchio e Costa pisana ed i mitili (Mytilus galloprovincialis) per tutti gli altri, in considerazione della loro abbondanza, diffusione e/o facilità di reperimento (stabulazione).
Tabella 10 : inquinanti chimici monitorati nella matrice biota dei corpi idrici costieri della Toscana
N. Sostanza 16 Numero CAS Pesci Molluschi
5 difenileteri bromurati (PP)
9 ter DDT totale (E)
15 fluorantene (P)
16 esaclorobenzene (PP)
17 esaclorobutadiene (PP)
21 mercurio e composti (PP)
28 benzo(a)pirene (PP)
34 dicofol
32534-81-9 x
Non applicabile x
206-44-0 x x
118-74-1 x
87-68-3 0 x
7439-97-6
50-32-8 x
115-32-2 x
35 acido perfluorottansolfonico e i suoi sali (PFOS) 1763-23-1 x
37 diossine e composti diossina simili - x x
Per i pesci sono state individuate varie specie appartenenti a taxa e livelli trofici differenti, tra quelle che vivono e si nutrono nei pressi del fondale (specie demersali), più comuni e con abitudini più stanziali per poterle riferire ad un determinato corpo idrico (Tabella 11).
I pesci necessari per le analisi vengono acquistati da pescatori professionisti che operano nei corpi idrici prescelti, registrando le coordinate del luogo di pesca e sono congelati fino al trasferimento nei laboratori per le analisi, effettuate sul pesce intero.
Tabella 11: specie di pesci demersali selezionate per la valutazione dello stato chimico nelle acque costiere della Toscana e relativo livello trofico da letteratura
Famiglia
Mugilidae Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) muggine 3
Chelon auratus (Risso, 1810) muggine 3
Chelon ramada (Risso, 1827) muggine 2
Chelon labrosus (Risso, 1827) muggine 3
Chelon saliens (Risso, 1810) muggine 3
Serranidae Serranus scriba (Linnaeus, 1758) sciarrano 4
Labridae Labrus viridis Linneus, 1758) Tordo 4
Symphodus tinca (Linnaeus, 1758). Tordo pavone 3
Per le sostanze che si accumulano soprattutto nella porzione lipidica degli organismi (difenileteri bromurati, fluorantene, esaclorobenzene, benzo[a]pirene, ecc.) le concentrazioni vengono normalizzate rispetto ad un contenuto lipidico del 5% per i pesci e del 1% per i molluschi.
Per le sostanze che si accumulano attraverso altri meccanismi, come il mercurio e l’acido perfluorottansolfonico (PFOS), la normalizzazione è basata sul peso secco, che per il pesce è pari al 26%, mentre per i molluschi è l’8,3%. Per le altre sostanze (DDT e diossine e 16 Vedi nota a pag.
composti diossina-simili), non è necessaria alcuna normalizzazione, dato che i valori vanno espressi in tenori equivalenti di tossicità (TEQ) su peso umido.
Tabella 12: SQA corretti per il livello trofico del biota (da ISPRA 17 modificato)
e composti diossina-simili
ed eptacloro epossido
Legenda: N.A. = non applicabile; N.D. = dati non disponibil; * = TMF calcolato su base lipidica; **= TMF calcolato su peso secco; *** = TMF calcolato su peso fresco
La concentrazione misurata nel biota deve essere normalizzata per la frazione lipidica (per le sostanze organoclorurate e IPA) o per la frazione di peso secco sul totale (per Hg, PFOS), per poi essere confrontata con gli SQA corretti e normalizzati secondo le Linee guida di ISPRA (Tabella 12) per la definizione dello stato chimico.
Il D.Lgs. 172/2015 stabilisce che la classificazione delle acque superficiali debba essere eseguita nella colonna d’acqua e nel biota, lasciando il monitoraggio dei sedimenti marini come una ulteriore alternativa a disposizione delle singole regioni.
In considerazione del fatto che questa matrice è quella di destinazione finale di una moltitudine di contaminanti (soprattutto le sostanze persistenti e insolubili) e che da più tempo è stata oggetto di prelievi ed analisi nelle diverse fasi dei monitoraggi marini a partire dalla fine degli anni ‘90, la Regione Toscana ha giustamente scelto di mantenere anche il monitoraggio dei sedimenti con l'obiettivo di avere una continuità di informazioni per una migliore interpretazione dei dati ambientali.
17 Vedi nota 15
18 TMF = Fattore di Magnificazione Trofica stabilito dalla Linea Guida di ISPRA
19 Attualmente i laboratori di ARPAT non riescono a raggiungere il livello di quantificazione necessaria per lo SQA nel biota dei PBDE
Tabella 13 : inquinanti chimici monitorati nella matrice sedimenti dei corpi idrici costieri della Toscana
Sostanza
arsenico
cadmio
cromo totale
Numero CAS
7440-38-2
7440-43-9
7440-47-3
cromo VI -
mercurio
piombo
benzo(a)pirene
benzo(b)fluorantene
benzo(k)fluorantene
benzo(g,h,i)perilene
fluorantene
naftalene
7439-97-6
7439-92-1
50-32-8
205-99-2
207-08-09
191-24-2
193-39-5
206-44-0
91-20-3
aldrin 309-00-2
α - esaclorocicloesano
319-84-6
β - esaclorocicloesano 319-85-7
Σ T.E. PCDD, PCDF (diossine e furani) e PCB diossina simili -
Di conseguenza, ARPAT esegue campionamenti di sedimenti marini tramite benna Van Veen con frequenza annuale in tutti i corpi idrici della Toscana per la ricerca di tutti i parametri previsti dalle tabelle 2/A, 3/A e 3/B del D.Lgs. 172/2015 (Tabella 13).
Si ricorda che, per valutare la conformità delle concentrazioni rilevate nei sedimenti rispetto agli SQA della Tabella 2/A, è consentito uno scostamento del 20% 20 .
20 Vedi nota 2 alla Tabella 2/A del D.Lgs. 172/2015
Il D.M. 131/2008 definisce le metodologie per effettuare la tipizzazione delle acque superficiali, l'individuazione dei corpi idrici superficiali e l’analisi delle pressioni e degli impatti.
Per la caratterizzazione delle acque costiere 21 si devono valutare, dapprima, i valori medi annuali di stabilità verticale (N) della colonna d’acqua (profili di densità), sulla base dei quali si distinguono 3 tipologie:
alta stabilità
media stabilità bassa stabilità N ≥ 0,3 0,15 <N > 0,3 N ≤ 0,15
Tutta la fascia marino costiera continentale e insulare della Toscana ricade, dal punto di vista idrologico, nella tipologia Bassa Stabilità (macrotipo 3), ossia tutta la zona è caratterizzata da siti costieri non influenzati da apporti d’acqua dolce continentale.
Integrando la classe di stabilità con le classi di tipologia costiera, a loro volta basate su descrittori geomorfologici, ai corpi idrici toscani sono state attribuite le seguenti classi: A3 (rilievi montuosi - bassa stabilità); E3 (Pianura alluvionale- bassa stabilità); F3 (Pianura di dune - bassa stabilità).
In generale in Toscana si distinguono:
• coste alte e rocciose (morfotipo a falesia) molto diffuse nella zona a Sud di Livorno (da Calafuria a Quercianella), nei promontori di Piombino, di Punta Ala, dell’Argentario, (da Cala di Forno nel Parco dell’Uccellina a Talamone) e nelle isole dell’Arcipelago Toscano (Capraia, Elba, Giglio, Gorgona e Montecristo);
• coste basse a litorale dritto, brevi tratti a litorale stretto o di delta (foci dell’Arno e dell’Ombrone);
• cordoni di duna talvolta soggetti a fenomeni erosivi.
La Regione Toscana ha approvato (DGRT 100/2010) una prima rete di monitoraggio dei corpi idrici toscani ai sensi della Direttiva Europea, aggiornandola, relativamente ai corpi idrici marino costieri, una prima volta con la DGRT 550/2014 e successivamente con la DGRT 608/2015; quest’ultima delibera prevede il monitoraggio di 16 corpi idrici (Figura 9), 1 dei quali (Arcipelago Toscano) suddiviso tra Isola d’Elba e Isole minori.
In ciascuno dei corpi idrici sono state identificate delle stazioni di monitoraggio, cioè delle ristrette porzioni (punti, aree, ecc.) definite da coordinate geografiche nelle quali vengono effettuate le attività (misure, prelievi, rilievi, ecc.) previste per il monitoraggio di una o più matrici (acqua, popolamenti bentonici, sedimenti, biota), sulla base delle caratteristiche indagate e della presenza dei diversi indicatori ecologici (EQB).
In genere, per ogni matrice viene monitorata solo 1 stazione per corpo idrico, ma nel caso dell’Arcipelago, vista la particolare conformazione delle coste insulari e le diverse caratteristiche idromorfologiche, sono state individuate 2 stazioni per l’Isola d’Elba (Elba Nord e Elba Sud) e 3 per le Isole minori (Capraia, Giglio e Montecristo).
21 Per acque costiere si intendono quelle comprese approssimativamente all'interno di una linea immaginaria distante un miglio nautico (1852m) dalla linea di costa ufficiale (lettera c, comma 1, art. 74, D.Lgs. 152/2006)

9: corpi idrici costieri della Toscana e relative stazioni di monitoraggio delle acque
Le stazioni di monitoraggio nei 16 corpi idrici costieri della Toscana sono in totale 19 (Tabella 14), di cui 5 nell’Arcipelago Toscano, ma, in realtà, considerando le singole matrici il numero aumenta per i subsiti localizzati sul fondale (sedimenti e popolamenti), gli areali dove vengono catturati i pesci, le scogliere per le macroalghe, ecc., secondo lo schema seguente:
• 19 per la matrice acqua e fitoplancton;
• 18 per macrozoobenthos;
• 12 per le praterie di posidonia;
• 10 per macroalghe;
• 16 per i pesci (biota), di cui 8 anche per molluschi bivalvi;
• 19 per i sedimenti.
Tabella 14: corpi idrici costieri della Toscana e relative stazioni di monitoraggio per le diverse matrici
Corpo Idrico
Denominazione Codice WISE 22
Costa della Versilia IT09R000TN001AC_1 Marina Carrara IT09S1662
Costa del Serchio IT09R019SE002AC_1 Nettuno IT09S0966
Costa pisana IT09N002AR003AC Fiume Morto IT09S0961
Costa livornese IT09R000TC004AC_1 Antignano IT09S0955
Costa di Rosignano IT09R000TC005AC_1 Rosignano Lillatro IT09S0968
Costa del Cecina IT09R000TC006AC Marina Castagneto IT09S0958
Costa di Piombino IT09R000TC007AC_1 Salivoli IT09S1663
Costa di Follonica IT09R000TC008AC Carbonifera
Costa di Punta Ala IT09R000OM009AC_1 Foce Bruna
Costa dell’Ombrone IT09R000OM010AC Foce Ombrone
Costa dell’Uccellina IT09R000OM011AC Cala Forno IT09S1660
Costa dell’Albegna IT09R000OM012AC Foce Albegna IT09S1659
Costa dell’Argentario IT09R000OM013AC_1 Porto S.Stefano IT09S1664
Costa di Burano IT09R000OM14AC Ansedonia
ArcipelagoIsola d'Elba IT09R000TC015AC_1 Elba Nord
Elba Sud
ArcipelagoIsole Minori IT09R000TC016AC_1
Legenda: W = acqua; S = sedimenti; Po = Posidonia oceanica; Z = Macrozoobenthos; C = Macroalghe; M = Mitili; P = Pesci
Dal punto di vista delle frequenze di campionamento ed analisi nel triennio di monitoraggio, anche queste si differenziano sulla base delle diverse matrici:
• bimestrale per acqua e fitoplancton;
• annuale per biota e sedimenti;
• almeno una volta nel triennio per tutte le altre.
Tutte le indagini vengono effettuate tramite l’utilizzo di un battello oceanografico, indispensabile per il prelievo sia dei campioni di acqua sia di sedimento, sia dei parametri biologici, costituendo la base di appoggio per gli operatori subacquei.
22 WISE Water Framework Directive database è la banca dati della direttiva europea sulle acque, all’interno del sistema informativo europeo
In base all’esperienza maturata in questi anni di monitoraggio ed a seguito di un’attenta analisi dei dati biologici e chimici raccolti, ARPAT ha ritenuto di sottoporre alla Regione Toscana, nel febbraio 2025, una proposta di revisione e modifica del piano di monitoraggio delle acque marino costiere della Toscana, approvato con la DGRT 608/2015. Tale proposta, ancora all’esame dei competenti settori della Regione Toscana, intende coniugare gli obiettivi della tutela ambientale con un’ottimizzazione dell’uso di risorse umane, strumentali ed economiche, orientando le scelte verso le eventuali criticità emerse negli ultimi 20 anni e migliorando il livello di approfondimento tecnico-scientifico.
I maggiori fattori di pressione che possono influenzare la qualità (stato ecologico e chimico) delle acque marino costiere sono riportati in Tabella 3.5 dell’allegato 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., all’interno della quale si possono distinguere 4 tipologie:
a) l’immissione di sostanze arricchenti (nutrienti e sostanze organiche) e/o inquinanti;
b) il prelievo di acque ai fini industriali o di altro tipo (dissalatori, ecc.);
c) l’alterazione della linea di costa (porti, scogliere, moli, dragaggi, ripascimenti, ecc.);
d) lo sfruttamento delle risorse marine (pesca, maricoltura, traffico marittimo, ecc.).
Per quanto riguarda gli ultimi due aspetti, si tratta, almeno in Toscana, di fattori presenti in modo diffuso nello spazio e nel tempo (alterazione antropica della costa) o i cui effetti sono difficilmente riferibili ad un determinato tratto di mare (pesca e traffico) soprattutto lungo la fascia costiera.
L’immissione di sostanze inquinanti e arricchenti ed il prelievo di acque si possono, invece, ragionevolmente legare agli apporti fluviali (o provenienti da altre acque interne) ed agli insediamenti portuali (dove sono maggiori anche il traffico marittimo e le attività di pesca) e/o industriali. Lungo le coste toscane (da Nord verso Sud) queste due tipologie di pressioni si incontrano spesso e si possono riassumere in:
• apporti fluviali: Magra (sfocia in Liguria ma influenza anche la parte più settentrionale della costa toscana), Serchio, Arno, Cecina, Bruna, Ombrone, Albegna;
• apporti di laghi e lagune costiere: canale Burlamacca (Lago Massaciuccoli); canale Ansedonia (Laguna di Orbetello), lago costiero di Burano;
• insediamenti portuali e industriali: Marina di Carrara, Viareggio, Livorno, Piombino, Portoferraio;
• altri insediamenti industriali: Rosignano Solvay. Come visto (par. 1.5), nella definizione del primo piano di monitoraggio delle acque marino costiere della Toscana (DGRT 100/2010), la tipizzazione (DM 131/2008) si è basata “soltanto sulla morfologia dell’area costiera sommersa e natura del substrato” (DGRT 416/2009), dato che tutta la costa toscana è risultata a bassa stabilità (N ≤ 0,15).
A questa prima suddivisione morfologica, nella quale i diversi tratti sono stati raggruppati per tipologie prevalenti per rendere tecnicamente ed organizzativamente sostenibile il piano, è stata sovrapposta l’analisi di pressioni e impatti sia nella prima stesura che nelle successive modifiche (DGRT 550/2014 e DGRT 608/2015), tanto da introdurre, ad esempio,
il corpo idrico Costa di Rosignano (DGRT 550/2014) caratterizzato da diverse e più significative pressioni rispetto alla restante parte di Costa del Cecina.
Tutte le revisioni effettuate, inoltre, hanno correttamente tenuto conto dei risultati acquisiti dai monitoraggi attuati, andando a valutare la significatività e reperibilità degli elementi di qualità biologica nelle diverse zone e le concentrazioni di sostanze chimiche nelle varie matrici (acqua e sedimenti fino all’entrata in vigore del D.Lgs 172/2015).
Il risultato di queste varie fasi ha portato, appunto, all’attuale piano di monitoraggio delle acque marino costiere (DGRT 608/2015) che, a distanza di quasi 10 anni, può essere utilmente aggiornato e migliorato, utilizzando gli stessi criteri ma con nuove conoscenze.
Innanzitutto, appare subito evidente (Tabella 15) come i principali elementi di pressione siano tutti o quasi ben riscontrabili nei corpi idrici costieri definiti dalla DGRT 608/2015, ma l’ubicazione delle stazioni di monitoraggio nella matrice acqua, sulla base della quale sono valutati sia lo stato ecologico (per EQB fitoplancton ed elementi a sostegno) che lo stato chimico (per il 90% delle sostanze), non è sempre coerente con gli obiettivi.
La scelta di monitorare le acque costiere antistanti la foce del Fiume Morto (un piccolo canale di bonifica che drena le acque della piana pisana della riva destra del bacino dell’Arno) non sembra ottimale per la valutazione dei possibili impatti degli apporti dell’Arno, cioè il principale e di gran lunga maggiore dei fiumi toscani.
La modifica introdotta nel 2015 “di controllare il corpo idrico Costa Livornese, finora controllato in due punti, Livorno porto e Antignano, con la sola postazione di Antignano”, non sembra essere coerente con le motivazioni sopra riportate. Infatti, se, da un lato, le acque portuali “non rientrano nella definizione di corpo idrico” (punto B.3.4.1 dell’Allegato 3 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006), le stesse acque, dall’altro lato, “sono da considerarsi sorgenti di inquinamento” (id.) ed è, quindi, logico e necessario valutarne l’impatto nelle acque costiere più vicine, ma la zona di Antignano, che si trova circa 5 km a Sud del Porto di Livorno, non sembra rispettare un criterio precauzionale rispetto, ad esempio, ad un’area antistante il porto e/o la città di Livorno, dove l’eventuale contaminazione potrebbe essere più facilmente misurabile. Discorso diverso, invece, per i sedimenti marini, dato che è stato ampiamente dimostrato 23 che nei fondali (a ca. -50m) di Antignano, per un gioco di correnti locali e di dinamica del trasporto solido, si siano accumulati, nel corso del tempo, molti dei principali contaminanti chimici provenienti dagli stabilimenti industriali di Rosignano Solvay, a cominciare dal mercurio.
Analogo ragionamento deve essere fatto per il porto di Piombino (terzo porto toscano di livello nazionale, dopo Livorno e Marina di Carrara) e zona industriale ad esso collegata, i cui impatti non sono mai stati veramente valutati, dato che il monitoraggio del corpo idrico Costa di Piombino è stato svolto nella zona a Nord-Ovest del porto, tra Salivoli e Baratti, cioè al di fuori del Golfo di Follonica, dove insiste il porto. È opportuno, invece, posizionare i punti di prelievo e indagine delle diverse matrici nella zona antistante il porto e modificare leggermente i confini del corpo idrico, separando così, all’interno del Golfo di Follonica, le acque marine di competenza di Costa di Piombino (fino a Perelli) da quelle di Costa di Follonica, che verrebbero estese fino al promontorio di Punta Ala.
23 ARPAT, 2008 “Monitoraggio degli effetti degli scarichi Solvay sull'ecosistema marino circostante”; ARPAT, 2014 “Qualità delle acque marino costiere prospicienti lo scarico Solvay di Rosignano (LI)”; entrambe pubblicate su http://www.arpat.toscana.it/
Tabella 15: attuale rete di monitoraggio delle acque marino costiere della Toscana e principali elementi di pressione
Corpo idrico costiero (DGRT 608/2015)
Costa della Versilia
Costa del Serchio
Principali elementi di pressione Stazione di monitoraggio (acqua)
Fiume Magra
Porto di Marina di Carrara
Canale Burlamacca (Massaciuccoli)
Porto di Viareggio
Fiume Serchio
Marina di Carrara
Nettuno (antistante Porto di Viareggio)
Costa Pisana Fiume Arno Fiume Morto
Costa livornese Porto di Livorno Antignano
Costa di Rosignano Insediamento industriale di Rosignano
Costa del Cecina
Solvay Rosignano Lillatro
Fiume Cecina Marina Castagneto
Costa di Piombino Porto di Piombino Salivoli
Costa di Follonica Carbonifera
Costa del Bruna Fiume Bruna Foce Bruna
Costa dell’Ombrone Fiume Ombrone Foce Ombrone
Costa dell'Uccellina Cala di Forno
Costa dell’Albegna Fiume Albegna Foce Albegna
Costa dell’Argentario
Costa di Burano
Costa dell'ArcipelagoIsola d'Elba
Canale Ansedonia (Laguna di Orbetello)
Porto S.Stefano
Lago di Burano Ansedonia
Porto di Portoferraio
Elba Nord (a Nord di Portoferraio) Elba Sud (Porto Azzurro - Mola)
Costa dell'Arcipelago –Isole minori Giglio Capraia Montecristo
2.2 Le modifiche al piano attuale
Oltre a quanto visto sopra, per ottimizzare le attività di monitoraggio è stato proposto l’eliminazione del corpo idrico Costa dell’Uccellina con conseguente ampliamento di Costa dell’Ombrone. Si tratta, infatti, di una zona prospiciente il Parco della Maremma ed i Monti dell’Uccellina, con alternanza di spiagge sabbiose e scogliere, del tutto naturali e senza alcun tipo di pressione, con un ambiente marino del tutto analogo a quello più propriamente influenzato dalla foce dell’Ombrone.
Inoltre, in considerazione della circolazione (idrologia) e della morfobatimetria del Mar Tirreno toscano, laddove l’Isola d’Elba costituisce una sorta di spartiacque, appare più logica una suddivisione dell’Arcipelago Toscano tra una parte settentrionale ed una meridionale, invece che tra Elba e isole minori, per quanto queste ultime abbiano origini ed evoluzioni diverse. Per coniugare le esigenze di operatività e di rappresentatività del monitoraggio, si propone un raggruppamento (Arcipelago Toscano Nord) che, a partire dalle coste settentrionali dell’Isola d’Elba (da Pomonte a Porto Azzurro), comprenderebbe le isole di Capraia e Gorgona, separato da uno meridionale (Arcipelago Toscano Sud) con la parte
Sud dell’Elba e le isole di Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri. Questi due corpi idrici verrebbero monitorati principalmente (matrice acqua) nella stazione di Elba Nord il primo e del Giglio in quello Sud, ma per gli elementi di qualità biologica maggiormente caratterizzanti (posidonia e macroalghe) verranno mantenute o introdotte altre zone (Capraia, Elba Sud).
Infine, alcune stazioni di monitoraggio dovrebbero essere spostate per garantire la massima sovrapposizione dei diversi EQB (fitoplancton, posidonia, macrozoobenthos e macroalghe) con la valutazione dello stato chimico in acqua e sedimenti, così da consentire una miglior integrazione delle diverse caratterizzazioni.
In definitiva, sono state proposte queste modifiche relative ai corpi idrici marino costieri ed alle relative stazioni di monitoraggio della matrice acqua:
a) Costa della Versilia, diventa Costa apuo-versiliese;
b) la stazione di Costa del Serchio (Nettuno) diventa Porto di Viareggio e si sposta leggermente più al largo;
c) Costa pisana diventa Costa dell’Arno e la stazione di Fiume Morto viene sostituita con una davanti alla Foce dell’Arno;
d) la stazione di Costa livornese di Antignano (acqua) viene sostituita da una stazione nella zona davanti all’imboccatura Nord del porto di Livorno;
e) il limite Sud di Costa di Rosignano viene leggermente arretrato in corrispondenza del porto di Vada / Pontile Solvada;
f) il nuovo Costa di Piombino viene delimitato a Nord dal Faro della Rocchetta (Piazza Bovio), attribuendo la costa tra il porticciolo antico di Piombino e Baratti (dove non ci sono pressioni significative) al Costa del Cecina, ampliandolo verso Est per comprendere una parte del Golfo di Follonica fino al canale Perelli e la stazione di Salivoli viene sostituita con una localizzata tra il porto di Piombino e Torre del Sale;
g) Costa di Follonica si estende dal canale Perelli fino al porto di Punta Ala, sostituendo la stazione di Carbonifera con una da localizzare nel tratto di mare tra Cala Violina e Punta Ala non distante dalla prateria di Posidonia oceanica attualmente monitorata;
h) Costa del Bruna si estende dal porto di Punta Ala fino all’emissario di San Leopoldo;
i) Costa dell’Ombrone si estende dall’emissario di San Leopoldo fino al porto di Talamone assorbendo Costa dell’Uccellina;
j) Costa dell’Albegna si estende dal porto di Talamone fino al Canale di Nassa; k) la stazione di Costa dell’Argentario (Porto S. Stefano) viene spostata verso il promontorio nella zona dove viene attualmente monitorata la prateria di P. oceanica; l) i corpi idrici Arcipelago-Isola d'Elba e Arcipelago-Isole minori che attualmente comprendono, il primo, le coste dell’intera Isola d’Elba e, il secondo, quelle delle isole di Capraia, Giannutri, Giglio, Gorgona, Montecristo e Pianosa, vengono diversamente suddivisi in:
o Arcipelago Toscano Nord, comprendente le coste settentrionali dell’Isola d’Elba (da Pomonte a Porto Azzurro) e le Isole di Capraia e Gorgona, mantenendo per la matrice acqua la sola stazione di Elba Nord;
o Arcipelago Toscano Sud comprendente le coste meridionali dell’Isola d’Elba e le isole di Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri, con la stazione del Giglio.
Sulla base di tali proposte, la nuova definizione dei corpi idrici costieri della Toscana è quella rappresentata nella Tabella 16 In rosso i nominativi dei corpi idrici che sono stati eliminati e/o modificati.
Tabella 16: ipotesi di nuova rete di monitoraggio delle acque marino costiere della Toscana
Corpo idrico costiero (DGRT 608/2015) Nuovo corpo idrico costiero Da A
Stazione di monitoraggio (acqua)
Costa della Versilia Costa apuoversiliese Torrente Parmignola Fosso dell’Abate Marina di Carrara
Costa del Serchio Costa del Serchio Fosso dell’Abate Fiume Morto Porto di Viareggio
Costa Pisana Costa dell’Arno Fiume Morto Foce Scolmatore Arno Foce Arno
Costa livornese Costa livornese
Costa di Rosignano Costa di Rosignano
Foce Scolmatore Arno
Porto Cala dei Medici
Porto Cala dei Medici Porto di Livorno
Porto di Vada Rosignano Lillatro
Costa del Cecina Costa del Cecina Porto di Vada Faro della Rocchetta Marina Castagneto
Costa di Piombino Costa di Piombino Faro della Rocchetta Canale Perelli Porto di Piombino
Costa di Follonica Costa di Scarlino Canale Perelli Porto di Punta Ala Punta Ala
Costa del Bruna Costa del Bruna Punta Ala
Costa dell’Ombrone Costa dell’Ombrone
Costa dell'Uccellina
Emissario San Leopoldo Foce Bruna
Emissario San Leopoldo Porto di Talamone Foce Ombrone
Costa dell’Albegna Costa dell’Albegna Porto di Talamone
Costa dell’Argentario Costa dell’Argentario
Canale Nassa
Canale Nassa Foce Albegna
Cala Galera Argentario
Costa di Burano Costa di Burano Cala Galera Torrente Chiarone Ansedonia
Costa dell'ArcipelagoIsola d'Elba
Costa dell'Arcipelago –Isole minori
Arcipelago toscano Nord
Arcipelago toscano Sud
Costa dei Comuni di Marciana, Marciana Marina, Portoferraio (escluso Montecristo), Porto Azzurro, Rio, Capraia Isola e isola di Gorgona (Livorno)
Elba Nord
Costa dei Comuni di Campo nell’Elba (compresa isola di Pianosa), Capoliveri, Isola del Giglio e isola di Montecristo (Portoferraio) Giglio
Al di là di alcune incertezze sulla esatta localizzazione di alcune stazioni (ad es. quelle di Piombino porto o di Elba Sud), come detto, si è cercato di concentrare in una stessa area di mare all’interno di ciascun corpo idrico il monitoraggio di acqua, EQB e sedimenti, compatibilmente con le caratteristiche naturali e gli standard metodologici. In pratica le sole eccezioni riguardano le macroalghe che vanno indagate lungo un tratto di almeno 3 km di zona intertidale rocciosa (indice CARLIT), le praterie di P. oceanica di Capraia ed Elba Sud (in aggiunta, rispettivamente, a quelle di Elba Nord e Giglio) ed i sedimenti di Antignano di cui si è già detto.
Tabella 17: ipotesi di stazioni di monitoraggio delle diverse matrici
Nuovo corpo idrico costiero
Costa apuoversiliese
Stazione di monitoraggio
Acqua e MW 24 Posidonia Macroalghe
Marina di Carrara
Costa del Serchio Viareggio Porto
Macrozoo benthos Sedimenti
Marina di Carrara Marina di Carrara
Viareggio Porto Viareggio Porto
Costa dell’Arno Foce Arno Foce Arno Foce Arno
Costa livornese Livorno Porto 25 Livorno Porto Romito
Costa di Rosignano Rosignano Lillatro Rosignano Lillatro
Costa del Cecina Marina di Castagneto
Costa di Piombino Piombino Porto Piombino Porto
Livorno Porto
Rosignano Lillatro
Promontorio di Populonia
Livorno Porto Antignano
Rosignano Lillatro
Marina di Castagneto Marina di Castagneto
Piombino Porto Piombino Porto
Costa di Follonica Punta Ala Punta Ala Punta Ala Punta Ala
Costa del Bruna Foce Bruna Foce Bruna Foce Bruna
Costa dell’Ombrone Foce Ombrone Uccellina Foce Ombrone Foce Ombrone
Costa dell’Albegna Foce Albegna Foce Albegna Foce Albegna Foce Albegna
Costa dell’Argentario Argentario Argentario Argentario Argentario Argentario
Costa di Burano Ansedonia Ansedonia Ansedonia Ansedonia Ansedonia
Arcipelago toscano Nord Elba Nord Elba Nord Elba Nord Elba Nord Elba Nord Capraia Capraia
Arcipelago toscano Sud Giglio Giglio Giglio Elba Sud Giglio Elba Sud
Le vere novità, per la matrice acqua, sono solo 4 stazioni sulle 15 proposte (23%) che potrebbero ridursi ancora mantenendo quella di Antignano (4 su 16), con una diminuzione, rispetto al monitoraggio programmato nel 2024 di 4 stazioni su 19 (21%), eliminando quelle ridondanti nelle varie isole dell’Arcipelago Toscano e quella di Costa dell’Uccellina.
Per quanto riguarda il bioaccumulo (stato chimico) nei pesci (biota), dato che, per ovvi motivi, ci si limita a reperire gli organismi all’interno di ciascun corpo idrico senza poter definire delle precise aree di prelievo, con la sola precauzione di aver selezionato specie stanziali e tendenzialmente nectobentoniche, si conferma il monitoraggio in tutti i nuovi corpi idrici.
Per i molluschi bivalvi, organismi da utilizzare per alcuni specifici parametri dello stato chimico (benzo(a)pirene, fluorantene e diossine e composti diossina simili), fino ad oggi è stata fatta la scelta di coniugare questo monitoraggio con quello specifico per le acque
24 MW = Mussel Watch, cioè analisi del bioaccumulo nei mitili stabulati per la definizione dello stato chimico
25 L’attuale stazione di Antignano potrebbe essere mantenuta in aggiunta alla nuova di Livorno Porto
idonee alla vita dei molluschi (VTM) 26 . Però, le popolazioni naturali di molluschi bivalvi (previste per VTM) in Toscana hanno subito un forte depauperamento negli anni (per fattori ambientali e/o pressione di pesca) e utilizzare specie con habitat e fisiologia diversa rende complicata una valutazione omogenea del bioaccumulo (obiettivo dello stato chimico). In particolare, infatti, le telline che caratterizzano le zone della costa sabbiosa settentrionale (attuali Costa del Serchio e Costa pisana) sono organismi di piccola taglia (e difficile reperimento in quantità sufficienti alle analisi) che vivono infossati nel sedimento, mentre i mitili si nutrono filtrando grandi volumi di acqua stando aderenti ad un substrato (naturale o artificiale) in acque libere e correnti. Vista, quindi, l’assenza di una specie di bivalvi filtratori che popoli naturalmente tutti i corpi idrici costieri, la sola possibilità è rappresentata dal Mussel Watch, cioè dal posizionare (in gabbie sommerse) un quantitativo di mitili (5kg circa) acquistati da uno stesso allevamento e lasciati in mare per almeno 30gg prima di essere sottoposti ad analisi, avendo cura di averle effettuate anche su uno dei lotti (bianco) prima del posizionamento in mare. Con questa soluzione sarà possibile controllare il bioaccumulo nei mitili nelle stesse stazioni dove viene effettuato il monitoraggio dell’acqua per lo stato chimico, senza alcun problema di reperibilità degli organismi o di variazioni di taglia, età, ecc., tutti fattori che potevano alterare i risultati.
2.3 Il monitoraggio dello stato ecologico
La valutazione dello stato ecologico si basa sulla valutazione degli elementi di qualità biologica (EQB) che, per le acque marino costiere italiane, sono la biomassa fitoplanctonica, il macrozoobenthos (o macroinvertebrati bentonici), le macrofite (macroalghe) e le angiosperme (Posidonia oceanica).
Per la biomassa fitoplanctonica non vi è alcuna necessità di differenziare le stazioni di monitoraggio nei diversi corpi idrici, dato che sia le analisi del popolamento fitoplanctonico (identificazione delle specie e stima della loro densità) sia le misure delle concentrazioni di clorofilla a (chl-a) tramite sonda multiparametrica (batisonda CTD) vengono effettuate nelle stesse stazioni della matrice acqua ogni 2 mesi (6 volte l’anno).
Dato che i macroinvertebrati bentonici sono quelli complessivamente più sensibili alle diverse pressioni insistenti sulla fascia costiera (per il 95% dei fattori di pressione riportati dalla Tabella 3.5 dell’allegato 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii) e vista la possibilità di analizzare queste comunità nella gran parte dei fondali costieri della Toscana, si è ritenuto di mantenerne un monitoraggio in tutti i corpi idrici, ubicando le stazioni nel modo più coerente con gli obiettivi e le ipotesi su esposte (vedi Tabella 17). Inoltre, riallineandosi a quanto previsto dalla Tabella 3.7 dell’allegato 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il campionamento del macrozoobenthos avverrà in tutte le stazioni con frequenza semestrale (2 volte l’anno).
Per quanto riguarda le praterie di Posidonia oceanica, secondo EQB per sensibilità alle pressioni (76% dei fattori), la situazione è diversa, ferma restando la sua importanza anche a livello di servizi ecosistemici offerti e la necessità di proteggere questo habitat stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE. Si tratta, infatti, di un ecosistema non sempre presente per caratteristiche naturali e/o storiche (attività antropiche e modifiche della fascia costiera avvenute o iniziate da oltre 50 anni) lungo le coste della Toscana e particolarmente sensibile ad alcuni fattori in particolare (apporti fluviali, alterazioni della trasparenza delle acque, modifiche dell’idrologia, ecc.). Di conseguenza, abbiamo operato una rivalutazione delle
26 Sezione C dell’Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii
attuali zone di praterie indagate, concentrando l’attenzione alle pressioni che si ritengono predominanti nei diversi corpi idrici e/o all’estensione delle praterie rispetto al corpo idrico, individuando due zone nuove davanti ai porti principali (“Livorno porto” e “Piombino porto”) ed una per la nuova suddivisione dell’Arcipelago Toscano (“Elba Sud” verrà posizionata nel Golfo di Campo o di Lacona in sostituzione di quella attuale di Mola), eliminando quella di Foce Albegna, poco rappresentativa della reale situazione del corpo idrico. In ognuna delle praterie così individuate, verrà applicato il protocollo metodologico previsto dalla Strategia Marina (D.Lgs. 190/2010), con un monitoraggio triennale (1 volta ogni 3 anni) in 3 stazioni intermedie e 3 del limite inferiore (3 transetti) ubicate all’interno di 1 area di 3 km2
Infine, per il monitoraggio delle macroalghe presenti nella fascia intertidale delle scogliere rocciose (indice CARLIT), si ritiene di mantenere le attuali 8 stazioni la cui frequenza è la stessa della posidonia (1 volta ogni 3 anni).
Le misure dei parametri chimico fisici lungo la colonna d’acqua (salinità, temperatura, torbidità, pH, ossigeno disciolto e clorofilla a) mediante sonda multiparametrica (CTD) così come il prelievo di campioni superficiali per le analisi di nutrienti e di fitoplancton, vengono tutte confermate, come attualmente previsto, mentre per quanto riguarda le sostanze previste dal D.Lgs 172/2015 per la classificazione chimica (tabella 1/A) ed ecologica (tabella 1/B), è stata proposta una riduzione del monitoraggio di questi inquinanti nella matrice acqua.
Innanzitutto, occorre premettere che le sostanze chimiche da monitorare sono solo quelle che “sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti” 27, vengono “scaricate, immesse” o disperse nelle acque marino costiere (sostanze prioritarie) o “qualora tali scarichi, immissioni o perdite nel corpo idrico siano in quantità significativa da poter essere un rischio” per l’ambiente.
Dopo la prima analisi di pressioni ed impatti sulle acque costiere della Toscana, si decise che venissero ricercate tutte le sostanze previste dalle tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., con le sole eccezioni di quelle per le quali i laboratori di ARPAT non dispongono di metodi e/o strumenti di analisi adeguati. I risultati di tale monitoraggio, attuato compiutamente a partire dal 2010 ed integrato successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs 172/2015, sono stati utilizzati per un’analisi statistica dei dati (dal 2013 fino al 2023 compreso), al fine di verificare la effettiva presenza di tali sostanze in concentrazioni significative.
Tale verifica, su oltre 10 anni di prelievi ed analisi, dimostra come vi siano delle reali criticità solo in alcune determinate zone delle acque marino costiere e per un ristretto numero di sostanze.
È emerso, infatti, che le concentrazioni della maggior parte degli analiti ricercati nella matrice acqua risulta essere sotto il limite di quantificazione (LOQ) in tutte le campagne di monitoraggio effettuate negli ultimi 11 anni (2013-2023):
• delle 25 sostanze non prioritarie previste dalla Tabella 1/B per lo stato ecologico 23 (92%) sono risultate costantemente <LOQ, cioè praticamente tutte ad eccezione dei due metalli, arsenico (As) e cromo totale (Cr tot);
27 punto A.3.3.4. dell’Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
• delle 46 sostanze prioritarie (Tabella 1/A per lo stato chimico) analizzate oltre la metà (27) sono risultate <LOQ.
Tali risultati, del resto, sono perfettamente coerenti con alcune caratteristiche di questi corpi idrici rispetto a quelli delle acque interne e sotterranee, caratteristiche che rendono l’analisi delle pressioni ed impatti, anche se aggiornata, poco significativa, in quanto:
• il trasporto solido costiero (particellato e sedimenti) così come il regime idrologico (correnti locali costieri) non sono di facile definizione rispetto, ad esempio, allo scorrimento di un corso d’acqua (monte e valle non hanno significato in mare) e sono fortemente influenzati dalle variabili meteomarine (venti, onde, ecc.);
• il potere diluente delle acque marine è enormemente maggiore di qualsiasi corso d’acqua o lago;
• in Toscana vi sono ampie porzioni di costa (rocciosa e sabbiosa) non direttamente interessate da apporti fluviali, ma che risentono di eventuali contaminazioni diffuse (agricoltura, dilavamento, ecc.) e/o da pressioni esclusive dell’ambito marino (traffico marittimo, maricoltura, ecc.).
Di conseguenza, a meno che non venga identificata e quantificata una sicura fonte di immissione delle suddette sostanze chimiche in mare, come accaduto per alcuni tratti costieri della Toscana (Costa del Cecina, Costa dell’Uccellina, Costa dell’Argentario, Costa di Burano, Arcipelago Isola d’Elba e Isole minori), è molto probabile che le stesse non siano rilevabili o non lo siano in modo significativo rispetto alle attuali tecniche analitiche.
Eliminando, quindi, dal monitoraggio della matrice acqua tutte le sostanze che hanno sempre avuto una concentrazione inferiore al limite di quantificazione sarà assicurato “il miglior rapporto tra affidabilità della classificazione dello stato chimico e risorse umane e finanziare impiegate”, come previsto per i criteri di monitoraggio dei corpi idrici superficiali interni e sotterranei della Toscana (sezione B.3 dell’Allegato D alla DGRT 1589/2024), ottimizzando l’uso delle risorse regionali. Così facendo, inoltre, si alleggerirebbe moltissimo anche il carico di lavoro dei laboratori dell’Agenzia, che potrebbero migliorare le prestazioni su quelle rimanenti e mettere a punto nuovi metodi analitici per quelle che attualmente non sono ricercate.
Di fatto, quindi, il campo di indagine si restringerà ai metalli (As, Cd, Cr tot, Hg, Ni, Pb), agli IPA, ad alcuni cloroderivati ed a qualche altra sostanza (Tabella 18) per un totale di 21 analiti rispetto ai 71 controllati fino ad oggi (30%).
Tabella 18: sostanze monitorate nella matrice acqua in tutte le stazioni dei corpi idrici costieri della Toscana
Riferimento N CAS Sostanza
Tab. 1/A 12 117-81-7 di(2-etilesil)ftalato - DEHP
Tab. 1/A 2 0120-12-07 antracene
Tab. 1/A 5 32534-81-9 difenileteri bromurati
Tab. 1/A 6 7440-13-9 cadmio e composti
Tab. 1/A 7 85535 cloroalcani C10-C13
Tab. 1/A 15 206-44-0 fluorantene
Tab. 1/A 16 118-74-1 esaclorobenzene
Tab. 1/A 18 608-73-1 esaclorocicloesano
Tab. 1/A 20 7439-92-1 piombo e composti
Tab. 1/A 21 7439-97-6 mercurio e composti
Tab. 1/A 23 7440-02-0 nichel e composti
Tab. 1/A 28 50-32-8 benzo(a)pirene
Riferimento N CAS Sostanza
Tab. 1/A 28 205-99-2
benzo(b)fluorantene
Tab. 1/A 28 0207-08-09 benzo(k)fluorantene
Tab. 1/A 28 191-24-2
benzo(g,h,i)perilene
Tab. 1/A 28 193-39-5 indeno(1,2,3-cd)pirene
Tab. 1/A 30 36643-28-4 tributilstagno (composti) (tributilstagnocatione)
Tab. 1/A 9 ter n.a DDT totale
Tab. 1/A 9 ter 50-29-3 p.p’-DDT
Tab. 1/B 1 7440-38-2 arsenico
Tab. 1/B 19 74440-47-3 cromo totale
Per le stazioni di nuova introduzione e corrispondenti a importanti fattori di pressioni, quali Foce Arno (Costa pisana), Livorno porto (Costa livornese) e Piombino porto (Costa di Piombino), si manterrà, per almeno un triennio (2025-2027) l’intero set analitico di sostanze previste dalle Tabelle 1/A e 1/B che i laboratori riescono a quantificare e che, ad oggi, è quello risultante dalla somma di Tabella 18 e Tabella 19.
Tabella 19: sostanze monitorate nella matrice acqua in aggiunta a quelle di Tabella 18 per le 3 stazioni nuove di Foce Arno (Costa pisana), Livorno porto (Costa livornese) e Piombino porto (Costa di Piombino)
Riferimento N CAS Sostanza
Tab. 1/A 1 15972-60-8 alacloro
Tab. 1/A 3 1912-24-9 atrazina
Tab. 1/A 4 71-43-2 benzene
Tab. 1/A 8 470-90-6 clorfenvinfos
Tab. 1/A 9 2921-88-2 clorpirifos -Clorpirifos etile
Tab. 1/A 10 0107-06-02 1,2-dicloroetano
Tab. 1/A 11 1975-09-02 diclorometano
Tab. 1/A 13 330-54-1 diuron
Tab. 1/A 14 115-29-7 endosulfan
Tab. 1/A 17 87-68-3 esaclorobutadiene
Tab. 1/A 19 34123-59-6 isoproturon
Tab. 1/A 22 91-20-3 2 naftalene
Tab. 1/A 24 84852-15-3 nonilfenoli (4-nonilfenolo)
Tab. 1/A 25 140-66-9 ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'- tetrametilbutil)- fenolo))
Tab. 1/A 26 608-93-5 pentaclorobenzene
Tab. 1/A 27 87-86-5 pentaclorofenolo
Tab. 1/A 29 122-34-9 simazina
Tab. 1/A 31 12002-48-1 triclorobenzeni
Tab. 1/A 32 67-66-3 triclorometano
Tab. 1/A 33 1582-09-08 trifluralin
Tab. 1/A 29 bis 27-18-4 tetracloroetilene
Tab. 1/A 29 ter 1979-01-06 tricloroetilene
Tab. 1/A 6 bis 56-23-5 tetracloruro di carbonio
Tab. 1/A 9 bis 309-00-2 aldrin
Tab. 1/A 9 bis 60-57-1 dieldrin
Tab. 1/A 9 bis 72-20-8 endrin
Tab. 1/A 9 bis 465-73-6 isodrin
Tab. 1/B 5 95-51-2 2-cloroanilina
Riferimento N CAS Sostanza
Tab. 1/B 6 108-42-9 3- cloroanilina
Tab. 1/B 7 106-47-8 4- cloroanilina
Tab. 1/B 8 108-90-7 clorobenzene
Tab. 1/B 9 95-57-8 2-clorofenolo
Tab. 1/B 10 108-43-0 3-clorofenolo
Tab. 1/B 11 106-48-9 4-clorofenolo
Tab. 1/B 16 95-49-8 2-clorotoluene
Tab. 1/B 17 108-41-8 3-clorotoluene
Tab. 1/B 18 106-43-4 4-clorotoluene
Tab. 1/B 22 95-76-1 3, 4 dicloroanilina
Tab. 1/B 23 95-50-1 1,2 diclorobenzene
Tab. 1/B 24 541-73-1 1,3 diclorobenzene
Tab. 1/B 25 106-46-7 1,4 diclorobenzene
Tab. 1/B 26 120-83-2 2,4 diclorofenolo
Tab. 1/B 30 330-55-2 linuron
Tab. 1/B 31 121-72-5 malation
Tab. 1/B 41 108-88-3 toluene
Tab. 1/B 42 71-55-6 1,1,1 tricloroetano
Tab. 1/B 43 95-95-4 2,4,5 triclorofenolo
Tab. 1/B 44 1988-06-02 2,4,6 triclorofenolo
Tab. 1/B 45 - terbutilazina (incluso metabolita)
Tab. 1/B 47 1330-20-7 xilene
Infine, rispetto alla frequenza mensile prevista dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (tabella 3.7 e punto A.3.4 dell’Allegato 1 alla parte terza) per le sostanze chimiche nella matrice acqua, si prevede un campionamento bimestrale (6 volte l’anno), coincidente con quanto previsto per fitoplancton, CTD e nutrienti. Tale riduzione è giustificata dai ragionamenti sviluppati in precedenza rispetto alla significatività di pressioni ed impatti ed alla reale presenza di queste sostanze nelle acque costiere della Toscana, oltre a tenere in considerazione le difficoltà operative di monitorare tutti i corpi idrici costieri della Toscana ogni mese, a
di condizioni meteomarine spesso proibitive e della notevole estensione della rete di monitoraggio regionale.
Tabella 20 : piano di campionamento delle acque marino costiere della Toscana per il triennio 2025-27
Corpo idrico
Legenda matrici: W = acqua (water); S= sedimenti; Po= P. oceanica; Z= macroZoobenthos; C= macroalghe (Carlit); M= biota-mitili; P= biota-pesci
Se da un lato, infatti, la maggior parte delle sostanze sono sempre state <LOQ, quelle che hanno determinato criticità (concentrazioni vicine o superiori agli SQA) sono poche e rilevate con una certa costanza in specifiche aree di mare, tanto che dall’analisi dei dati pregressi si può escludere che la riduzione di frequenza “determini una perdita della rappresentatività del monitoraggio né problemi nella determinazione dello stato di qualità” (sezione B.3 dell’Allegato D alla DGRT 1589/2024). Tale riduzione, a nostro avviso, rientra nel campo di applicazione del punto A.3.5. dell’Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., laddove si prevede che “è possibile ridurre le frequenze di campionamento solo se giustificabili sulla base di conoscenze tecniche e indagini”.
Mettendo a confronto quanto previsto nel programma di monitoraggio 2022-24 (Tabella 14) con il nuovo piano per il triennio 2025-27 (Tabella 20) risulta quanto segue:
• una riduzione delle stazioni di prelievo per tutte le matrici tra il 12 ed il 20%, oltre all’eliminazione totale del monitoraggio VTM;
• un aumento significativo sia delle stazioni che dei campioni per quanto riguarda il bioaccumulo nei mitili, controllato in tutti i nuovi corpi idrici;
• un aumento significativo dei campionamenti per macrozoobenthos (2 volte l’anno) e posidonia (su 6 stazioni invece che 2);
• una leggera riduzione nei campioni di acqua, alla quale si aggiunge un significativo minor carico analitico corrispondente a circa il 30% di quello attuale.
Tabella 21 – confronto tra il piano di campionamento delle acque marino costiere della Toscana attuato nel triennio 2022-24 e quello proposto per il triennio 2025- 27
Matrice
In conclusione, quindi, si avrà un minor impegno di risorse umane, economiche e strumentali sia in termini di zone da monitorare, grazie ad una miglior localizzazione e distribuzione di stazioni e corpi idrici, sia come carico analitico, unitamente ad un miglioramento sull’affidabilità e rappresentatività dei dati per quanto riguarda i 2 principali EQB (macrozoobenthos e posidonia). Questi 2 aspetti porteranno ad una migliore valutazione dello stato di qualità ecologica delle acque marino costiere della Toscana mantenendo uno stesso livello nella rappresentatività del monitoraggio e nella determinazione dello stato di qualità chimica.
28 I campioni di acqua avranno un “peso” molto minore rispetto all’attuale, dato che è prevista una riduzione di circa il 70% delle analisi chimiche
Nell’anno 2024, a causa dell’indisponibilità di un mezzo nautico nella seconda metà dell’anno, sono stati effettuati circa il 62% (Tabella 22) dei campionamenti e sopralluoghi previsti nelle diverse matrici. Tale indisponibilità, a partire da agosto 2024, è stata determinata da un importante guasto al battello oceanografico di ARPAT (“Poseidon”) che aveva garantito tutte le attività di monitoraggio marino negli ultimi 25 anni: non è stato possibile rimediare a tale inconveniente, a causa della vetustà del mezzo e della sua prevista sostituzione, per cui a fine luglio è stato dismesso. Purtroppo, però, non è stato neppure possibile utilizzare la nuova imbarcazione, il catamarano “Polaris” realizzato dai cantieri Ferrato Nautica di Chioggia e consegnato a Livorno ad aprile 2024, per una serie di ritardi e problemi nelle procedure amministrative di collaudo, verifica di dotazioni e requisiti per la navigazione ed immatricolazione a traffico. Polaris è diventato operativo solo da maggio 2025.
Tabella 22 : attività svolte da ARPAT nel 2022-24 per il monitoraggio delle acque costiere della Toscana
stato ecologico acqua (tab. 1/B)
stato chimico acqua e biota (tab. 1/A)
stato chimico sedimenti (tab. 2/A, 3/A e 3/B)
Come detto, lo stato ecologico per le acque costiere viene definito sulla base di 4 elementi di qualità biologica (EQB) e, successivamente, verificato sulla base degli elementi di qualità fisico – chimica a sostegno (Fase I) e degli inquinanti non prioritari (Fase II). Dato che la maggior parte di questi ulteriori elementi (Fase I e II) caratterizzano la colonna d’acqua e possono influenzare, soprattutto, le comunità fitoplanctoniche rispetto a quelle bentoniche, si è ritenuto di invertire il normale ordine di esposizione dei risultati sugli EQB, anteponendo macroinvertebrati bentonici, macroalghe e posidonia alla biomassa fitoplanctonica, posta immediatamente prima dei parametri chimico-fisici (CTD, nutrienti, TRIX, ecc.) ai quali è maggiormente relazionata
Nel 2024 (1-31 luglio) sono stati prelevati campioni in 3 stazioni di Costa livornese, Costa Rosignano ed Elba Nord, che si aggiungono alle 6 monitorate nel 2022 e alle 4 del 2023 29 . A causa dei ritardi nella consegna del Polaris e il fermo del Poseidon non è stato possibile campionare le altre 5 stazioni di Costa Versilia, Costa del Serchio, Costa pisana, Arcipelago Isola d’Elba (Elba Sud) e Arcipelago Isole Minori (Giglio).
Dal punto di vista granulometrico, tutte le stazioni sono caratterizzate da una netta prevalenza (>90%) di sabbie (Tabella 23), ad eccezione di Livorno, Rosignano, Foce Albegna, Porto S. Stefano e Giglio. In particolare, la stazione localizzata al Giglio, si discosta da tutte le altre per la frazione granulometrica >2 mm (ghiaia) che qui rappresenta l’8,8%.
Per quanto riguarda, invece, Livorno, Rosignano, Foce Albegna e Porto S. Stefano, la componente pelitica è tra il 26 e il 41%.
Il carbonio organico totale (TOC) è nella maggior parte dei casi <1% a indicare zone di fondale poco ricche di sostanza organica, ad eccezione delle stazioni di Cala di Forno, Foce Albegna, Porto Santo Stefano e Rosignano: quest’ultima stazione presenta il valore di TOC maggiore tra le stazioni monitorate, 2,1%.
Tabella 23: frazioni granulometriche e carbonio organico totale (TOC) nei sedimenti dei popolamenti a macroinvertebrati bentonici monitorati nel 2022-2024
Corpo idrico Stazione
Costa della Versilia Marina di Carrara
Costa del Serchio Nettuno
Costa Pisana Foce Morto
livornese
Costa di Punta Ala Foce Bruna
Costa dell’Ombrone Foce Ombrone
dell’Albegna Foce Albegna
Costa di Burano Ansedonia
Arcipelago - Isola d’Elba Elba Nord
Elba Sud
Arcipelago - Isole Minori Capraia
Giglio
Legenda: c.n.e.= campionamento non effettuato; Le analisi delle comunità nelle 3 stazioni monitorate nel 2024 hanno permesso di individuare complessivamente 162 specie di macroinvertebrati bentonici con un minimo di 58 specie nella stazione di Elba Nord e un massimo di 110 a Livorno.
29 ARPAT, 2023, “Acque marino costiere della Toscana. Monitoraggio 2022 e proposta di classificazione provvisoria” e ARPAT, 2023, “Acque marino costiere della Toscana. Monitoraggio 2022 e proposta di classificazione provvisoria”
La distribuzione delle specie nei 5 gruppi ecologici per ciascuna delle 3 repliche (Figura 10) per l’anno 2024 indica almeno 3 diverse situazioni:
• nella stazione di Livorno prevalgono le specie sensibili (Gruppo I valore medio 48%), seguite da quelle tolleranti (Gruppo III valore medio 31%); le specie opportuniste, del Gruppo IV e V rappresentano 2%.
• a Rosignano sono più abbondanti le specie sensibili e sensibili/tolleranti (gruppo I e II valore medio 71,2%), mentre le specie opportunistiche sono il 3%
• nella stazione Elba Nord, il popolamento è costituito per il 69% da specie sensibili, mentre le specie opportunistiche sono <1%.
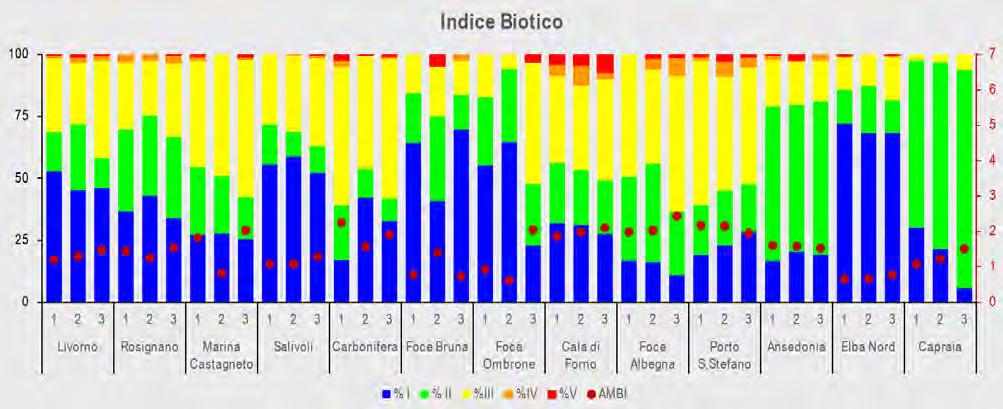
(II ord.)
Figura 10: distribuzione dei 5 gruppi ecologici nelle diverse repliche di ogni stazione nel 2022-2024
Tali diverse caratteristiche vengono evidenziate (Tabella 25) anche dal calcolo dell’indice AMBI 30 con valori più elevati (tra 1,33 e 1,42) in Costa livornese e Costa di Rosignano e più bassi (0,70) all’Isola d’Elba (Elba Nord). Integrando, come detto, questo primo indice con quello della diversità specifica (H’) e con il numero di specie (S), si ottiene l’indice M-AMBI che per Costa livornese e Costa Rosignano risulta in stato ecologico elevato, mentre per Elba Nord in buono.
In generale, nel periodo 2022-2024 sono stati identificati 266 taxa di cui 259 a livello di specie: il maggior numero di specie è stato rilevato nella stazione di Livorno 110 e il minore a Capraia, 19, ma quest’ultimo caso merita un approfondimento.
A Capraia nel 2023 i livelli di diversità e ricchezza specifica misurati nel macrozoobenthos sono nettamente inferiori rispetto ai campioni delle campagne precedenti (2012, 2015, 2017 e 2020). In particolare, sebbene il valore del solo indice AMBI (Tabella 24) nel 2024 risulti abbastanza elevato (1,27) per la netta prevalenza di specie sensibili e tolleranti (gruppi I e II), il numero estremamente limitato di specie (19) e la presenza di un polichete (Aponuphis
30 Software AMBI 6.0 sulla base di una lista specie aggiornata a maggio 2022
brementi) piuttosto tollerante alle perturbazioni e molto più abbondante di tutte le altre specie, determina un valore di M-AMBI inferiore agli altri e di qualità “sufficiente”.
In nessun caso, sembra che vi sia una correlazione con le caratteristiche del substrato, dato che granulometria e sostanza organica sono pressoché omogenee in tutti gli anni monitorati ed anche analoghe alle altre 3 stazioni analizzate nel 2023.
Il dato di Capraia del 2023, quindi, è del tutto anomalo e non dovrebbe essere attribuibile a fattori di pressione antropica, considerato che in quell’area (Cala del Ceppo, nella costa sudorientale dell’Isola) non si ravvisano attività significative. Inoltre, il valore di Capraia nel 2023 è ancor più eccezionale e senza spiegazione apparente se lo si confronta con tutti i campioni analizzati nelle acque marine della Toscana: confrontando i dati di diversità (H’) e numero di specie (S) rilevati nel triennio 2022-24 (Tabella 25) ed in quelli precedenti (tra 2012 e 2021), quelli di Capraia sono i valori più bassi mai rilevati tra tutte le acque costiere della Toscana 31
Tabella 24: stato ecologico per l’EQB macroinvertebrati bentonici per Capraia dal 2015 al 2023
- Isole Minori Capraia
Purtroppo, nel triennio 2022-24 non è stato possibile campionare l’altra stazione prevista per il corpo idrico Arcipelago Isole Minori (Giglio), per cui il valore di M-AMBI di Capraia condizionerebbe anche lo stato ecologico di questo corpo idrico, che risulterebbe in classe “sufficiente”, unico in Toscana. In definitiva, quindi, si ritiene che il valore di M-AMBI di Capraia non debba essere considerato per la valutazione dello stato ecologico e che il corpo idrico Arcipelago Isole Minori debba essere classificato sulla base degli altri EQB.
L’elaborazione dell’M-AMBI (Tabella 25) relativa ai campionamenti del triennio 2022-2024 in 13 corpi idrici costieri della Toscana, non potendo considerare valido quello di Capraia, indica che le comunità macrozoobentoniche sono in uno stato ecologico elevato in 9 corpi idrici e buono nei restanti 3 (Isola d’Elba, Costa Albegna e Costa Burano).
31 In realtà, nel 2013 si sono registrati 3 valori di M-AMBI tra 0.44 e 0.58, ma il dato era stato influenzato da una diversa tecnica di conservazione del campione (congelamento) risultata non idonea, tanto che nel 2014 sono stati ripetuti i prelievi nelle stesse 3 stazioni con esiti del tutto normali (Foce Albegna= 0.71; Rosignano Lillatro= 0.82; Cala di Forno =0.89)
Tabella 25: stato ecologico per l’EQB macroinvertebrati bentonici nei corpi idrici costieri nel 2022-2024
Corpo idrico Stazione
Costa della Versilia Marina di Carrara 2024
Costa del Serchio Nettuno 2024
Costa Pisana Foce Morto 2024
Costa livornese Livorno
Costa di Rosignano Rosignano
Costa del Cecina Marina Castagneto 2023
Costa di Piombino Salivoli 2023
Costa di Follonica Carbonifera 2023
Costa di Punta Ala Foce Bruna 2022
Costa dell'Ombrone Foce Ombrone
Costa dell'Uccellina Cala di Forno
Elevato
Elevato
Elevato Costa dell'Albegna Foce Albegna
Costa dell'Argentario Porto S.Stefano
Costa di Burano Ansedonia
Arcipelago – Isola d’Elba Elba Nord
Elba Sud
Arcipelago - Isole Minori Capraia 2023
Giglio 2024
Legenda: c.n.e.= campionamento non effettuato; NC= valore da non considerare per la classificazione in quanto basato su dati anomali
Come già accennato, ampliando il confronto ai trienni precedenti (2013-2015, 2016-2018, 2019-2021), oltre all’anomalia di Capraia, possiamo osservare (Tabella 26 Tabella 25) come la variabilità nel corso del tempo sia abbastanza importante, con 7 stazioni che mostrano una deviazione standard <5%, altre (7) tra 5 e 10% ed alcune (4) tra 11 e 17%. In realtà, per quelle con la maggiore variabilità, per quanto con 4 valori sia improprio applicare una vera analisi statistica, vi è solo 1 valore che si distacca dagli altri sia in aumento (ad es. Nettuno nel 2015) o in diminuzione (ad es. Livorno nel 2013 o Elba Sud nel 2021).
In particolare, il primo triennio (2013-15) è quello che più spesso presenta in varie stazioni risultati dell’indice M-AMBI che si distaccano maggiormente rispetto ai successivi trienni, ma dobbiamo considerare che sono cambiate più volte le liste specie ed i gruppi ecologici (ad es., la prima lista specie del maggio 2012 comprendeva 6’500 taxa, mentre nel 2024 ne sono presenti 11'562), per cui lo stesso campione analizzato con i vari aggiornamenti del Software AMBI potrebbe dare risultati diversi.
Dal punto di vista dello stato ecologico, tali differenze sono meno accentuate, ovviamente, perché i valori vengono “raggruppati” in una stessa classe (Tabella 1) e, ad esempio, per valori compresi tra 0,80 - 0,61 si ha uno stato ecologico “buono”. D’altro canto, una piccola
variazione, anche dell’ordine dei millesimi di M-AMBi 32, può comportare un cambio di classe tra due situazioni molto simili (valori borderline).
Tabella 26: stato ecologico per l’EQB macroinvertebrati
Ombrone Foce Ombrone
Albegna Foce Albegna
Legenda:
c.n.e.= campionamento non effettuato; NC= valore da non considerare per la classificazione in quanto basato
In linea generale, le aree dove si sono riscontrati con maggior frequenza i valori più bassi (<0.81) sono quelle settentrionali (dalla Versilia alla Costa pisana), dove le pressioni antropiche sono sicuramente più importanti e le caratteristiche naturali (batimetria, idrologia, idrodinamica, ecc.) non riescono a compensare adeguatamente gli impatti: se si volesse calcolare il valore medio di M-AMBI, risulterebbe (vedi nota 33), questo porterebbe ad una classe “buona” per tutti i 3 corpi idrici. Inoltre, due delle altre 3 aree influenzate da apporti fluviali (Foce Bruna e Foce Albegna) risulterebbero anch’esse in uno stato ecologico mediamente “buono”, a dimostrare una possibile influenza da parte delle acque e delle sostanze veicolate da questi corsi d’acqua, ma così non accade per Foce Ombrone.
32 Nel DM 260/2010 i limiti di classe per M-AMBI (RQE) sono espressi con 2 decimali, ma anche la terza cifra decimale (millesimi) può comportare un passaggio di classe, come, ad es., nel 2024 a Foce Ombrone (0.811=elevato) e Elba Nord (0.807=buono)
33 La media tra i trienni non è un valore previsto dalla normativa e non può, quindi, determinare lo stato ecologico di un corpo idrico
Tutti gli altri corpi idrici costieri risulterebbero mediamente in classe “elevata” con valori di M-AMBI ampiamente superiori a 0.81, ad eccezione del Giglio, dove le difficoltà di reperimento di fondali idonei e le variazioni granulometriche hanno portato ad escludere tale area nei prelievi dell’ultimo triennio e possono avere influito sui valori rilevati nei primi anni.
3.1.2 Macroalghe
Nel 2024 (tra 5 giugno e il 5 agosto), è stato effettuato il monitoraggio delle comunità di macroalghe presenti nella fascia intertidale delle scogliere rocciose delle aree localizzate lungo la costa continentale della Toscana in 5 corpi idrici: Costa livornese (Romito), Costa di Piombino (Salivoli), Costa dell’Uccellina (Cala di Forno), Costa dell’Argentario (Porto S.Stefano) e Costa di Burano (Ansedonia). Nei due anni precedenti sono stati monitorati i popolamenti lungo le coste insulari di Capraia, Giglio e Montecristo (2022) e dell’Isola d’Elba (2023), nelle due zone di Elba Nord ed Elba Sud.
I popolamenti delle coste continentali (2024) mostrano una diversità di composizione tra le stazioni della zona Nord e quelle più a Sud (Figura 11) principalmente imputabile alle diverse condizioni edafiche (idrodinamismo ed esposizione alla radiazione solare): Romito e Salivoli, infatti, sono caratterizzati dalla maggior presenza di Cystoseira compressa (>50%) e Dictyotales/ Stypocaulaceae (25-32%), mentre tra Cala di Forno e Ansedonia si ha una prevalenza di Corallina in progressivo aumento (da 33 a 53%), di concrezioni a marciapiede (“trottoir”) (da 22 a 47%).
Dal punto di vista della composizione specifica, i popolamenti macroalgali delle coste elbane, campionate nel 2023, sono abbastanza simili tra loro ed alle stazioni di Costa Livornese e Costa Piombino, in particolare Elba Nord:
• a Elba Nord il popolamento di macroalghe è rappresentato da Cystoseira compressa (45,2%), da Dictyotales/Stypocaulaceae (37,6%) e Corallina (15,1%);
• a Elba Sud sono maggiormente rappresentati i popolamenti con Dictyotales /Stypocaulaceae (73,8%) e Cystoseira compressa (21,3%).
I popolamenti macroalgali delle coste insulari, campionate nel 2022, sono abbastanza diversi e caratterizzati dalla presenza di un maggior numero di raggruppamenti ecologici:
• a Capraia il popolamento di macroalghe è rappresentato in modo abbastanza equilibrato da Corallina (29,1%), Cystoseira amentacea/mediterranea a cintura (20%) e Dictyotales/Stypocaulaceae (16,4%);
• a Montecristo prevale Cystoseira amentacea/mediterranea a grandi chiazze (40,2%);
• al Giglio sono maggiormente rappresentati i popolamenti con Cystoseira amentacea/ mediterranea a cintura (29,50%) e Corallina (21,60%).
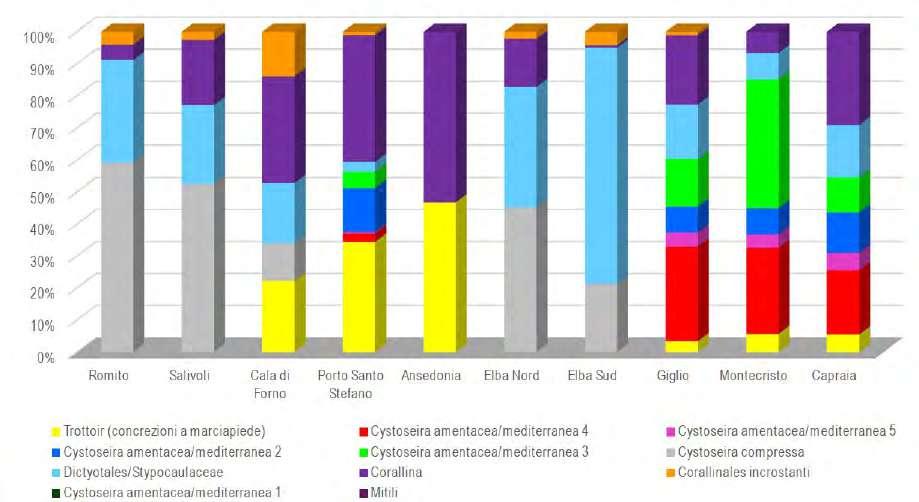
Figura 11: Struttura delle comunità macroalgali monitorate nel 2022-2024
Il calcolo dell’indice CARLIT (RQE) per il 2024 indica uno stato ecologico buono in Costa livornese, Costa Piombino, ed elevato in Costa dell’Uccellina, Costa Argentario e Costa Burano (Tabella 27).
Tabella 27: stato ecologico per l’EQB macroalghe nei corpi idrici costieri della Toscana nel 2022-2024
Corpo idrico (c. i.) Stazione
Isola d’Elba
Nel complesso, i risultati dei corpi idrici Arcipelago Isola d’Elba e Arcipelago Isole Minori, rispettivamente in stato ecologico buono ed elevato, sono sovrapponibili a quelli del triennio 2019-21. Nel 2019 (ultimo rilevamento del triennio di monitoraggio precedente) il popolamento in queste stesse 3 stazioni era leggermente diverso, con una minor presenza, ad esempio, di Corallina (a Capraia e Giglio), con diverse associazioni a Cystoseira amentacea/mediterranea (C3 e C2 a Capraia nel 2019 invece che C3 e C4) o con una diversa specie prevalente di cistoseira a Montecristo (Cystoseira compressa al 37%). Nel
Toscana nel triennio 2022-2024
2020 (ultimo rilevamento del triennio precedente) il popolamento delle 2 zone dell’Isola d’Elba era molto simile a quello del 2023. Risulta evidente che i popolamenti delle 3 stazioni delle Isole minori dell’Arcipelago Toscano (Capraia, Giglio e Montecristo), e delle 2 dell’Isola d’Elba siano diversi, confermando la necessità di considerare distinti questi due corpi idrici.
I tratti di costa che afferiscono ai corpi idrici Costa Livornese, Costa Piombino, Costa dell’Uccellina, Costa Argentario presentano nel corso dei trienni degli RQE sovrapponibili; diversa la situazione Costa Burano, che nei trienni precedenti è sempre stata classifica in stato ecologico buono, mentre nel triennio 2022-2024 risulta essere elevato.
Tabella 28: stato ecologico per l’EQB macroalghe nei corpi idrici costieri della Toscana dal 2013 al 2024
3.1.3.1 Estensione dell’habitat a Posidonia oceanica
Tra le attività previste dai Programmi di monitoraggio della Strategia Marina (D.Lgs. 190/2010), vi è anche la definizione dell’estensione dell’habitat a Posidonia oceanica (modulo D1, scheda 1.6.1) attraverso l’acquisizione di dati acustici, tramite Multibeam echosounder (MBES) o Side Scan Sonar (SSS) sulla morfologia del substrato e la raccolta di documentazione video fotografica ad alta definizione e georeferenziata in aree di 3 km2 L’estensione dell’habitat viene valutato mediante elaborazione ed analisi del backscatter, e del modello digitale del terreno (DTM), che consente di distinguere le zone ricoperte da Posidonia oceanica o da matte morta da quelle con solo il substrato di fondo (sabbia, roccia)
La restituzione di queste informazioni opportunamente elaborate ed interpretate ha consentito la produzione di mappe, che, seppur limitate a porzioni delle praterie, hanno coperto estensioni ben superiori ai 3 km2 e sono un fondamentale supporto per la pianificazione delle altre attività di monitoraggio della Posidonia oceanica e per la valutazione dei risultati.
Nel triennio 2022-2024, sono state monitorate, complessivamente 15 diverse praterie (Tabella 29), 12 delle quali inserite anche nella rete di monitoraggio regionale (par. 1.5), in ciascuna delle quali sono state individuate 3 stazioni intermedie (fondale di 15m) e 3 sul limite inferiore per la valutazione dello stato ecologico (indice PREI). A queste si aggiungono alcune mappe realizzate nel triennio precedente (2019-2021) nell’ambito della Strategia Marina (D.Lgs. 190/2010), nelle quali non è stato attuato il monitoraggio dello stato ecologico: Secche di Vada, Lacona, Marina di Campo e Giannutri.
Tabella 29: estensione delle praterie di Posidonia oceanica monitorate tra 2021 e 2024
Corpo idrico costiero Nr 34 . Prateria
Anno Rif. normativo
Costa livornese 2 Antignano 2024 DGRT 608/2015 e D.Lgs 190/2010
Costa di Rosignano 3 Rosignano 2024 DGRT 608/2015 e D.Lgs 190/2010 4 Secche di Vada 2021 D.Lgs 190/2010
Costa di Piombino 6 Cala Moresca 2024 DGRT 608/2015 e D.Lgs 190/2010
Costa di Punta Ala 12 Punta Ala 2024 DGRT 608/2015 e D.Lgs 190/2010
Costa dell’Albegna 15 Foce Albegna 2023 DGRT 608/2015 e D.Lgs 190/2010
Costa dell’Argentario 17 Argentario 2022 DGRT 608/2015 e D.Lgs 190/2010
Costa di Burano 19 Ansedonia 2023 DGRT 608/2015 e D.Lgs 190/2010
7 Elba Nord 2022 DGRT 608/2015 e D.Lgs 190/2010
8 Elba Sud 2022 DGRT 608/2015 e D.Lgs 190/2010
Arcipelago - Isola d’Elba
9 Lacona 2021 D.Lgs 190/2010
10 Marina di Campo 2021 D.Lgs 190/2010
Arcipelago - Isole Minori 1 Gorgona 2024 D.Lgs 190/2010 5 Capraia 2023 DGRT 608/2015 e D.Lgs 190/2010
16 Giglio 2023 DGRT 608/2015 e D.Lgs 190/2010
18 Giannutri 2021 D.Lgs 190/2010 14 Montecristo 2022 DGRT 608/2015 e D.Lgs 190/2010
11 Pianosa 2023 D.Lgs 190/2010
13 Scoglio d’Africa 2022 D.Lgs. 190/2010
L’elaborazione delle informazioni per la produzione di mappe delle praterie monitorate è ancora in corso, ma il quadro a livello regionale è già importante (Figura 12).

Figura 12: localizzazione delle praterie indagate per l'estensione dell'habitat a Posidonia oceanica in Toscana
In alcuni casi, utilizzando anche i rilievi acustici effettuati per la valutazione di altri habitat bentonici (coralligeno, letti a rodoliti, ecc.), sempre previsti dalla Strategia Marina, è stato possibile ricostruire una mappa di aree anche superiori ai 3 km2, come per l’intero perimetro costiero dell’Isola di Gorgona (Figura 37) e di Giannutri (Figura 46) o per una gran parte delle isole di Capraia (Figura 38) o di Pianosa (Figura 42).
Questa documentazione, il cui dettaglio è riportato in Appendice, potrà essere una base utile a realizzare l’aggiornamento della cartografia completa delle biocenosi bentoniche marine della Toscana, attesa dalla fine degli anni ’90. A tal fine, potrebbero essere utilizzate le numerose mappe realizzate nel frattempo da vari soggetti e con diverse finalità (ad es. dal Parco dell’Arcipelago Toscano o da vari soggetti per la realizzazione di opere ed interventi sulla fascia costiera) ma sarebbe necessario un importante lavoro di acquisizione, archiviazione e verifica dei requisiti per comporre un quadro omogeneo ed affidabile.
3.1.3.2
Nel 2024 sono state campionate, tra giugno e agosto, 4 praterie di Posidonia oceanica (Antignano, Rosignano, Cala Moresca e Punta Ala), appartenenti ai relativi 4 corpi idrici di Costa livornese, Costa di Rosignano, Costa di Piombino e Costa di Punta Ala, nei quali si suddivide la costa continentale della Toscana tra Livorno e Castiglione della Pescaia.
Come detto (par. 1.3.2), per ogni prateria è stata individuata un’area di 3 km2 circa, all’interno della quale sono state scelte 3 stazioni sul limite inferiore e 3 in una zona intermedia (circa 15m di profondità), tutte localizzate su substrato mobile, ad eccezione di quella di Antignano dove sono presenti anche tratti di roccia.
La composizione granulometrica dei fondali appare sostanzialmente omogenea all’interno di ciascuna area (Tabella 30), con solo leggere differenze tra stazioni più profonde (limite inferiore) ed intermedie, nelle quali si trovano valori più elevati di ghiaie e, soprattutto, sabbie, come normale distribuzione dei sedimenti marini secondo un gradiente costa largo. A questa omogeneità della prateria indagata, fa eccezione quella di Rosignano (sabbie tra 37 e 77% e peliti tra 16 e 46%) che, seppur localizzata in una zona a Sud e distante almeno 2 km dallo sbocco a mare del Fosso Bianco, cioè il punto di scarico finale dello stabilimento Solvay, risente sicuramente degli importanti apporti di solidi sospesi che si disperdono in un’ampia zona di mare. L’impatto di questa pressione potrebbe anche essere la causa di una relativamente minor copertura della zona intermedia con piante vitali (80%) rispetto ad una presenza di matte morta (20%).
In generale, quindi, si tratta di praterie dove prevalgono le frazioni di ghiaia (<2mm) e sabbia (valori tra 2mm e 0,065mm), con un tendenziale aumento di quella pelitica a maggiore profondità, ma in quella di Punta Ala si ha una costante e netta prevalenza (>70%) di sedimenti fini (peliti), caratteristica rilevata anche nel 2021 e della quale non sappiamo se sia imputabile a qualche alterazione antropica.
Entrando nel dettaglio dei vari descrittori relativi allo stato ecologico delle singole praterie monitorate nel 2024 possiamo osservare quanto segue.
Antignano
La prateria è di tipo discontinua e pura (cioè senza presenza di altre fanerogame marine), impiantata prevalentemente su sabbia con presenza di zone a matte morta e porzioni rocciose e questa disomogeneità di substrato influenza alcuni parametri rendendo più complicata l’applicazione dell’indice PREI (che prevede il campionamento su praterie impiantate su sabbia o matte) nella valutazione (media) dei 3 transetti. Infatti, nel 2024 il valore particolarmente basso del PREI (0,557) del transetto 5-6, posizionato approssimativamente davanti all’Hotel Rex di Livorno nella parte più a Sud di quest’area di prateria, condiziona la media complessiva della prateria che risulta inferiore a quella degli anni precedenti (Tabella 33), calcolata, però, solo sul transetto 2-1, il solo monitorato fin dal primo triennio 2013-15. La stazione intermedia più meridionale (PA6) presenta, infatti, valori inferiori di tutti i descrittori (Tabella 31) rispetto alle altre 2 stazioni intermedie (PA2 e PA4), determinati in gran parte da foglie più corte e strette, forse indice di una ridotta trasparenza delle acque e alterazione dei flussi sedimentari.
Tabella 30: granulometria nei sedimenti delle praterie di P. oceanica monitorate nel triennio 2022-2024
Corpo idrico Prateria Frazione
Costa livornese Antignano
Costa di Rosignano Rosignano
Costa di Piombino Cala Moresca
Costa di Punta Ala Punta Ala
Costa dell’Albegna Foce Albegna
Costa dell’Argentario Argentario
Costa di Burano Ansedonia
Arcipelago Isola d’Elba
La prateria è continua, pura, impiantata su un substrato caratterizzato prevalentemente da matte morta. L’indice PREI presenta valori crescenti (Tabella 32) via via che ci si allontana dal Fosso Bianco (scarico finale Solvay) verso Sud, a partire dal transetto 3-4 (più a Nord) e proseguendo con il transetto 1-2 e 5-6 (quello più lontano e meridionale). Il calo del PREI, per quanto si resti sempre nella classe buona, nel transetto 3-4 è da attribuirsi ai valori più bassi di superficie fogliare e biomassa degli epifiti (Tabella 31) e potrebbe essere messo in relazione con la diluizione degli apporti solidi del Fosso Bianco, che interferiscono con la penetrazione della luce e la fotosintesi e, di conseguenza, con la crescita della pianta.
Tabella 31: descrittori dell’indice PREI 35 (EQB Posidonia oceanica) nei corpi idrici monitorati nel 2024
Corpo idrico Prateria
Costa livornese Antignano
Costa di Rosignano Rosignano
Costa di Piombino Cala Moresca
Costa di Punta Ala Punta Ala
Cala Moresca
La prateria è continua, pura, impiantata su un substrato misto di sabbia e matte morta; i valori calcolati per i diversi parametri che concorrono al calcolo del PREI mostrano una certa variabilità che potrebbe anche dipendere dal tipo di substrato, che si presenta stranamente ricco (97%) di ghiaia (>2mm) in una delle stazioni intermedie (PA6), rispetto ad una a prevalenza di sabbie (PA2) o con granulometria più eterogenea (PA4).
Punta Ala:
Il campionamento ha evidenziato una prateria continua e pura impiantata su un substrato composto perlopiù da peliti. La densità dei fasci è risultata piuttosto bassa (tra 195 e 218 fasci/m2) in tutte le stazioni poste a circa 15 metri di profondità, tanto che, secondo una vecchia classificazione (Giraud, 1977), sarebbe una “prateria molto rada, probabilmente in regressione, rimaneggiata in seguito a erosione” (anche il limite inferiore è stato identificato come “regressivo” e in PA1 si ha un valore di densità fogliare inferiore a quello di riferimento). Anche rapportando la densità fogliare con la profondità (Pergent et al., 1995; PergentMartini e Pergent, 1996) la prateria di Punta Ala risulterebbe “disturbata”, cioè influenzata da fattori antropici di varia natura. Il passaggio ad uno stato ecologico più basso (sufficiente) rispetto al triennio precedente (buono) sembra proprio legato alla densità più bassa, ma in realtà ricalcolando (rispetto a quanto già pubblicato 36) il valore del PREI sui tre transetti (già indagati nel 2019-2021) risulterebbe uno stato ecologico “sufficiente” (valore di 0,539).
35 I descrittori utilizzati nel calcolo del PREI sono quelli relativi alla sola stazione intermedia, oltre a tipo e profondità del limite inferiore
36 https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-acque-marino-costiere-della-toscanatriennio-2019-2021
Tabella 32: stato ecologico per l’EQB P. oceanica (angiosperme) nei corpi idrici monitorati nel 2022- 24
Corpo idrico Prateria
Costa livornese Antignano
Costa di Rosignano Rosignano
Costa di Piombino Cala Moresca
Costa di Punta Ala Punta Ala
Costa dell’Albegna Foce Albegna
Costa dell’Argentario Argentario
Costa di Burano Ansedonia
Elba Nord
Arcipelago
Isola d’Elba
Elba Sud
Zona di prateria Anno RQE'18 RQE (PREI) Stato ecologico RQE (PREI) Stato ecologico
Zona (transetto) Prateria Corpo idrico (PREI)
Arcipelago
Isole Minori Capraia
Montecristo
Giglio
PA1-PA2 2024 0,5578 0,607 Buono 0,588 Buono Buono
PA3-PA4 2024 0,5510 0,601 Buono
PA5-PA6 2024 0,5028 0,557 Buono
PA1-PA2 2024 0,5846 0,631 Buono 0,669 Buono Buono
PA3-PA4 2024 0,5672 0,616 Buono
PA5-PA6 2024 0,7272 0,761 Buono
PA1-PA2 2024 0,5915 0,638 Buono 0,667 Buono Buono
PA3-PA4 2024 0,6459 0,687 Buono
PA5-PA6 2024 0,6338 0,676 Buono
PA1-PA2 2024 0,4024 0,466 Sufficiente 0,474 Sufficiente Sufficiente
PA3-PA4 2024 0,4102 0,473 Sufficiente
PA5-PA6 2024 0,4219 0,484 Sufficiente
PA1-PA2 2023 0,4164 0,479 Sufficiente 0,456 Sufficiente Sufficiente
PA3-PA4 2023 0,3762 0,442 Sufficiente
PA5-PA6 2023 0,3807 0,446 Sufficiente
PA1-PA2 2022 0,6753 0,714 Buono 0,734 Buono Buono
PA3-PA4 2022 0,7111 0,746 Buono
PA5-PA6 2022 0,7070 0,743 Buono
PA1-PA2 2023 0,5033 0,558 Buono 0,538 Sufficiente Sufficiente
PA3-PA4 2023 0,4874 0,543 Sufficiente
PA5-PA6 2023 0,4553 0,514 Sufficiente
PA1-PA2 2022 0,6978 0,734 Buono
PA3-PA4 2022 0,7930 0,821 Elevato
PA5-PA6 2022 0,6669 0,706 Buono
Buono
PA1-PA2 2022 0,6213 0,665 Buono 0,635 Buono
PA3-PA4 2022 0,5498 0,600 Buono
PA5-PA6 2022 0,5953 0,641 Buono
PA3-PA4 2023 0,6488 0,690 Buono
PA5-PA6 2023 0,6397 0,682 Buono
PA1-PA2 2022 0,8281 0,853 Elevato
PA3-PA4 2022 0,8434 0,867 Elevato
0,862 Elevato
PA1-PA2 2023 0,6463 0,688 Buono 0,687 Buono Buono (0,740)
PA5-PA6 2022 0,8413 0,865 Elevato
PA1-PA2 2023 0,5460 0,596 Buono 0,671 Buono
PA3-PA4 2023 0,6320 0,675 Buono
PA5-PA6 2023 0,7047 0,741 Buono
Considerando nel loro complesso i valori dell’indice PREI nelle 12 praterie monitorate nel triennio 2022-2024 (Tabella 32), lo stato di conservazione migliore si ha in quella dell’Isola di Montecristo, che risulta in stato ecologico elevato, rispetto alle altre due praterie di Capraia e Giglio, appartenenti al medesimo corpo idrico dell’Arcipelago - Isole Minori e monitorate nel 2023, che ricadono in uno stato ecologico buono.
Le praterie di Porto S. Stefano (Costa dell’Argentario), Elba Nord ed Elba Sud (Arcipelago Isola d’Elba) hanno un indice PREI tra 0,64 e 0,75 al quale corrisponde uno stato ecologico buono, ma se per l’Isola d’Elba questo giudizio è una conferma (buono anche nel 2019-21), rappresenta un peggioramento per l’Argentario che era elevato nel precedente triennio (PREI = 0,791). Analogo peggioramento si registra per Ansedonia (Costa di Burano) che passa da buono a sufficiente e per Arcipelago - Isole Minori da elevato a buono a causa di valori significativamente più bassi rispetto al passato di Montecristo e Capraia.
Confrontando i valori del PREI nel corso degli ultimi 4 trienni (Tabella 33) si osserva che:
• alcune praterie (Antignano, Capraia e Giglio) sono in progressivo peggioramento nei valori assoluti anche se non sempre questo determina il passaggio allo stato ecologico di qualità inferiore;
Tabella 33: stato ecologico per l’EQB P. oceanica nei corpi idrici costieri della Toscana dal 2013 al 2024 37
Corpo idrico Prateria
Rosignano
Punta
dell’Argentario
Isole Minori
• la prateria di Punta Ala è sicuramente in graduale peggioramento nel periodo 20132024, ma il confronto con il PREI ricalcolato sui 3 transetti nel triennio 2019-2021 mostrerebbero un valore già ricadente nello stato ecologico “sufficiente” (0,539);
37 Si ricorda che fino al 2021 il calcolo del PREI è stato basato su 1 solo transetto per ogni area di prateria, mentre nel triennio 202224 è stata calcolata la media tra 3 transetti
• vi è un netto peggioramento rispetto al 2019-21 per le praterie dell’Argentario, e di Ansedonia che passano, rispettivamente, da elevato a buono e da buono a sufficiente;
• la prateria di Rosignano sembra essere in progressivo miglioramento, avendo raggiunto stabilmente la qualità buona con valori nettamente più elevati nell’ultimo triennio, con un valore più basso nel transetto più a Nord e più vicino alla fonte di impatto rappresentata dalla Solvay, via via crescente allontanandosi verso Sud;
• le praterie dell’Isola d’Elba sono stabili nel corso di questi 12 anni, così come quella di Montecristo, mentre a Cala Moresca si è registrata molta variabilità nei diversi descrittori pur restando sempre nello stato ecologico buono.
Come detto (par. 1.3.5), l’habitat a coralligeno, per quanto non inserito tra gli EQB utilizzabili per la valutazione dello stato ecologico (D.M. 260/2010 e ss.mm.ii.), è previsto dalla strategia marina (D.Lgs. 190/2010) ed ARPAT da molti anni lo ha mantenuto all’interno dei propri obiettivi in materia di monitoraggio marino costiero.
Purtroppo, però, la scarsità di risorse e la difficoltà di queste specifiche attività di indagine (fondamentalmente attraverso operatori subacquei) e di riconoscimento delle componenti vegetali e animali del popolamento a coralligeno non hanno permesso di mantenere una frequenza di monitoraggio costante ed uniforme nelle diverse aree della costa Toscana.
Gli sforzi sono stati concentrati sulle zone con coralligeno di parete, rispetto a quello di piattaforma, più raro e più difficilmente raggiungibile con le immersioni, oltre alle attività legate al recupero ambientale (ripristino di habitat) conseguente l’incidente della nave Costa Concordia, alla cui relazione finale si rimanda per le specifiche risultanze.
Tabella 34: valore dell’indice ESCA per i popolamenti a coralligeno di parete della Toscana tra 2008 e 2018
Sud (Porto Azzurro)
Pur essendo un quadro disomogeneo, i valori dell’indice ESCA che è stato possibile calcolare fino ad oggi, indicano (Tabella 34) che i popolamenti a coralligeno presenti lungo le coste delle isole dell’Arcipelago Toscano tra 2008 e 2018 hanno una qualità ambientale migliore rispetto a quelli della costa continentale, dove le scogliere del Romito (Costa livornese) e del promontorio di Piombino presentano i valori più bassi (classe sufficiente).
A titolo esemplificativo, sottoponendo i risultati del 2018 (l’anno più recente) a tecniche di analisi statistica multivariata per la semplificazione dei dati e distinguere tra le principali differenze significative a livello specifico tra i 3 popolamenti (Romito, Argentario e Capraia) attraverso l'analisi delle componenti principali (PCA = principal component analysis) possiamo evidenziare che sono nettamente distinti:
• in quello del Romito prevalgono le alghe incrostanti ed il corallo (Corallium rubrum) probabilmente per la maggior torbidità dell’acqua e alla presenza di numerose nicchie lungo la parete verticale;
• a Capraia il popolamento è molto più differenziato e tipico del coralligeno in un buono stato ecologico, prevalendo alghe dei generi Palmophyllum, Pseudoclorodesmis, Flabellia e Peyssonnelia;
• all’Argentario il popolamento è leggermente sbilanciato verso la parte animale (Paramuricea) con un feltro (“turf”) di alghe rosse calcaree, che resiste meglio all’azione abrasiva del sedimento in occasione delle mareggiate, vista la zona molto esposta all’idrodinamismo.
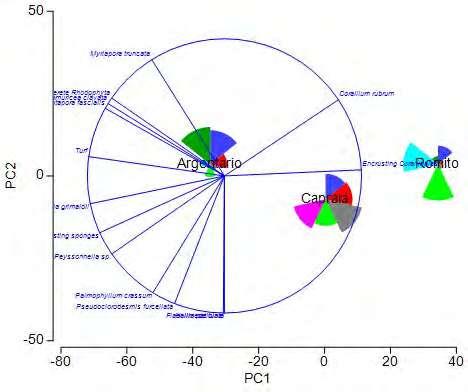
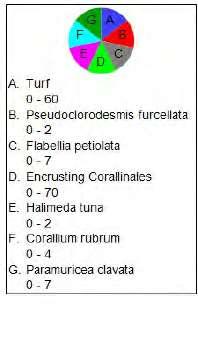
In generale, poi, si osserva una sostanziale stabilità nel corso degli anni (per quei pochi popolamenti oggetto di monitoraggi ripetuti e/o continuativi per più anni) con qualche eccezione (Meloria e Pianosa).
Per quanto riguarda il netto peggioramento della classe ecologica tra 2008 e 2009-10 dei popolamenti della Meloria, sembra che i cambiamenti possano essere dipesi sostanzialmente da una maggior proliferazione della componente macroalgale bentonica (feltro) che ha comportato:
• il ricoprimento del substrato con diminuzione della visibilità degli organismi animali, nonostante la copertura percentuale sia rimasta relativamente costante;
• la riduzione della luce disponibile, l’aumento della torbidità e l’abrasione del substrato; • l’inibizione della crescita di alghe erette come Halimeda tuna.
Per aggiornare e completare la valutazione dei popolamenti a coralligeno di parete lungo le coste della Toscana, è stato programmato, nel triennio 2025-27, un piano di monitoraggio suddiviso per zona geografica e tipologia ambientale come di seguito descritto:
• 2025 – Zona Nord, confronto tra ambienti simili (secche e isole) e valutazione possibili impatti antropici (Livorno-Secche Meloria e Rosignano-Secche di Vada: Secche di Vada, Secche della Meloria, Gorgona, Capraia e Romito);
• 2026 – Zona Centrale, confronto tra promontori, ambienti insulari e impatti locali: Promontorio di Piombino, Romito, Elba e Pianosa;
• 2027 – Zona Sud, definizione di valori di riferimento e confronto tra insularità e secche: Giglio, Giannutri, Montecristo, Secche delle Formiche, Secche Canale di Mezzo o Argentario, Romito (per continuità temporale).
Complessivamente, nel 2024, sono stati analizzati 68 campioni per la determinazione qualiquantitativa del fitoplancton (frequenza bimestrale) nelle 17 stazioni di monitoraggio e sono stati identificati 337 taxa a diverso raggruppamento tassonomico (Tabella 35).
Tabella 35: categorie tassonomiche individuate per ciascun raggruppamento principale
Raggruppamento
Nel 2024 l’abbondanza del fitoplancton ha avuto un andamento diverso per le tre componenti principali (diatomee, dinoflagellati e altro fitoplancton), ma con caratteristiche stagionali abbastanza tipiche delle acque costiere del Mediterraneo settentrionale (Figura 14), con picchi nei periodi primaverile (maggio/giugno) e inizio autunno (settembre/ottobre) per le diatomee e aumenti dei dinoflagellati nella tarda primavera inizio estate.
La componente principale del popolamento è mediamente costituita dall’altro fitoplancton (72%) e dalle diatomee (20%), mentre i dinoflagellati rappresentano circa un 8%, percentuali analoghe a quelle degli anni precedenti dello stesso triennio.
Nel 2024 sono state rinvenuti un massimo di 137 taxa (Costa di Burano) e un minimo di 59 (Costa di Rosignano), come già avvenuto lo scorso anno, mentre la densità cellulare media
più alta è pari a 6,5×106 cell/l (Costa del Serchio) e la più bassa è di 1,0×105 cell/l Elba Sud (Arcipelago - Isola d’Elba). La concentrazione fitoplanctonica media è stata inferiore a 3,0×105cell/L nella maggior parte (14 su 17) stazioni della costa toscana, ma si distaccano nettamente Costa del Serchio e Costa pisana e Costa livornese, con densità superiori a 1,6×106cell/L.
Più in generale, il triennio 2022-2024 vede un numero di taxa che va da un massimo di 251 (Costa del Serchio) a un minimo di 167 (Costa Rosignano). Le concentrazioni medie più alte sono state 7,4×106 e 2,9×106 cell/L, rispettivamente in Costa del Serchio e Costa pisana, la più bassa, 1,2×105 cell/Lin Arcipelago Isola d’Elba. La relazione tra questi due variabili, numero taxa e densità cellulare media (Figura 15) indica come le stazioni di Costa del Serchio e Costa pisana si differenzino dalle altre stazioni per numero di taxa e densità cellulare con valori alti di entrambe le variabili; stessa cosa ma con bassi valori vale per la stazione Costa Rosignano.

Figura 14: densità media mensile delle principali componenti fitoplanctoniche in Toscana tra 2022 e 2024
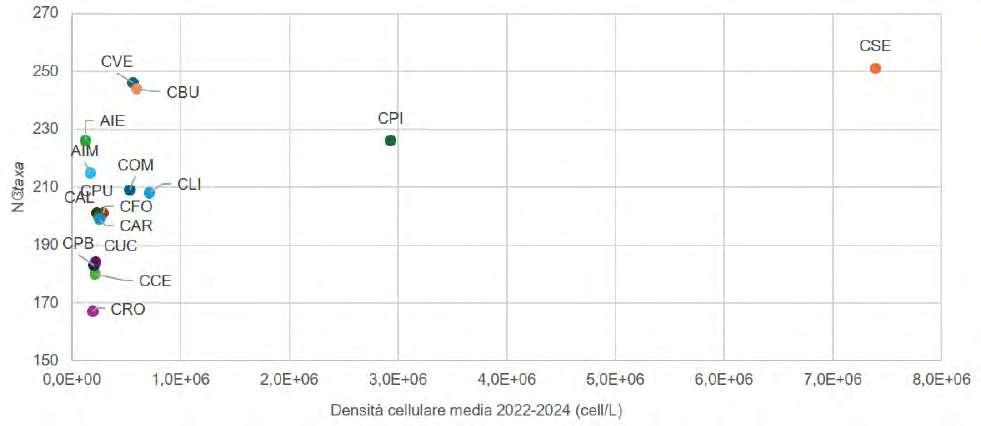
Figura 15: relazione tra il numero delle specie e densità cellulare per corpo idrico nel triennio 2022-24
In particolare, nella stazione di Nettuno (Figura 16) sono state rilevate le densità fitoplanctoniche maggiori di 1,0×106 cell/L in 9 campagne di monitoraggio sulle 16 condotte tra il 2022 e il 2024 e le tre con le densità più alte (da 5,3×106 a 7,5×106 cell/L), sono caratterizzate da un popolamento in cui i cianobatteri rappresentano dal 51 al 95 %. In tutti e tre i casi il picco è dovuto alla presenza del genere Merismopedia e in modo minore dalle specie Planktolyngbya limnetica e Pseudanabaena limnetica. Molto particolare poi la presenza della specie Prynmesium parvum rinvenuto a marzo 2022 (72.651 cell/l), dicembre 2023 (402.571 cell/l) e febbraio 2024 (345.808 cell/l): nel caso del 2024 è stata rilevata infatti una fioritura di questo organismo all’interno del Lago di Massaciuccoli (campionamento del 29/1/2024 con 21.034.000 cell/l).
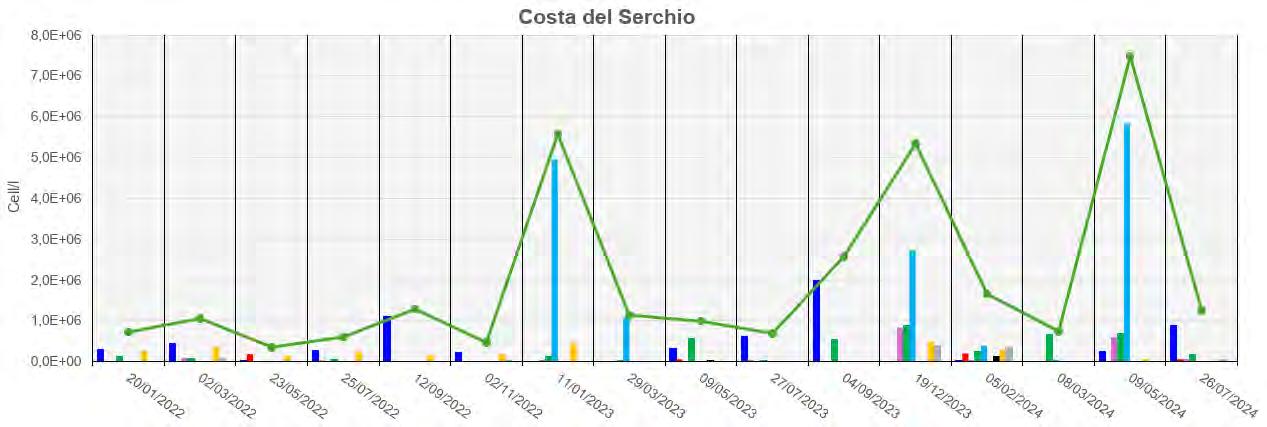
Figura 16: densità fitoplanctoniche nella stazione di Nettuno (Costa del Serchio) tra 2022 e 2024
In definitiva, la presenza di Prynmesium parvum e di cianobatteri, rilevate nel punto di Costa del Serchio, caratteristici del popolamento del Lago di Massaciuccoli fa ritenere che il punto di campionamento sia fortemente influenzato da quest’ultimo le cui acque arrivano tramite
il Canale Burlamacca (emissario del Lago di Massaciuccoli) all’interno del Porto di Viareggio e non lontano dalla stazione di monitoraggio.
Tutti gli altri picchi fitoplanctonici sono dovuti alla presenza di diatomee: Thalassiosira gravida, Cyclotella catenata e Chaetoceros socialis a settembre del 2022; Skeletonema pseudocostatum, Leptocylindrus danicus, Chaetoceros socialis e Chaetoceros curvisetus a settembre 2023; Skeletonema pseudocostatum, Leptocylindrus danicus e Chaetoceros wighamii a luglio 2024.
La concentrazione più alta di fitoplancton del triennio lungo la costa toscana è stata rilevata a Fiume Morto nel maggio del 2023 con 1,0×107 cell/L dovuta alla presenza di Pseudonitzschia spp. del “Nitzschia delicatissima Complex”, Chaetoceros socialis e criptoficee.
Per descrivere meglio la ricchezza tassonomica è stato scelto di utilizzare l’indice di Menhinick (S/√N), come indicatore di eutrofizzazione nelle acque costiere 38 39: i corpi idrici con un valore più basso di indice e, quindi, con un possibile squilibrio trofico risultano (Figura 17) Costa del Serchio e Costa pisana con valori rispettivamente di 0,09 e 0,13; Costa livornese e Costa dell’Ombrone presentano valori di 0,25 e 0,29, mentre nell’Arcipelago Isola d’Elba e arcipelago Isole Minori hanno valori più bassi ci sono i valori più alti rispettivamente 0,64 e 0,52; tutti gli altri presentano valori analoghi compresi tra 0,31 e 0,42 .
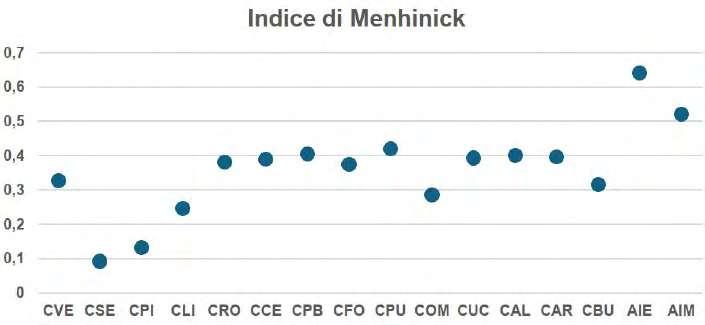
Figura 17: indice di ricchezza specifica di Menhinick - triennio 2022-2024
Per quanto riguarda i taxa maggiormente rappresentati in questo triennio, molti sono gli organismi di piccole dimensioni (<10µm), come coccolitoforidei, criptoficee, gymnodiniales, dinoflagellati e flagellati indeterminati. Tra le diatomee le più frequenti sono pennate indeterminate, Cylindrotheca closterium, Leptocylindrus danicus, Proboscia alata e Thalassionema nitzschiodes, mentre tra i dinoflagellati Heterocapsa niei, Scrippsiella acuminata e Lessardia elongata (Figura 18).
38 Spatharis, S.; Tsirtsis, G., Ecological quality scales based on phytoplankton for the implementation of Water Framework Directive in the Eastern Mediterranean. Ecol. Indic. 2010, 10, 840–847
39 Bužančić, M. et al., Eutrophication influence on phytoplankton community composition in three bays on the eastern Adriatic coast Oceanologia. 2016, 58,302-316.

Figura 18: taxa maggiormente presenti lungo le coste toscane. Triennio 2022-2024
I dati analizzati a partire dal 2010 mostrano quanto già più volte espresso ossia che la maggiore densità fitoplanctonica è tipica delle aree più a Nord della Toscana, area più ricca di nutrienti in rapporto alle portate fluviali (Figura 19).
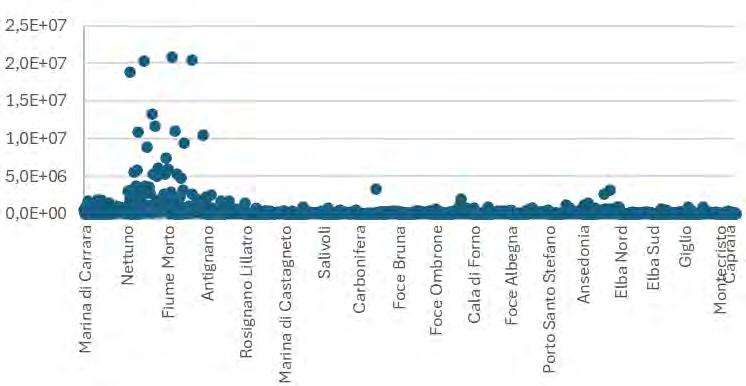
Figura 19: densità cellulare di fitoplancton totale dal 2010 al 2024 in Toscana
Da notare che nel corso degli anni si assiste a un aumento consistente dell’altro fitoplancton rappresentato soprattutto dalle forme più piccole, di dimensioni <10µm non determinate, da cryptoficee e coccolitoforidi, e conseguente riduzione della componente delle diatomee. Si individuano quindi tre periodi: dal 2010 al 2015 le diatomee rappresentano il 90-80% del
popolamento, nel periodo 2016-2021 il 60-50% fino ad arrivare al 30% del triennio 20222024 (Figura 21).
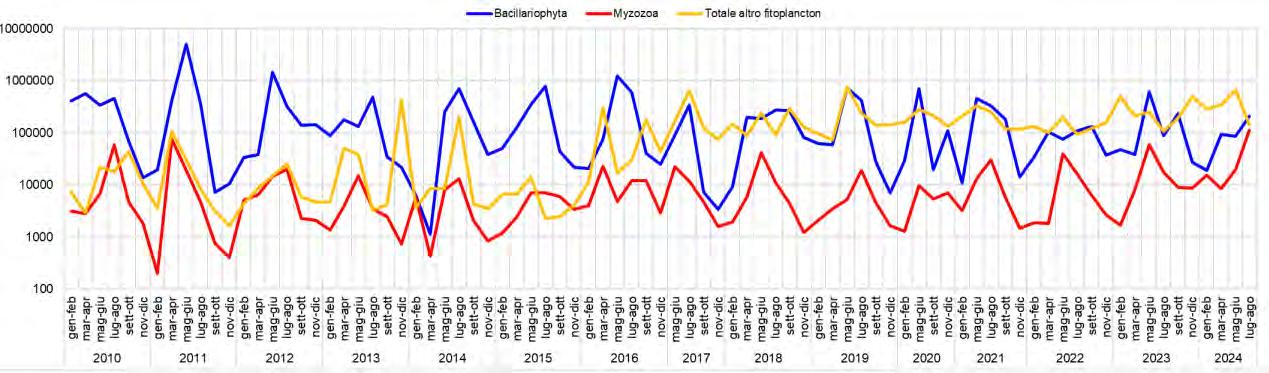
Figura 20: medie bimestrali delle tre maggiori componenti di fitoplancton (cell/l) nelle acque costiere della Toscana tra il 2010 ed il 2024
L’aumento dell’altro fitoplancton e dei dinoflagellati con dimensioni inferiori a 20µm (quest’ultimi passano dal 2% del periodo 2010-2021 al 5% dell’ultimo triennio) e la diminuzione della componente delle diatomee potrebbe essere dovuto ad una minor stabilità della colonna d’acqua dovuta all’innalzamento delle temperature che in acque oligotrofiche determina un maggior accrescimento delle specie più piccole di fitoplancton.
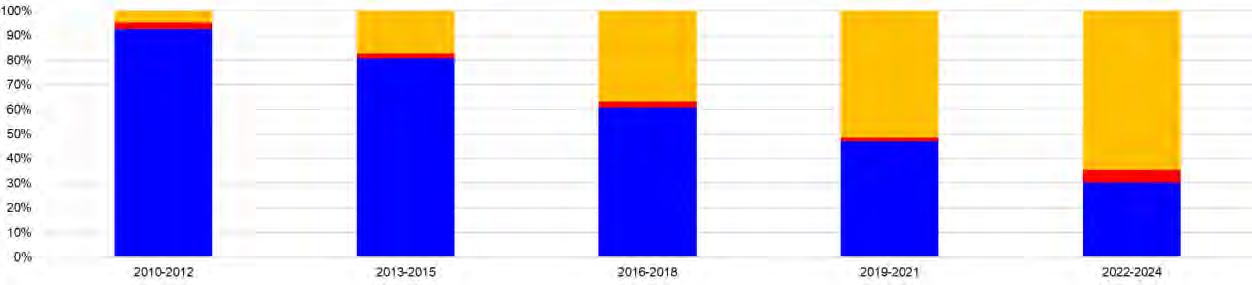
Figura 21: Composizione media dei popolamenti fitoplanctonici (nelle 3 maggiori componenti) nelle acque costiere della Toscana nei 5 trienni dal 2010 al 2024
Esaminando la composizione media dei popolamenti fitoplanctonici nel periodo 2010-2024 nelle singole stazioni di monitoraggio (Figura 22) si nota che:
• nella zona a Nord le Bacillariophyta sono la componente principale (65-81%);
• i Cyanobacteria sono presenti quasi esclusivamente in corrispondenza della stazione di Nettuno (20%) e in minima parte alla foce dell’Ombrone (0,4%);
• le Cryptoficee sono presenti lungo tutta la costa in particolare nell’area del Golfo di Follonica (48%), Cala di Forno (26%) e nelle due stazioni dell’Elba (18-24%);
• le Haptophyceae sono maggiormente rappresentate nelle Isole Montecristo e Capraia (20%);
• la componente altro fitoplancton indeterminato è maggiore del 50% in Elba Sud, Capraia e Montecristo.
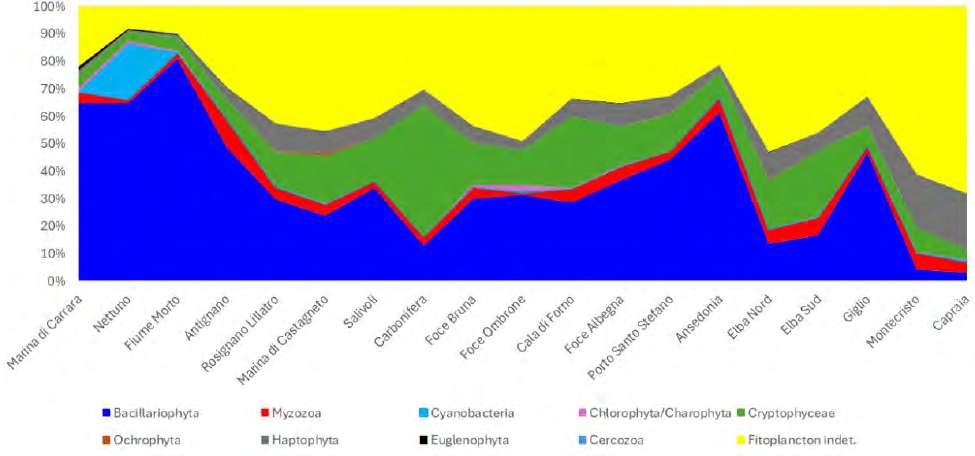
Figura 22: composizione dei popolamenti fitoplanctonici nelle acque costiere toscane (medie 2010- 2024)
La biomassa fitoplanctonica stimata sulla base delle concentrazioni di clorofilla “a” (chl-a) nei corpi idrici costieri della Toscana conferma sostanzialmente quanto già emerso nell’analisi del popolamento fitoplanctonico ossia che i valori più elevati, sia come media annuale sia come 90° percentile dei dati annuali (valore utilizzato per il calcolo di RQE) sia come massima concentrazione, si osservano (Figura 23) nelle stazioni della costa settentrionale e, in particolare, a Nettuno (Costa del Serchio).
La biomassa elevata e le fioriture algali nei periodi primavera-autunno (vedi par. 3.1.5), confermano l’importanza degli apporti fluviali come fondamentale fattore di arricchimento per le acque costiere, altrimenti oligotrofiche. Infatti, nella parte più settentrionale della Toscana si concentrano le foci di Serchio e Arno, i 2 principali fiumi toscani, oltre a quelle di numerosi fossi e torrenti (Parmignola, Carrione, Lavello, Motrone, Magliano, Versilia, Fiumetto, Abate; ecc.) e dell’emissario del Lago di Massaciuccoli (canale Burlamacca).
In particolare, proprio quest’ultimo corso d’acqua (Burlamacca), che sfocia nella zona portuale e che trasporta le acque lacustri ricche di nutrienti, sostanza organica e biomassa fitoplanctonica, è la causa principale della elevata concentrazione di clorofilla nella zona di mare antistante il porto di Viareggio (stazione di “Nettuno”), come dimostra anche la particolare composizione del popolamento fitoplanctonico (vedi par. 3.1.5).
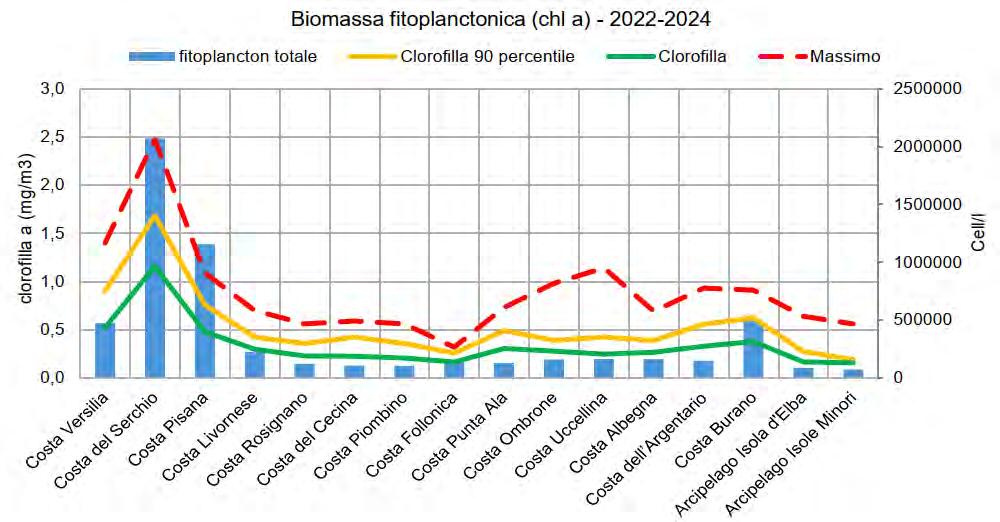
Figura 23: concentrazione di biomassa fitoplanctonica (chl-a) e del fitoplancton totale nei corpi idrici costieri (medie 2022-2024)
Gli apporti dal Lago di Massaciuccoli, per quanto in volume non paragonabile a quelli di un grande fiume, sono sicuramente impattanti in un tratto di acque marine (quelle del litorale versiliese) a basso fondale e scarso ricambio, tutte condizioni che possono favorire lo sviluppo di fitoplancton: come si vedrà in seguito, anche i dati di nutrienti (par. 3.1.8.3) e dell’indice TRIX (par. 3.1.8.2) sembrano confermare questa ipotesi.
Anche la valutazione dello stato ecologico conferma questa particolarità di Costa del Serchio, che è il solo corpo idrico della Toscana in qualità buona nel triennio 2022-2024 (Tabella 36), mentre tutti gli altri sono in stato elevato.
Allargando il confronto con i dati rilevati nei precedenti trienni (Tabella 37), la stazione di “Nettuno” è quella costantemente con le concentrazioni di biomassa fitoplanctonica più elevate di tutta la Toscana, con oscillazioni (annuali e triennali) probabilmente dipendenti dalle condizioni meteorologiche (precipitazioni), che mantengono lo stato tra sufficiente e buono, anche se sembrerebbe in progressivo aumento negli ultimi anni (da 1,4 mg/m3 nel 2016-18 a 1,6 nel 2019-21 e 1,7 mg/m3 Chl-a nel 2022-24).
Inoltre, si nota (Tabella 38) una progressiva diminuzione delle concentrazioni di clorofilla nella stazione antistante la foce del fiume Morto (Costa Pisana), che è un piccolo corso d’acqua, in parte artificiale, che scorre in gran parte nel territorio del Parco Naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e che è oggetto da tempo di interventi di risanamento ed adeguamento del sistema depurativo dell’area pisana, tali da aver probabilmente ridotto il carico trofico in arrivo al mare.
Tabella 36: biomassa fitoplanctonica (chl-a) e stato ecologico nelle acque costiere della Toscana nel 2022-24
Corpo idrico costiero Stazione
Costa Versilia Marina di Carrara
Costa del Serchio Nettuno
Costa pisana Fiume Morto
Costa livornese Antignano
Costa Rosignano Rosignano Lillatro
Costa del Cecina Marina di Castagneto
Costa Piombino Salivoli
Costa Follonica Carbonifera
Costa Punta Ala Foce Bruna
Costa Ombrone Foce Ombrone
Costa Uccellina Cala di Forno
Costa Albegna Foce Albegna
Costa Argentario Porto S.Stefano
Costa di Burano Ansedonia
Isola d'Elba Elba Nord
Isole Minori Giglio
Tabella 37: biomassa fitoplanctonica (chl-a) e stato ecologico nei corpi idrici costieri della Toscana nel periodo 2013-2024
Corpo idrico costiero
Dopo che nel triennio 2013-15 questo corpo idrico era addirittura in stato ecologico sufficiente (insieme a Costa del Serchio) nei successivi trienni (20216-18 e 2019-21) è migliorato a buono per risultare addirittura elevato nel 2022-24. Come detto (vedi par. 2.2),
però, questa stazione è da considerarsi poco rappresentativa della reale situazione delle acque costiere della Costa pisana, dove il principale fattore di pressione è sicuramente il Fiume Arno, che sfocia circa 6km più a Sud, dove verrà posizionata la nuova zona di monitoraggio a partire dal 2025.
3.1.7 Prima definizione dello stato ecologico
Sulla base dei risultati del monitoraggio 2022-24 sui 4 elementi di qualità biologica, macrozoobethos (M-AMBI), macroalghe (CARLIT), Posidonia oceanica (PREI) e biomassa fitoplanctonica (chl-a), si procede ad una prima definizione dello stato ecologico delle acque costiere della Toscana (Tabella 38), che verrà successivamente sottoposta alle verifiche di Fase I (vedi par. 0) e Fase II (vedi par. 0).
Tabella 38: stato ecologico sulla base dei soli EQB nei corpi idrici costieri toscani nel 2022- 2024
Corpo Idrico
Versilia
Legenda: NP= EQB non pertinente per questo corpo idrico; c.n.e. = campionamento non effettuato; ND = RQE non determinato
Per i popolamenti a macrozoobenthos (vedi par. 3.1.1) l’indice M-AMBI, nel triennio 20222024, classifica 9 corpi idrici in stato elevato (Costa livornese, Costa Rosignano, Costa del Cecina, Piombino, Follonica, di Punta Ala, dell’Ombrone, dell’Uccellina e dell’Argentario), 3 in buono (Costa dell’Albegna e di Burano e Arcipelago Isola d’Elba) e 1 (Arcipelago isole Minori) in sufficiente, ma quest’ultimo dato, relativo alla sola stazione di Capraia, non deve essere considerato per lo stato ecologico.
Rispetto agli anni precedenti si osserva un peggioramento per Costa dell’Albegna e Costa di Burano (da elevato scendono a buono)
La classificazione ecologica delle macroalghe della fascia intertidale (vedi par. 3.1.2) sulla base dell’indice CARLIT risulta essere elevata in 4 corpi idrici (Costa dell’Uccellina, Costa Argentario, Costa Burano e Arcipelago Isole Minori) e buona in 3 (Costa livornese, Costa Piombino e Arcipelago Isola d’Elba), confermando quanto già rilevato nei trienni precedenti. Lo stato ecologico delle praterie di posidonia (vedi par. 3.1.3.2) risulta sufficiente in 3 corpi idrici (Costa di Punta Ala, Costa dell'Albegna e Costa di Burano) e buono negli altri 6 dove è presente questo EQB. In particolare, si deve evidenziare un peggioramento di qualità ecologico sia per le praterie di Punta Ala e Ansedonia (Costa di Burano) che passano da buono nel triennio 2019-21 a sufficiente sia per quelle dell’Argentario e delle Isole Minori dell’Arcipelago che scendono da elevato a buono. In particolare, per queste ultime, pur restando nelle stesse classi singolarmente (buona per Capraia e Giglio; elevata per Montecristo), la diminuzione del valore di PREI in tutte le 3 praterie determina una media più bassa (0,740) per il corpo idrico nel suo complesso rispetto al 2019-21 (0,783) ed inferiore al livello di riferimento per la classe elevata (0,775).
I dati completi di biomassa fitoplanctonica (vedi par. 3.1.6), espressi come media del 90° percentile della concentrazione annuale di clorofilla “a” (chl-a), determinano uno stato ecologico elevato in quasi il 94% delle stazioni ed in 15 dei 16 corpi idrici, con la sola eccezione di Costa del Serchio in stato ecologico buono.
In definitiva, quindi, sulla base degli EQB monitorati nel 2022-2024, 6 corpi idrici costieri della Toscana risultano in stato ecologico elevato (37,5%), 7 in stato buono (43,7%) e 3 in classe sufficiente (18,8%).
3.1.8 Elementi di qualità fisico–chimica a sostegno e idromorfologici - Fase I
Gli elementi chimico fisici della Fase I di conferma dello stato ecologico sono quelli che occorrono per il calcolo dell'Indice Trofico TRIX e, cioè, l’ossigeno disciolto, la clorofilla a e i nutrienti, mentre tutti gli altri parametri sono utili solo per una interpretazione dei dati.
3.1.8.1 Temperatura, salinità e ossigeno disciolto
I profili verticali di temperatura e salinità servono per evidenziare la presenza di eventuali apporti di acque fluviali (dolci, generalmente più fredde e ricche di nutrienti e sostanza organica) o di altra provenienza (risalita di acque profonde, ecc.) e la stratificazione della colonna d’acqua che limita il rimescolamento. Entrambe queste condizioni, unitamente alla trasparenza e, quindi, alla penetrazione della luce solare, influiscono sullo sviluppo della biomassa fitoplanctonica, mentre i tenori di ossigeno disciolto sono una stima della produzione primaria (vedi indice TRIX) e, in alcune particolari circostanze, possono rivelare un’alterazione (anossia o ipossia) dell’ecosistema bentonico.
Le medie di temperatura e salinità superficiale (strato 0-10m) delle acque costiere toscane nei sei periodi di campionamento del triennio 2022-2024 (Tabella 39), mostrano variazioni imputabili ai fenomeni stagionali di evaporazione e precipitazione:
• acque molto più calde in estate, con medie comprese tra 23-25°C da luglio a settembre e valori massimi superiori ai 28-29°C, quando è massimo l’irraggiamento solare, la cui energia viene accumulata e mantenuta più a lungo in mare, rispetto all’atmosfera ed alla superficie terrestre, tanto che a fine anno ancora si superano i 18°C come a primavera inoltrata (maggio-giugno);
• minimi di temperatura (14-15°C) e di salinità (<37.8) che si raggiungono solo ad inverno inoltrato (tra gennaio e marzo), dopo che le acque marine hanno ceduto tutto
il calore estivo anche negli strati più profondi e sono progressivamente aumentate le precipitazioni e, di conseguenza, gli apporti fluviali.
Tabella 39: medie di salinità, temperatura e ossigeno disciolto nello strato superficiale (0-10m) della colonna d’acqua nel periodo 2022-2024
Ovviamente, i valori di salinità più bassi e, in generale, quelli inferiori a 38 ppt 40 si ritrovano solo nei corpi idrici influenzati dai principali corsi d’acqua della Toscana (Tabella 40): Costa della Versilia (Fiume Magra e vari torrenti), del Serchio (Fiume Serchio e Canale Burlamacca), pisana (Fiume Arno), di Punta Ala Fiume Bruna) e dell’Ombrone (Fiume Ombrone). In particolare, l’influenza del Canale Burlamacca, emissario del Lago di Massaciuccoli, sulla stazione di monitoraggio di Costa del Serchio (Nettuno) ha fatto registrare valori anche inferiori ai 30ppt, con la salinità media più bassa di tutta la Toscana (<36ppt), per quanto si debba sempre ricordare che attualmente l’apporto dell’Arno viene misurato solo in modo molto diluito alla foce del Fiume Morto (Costa pisana).
Per quanto riguarda l’ossigeno disciolto nelle acque superficiali, i valori massimi coincidono con il periodo primavera estate (maggio giugno), cioè quando si ha la combinazione tra concentrazioni di nutrienti ancora relativamente elevate (per effetto delle precipitazioni sugli apporti fluviali) con un sufficiente irraggiamento solare che permette la massima produzione fotosintetica da parte del fitoplancton e, quindi, la sovrasaturazione (OD>100%).
In tarda estate le precipitazioni generalmente scarse e, di conseguenza, l’assenza di apporti da terra, unitamente ad una netta stratificazione delle acque marine che impedisce la risalita di acque meno oligotrofiche, fanno progressivamente scendere i valori di OD%. Via via che la luce solare diminuisce andando verso l’inverno, diventa un fattore limitante la fotosintesi e la produzione netta di ossigeno si riduce ancora.
40 La salinità media del Mar Mediterraneo occidentale e, in particolare, del bacino tirrenico è sempre >38ppt
Tabella 40: medie di salinità nell'intera colonna d'acqua dei diversi corpi idrici costieri tra 2022 e 2024
Corpo idrico costiero Stazione
Costa Versilia
Costa Rosignano
Costa del Cecina Marina di Castagneto
Costa Piombino
Costa Punta Ala
Ombrone Foce Ombrone
Costa Uccellina
Costa Albegna
Isola d'Elba
Arcipelago Isole Minori
3.1.8.2
In generale nelle acque costiere toscane le concentrazioni di sostanze fosforate disciolte (P-PO4) sono molto basse e quasi sempre al di sotto del limite di quantificazione del metodo (0,2 µmol/l), probabilmente a causa di una fosforo-limitazione della biomassa fitoplanctonica, rispetto ad una relativamente maggiore disponibilità di sali azotati, cosicché le piccole quantità vengono immediatamente assimilate dalle cellule microalgali. Anche nel triennio 2022-24 si conferma questa generale oligotrofia ed i soli valori significativi sono quelli misurati nella stazione di Nettuno (Costa del Serchio), per gli apporti del Canale Burlamacca. Il fosforo totale (P-tot), che, come detto (par. 1.3.6), oltre alla componente disciolta, comprende anche tutte le forme particellate inorganiche (detriti) e organiche (fitoplancton), risulta un indicatore più efficace a valutare il reale trofismo di queste acque. Le concentrazioni medie annuali sono più alte nei corpi idrici più settentrionali della Toscana (Tabella 41), probabilmente a causa dell’apporto di sostanza organica da parte dei corsi d’acqua maggiormente presenti in questa zona. In particolare, in Costa del Serchio si registra il valore più alto di fosforo totale 1,2µmol/l del triennio con un progressivo aumento da 2022 al 2024, forse a causa di un ritorno ad anni più piovosi dopo la grande siccità del 2022-23.
Tabella 41: Concentrazioni medie annuali di fosforo totale (P-tot) e ortofosfato (P- PO4) nel 2022- 2024
Corpo idrico
Costa della Versilia
del Serchio
pisana
Costa livornese
Costa di Rosignano
Costa del Cecina
Costa di Piombino
Costa di Follonica
Costa di Punta Ala
Costa dell'Ombrone
Costa dell'Uccellina
Costa dell'Albegna
Costa dell’Argentario
Costa di Burano
Isola d'Elba
Isole Minori
Ampliando il confronto ai dati elaborati (come medie annuali per singolo corpo idrico) dal 2013 ad oggi (Figura 25), le concentrazioni delle sostanze fosforate lungo la costa toscana risultano essere sempre molto basse, con l’eccezione di due anni in particolare, il 2013 ed il 2019, nei quali i corpi idrici più settentrionali (Costa Versilia, del Serchio e pisana) hanno mostrato degli aumenti significativi: ad esempio in Costa pisana si sono raggiunti i massimi di tutto il periodo considerato con valori di fosforo totale rispettivamente di 2,1 e 3,2µmol/l.
Inoltre, a partire dal 2017 le concentrazioni di fosforo totale e, in minor misura, di ortofosfato aumentano progressivamente in Costa del Serchio: da un valore medio di fosforo totale di 0,6µmol/l nel 2017 si arriva nel 2024 allo stesso valore del 2019 di 1,2µmol/l.
Anomalo, infine, il dato di Costa dell’Uccellina del 2020 con un valore medio di fosforo totale di 1,3µmol/l, rispetto a valori sempre <0.5 negli altri anni, dovuto essenzialmente ad una concentrazione molto elevata nel mese di settembre (5,3µmol/l), probabilmente legata ad una situazione meteorologica locale.
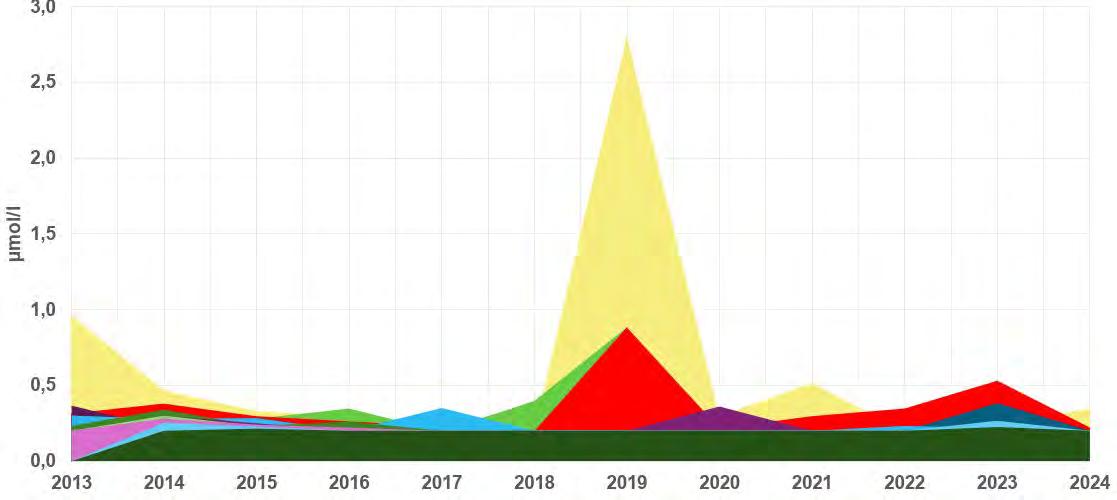
24: Concentrazioni medie annuali di ortofosfato (P-PO4) nei corpi idrici costieri della Toscana tra 2013 e 2024
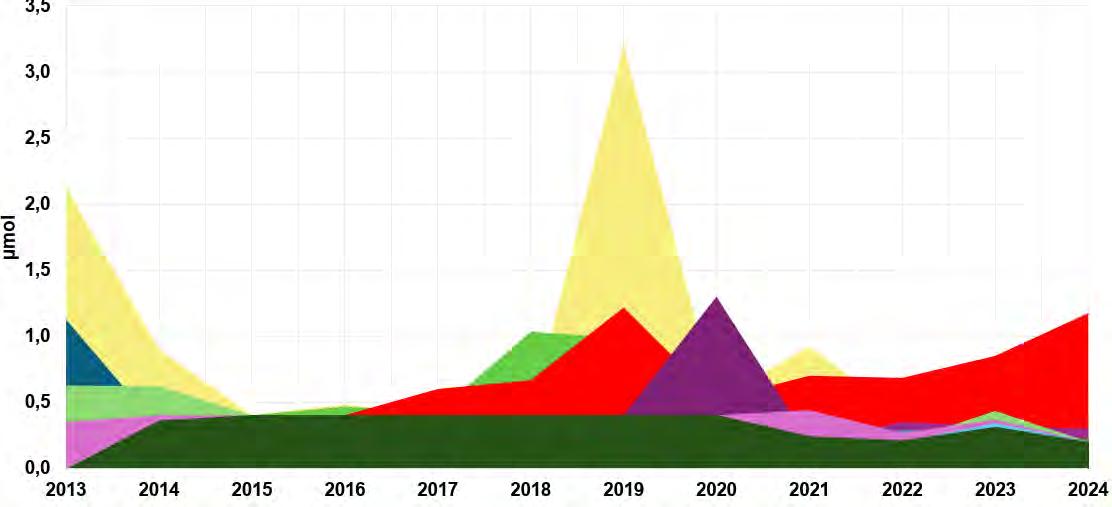
Figura 25: Concentrazioni medie annuali di fosforo totale nei corpi idrici costieri della Toscana tra 2013 e 2024
Le componenti azotate ricercate sono l’azoto totale (N-tot) e le sue forme disciolte di azoto nitroso (N-NO2), nitrico (N-NO3) e ammoniacale (N-NH3): la somma di queste tre
componenti solubili, chiamata DIN (Dissolved Inorganic Nitrogen), viene utilizzata nel calcolo dell’indice trofico TRIX.
Come già evidenziato per il fosforo, anche i nutrienti azotati raggiungono le medie più elevate di tutta la costa Toscana (tabella 42) nella parte più settentrionale e, in particolare, nella stazione di Nettuno (Costa del Serchio): 20,4 µmol/l di nitrati nel 2023, 5 volte maggiore rispetto a quella del 2022; 1,1 µmol/l N-NO2 nel 2023; 6,5 µmol/l N-NH3 nel 2024; 74µmol/l di azoto totale nel 2024. Le maggiori concentrazioni nella zona Nord sono confermate anche dall’analisi dei singoli prelievi (Figura 26), che evidenziano anche alcuni casi di aumento (meno evidenti nel calcolo della media annuale) in prossimità delle foci dei Fiumi Bruna e Ombrone.
Tabella 42: Concentrazioni medie annuali dei composti azotati nel 2022-2024. Valori massimi in azzurro.
Versilia
del Serchio
Oltre alla costa Nord della Toscana, gli unici altri casi di aumenti significativi sono legati, con ogni probabilità, ad apporti straordinari di acque in uscita dalla Laguna di Orbetello attraverso i Canali di Nassa (Laguna di Ponente) e di Ansedonia (Laguna di Levante), che possono rispettivamente aver influenzato la stazione di Porto S. Stefano (5,4 µmol/l N-NO3 a Costa dell’Argentario nel 2022) e di Costa Burano (50,3 µmol/l di N tot nel 2023), mentre un discorso a parte va fatto per l’azoto totale a Salivoli (Costa di Piombino).
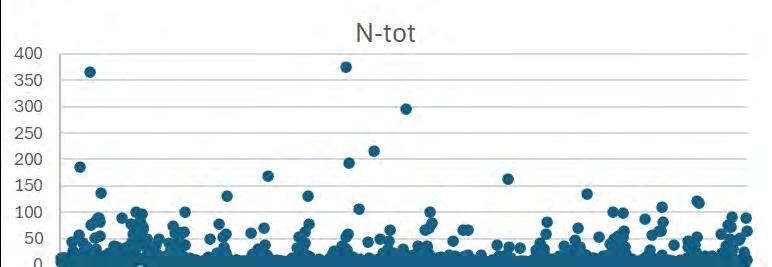
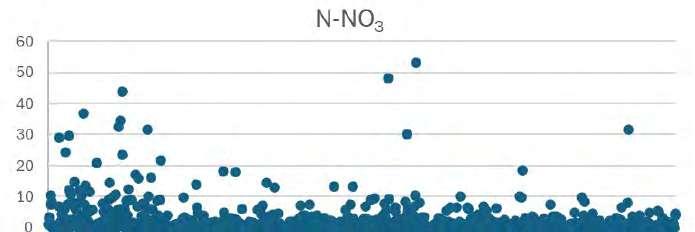
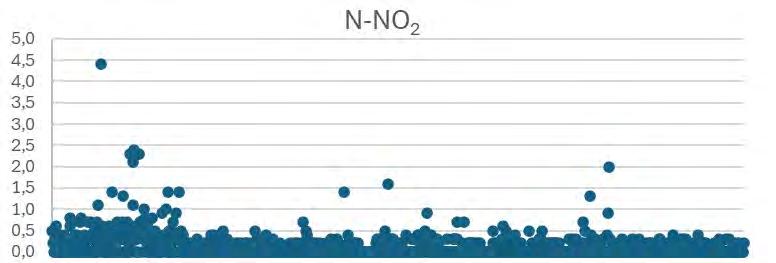
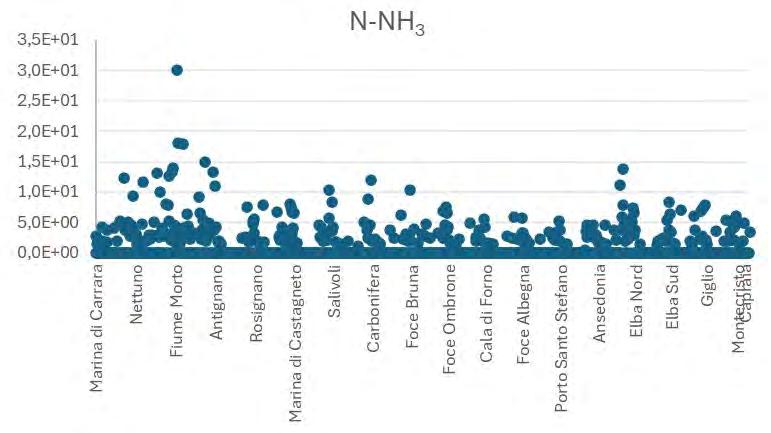
26: Concentrazioni medie (µmol/l) delle varie componenti azotate nel periodo 2013-2024
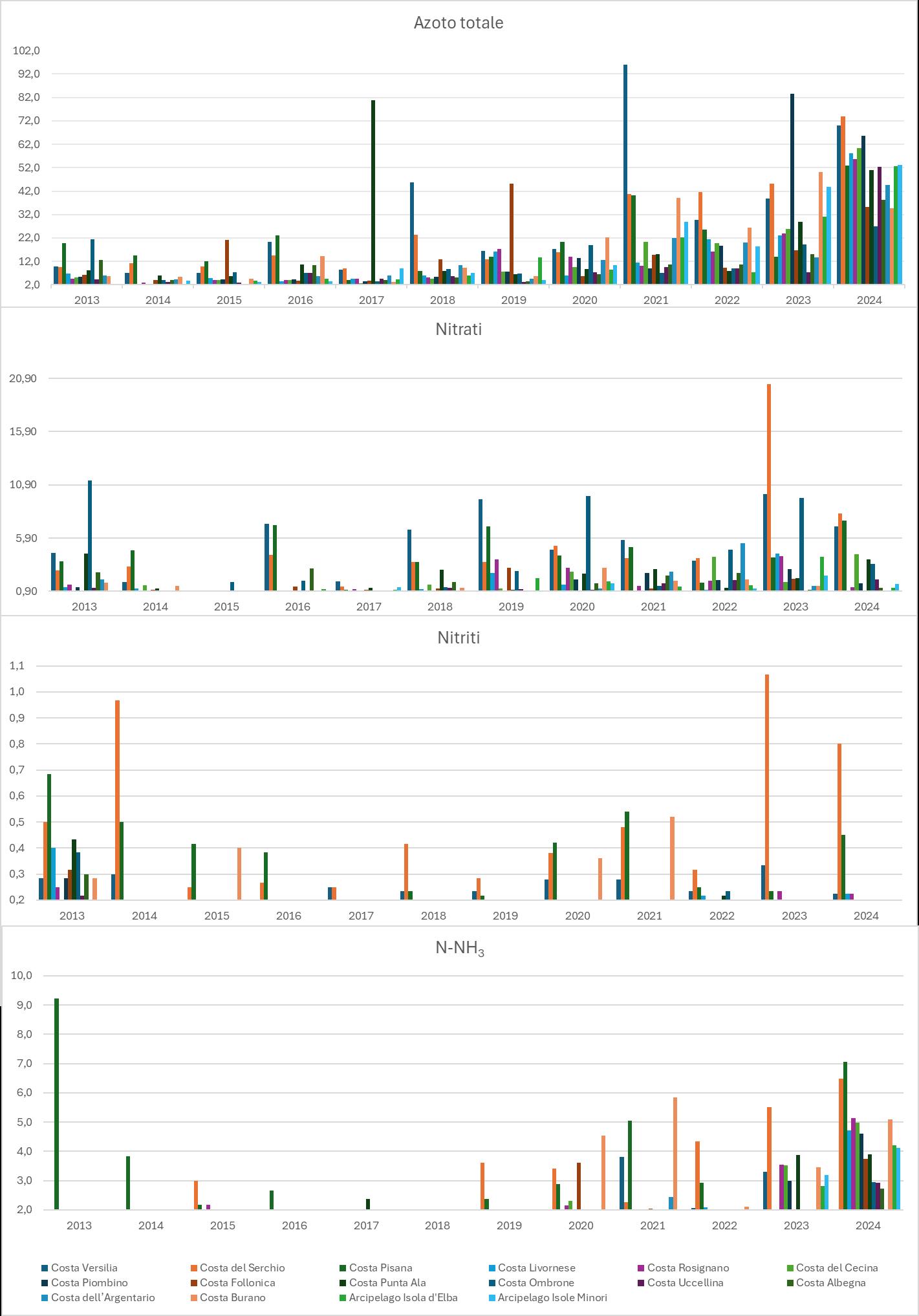
27: concentrazioni medie annuali (µmol/l) delle varie componenti azotate tra 2013 e 2024
La costa di Salivoli è caratterizzata da un’ampia spiaggia chiusa da un lato dal porto turistico “Marina di Salivoli” e dall’altro dal promontorio della zona urbana di Piombino, con acque basse e interessate dall’apporto del Rio Salivoli. Proprio questo piccolo corso d’acqua che, come meglio descritto in altra pubblicazione 41, veicola a mare anche una parte dei reflui urbani degli agglomerati che attraversa, potrebbe aver influito su alcuni valori molto elevati di azoto totale (375 µmol/l il 18/9/2023; 193 µmol/l il 10/05/2024) rilevati a mare e probabilmente legati a sostanza organica e contaminazione fecale.

Figura 28: concentrazioni medie annuali (µmol/l) di azoto nitrico (N-NO3), ammoniacale (N-NH3) e totale (Ntot) e fosforo totale (P-tot) a Costa del Serchio tra 2013 e 2024
Tabella 43: test Mann – Kendall sulle concentrazioni medie annuali di azoto nitrico (N-NO3), ammoniacale (N-NH3) e totale (N-tot) e fosforo totale (P-tot) a Costa del Serchio tra 2013 e 2024
Parametro
Più in generale dal 2013 ad oggi si assiste a un aumento in tutti i corpi idrici toscani delle componenti azotate e in particolare dell’azoto totale (Figura 27): l’aumento inizia a partire dal 2021, ma è il 2024 l’anno nel quale ci sono la maggior parte (59%) dei valori più elevati (N-tot >100µmol/l) e le minime aumentano da una media tra 2 e 7 µmol/l a 27µmol/l.
41 https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/rapporti-balneazione/il-controllo-delle-acque-dibalneazione-stagione-2023
L’aumento delle sostanze azotate è particolarmente evidente nei corpi idrici posti a Nord e in particolare in Costa del Serchio (Figura 28), che ha una tendenza positiva statisticamente significativa (Tabella 43). A conferma dell’ipotesi che tale arricchimento trofico dipenda dal Canale Burlamacca e, quindi, dal Lago di Massaciuccoli si riportano i dati dei nutrienti azotati rilevati nella stazione di “centro lago” del monitoraggio delle acque superficiali interne (rete MAS) tra il 2012 ed il 2024, che mostrano un’analoga tendenza (Tabella 44), con un incremento piuttosto evidente a partire dal 2022 (il 2020 non ha dati per molti parametri a causa dell’emergenza Covid) I motivi di tale aumento all’interno del Lago non sono ancora noti, ma è probabile che dipendano dai carichi sversati e dal dilavamento dei
Tabella 44: concentrazioni medie annuali (mg/l) dei composti azotati rilevate nella stazione MAS 650 del Lago di Massaciuccoli tra 2012 e 2024
Per quanto riguarda i silicati, i valori maggiori nel triennio 2022-2024 (Tabella 45) si registrano nelle stazioni posizionate nei corpi idrici di Costa del Serchio (16,6 µmol/l) e Costa dell’Ombrone (13,4 µmol/l) nel 2023.
Tabella 45: Concentrazioni medie annuali di silicati nel 2022- 2024 Corpo idrico
Arcipelago Isole Minori
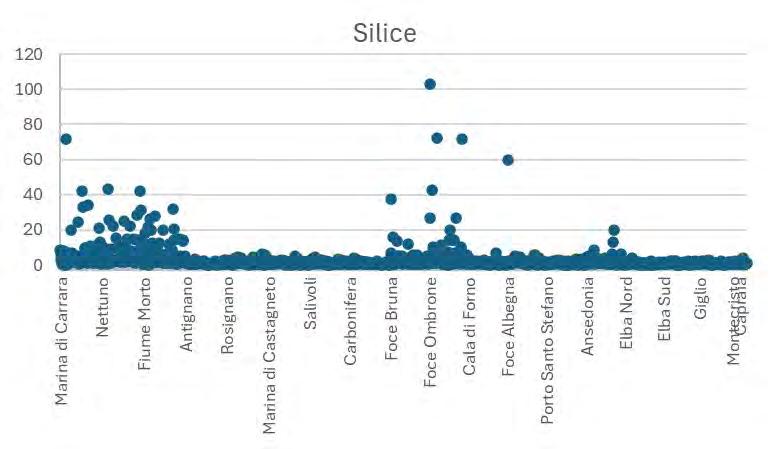
Figura 29: Concentrazioni in µmol/l dei silicati dal 2013 al 2024
Dall’analisi del set completo dei dati disponibili tra 2013 e 2024, si nota (Figura 29) come le concentrazioni di silicati possano essere messe in relazione alle portate fluviali con maggiori valori nell’area più settentrionale della Toscana e nell’area Bruna-Ombrone, come osservato per tutti gli altri nutrienti.
3.1.8.3 Indice Trofico TRIX
I valori dell'indice trofico TRIX indicano, in generale, una condizione di oligotrofia in tutte le acque marino costiere della Toscana, con alti tassi di ossigeno disciolto e basse concentrazioni di nutrienti, spesso al limite di quantificazione strumentale.
Nel 2024 i valori medi annuali (Tabella 46) superano il valore soglia per lo stato ecologico sufficiente nel corpo idrico di Costa pisana e Costa del Serchio, ma solo per quest’ultimo, la media 2022-24 di TRIX conferma il declassamento a sufficiente.
Analizzando i dati dal 2013 ad oggi vediamo (Figura 30) che Costa pisana e Costa del Serchio hanno molto spesso valori di TRIX maggiori di 4 (rispettivamente nel 42% e 58% delle medie annuali), rappresentando insieme oltre il 90% dei superamenti del limite di stato sufficiente, con le sole eccezioni di Marina di Carrara e Ansedonia nel 2021 (rispettivamente 4,7 e 4,1). Tutte le altre stazioni presentano per lo più valori di TRIX compresi tra 2 e 3 tra il 2016 e il 2021, con i minimi rilevati sempre nelle zone insulari, ma nel primo (2013-15) e nell’ultimo triennio (2022-24) il range dei valori sale tra 3 e 4.
Tabella 46: valori medi annuali dell'indice trofico TRIX 2022- 2024

30: medie annuali di TRIX nelle acque costiere della Toscana dal 2013 al 2024
Come era prevedibile, quindi, l’indice di stato trofico risente fondamentalmente dagli apporti di acque eutrofiche provenienti dai corsi d’acqua (fiumi e torrenti) e da altri corpi idrici (laghi e lagune), soprattutto laddove le caratteristiche morfobatimetriche della costa riducono il rimescolamento e la diluizione con le acque marine oligotrofiche (litorale apuo-versiliese e pisano). In particolare, l’influenza del Lago di Massaciuccoli e del Canale Burlamacca, suo emissario, sta determinando un preoccupante aumento della trofia delle acque davanti a
Viareggio (stazione di “Nettuno”), confermato da un trend statisticamente positivo significativo (test non parametrico di Mann-Kendall a due code = 98%).
Come detto (par. 1.3.7), nelle acque costiere della Toscana sono state ricercate quelle sostanze non appartenenti all’elenco di priorità (tabella 1/B del D.Lgs. 172/2015), delle quali si è ipotizzata la presenza in base a studi sulle pressioni ambientali.
Come accaduto sempre dal 2016, anche nel 2024 non si sono evidenziati superamenti degli SQA-MA per nessuna delle sostanze di sintesi ricercate e, le concentrazioni sono risultate al di sotto del limite di quantificazione (LOQ).
Per quanto riguarda, invece, i metalli, elementi cioè che possono anche essere presenti in concentrazioni elevate per caratteristiche naturali o storiche (vedi par. 1.4), si sono verificate due situazioni diverse.
Le concentrazioni di arsenico nelle acque marine dal 2016 ad oggi sono sempre state comprese tra 1 e 5µg/l, con valori medi annuali tra 1 e 2,4µg/l (Costa Argentario 2018), ampiamente al di sotto del valore SQA-MA (5µg/l) ed anche il triennio 2022-2024 (Tabella 47), non fa eccezione.
Tabella 47: concentrazioni medie (µg/l) di arsenico e cromo nei corpi idrici costieri nel triennio 2022- 2024
Corpo idrico Stazioni
Il cromo ha nel tempo avuto una variabilità maggiore con valori misurati tra 1 e 10µg/l (Costa Burano) e medie annuali comprese tra 1 e 2,8µg/l (Costa Livornese 2023), ma fino al 2023 sempre inferiori al SQA-MA (4µg/l). Nel 2024 si è registrato un aumento di questo metallo nella maggior parte dei corpi idrici con valori fino a 27µg/l (Costa Burano) e medie annuali in ben 10 corpi idrici tra 5 e 11µg/l (Costa Rosignano), superando lo standard di qualità ambientale per questo metallo.
Il giudizio di Fase II pertanto sarà buono per i corpi idrici di Costa Versilia, Costa del Serchio, Costa Follonica, Costa Albegna, Costa Argentario, Costa Burano e Arcipelago Isole Minori. Tutti gli altri corpi idrici, a causa del superamento del SQA-MA del cromo, avranno un giudizio sufficiente e il loro stato ecologico finale sarà sufficiente. Sull’utilizzo dei dati 2024 dei metalli nelle acque marine e, quindi, del cromo per la valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici costieri ci sono alcune perplessità, che verranno meglio esposte successivamente per lo stato chimico (par. 3.2.1.1).
3.2 Stato chimico
Lo stato chimico, come detto (par. 1.4) viene determinato sulla base del confronto con gli SQA delle sostanze chimiche ricercate nelle acque e nel biota e, eventualmente, nei sedimenti (tabella 1/A e 2/A del D.Lgs. 172/2015 e All. B alla DGRT 264/2018).
3.2.1 Stato chimico nelle acque costiere
3.2.1.1 Metalli
Le concentrazioni di mercurio rilevate nel triennio 2022-2024 nelle acque marine della Toscana presentano valori medi compresi tra <0,01 e 0,06 µg/l (Tabella 48), con valori medi leggermente più alti in quest’ultimo anno di indagine. Lo standard di qualità ambientale per questo metallo è la concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA) su singolo campione (0,07 µg/l) e 3 stazioni risultano superare tale valore, come indicato nella tabella 49: Rosignano Lillatro nel 2023 (la concentrazione maggiore rilevata in questo triennio), Elba Nord nel 2023 e 2024 e infine Isola del Giglio nel 2022 e nel 2024. La concentrazione di 0,08 µg/l rilevata nella stazione di foce Albegna nel 2023 è da considerarsi conforme poiché, pur essendo maggiore del SQA-CMA, risulta essere, però, inferiore a quello riportato nello Studio sui valori di fondo - DGRT 1273/2016 (valore di fondo = 0,26µg/l).
Le concentrazioni di piombo nel 2024 risultano essere più alte rispetto a quelle rilevate negli anni precedenti con superamenti del SQA-MA nelle stazioni di Rosignano Lillatro, Marina di Castagneto, Foce Ombrone, Porto Santo Stefano, Elba Nord, Elba Sud e Giglio (Tabella 48), mentre non sono stati rilevati superamenti delle concentrazioni massime ammissibili (SQACMA) nei tre anni in esame.
Come per il piombo, anche per il cadmio è stato rilevato nel 2024 un aumento delle concentrazioni di questo metallo, con superamenti dello standard di qualità ambientale medio annuo a Salivoli e Foce Ombrone (Tabella 50). La concentrazione media rilevata nella stazione di Nettuno risulta, invece, conforme perché, pur eccedendo rispetto al valore del SQA-MA, è inferiore al valore di fondo (vedi Tabella 13), riportato nello Studio sui valori di fondo - DGRT 1273/2016 (valore di fondo = 0,3µg/l). Non sono stati rilevati superamenti delle concentrazioni massime ammissibili nei tre anni in esame (Tabella 51).
Tabella 48: concentrazioni medie (µg/l) di mercurio e piombo nelle acque
Corpo idrico
Costa della Versilia Marina di Carrara
Costa del Serchio Nettuno
Costa pisana Fiume Morto
Costa livornese Antignano
Costa di Rosignano Rosignano Lillatro
Costa del Cecina Marina di Castagneto
Costa di Piombino Salivoli
Costa di Follonica Carbonifera
Costa Punta Ala Foce Bruna
Costa dell'Ombrone Foce Ombrone
Costa dell'Uccellina Cala di Forno
Costa dell'Albegna Foce Albegna
Costa dell'Argentario Porto S. Stefano
Costa di Burano Ansedonia
Isola d’Elba Elba Nord
Elba Sud
Tabella 49: concentrazioni massime (µg/l) di mercurio e
Isole Minori Giglio
Tabella 50: concentrazioni medie annuali (µg/l) di cadmio e nichel
Corpo idrico
Isola d’Elba Elba
Isole Minori Giglio
Tabella 51: concentrazioni massime (µg/l) di cadmio e nichel acque costiere toscane nel
Nel 2022 non si evidenziano superamenti del nichel né come concentrazioni medie annue né come concentrazioni massime ammissibili; il 2023, invece, presenta superamenti dello standard di qualità, sia come valore medio, sia come concentrazione massima ammissibile: le concentrazioni medie annue superano SQA-MA nelle stazioni di Antignano, Cala di Forno, Porto Santo Stefano (tabella 50), mentre le concentrazioni massime ammissibili (SQA-CMA
= 34µg/l) sono superate a Antignano e Porto Santo Stefano (tabella 51). Nel 2024, come nel 2023, si hanno superamenti dello standard di qualità, sia come valore medio, sia come concentrazione massima ammissibile: le concentrazioni medie annue superano SQA-MA nelle stazioni di Antignano, Rosignano Lillatro, Marina di Castagneto, Salivoli, Carbonifera, Cala di Forno, Elba Nord e Elba Sud (tabella 50) mentre le concentrazioni massime ammissibili (SQA-CMA = 34µg/l) sono superate a Antignano, Rosignano Lillatro, Salivoli e Elba Nord (tabella 51).
Come già visto per il cromo (par. 3.1.9), i dati di quasi tutti i metalli ricercati nelle acque costiere della Toscana durante il 2024 presentano un aumento generalizzato nelle concentrazioni, tale da compromettere, in molti casi, lo stato chimico finale.
Riassumendo, infatti, oltre ai 9 corpi idrici che risulterebbero in stato ecologico sufficiente per i superamenti del cromo, rispetto a nessuno nel biennio 2022-23 né nei trienni precedenti, la situazione risulterebbe la seguente:
• per il mercurio solo 2 superamenti di SQA-CMA, come accaduto nel 2023 ed altre volte in passato, senza particolari aumenti di concentrazioni;
• per il piombo si sono avuti 7 superamenti di SQA-MA in 6 corpi idrici (2 all’Isola d’Elba) con concentrazioni molto più elevate di prima, tanto che il 90% dei campioni supera le medie più elevate del biennio 2022-23;
• in 3 corpi idrici ci sarebbero superamenti delle medie annuali di cadmio, ma in 1 caso sarebbe inferiore al valore di fondo, con un aumento delle concentrazioni nel 2024 per cui il 50% dei campioni supera i valori più elevati del biennio 2022-23;
• il nichel mostra superamenti di SQA-MA in 7 casi e di SQA-CMA in 4 corpi idrici, mentre in precedenza era successo in 2 casi solo nel 2023;
• per cromo, cadmio e piombo i superamenti del 2024 sono i primi rilevati dal 2012.
Tuttavia, è necessario riconsiderare l’attendibilità dei dati 2024 per i metalli alla luce di alcune circostanze eccezionali che si sono verificate in quest’ultimo anno del triennio di monitoraggio.
Oltre ad aver potuto prelevare solo la metà circa dei campioni in colonna d’acqua a causa della indisponibilità, da agosto 2024, della nostra imbarcazione, come già detto (pag. 46), nel corso dell’anno sono emersi alcuni inconvenienti tecnici sulla strumentazione analitica, che, oltre a determinare ritardi per fermo macchine o sostituzioni (da ICPMS a ICPTQ), si ritiene possano aver alterato in una certa misura ed in modo del tutto casuale la confrontabilità dei risultati rispetto ad un singolo campione e/o parametro.
Peraltro, queste possibili anomalie nei valori di concentrazioni misurati risultano aver interessato solo questi metalli a causa di problemi analitici; infatti, il mercurio, che, da anni ha una propria linea analitica con contenitori, metodi e strumenti dedicati, nel 2024 non ha mostrato alcun particolare incremento.
In relazione alle riflessioni di cui sopra, quindi, è stato ritenuto di non prendere in considerazione per la classificazione dello stato ecologico né dello stato chimico i dati per cadmio, cromo, nichel e piombo rilevati nel 2024 nelle acque marine della Toscana.
Nel caso ciò dovessero emergere anche nel 2025, primo anno del nuovo triennio, valori particolarmente elevati in assenza di problemi analitici, si rivaluterà tale decisione
3.2.1.2 TBT, IPA e altre sostanze prioritarie
Nel 2023 le concentrazioni medie (Tabella 52) del tributilstagno ed i suoi composti (TBT) sono state tendenzialmente più elevate nella zona più settentrionale della costa toscana, dove la presenza di insediamenti portuali (Marina di Carrara e Viareggio) rappresenta un fattore di potenziale inquinamento specifico, dato che sono sostanze persistenti e storicamente impiegate in vernici antivegetative. Lo scarso ricambio idrico ed i bassi fondali di questa zona possono aver diminuito il potere diluente delle acque marine rispetto ad altre aree portuali (Livorno, Piombino, Portoferraio).
Nel caso di Costa del Serchio, come già accaduto nel triennio 2019-21, viene superato lo SQA-MA in tutti e tre gli anni, ma non la concentrazione massima ammissibile. Nel 2024 si rileva il superamento del SQA-MA anche per la stazione di Fiume Morto.
Per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), sottoprodotti della combustione di combustibili fossili, materia inorganica e legname e, quindi, collegati alla produzione energetica (centrali termiche), al traffico veicolare (motori diesel e benzina) e ad alcune attività industriali (cokerie, produzione e lavorazione grafite, trattamento del carbon fossile).
Nella Tabella 1/A del D.Lgs. 172/2015 è previsto il monitoraggio di 5 diversi IPA nelle acque marine, tutti indicati come sostanze pericolose prioritarie, ma lo SQA-MA viene indicato solo per il benzo[a]pirene (BaP) 42, che, nel 2022, viene superato solo a Carbonifera (Costa di Follonica). Questo superamento è determinato, in pratica, da 1 solo campione (26 luglio 2022) sui 6 prelevati che presenta concentrazioni molto elevate di tutti gli IPA analizzati, arrivando a superare anche lo SQA-CMA nel caso del Benzo[g,h,i]perilene (0,0040 µg/l), del Benzo[b]fluorantene (0,100µg/l) e del Benzo[k]fluorantene (0,021µg/l).
La concentrazione di Benzo[g,h,i]perilene supera lo SQA-CMA (0,00082 µg/l) anche a Nettuno (Costa del Serchio) nel prelievo del 12/09/2022 (0,00140 µg/l) ed a Fiume Morto (Costa Pisana) il 12/03/2022 (0,00230 µg/l). Nel 2023 non sono stati rilevati superamenti degli standard di qualità ambientali. Nel 2024 sono stati rilevati superamenti del SQA-MA per il benzo[a]pirene nelle stazioni di Nettuno, Fiume Morto e Ansedonia (Tabella 52) e del SQA-CMA per Benzo[g,h,i]perilene a Fiume Morto il 09/05/2024 (0,0009 µg/l).
Il di-2-etilesilftalato (DEHP) è un plastificante molto utilizzato nella produzione industriale e pericoloso per l’ambiente e per la salute umana, la cui presenza in mare è legata agli scarichi industriali e, soprattutto, al rilascio da parte di materie plastiche (rifiuti), ma, per le sue stesse caratteristiche, permane a lungo e viene trasportato in zone anche non costiere. Questo composto nel triennio 2022-2024 è stato ritrovato in quantità rilevabili in molti campioni analizzati (presenza diffusa), ma la sua media annuale non ha mai superato lo SQA-MA, come era accaduto, ad esempio, alla foce dell’Albegna nel 2017 e nel 2020.
42 Vedi nota 11 alla Tabella 1/A del D.Lgs. 172/2015
Tabella 52: concentrazioni medie annuali (µg/l) di TBT, BaP e DEHP acque costiere toscane nel 2022-24
Corpo idrico Stazione
Costa della Versilia Marina di Carrara
del Serchio Nettuno
Costa pisana Fiume Morto
Costa livornese Antignano
Costa di Rosignano Rosignano Lillatro
del Cecina Marina di Castagneto
Costa di Piombino Salivoli
di Follonica Carbonifera
Costa Punta Ala Foce Bruna
Costa dell'Ombrone Foce Ombrone
Costa dell'Uccellina Cala di Forno
Costa dell'Albegna Foce Albegna
dell'Argentario Porto S. Stefano
N.B.: in rosso i valori >SQA
Per quanto riguarda tutte le altre sostanze ricercate (fitofarmaci, pesticidi e altri composti organoalogenati, ecc.), come accaduto nei due trienni precedenti, nel 2023 le concentrazioni sono sempre rimaste tutte ampiamente al di sotto degli standard di qualità ambientali e spesso anche dei limiti di quantificazione dei metodi di analisi.
Sulla base, quindi, delle sostanze di tabella 1/A D.Lgs. 172/2015 ricercate nelle acque, lo stato chimico relativo al triennio 2022-2024, considerando, come detto, non attendibili i dati 2024 di cadmio, nichel e piombo, risulterebbe buono (Tabella 53) in 7 dei corpi idrici toscani: Costa Versilia, Costa del Cecina, Costa di Piombino, Costa di Punta Ala, Costa dell'Ombrone, Costa dell'Uccellina e Costa dell'Albegna.
Tabella 53: sostanze superiori a SQA e stato chimico nelle acque costiere della Toscana nel 2022-24
Corpo idrico Stazione
Sostanze superiori a SQA Stato chimico >SQA-MA >SQA-CMA
Costa della Versilia Marina di Carrara Buono
Costa del Serchio Nettuno
Costa pisana Fiume Morto
benzo[a]pirene (2024) TBT (2022, 2023 e 2024)
benzo[g,h,i]perilene (2022) Non buono
benzo[a]pirene (2024) benzo[g,h,i]perilene (2022) Non buono
Costa livornese Antignano nichel (2023); TBT (2024) nichel (2023) Non buono
Costa di Rosignano Rosignano Lillatro mercurio (2023) Non buono
Costa del Cecina Marina di Castagneto Buono
Costa di Piombino Salivoli Buono
Costa di Follonica Carbonifera BaP (2022)
benzo[b]fluorantene (2022)
benzo[k]fluorantene (2022)
benzo[g,h,i]perilene (2022) Non buono
Costa Punta Ala Foce Bruna Buono
Costa dell'Ombrone Foce Ombrone Buono
Costa dell'Uccellina Cala di Forno Buono
Costa dell'Albegna Foce Albegna Buono
Costa dell'Argentario Porto S. Stefano nichel (2023) nichel (2023) Non buono
Costa di Burano Ansedonia
Arcipelago Isola d’Elba Elba Nord
benzo[a]pirene (2024) Non buono
mercurio (2023 e 2024) Non Buono Elba Sud
Arcipelago Isole Minori Giglio
3.2.2 Stato chimico nel biota
mercurio (2022 e 2024) Non buono
Nel triennio 2022-2024 sono stati prelevati e analizzati 44 campioni di biota (13 di molluschi e 31 nei pesci), cioè poco meno del 60% di quelli previsti dal piano di monitoraggio (9 di molluschi e 16 di pesci ogni anno, vedi Tabella 14). Infatti, nel 2022 sono stati raccolti solo 4 campioni di mitili e 4 di pesci, nel 2023, rispettivamente, 4 e 14 e nel 2024, invece, 5 e 13.
Tali carenze sono state determinate da difficoltà nel reperimento degli organismi in alcuni corpi idrici (pesci), sia nell’acquisto dei mitili sia nella scomparsa di quelli messi a stabulare in mare (per mareggiate o altre cause non determinate). A questo si è aggiunto il problema dell’approvvigionamento delle quantità necessarie nel caso dei popolamenti naturali di telline, tanto da rendere impossibile l’analisi.
3.2.2.1 Molluschi
Le concentrazioni rilevate in tutti i molluschi nel triennio 2022-2024 (Tabella 54) sono state sempre estremamente basse, molto inferiori agli SQA per tutte le sostanze ed inferiori al LOQ per fluorantene e benzo[a]pirene.
La sola eccezione è rappresentata dai mitili stabulati all’Isola d’Elba nel 2024, dove sono stati rilevati superamenti dell’SQA per benzo[a]pirene (33µg/kg) e fluorantene (37µg/kg). Questi superamenti, però, potrebbero non essere casuali dato che, analizzando i dati dal 2018 al 2024 nella stessa zona, si sono rilevati la maggior parte di valori misurabili (LOQ<x<SQA) per entrambe le sostanze che, al contrario, sono risultate quasi sempre <LOQ (1µg/kg) in tutti gli altri campioni e corpi idrici (ad esempio, l’87% dei valori di benzo[a]pirene). A tal proposito, bisogna ricordare che, per esigenze logistiche e di sicurezza, la stabulazione dei mitili di Elba Nord viene effettuata in una zona interna al Golfo di Portoferraio e antistante la Località di Schiopparello, molto distante da quella dove, ad esempio, si effettua il monitoraggio della colonna d’acqua (davanti alla costa Nord di Portoferraio).
Le diossine (PCDD+PCDF+PCB-DL) risultano superiori allo standard di qualità ambientale solo in Costa Argentario nel 2017 (0,09 µg/kg) e nel 2021 (0,0069 µg/kg).
Tabella 54: concentrazioni (µg/kg) di diossine, fluorantene e benzo[a]pirene rilevate nei molluschi (biota) dei corpi idrici costieri nel 2022 - 2024 (vedi par. 1.4)
Corpo idrico Molluschi bivalvi
Costa del Serchio
Costa pisana
Costa livornese
Costa di Rosignano
Costa di Piombino
Costa di Follonica
Costa dell'Argentario
Arcipelago Isola d’Elba
Arcipelago Isole Minori
Telline
Mitili
Mitili
Mitili
Mitili
Telline = Donax trunculus; Mitili = Mytilus galloprovincialis
Legenda: c.n.e = campione non effettuato; a.n.e. = analisi non eseguita; in rosso i valori >SQA
3.2.2.2 Pesci
Il monitoraggio del bioaccumulo nei pesci (biota) campionati nel 2024 in 13 corpi idrici ha evidenziato (Tabella 55) concentrazioni superiori agli SQA in tutti i corpi idrici per il mercurio (Hg) e per i difenileteri bromurati (PBDE), confermando il dato degli anni precedenti, ma con una forte variabilità nelle concentrazioni tra anni e corpi idrici.
L’esaclorobenzene (HCB) risulta non conforme nel 2022 in costa del Cecina, nel 2023 in Costa di Follonica e Costa dell'Albegna e nel 2024 in Costa di Rosignano.
Il dicofol e l’esaclorobutadiene risultano conformi in tutti i corpi idrici indagati, con valori sempre al di sotto del LOQ (rispettivamente <0,1µg/kg e <10µg/kg).
Le concentrazioni dell’acido perfluorottansolfonico (PFOS) sono risultate durante tutto il triennio inferiori al LOQ (<1µg/kg) nella maggior parte dei corpi idrici (77%) o comunque inferiore all’SQA (20%): solo un campione (3%) prelevato nel 2024 in Costa del Serchio risulta superiore allo standard di qualità ambientale (rilevato 14,9µg/kg valore normalizzato 55µg/kg).
Le diossine ed i composti diossina simili (PCDF+PCDD+PCB-DL) risultano superiori allo standard di qualità ambientale in Costa Rosignano nel 2024 (Tabella 56), così come il DDT che supera lo SQA anche in Costa del Cecina nel 2022 e 2023 43
43 Diossine e DDT non necessitano di normalizzazione ed i relativi SQA, rispettivamente di 0,0065 e 50 µg/kg sono indipendenti dal livello trofico dell’organismo testato, come riportato nel paragrafo 1.4
Tabella 55: concentrazioni (µg/kg) di mercurio (Hg), difenileteri bromurati (PBDE) ed esaclorobenzene (HCB), rilevate nei pesci (biota) dei corpi idrici costieri nel triennio 2022-2024,
Corpo idrico
Costa Versilia c.n.e.
Costa Serchio c.n.e.
Costa pisana C. auratus 48 30 (<0,1)
Costa livornese
Costa Rosignano c.n.e.
ramada
cephalus 142 80 18
ramada 168 154 30
Costa Cecina C. ramada 238 186 58 C. ramada 33 74 24 C. ramada 426 5 8
Costa Piombino c.n.e. L. viridis 3150 1,2 22 M. cephalus 148 116 12
Costa Follonica c.n.e.
Costa Punta Ala c.n.e.
Costa Ombrone c.n.e.
Costa Uccellina c.n.e.
77 66 6
auratus 353 5,6 (<0,1) c.n.e.
C. auratus) 195 66 6
ramada 158 11 14 C. auratus 543 4 4
Costa Albegna c.n.e. C. ramada 184 16,2 28 C. ramada 467 8 6
Costa Argentario M. cephalus 290 1,5 0,8
Costa di Burano c.n.e.
135 68 4
ramada 84 174 20 c.n.e.
Arcipelago Isola d’Elba C. labrosus 48 9,2 (<0,1) c.n.e. c.n.e.
Arcipelago Isole Minori c.n.e. S. tinca 175 12,2 (<0,1) L. viridis 255 0 1,5 (<0,1)
valori calcolati dopo normalizzazione (vedi par. 1.4); in rosso i valori >SQA; c.n.e = campione non effettuato;
Per quanto riguarda il confronto con gli anni precedenti sia i costanti superamenti di Hg e PBDE sia l’assenza di criticità per la maggior parte delle altre sostanze sono caratteristiche già rilevate nel triennio 2019-21.
Risultano, invece, anomali le concentrazioni di esaclorobenzene, che, tra il 2017 e il 2021, sono state elevate e, spesso, anche superiori allo SQA in altri corpi idrici (Costa livornese, di Rosignano, del Cecina dell’Uccellina e dell’Argentario) rispetto a quelli del 2022-2024 (Costa del Cecina, Costa di Follonica e Costa dell'Albegna).
Un caso particolare, infine, è rappresentato dal PFOS, che, dopo aver avuto concentrazioni >SQA nella maggior parte dei corpi idrici tra 2017 e 2019, è progressivamente diminuito (nel 2020 sempre conforme e nel 2021 un solo superamento) fino a quasi scomparire nell’ultimo triennio (77% dei campioni <LOQ). Dall’analisi delle tendenze (vedi par.4.2) questo composto risulta avere un trend in aumento nella stazione di Rosignano.
Tabella 56: concentrazioni (µg/kg) diossine (PCDD, PCDF, PCB-DL) e DDT totale rilevate nei pesci (biota) dei corpi idrici costieri nel triennio 2022-2024, con evidenziati i valori >SQA
Corpo idrico
Costa Versilia c.n.e.
Costa Serchio c.n.e.
Costa pisana C.auratus
Costa livornese c.n.e. c.n.e. c.n.e.
Costa Rosignano
Costa Cecina C.ramada
Costa Piombino c.n.e.
L.viridis 0,0028 0,4 M.cephalus 0,0032 13,6
Costa Follonica c.n.e. c.n.e. c.n.e. C.auratus 0,0009 3,8 M.cephalus 0,0034 8,9
Costa Punta Ala c.n.e. c.n.e. c.n.e. C.auratus 0,0009 0,5 c.n.e. c.n.e. c.n.e.
Costa Ombrone c.n.e. c.n.e. c.n.e. c.n.e. c.n.e. c.n.e. C.auratus) 0,0036 8,9
Costa Uccellina c.n.e. c.n.e. c.n.e. C. ramada 0,0009 9,2 C.auratus 0,0007 0,7
Costa Albegna c.n.e. c.n.e. c.n.e. C.ramada 0,0023 8,9 C.ramada 0,0011 2,5
Costa Argentario M.cephalus 0,0019 3,4 C.auratus 0,0008 7,2 C.ramada 0,0023 3,3
Costa di Burano c.n.e. c.n.e. c.n.e. C.ramada 0,0037 26 c.n.e. c.n.e. c.n.e.
Arcipelago Isola d’Elba C.labrosus 0,0014 0,4 c.n.e. c.n.e. c.n.e. c.n.e. c.n.e. c.n.e.
Arcipelago Isole Minori c.n.e. c.n.e. c.n.e. S.tinca 0,0009 0,4 L.viridis 0,0030 0,4 valori calcolati dopo normalizzazione (vedi par. 1.4); in rosso i valori >SQA; c.n.e = campione non effettuato;
Purtroppo, come già detto (vedi pag. 48), a causa dell’indisponibilità di un mezzo nautico nella seconda metà del 2024, la prevista campagna di monitoraggio dei sedimenti marini non è stata effettuata ed i dati disponibili nel triennio sono solo quelli del 2022-2023, già oggetto di specifiche relazioni negli anni scorsi, ma che riportiamo qui in forma aggregata.
Dal punto di vista della composizione granulometrica si osserva (Tabella 57) una netta prevalenza (>90%) della componente più fine (peliti) nella maggior parte delle stazioni (1112), numero che aumenta ancora (14-15), considerando anche le stazioni di Ansedonia, Elba Nord e Piombino, dove la prevalenza di peliti è meno accentuata (60-80%).
A questo panorama di fondali marini ricoperti fondamentalmente da sedimenti fini fanno eccezione le stazioni di Rosignano, dove si ha una leggera prevalenza di sabbie (50-60%) rispetto alle peliti (40-48%) sia nel 2022 che nel 2023, mentre a Marina di Castagneto questa stessa caratteristica è emersa solo nel 2023.
Tabella 57: frazioni granulometriche nei sedimenti dei corpi idrici costieri nel 2022 -2023
Corpo idrico Stazione
pisana Fiume Morto
Costa di Rosignano Rosignano Lillatro
di Punta Ala Foce Bruna
dell'Ombrone Foce Ombrone
Inoltre, nelle 3 stazioni delle isole minori dell’Arcipelago Toscano si ha una prevalenza più netta di sabbie (65-85%), accompagnata in qualche caso da piccole percentuali di ghiaie Montecristo 9-23%; Capraia 6-9%), che, com’era prevedibile a queste distanze dalla costa, nel resto della costa toscana sono quasi assenti (<3%). Si tratta, infatti, di fondali localizzati generalmente a distanze superiori a 2km dalla linea di costa più vicina su profondità variabili tra 15 e 60m, dove, cioè, arrivano a depositarsi solo i sedimenti più fini (peliti).
Per quanto riguarda le sostanze ricercate nei sedimenti (Tabella 13), dobbiamo, innanzitutto, ricordare che per alcuni metalli sono stati definiti i valori di fondo naturale (Tabella 8) che sostituiscono gli SQA per molte delle stazioni di monitoraggio della Toscana. A questo proposito, infatti, anche dagli esiti del monitoraggio 2022-23 emergono delle situazioni ascrivibili in gran parte a fenomeni di arricchimento naturale e/o storico ed altre che, al contrario rivelano dei fattori antropici ancora in essere.
Del primo caso (anomalie geochimiche naturali o storiche), fanno sicuramente parte le concentrazioni di cromo totale che risultano (Tabella 58) superiori agli SQA nella maggior parte delle stazioni e, in alcuni casi, anche agli stessi valori di fondo. Questa generalizzata presenza di quantità elevate cromo nei sedimenti marini della Toscana è una caratteristica consolidata da molti anni (almeno dal 2016) che non sembra legata né ad una particolare composizione granulometrica né ad una conformazione di alcuni tratti di costa, come testimoniano i ripetuti superamenti dei valori di fondo, che possono essere determinati, però, dalla presenza nel campione analizzato di granuli contenenti questo metallo (cromiti).
Tabella 58: concentrazioni (mg/kg s.s.) di arsenico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), mercurio (Hg), piombo (Pb) ed esaclorobenzene (HCB) nei sedimenti marini della Toscana nel 2022-2023
Corpo idrico Stazione
Costa della Versilia Marina di Carrara
Costa del Serchio Nettuno
Costa pisana Fiume Morto
Costa livornese Antignano
di Rosignano Rosignano Lillatro
del Cecina Marina
Costa di Piombino Promontorio di Piombino
di Follonica Carbonifera
di Punta Ala Foce Bruna
dell'Ombrone Foce Ombrone
dell'Uccellina Cala di Forno
dell'Albegna Foce Albegna
dell'Argentario Porto S. Stefano
Valori di fondo Vedi Tabella 8 Vedi Tabella 8
Legenda: * = valori che superano gli SQA, ma inferiori ai valori di fondo della Tabella 8; in rosso i valori >SQA
Per quanto riguarda l’arsenico la situazione è leggermente differente perché, oltre a valori mediamente superiori agli SQA in gran parte dei sedimenti marini analizzati, emergono alcune situazioni particolari di concentrazioni superiori anche ai valori di fondo nel 2022 (Rosignano, Carbonifera, Eba Nord, Elba Sud e Giglio). Nel 2023 ciò accade solo per Elba Sud, dove anche altri metalli (cadmio, cromo e piombo) raggiungono le concentrazioni più elevate. Questa stazione (Elba Sud) e quella antistante il promontorio di Piombino, seconda per valori assoluti di arsenico, cromo e piombo, sono entrambe condizionate dalle anomalie geochimiche di queste coste, famose fin dall’antichità per la ricchezza di minerali del ferro ed oggetto di intensa attività estrattiva, i cui “scarti di produzione” si sono accumulati sui fondali marini circostanti, come ha anche accertato lo Studio di ARPAT sui valori di fondo (DGRT 1273/2016).
Per il mercurio (Hg), invece, vanno distinte le situazioni di arricchimento naturale rilevate nei sedimenti (Tabella 58) a Carbonifera, nella parte meridionale della costa toscana (da Cala di Forno ad Ansedonia) e a Elba Sud, con concentrazioni comprese tra gli SQA
(considerando anche la tolleranza del 20% 44) ed i valori di fondo, da quelle superiori ad entrambi di chiara influenza antropica. Infatti, come accaduto quasi sempre tra 2016 e 2021, nel 2022 e nel 2023 le stazioni di Antignano (Costa livornese) e di Rosignano Lillatro presentano valori ampiamente superiori a quelli di fondo naturale, confermando la presenza di una contaminazione determinata, con ogni probabilità, dagli scarichi dello stabilimento Solvay che hanno immesso in mare questo metallo, attraverso il fosso Bianco, fino ad almeno il 2007 in quantità tra 100 e 400kg/anno 45 .
Tra le altre sostanze ricercate, si deve sottolineare la presenza di alte concentrazioni, superiori all’SQA (0,4 µg/kg s.s.) di esaclorobenzene (HCB) nelle stazioni di Antignano (Costa livornese) e di Rosignano. Concentrazioni elevate (>SQA) di questo analita erano già state registrate negli anni precedenti (dal 2016 in poi, con la sola eccezione del 2022 appena al di sotto dello SQA), con valori massimi ad Antignano e, leggermente inferiori, a Rosignano, analogamente a quanto si osserva per il mercurio, caratteristica che fa ipotizzare una possibile comune fonte di contaminazione nello scarico a mare dello stabilimento Solvay (vedi sopra). Inoltre, in entrambe le stazioni le concentrazioni di HCB sembrano avere un trend di aumento progressivo (par. 4.1).
Tutte le altre sostanze previste dalle Tabella 2/A, 3/A e 3/B (TBT, antracene, naftalene, aldrin, α-, β-, γ-esaclorocicloesano, DDT, DDE e DDD, vari IPA, PCB e composti diossina-simili, ecc.), sono risultate inferiori agli standard ambientali e spesso al di sotto del limite di quantificazione ad eccezione della sommatoria T.E delle diossine, furani e PCB diossina simili nella stazione di Antignano (0,02µg/kg rispetto ad un SQA di 0,002 µg/kg)
3.4 Stato chimico del triennio 2022-2024
Mettendo insieme i risultati del monitoraggio dei contaminanti chimici nelle diverse matrici (acqua, pesci e molluschi) possiamo valutare lo stato chimico delle acque marino costiere delle Toscana nel triennio 2022-2024 (Tabella 64), tenendo conto, come detto, che i superamenti dei diversi SQA per cadmio, nichel e piombo rilevati nel 2024 nelle acque non sono stati ritenuti attendibili e, quindi, non sono stati considerati per la classificazione.
Per quanto riguarda le sostanze presenti nella colonna d’acqua (vedi par. 3.2.1), si sono rilevati superamenti rispetto ai diversi SQA nel 56% dei corpi idrici:
• nel caso dei metalli, escludendo, come visto (3.2.1.1), i dati rilevati nel 2024 per cadmio, cromo, nichel e piombo: il mercurio risulta superiore (>SQA-CMA) in 5 casi (Giglio 2022 e 2023, Rosignano 2023 ed Elba Nord 2023 e 2024) ed il nichel risulta superiore agli SQA in 2 corpi idrici nel 2023 (Costa livornese e Costa dell’Argentario e Arcipelago Isola Elba);
• concentrazioni di TBT superiori alla media annuale (SQA-MA) sono state rilevate costantemente in Costa del Serchio e in Costa livornese;
• i vari IPA risultano eccedere gli SQA in costa Pisana e Costa del Serchio nel 2022 (benzo[ghi]perilene) e nel 2024 (benzo[a]pirene), in Costa di Follonica nel 2022 (benzo[a]pirene, benzo[k]fluorantene, benzo[b]fluorantene e benzo[ghi]pirilene) ed in Costa di Burano nel 2024 (benzo[a]pirene).
44 Vedi nota
Tabella 59: sostanze superiori a SQA e stato chimico dei corpi idrici costieri della Toscana nel 2022-2024
Corpo idrico
Costa della Versilia
Costa del Serchio benzo[a]pirene (2024) TBT (2022, 23 e 24)
Acqua
benzo[g,h,i]perilene (2022)
Costa pisana benzo[a]pirene (2024) benzo[g,h,i]perilene (2022)
Costa livornese nichel (2023); TBT (2024)
Costa di Rosignano
Costa del Cecina
Costa di Piombino
Costa di Follonica benzo[a]pirene (2022)
Costa Punta Ala
Costa dell'Ombrone
Costa dell'Uccellina
Costa dell'Albegna
nichel (2023)
mercurio (2023)
benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[g,h,i]perilene (2022)
Costa dell'Argentario nichel (2023) nichel (2023)
Costa di Burano benzo[a]pirene (2024)
Arcipelago Isola d’Elba
Arcipelago Isole Minori
mercurio (2023 e 24)
mercurio (2022 e 24)
Biota (Pesci)
mercurio e PBDE (2023 e 24) Non buono
Mercurio e PBDE (2023 e 24)
PFOS (2024) Non buono
mercurio (2022 e 24)
PBDE (2022, 23 e 24) Non buono
mercurio (2024)
PBDE (2023 e 24) Non buono
mercurio e PBDE (2023 e 24) HCB (2024)
diossine (2024) DDT (2024) Non buono
mercurio e PBDE (2022,23 e 24) DDT (2022 e 23)
HCB (2022) Non buono
mercurio e PBDE (2023 e 24) Non buono
mercurio e PBDE (2023 e 24)
HCB (2023) Non buono
mercurio e PBDE (2023 Non buono
mercurio e PBDE (2024) Non buono
mercurio e PBDE (2023 e 24) Non buono
mercurio e PBDE (2023 e 24)
HCB (2023) Non buono
mercurio e PBDE (2022, 23 e 24) Non buono
mercurio e PBDE (2023) Non buono
mercurio e PBDE (2022) fluorantene (2024) (*) benzo[a]pirene (2024) (*) Non buono
mercurio e PBDE (2023 e 24) Non buono
Legenda: c.n.t. = campione non trovato dopo stabulazione; c.n.e. = campionamento non effettuato; NP = monitoraggio non previsto in questo corpo idrico; (*): analisi effettuata su mitili (biota)
I dati rilevati nel biota e, in particolare, nei pesci, come detto (vedi par. 3.2.2), rilevano alte concentrazioni (>SQA) di mercurio e PBDE in tutti i corpi idrici (100%) ed altri superamenti in:
• Arcipelago Isola d’Elba per fluorantene e benzo[a]pirene (molluschi 2024);
• Costa Rosignano (2024) e Costa del Cecina (2022 e 2023) per DDT;
• Costa Rosignano (2024), Costa del Cecina (2022), Costa Follonica (2023) e Costa dell’Albegna (2023) per l’esaclorobenzene (HCB);
• Costa del Serchio per il PFOS (2024);
• Costa di Rosignano (2024) per diossine e composti diossina simili.
2022-2024
In definitiva, integrando i risultati ottenuti dal monitoraggio delle acque e del biota nei 3 anni monitorati il 100% dei corpi idrici della Toscana (16) non raggiunge lo stato chimico buono a causa di valori superiori a quelli di riferimento (SQA) rilevati nel 17% (45 su 272) dei campioni analizzati nel triennio 2022-2024 per la matrice acqua e nel 73% (32 su 44) per il biota (pesci e molluschi).
Vista la disponibilità di dati di monitoraggio marino acquisiti secondo criteri ed indicazioni sostanzialmente stabili e uniformi da più di 10 anni, si può iniziare a fare una valutazione delle tendenze eventualmente mostrate dalle diverse sostanze inquinanti nelle principali matrici di indagine. In particolare, vista la caratteristica da parte di sedimenti e biota di integrare nel tempo i dati di concentrazione, con ambiti temporali diversi, sono state scelte queste due matrici per avviare questa valutazione, anche grazie al fatto che nel 2023 è stata pubblicata una linea guida nazionale per l’elaborazione dei dati di monitoraggio 46. L’analisi delle tendenze è stata, quindi, effettuata valutando la significatività dell’andamento dei valori di concentrazione nel tempo mediante l’applicazione di un metodo statistico non parametrico (Mann-Kendall) con un livello di significatività stabilito al 90%.
Ai fini di una valutazione delle tendenze sono stati presi in considerazione solo alcuni metalli ed altri contaminanti che nel corso degli anni hanno mostrato delle criticità (>SQA) o che hanno avuto concentrazioni significative (>LOQ) e variabili.
Per i sedimenti sono stati elaborati i dati dal 2010 (ove disponibili) fino al 2023 relativi alle concentrazioni di arsenico, cadmio, cromo, mercurio, piombo, esaclorobenzene (HCB) e TBT, ma sono stati riportati (Tabella 60) solo quei parametri che hanno mostrato una tendenza significativa (a 1 e/o 2 code) per ciascuna stazione. Dall’analisi delle tendenze risulta:
• arsenico: trend positivo in 4 stazioni (Foce Bruna, Cala di Forno, Ansedonia ed Elba Sud) tutte localizzate nella parte meridionale della costa toscana; trend negativo per Foce Ombrone;
• cadmio: un generale trend negativo in quasi tutti i corpi idrici toscani;
• cromo: trend positivo per 6 stazioni (Marina di Castagneto, Piombino, Carbonifera, Foce Bruna, Foce Albegna ed Elba Sud); trend negativo per Montecristo e Capraia;
• mercurio: trend positivo per 3 stazioni (Rosignano Lillatro, Foce Albegna e Ansedonia); trend negativo per 6 (Fiume Morto, Foce Bruna, Foce Ombrone, Elba Sud, Montecristo e Capraia);
• piombo: trend positivo per Piombino e Elba Sud; trend negativo per Montecristo e Capraia;
• tributilstagno e composti (TBT): trend negativo per 3 stazioni (Marina di Carrara, Nettuno e Carbonifera);
• esaclorobenzene (HCB): trend positivo per 5 stazioni (Antignano, Rosignano Lillatro, Piombino, Foce Bruna, Porto Santo Stefano); trend negativo per Foce Albegna.
46 ISPRA, 2023, “Linee Guida per la valutazione della tendenza a lungo termine delle sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi nei sedimenti e nel biota (Dlgs 172/2015)”. Manuali e linee guida 205/2023
Tabella 60: tendenze con trend significativo (test di Mann Kendall con probabilità al 90%) a una coda e a due code dei contaminanti chimici nei sedimenti marini della Toscana tra 2010 e 2023
Marina di Carrara
Fiume Morto
Lillatro
di Castagneto
Promontorio di Piombino
Carbonifera
Foce Bruna
Foce Ombrone
di Forno
Foce Albegna
Porto S. Stefano
Ansedonia
Montecristo
2013-22 8 -18 0,016 98,4 significativo
significativocromo 2013-22 8 -18 0,016 98,4 significativo 96,8 significativomercurio 2013-22 8 -14 0,054 94,6 significativo 89,2 Non significativopiombo 2013-22 8 -17 0,0235 97,7 significativo 95,3 significativo -
Capraia
cadmio 2013-23 10 -28 0,0065 99,4 significativo 98,7 significativocromo 2013-23 10 -17 0,078 92,2 significativo 84,4 Non significativomercurio 2013-23 10 -18 0,066 93,4 significativo 86,8 Non significativopiombo 2013-23 10 -19 0,054 94,6 significativo 89,2 Non significativo -
N = numerosità (anni) della serie ordinata dei campionamenti annuali dei sedimenti
S= somma algebrica delle differenze tra la concentrazione all’inizio della serie storica ordinata e quelle successive (coppie di dati), che potrà risultare -1 o +1, a seconda del segno di ciascuna differenza e 0 se nulla
MK = significatività dell’ipotesi nulla (assenza di tendenze) per la statistica di Mann-Kendall S (test a una coda)
Per quanto riguarda arsenico e cromo, cioè quei metalli che mostrano tendenze in aumento in vari corpi idrici, la spiegazione, nella maggior parte dei casi, è legata alla loro stessa presenza in concentrazioni elevate nei sedimenti marini per una diffusa anomalia geochimica naturale delle coste toscane, già messa in evidenza nello studio sui valori di fondo (vedi par. 1.4). Un caso esemplificativo sono sicuramenti i fondali tra il promontorio di Piombino e l’Isola d’Elba, dove si registrano le massime concentrazioni di questi due metalli
e del piombo per la nota presenza di minerali ferrosi (e industria estrattiva dall’antichità) e dove tutti questi appaiono in aumento.
Invece per l’esaclorobenzene (HCB), sostanza non presente in natura, la situazione è difficile da spiegare per le stazioni nella parte più meridionale (Piombino, Foce Bruna, Porto Santo Stefano), nelle quali, però, le concentrazioni molto spesso vicine al limite di rilevabilità (LOQ = 0,1 mg/kg s.s) possono aver influito sulla significatività della tendenza. Ciò, al contrario, non può essere vero per quelle di Antignano e Rosignano Lillatro, dove si hanno le massime concentrazioni nel 2022-2023 e si accoppiano a quelle del mercurio in un trend positivo: in questi 2 zone, infatti, sono già stati accertati dei fattori di contaminazione antropica (Solvay) dei sedimenti marini, nei quali, come visto in precedenza (par. 3.2.1), sia Hg che HCB hanno spesso superato gli SQA nel corso degli ultimi anni (talvolta anche nella colonna d’acqua) e per i quali si dovrebbe ipotizzare che siano fattori tutt’ora in atto o che il loro impatto sia molto prolungato nel tempo.
Infine, per le restanti aree con tendenza all’aumento di mercurio nei sedimenti marini (Foce Albegna e Ansedonia) è possibile che questa derivi dalla nota anomalia geochimica della maremma meridionale come riportato nello studio sui valori di fondo 47 , e dalle attività minerarie (in passato) e geotermiche (attuali) della zona dell’Amiata, i cui impatti potrebbero essere veicolati dal fiume Albegna e dai canali emissari della Laguna di Orbetello.
4.2 Biota (pesci)
Sono stati presi in considerazione i dati relativi alle concentrazioni di esaclorobenzene (HCB), PBDE, mercurio, DDT e diossine e composti diossina simili (PCDF+PCDD+PCB-DL) in campioni di pesci a partire dal 2017 (anno di inizio di questo tipo di monitoraggio) fino al 2024 e sono stati riportati (Tabella 61) solo i casi di trend significativo.
La maggior parte dei corpi idrici non presenta tendenze significative anche a causa della ridotta quantità di dati, dell’incertezza circa l’esatta zona di prelievo degli organismi e della variabilità nel corso degli anni anche rispetto all’areale di alimentazione dei singoli individui, ma si evidenzia che:
• il mercurio ha un trend positivo in Costa dell’Uccellina e Arcipelago Isole Minori
• il PBDE mostra un trend negativo in Costa pisana, Costa del Cecina e Costa dell’Albegna;
• l’esaclorobenzene presenta un trend negativo in Costa del Serchio, Costa livornese, Costa dell’Uccellina;
• Il DDT ha un trend negativo in Costa del Serchio, Costa pisana, Costa dell’Uccellina, Costa dell’Argentario, Arcipelago Isola d’Elba e Arcipelago Isole Minori
• la sommatoria delle diossine e composti diossina simili (PCDF+PCDD+PCB-DL) mostra un trend negativo nel corpo idrico Costa dell'Argentario;
• il PFOS mostra un trend negativo in Costa della Versilia, Costa livornese, Costa del Cecina e un trend positivo in Costa di Rosignano.
Tabella 61: tendenze con trend significativo (test di Mann Kendall con probabilità al 90%) a una coda e a due code dei contaminanti chimici nei pesci della Toscana nel periodo 2017-2024
Stazione
Costa Versilia PFOS
7 -11 0,068 93,2 significativo 86,4 Non significativo -
Costa del Serchio HCB 2017-24 7 -12 0,0515 94,9 significativo 89,7 Non significativo -
2017-24 7 -16 0,01 99,0 significativo 98,0 significativo -
-
Costa pisana
Costa Livornese HCB 2017-24 7 -15 0,015 98,5 significativo 97,0 significativoPFOS 2017-24 7 -12
Costa di Rosignano
Costa del Cecina PBDE 2017-24 7 -13 0,035 96,5 significativo 93,0 significativo -
Costa dell’Uccellina
-
2017-24 7 -11 0,068 93,2 significativo 86,4 Non significativomercurio 2017-24 7 13 0,035 96,5 significativo 93,0 significativo +
2017-24 7 -15 0,015 98,5 significativo 97,0 significativo -
Costa Albegna PBDE 2017-24 6 -9 0,068 93,2 significativo 86,4 Non significativo -
Costa Argentario diossine 2017-24 7 -11 0,068 93,2 significativo 86,4 Non significativoDDT 2017-24 7 -13 0,035 96,5 significativo 93,0 significativo -
Arcipelago Isola d’Elba DDT 2018-22 5 -8 0,042 95,8 significativo 91,6 significativo -
Arcipelago Isole minori mercurio 2017-24 6 13 0,008 99,2 significativo 98,4 significativo + DDT 2017-24 6 -12 0,018 98,2 significativo 96,4 significativo -
N = numerosità (anni) della serie ordinata dei campionamenti annuali dei sedimenti
S= somma algebrica delle differenze tra la concentrazione all’inizio della serie storica ordinata e quelle successive (coppie di dati), che potrà risultare -1 o +1, a seconda del segno di ciascuna differenza e 0 se nulla
MK = significatività dell’ipotesi nulla (assenza di tendenze) per la statistica di Mann-Kendall S (test a una coda)
Per il calcolo della tendenza del parametro diossine e composti diossina simili (PCDF+PCDD+PCB-DL) sono stati elaborati tutti i dati disponibili, inserendo anche quelli acquisiti con il monitoraggio delle acque a specifica destinazione per la vita dei molluschi.
In 5 dei 9 corpi idrici analizzati non ci sono tendenze significative, con valori per lo più stazionari, mentre negli altri 4 (Costa del Serchio, Costa pisana, Costa livornese e Costa di Follonica) è stato evidenziato (Tabella 62) un trend positivo, in particolare per quest’ultimo (Costa di Follonica) che ha più dati significativamente diversi (in aumento) rispetto al 2017.
Tabella 62: tendenze con trend significativo (test di Mann Kendall con probabilità al 90%) a una coda e a due code di PCDF+PCDD+PCB-DL nei molluschi della Toscana nel periodo 2017- 2024
Stazione Periodo N S MK Test 1 coda Trend 1 coda Test 2 code Trend 2 code Tendenza
Costa del Serchio 2018-24 10 16 0,093 90,7 significativo 81,4 Non significativo +
Costa pisana 2018-24 11 20 0,071 92,9 significativo 85,8 Non significativo +
Costa Livornese 2018-24 6 6 0,042 95,8 significativo 91,6 significativo +
Costa Follonica 2018-24 15 36 0,0415 95,9 significativo 91,7 significativo +
N = numerosità (anni) della serie ordinata dei campionamenti annuali dei sedimenti S= somma algebrica delle differenze tra la concentrazione all’inizio della serie storica ordinata e quelle successive (coppie di dati), che potrà risultare -1 o +1, a seconda del segno di ciascuna differenza e 0 se nulla MK = significatività dell’ipotesi nulla (assenza di tendenze) per la statistica di Mann-Kendall S (test a una coda)
Al termine del triennio 2022-2024 può essere eseguita la classificazione dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici marino costieri della Toscana, avendo completato il monitoraggio degli elementi di qualità biologica (EQB) che si svolge, come detto, con questa frequenza (1 volta ogni 3 anni) in ciascun corpo idrico.
Sia per lo stato ecologico che per quello chimico vale il principio di classificazione “One Out - All Out”, secondo il quale lo stato ecologico è determinato dal più basso dei giudizi riscontrati per i singoli EQB ed è sufficiente il superamento dello SQA di una sola sostanza per non raggiungere il buono stato chimico. Lo stato di qualità ambientale "buono" (obiettivo da raggiungere ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per tutti i corpi idrici) si raggiunge solo se stato ecologico e chimico sono in classe almeno buona.
5.1 Stato ecologico
Come abbiamo visto (Tabella 14), il solo EQB monitorato in tutte le 19 stazioni distribuite nei 16 corpi idrici toscani è stata la biomassa fitoplanctonica, perché per il macrozoobenthos, l’altro EQB presente in tutti i corpi idrici costieri della Toscana, sono venuti a mancare i campionamenti delle zone più a Nord previsti nel 2024, a causa dei problemi già esposti (vedi par. 3.1.1). Per macroalghe (macrofite) e Posidonia oceanica (angiosperme), invece, le caratteristiche naturali delle acque costiere della Toscana non consentono una copertura territoriale completa e questi popolamenti sono presenti solo in, rispettivamente, 10 tratti costieri appartenenti a 7 corpi idrici e 12 praterie (9 corpi idrici), tutti regolarmente monitorati nel 2022-24. In definitiva, quindi, tutti i 4 EQB sono stati monitorati nel triennio solo in 6 corpi idrici, con dati utilizzabili in 5 di questi, per il problema del macrozoobenthos a Capraia (vedi par. 3.1.1) e sintetizzando i risultati emersi (Tabella 63), possiamo evidenziare quanto segue:
• la biomassa fitoplanctonica (vedi par. 3.1.6) risulta in stato elevato in tutti i corpi idrici ad eccezione di Costa del Serchio (buono), probabilmente, a causa degli apporti del Canale Burlamacca (emissario del Lago di Massaciuccoli);
• per i popolamenti a macrozoobenthos (vedi par. 3.1.1) l’indice M-AMBI classifica 9 corpi idrici in stato elevato (Costa livornese, Costa Rosignano, Costa del Cecina, Piombino, Follonica, di Punta Ala, dell’Ombrone, dell’Uccellina e dell’Argentario), 3 in buono (Costa dell’Albegna e di Burano e Arcipelago Isola d’Elba), non considerando valido il valore (sufficiente) di Capraia (Arcipelago isole Minori);
• la classificazione ecologica delle macroalghe della fascia intertidale (vedi par. 3.1.2) sulla base dell’indice CARLIT risulta essere elevata in 4 corpi idrici (Costa dell’Uccellina, Costa Argentario, Costa Burano e Arcipelago Isole Minori) e buona in 3 (Costa livornese, Costa Piombino e Arcipelago Isola d’Elba), confermando quanto già rilevato nei trienni precedenti;
• nessuna delle praterie di Posidonia oceanica è risultata in stato elevato (vedi par. 3.1.3.2), mentre almeno 2 (Costa dell'Argentario e Arcipelago Isole minori) lo erano sempre state nei trienni precedenti; 4 sono in stato ecologico buono (Antignano, Rosignano, Argentario e Isola d’Elba) ed è da segnalare il miglioramento della prateria di Rosignano, soprattutto nei transetti più lontani (verso Sud) dallo scarico Solvay (Fosso Bianco); 3 sono in stato sufficiente, ma, mentre per Costa dell’Albegna è una conferma, per la prateria di Ansedonia (Costa di Burano) e di Punta Ala si tratta di un progressivo peggioramento;
Tabella 63: classificazione dello stato ecologico delle acque marino costiere toscane: 2022-2024
Corpo Idrico
Costa
Legenda:
c.n.e. = campionamento non effettuato; NP = EQB non previsto in questo corpo idrico
Sottoponendo queste valutazioni alla verifica con gli elementi chimico fisici a sostegno (Fase I), lo stato ecologico viene confermato per tutti i corpi idrici tranne Costa del Serchio a causa dell'indice TRIX (vedi par. 3.1.8.3), che lo declassa a sufficiente per l’effetto eutrofico del Canale Burlamacca emissario del Lago di Massaciuccoli, come accaduto anche nel triennio 2018-2021.
Per quanto riguarda le concentrazioni degli inquinanti non prioritari (vedi par. 3.1.9) nelle acque e la loro eventuale influenza sullo stato ecologico (Fase II) si deve sottolineare che non sono stati considerati attendibili i dati 2024 del cromo, a causa di una serie di problemi analitici emersi anche per altri metalli (vedi par.3.2.1.1). Di conseguenza, escludendo dalla valutazione i dati del cromo raccolti nel 2024, non si ha alcuna modifica a seguito della Fase II di verifica dello stato ecologico per il triennio 2022-2024.
In definitiva, quindi, lo stato ecologico delle acque costiere della Toscana risulta elevato in 6 corpi idrici costieri (37,5%), buono in 6 corpi idrici costieri (37,5%) e sufficiente in 4 corpi idrici costieri (25%). I corpi idrici in classe elevata, inoltre, potrebbero verosimilmente essere in numero inferiore, considerando che in precedenza i 3 corpi idrici più settentrionali (Costa della Versilia, Costa del Serchio e Costa pisana) sono quasi sempre risultati in classe buona già per il macrozoobenthos, EQB non monitorato nel 2022-24. In ogni caso, il raddoppio di quelli in stato ecologico sufficiente (da 2 nei trienni precedenti) evidenzia un certo 48 Dato da non considerare
peggioramento attribuibile soprattutto a quanto rilevato sulle praterie di Posidonia oceanica, dato che passano da 1 a 3 con un PREI sufficiente.
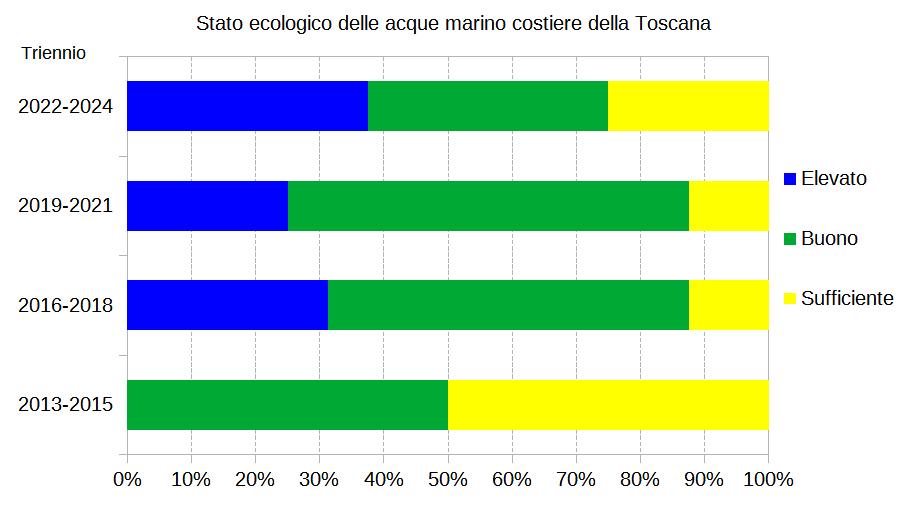
Figura 31: stato ecologico dei corpi idrici della Toscana nei trienni di monitoraggio marino dal 2013 al 2024
Inoltre, si deve segnalare un aumento generale delle componenti azotate nelle acque costiere e, in particolare, nei corpi idrici posti a Nord tanto che, ad esempio, in Costa del Serchio si ha una tendenza positiva (test Mann-Kendall) nelle concentrazioni medie annuali per l’azoto totale, i nitrati e l’azoto ammoniacale. Questo aumento statisticamente significativo dei nutrienti ovviamente si riflette anche sull’indice trofico TRIX i cui valori nel periodo 2022-2024 risultano leggermente più alti rispetto ai trienni precedenti.
5.2 Stato chimico
Come già riportato (par. 3.4), il monitoraggio dei contaminanti chimici nelle diverse matrici (acqua, pesci e molluschi) nel triennio 2022-2024 ha determinato uno stato chimico non buono in tutte le acque marino costiere della Toscana, anche escludendo i dati di cadmio, nichel e piombo rilevati nel 2024 nelle acque dalla classificazione.
Esaminando le sostanze che hanno impedito il raggiungimento di uno stato chimico buono nei corpi idrici costieri della Toscana nel triennio 2022-2024 per superamento degli SQA, come media annuale (SQA-MA) e/o concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA), nelle diverse matrici (acqua, molluschi e pesci) e gli eventuali trend di aumento o diminuzione delle stesse sostanze nel periodo 2013-2024 in pesci e sedimenti (Tabella 64), possiamo, innanzitutto, notare che sono i superamenti nei pesci a determinare lo stato chimico non buono in tutti i corpi idrici.
Tabella 64: sostanze che hanno determinato lo stato chimico dei corpi idrici costieri della Toscana nel 20222024 ed eventuali tendenze in pesci e sedimenti (verde trend negativo, arancio trend positivo)
Corpo idrico costiero Acqua
Costa della Versilia
Costa del Serchio
Costa pisana
Biota
Tendenze Molluschi Pesci Pesci Sedimenti
mercurio PBDE
benzo[a]pirene
benzo[g,h,i]perilene TBT
benzo[a]pirene
benzo[g,h,i]perilene
Costa livornese nichel; TBT
c.n.t.
Costa di Rosignano mercurio c.n.t.
Costa del Cecina
mercurio PBDE PFOS Non buono
mercurio PBDE Non buono PBDE Mercurio
mercurio PBDE Non buono
mercurio PBDE HCB diossine DDT Non buono
mercurio PBDE HCB DDT Non
Costa di Piombino mercurio PBDE
Costa di Follonica
Costa Punta Ala
Costa dell'Ombrone
Costa dell'Uccellina
Costa dell'Albegna
benzo[a]pirene
benzo[b]fluorantene
benzo[k]fluorantene
benzo[g,h,i]perilene
mercurio PBDE HCB Non buono
mercurio PBDE Non buono Mercurio
Costa dell'Argentario nichel mercurio PBDE
Costa di Burano benzo[a]pirene
Arcipelago Isola d’Elba mercurio fluorantene benzo[a]pirene mercurio PBDE Non buono
Arcipelago Isole Minori mercurio
In particolare, poi, possiamo evidenziare le diverse situazioni risultanti dai monitoraggi dello stato chimico nelle acque costiere della Toscana:
• concentrazioni >SQA di mercurio e PBDE rilevate nei pesci (biota) in tutti i corpi idrici quasi sempre tra 2022 e 2024, ma, mentre i PBDE sembrano in progressiva
diminuzione in almeno 3 corpi idrici (Costa pisana, Costa del Cecina e Costa dell’Albegna) il mercurio appare anche in aumento in Costa dell’Uccellina e nelle Isole minori (Giglio) dell’Arcipelago toscano;
• nei pesci (biota), sono stati rilevati superamenti anche di esaclorobenzene (HCB) in 4 corpi idrici (Costa Rosignano, Costa del Cecina, Costa Follonica e Costa dell’Albegna), dei DDT in 2 corpi idrici (Costa Rosignano e Costa del Cecina), di PFOS in Costa del Serchio e di diossine e composti diossina simili in Costa di Rosignano;
• superamenti degli SQA (soprattutto nel 2022 e nel 2024) di alcuni idrocarburi policlici aromatici (IPA) e, in particolare, del Benzo[a]pirene ed il Benzo[g,h,i]perilene nella colonna d’acqua in 4 corpi idrici (Costa del Serchio, Costa Pisana, Costa di Follonica e Costa di Burano) e nei mitili (biota) all’Isola d’Elba;
• nelle acque il mercurio è determinante in senso negativo in 3 corpi idrici (Costa di Rosignano, Isola d’Elba e Isole Minori) ed il nichel in 2 (Costa livornese e Costa dell’Argentario), così come il TBT (Costa del Serchio e Costa livornese);
• Costa di Rosignano è il corpo idrico con il maggior numero di sostanze >SQA (5 nei pesci ed il mercurio nelle acque), alcune delle quali (mercurio e HCB) sono in aumento nello strato superficiale dei sedimenti
Come visto, di fatto il mercurio è il parametro che condiziona la caratterizzazione chimica dei corpi idrici costieri della Toscana, ritrovandosi sempre (100% dei corpi idrici e 97% dei campioni del triennio 2022-2024) in concentrazioni >SQA nei pesci e nel 19% delle acque. Per trovare una possibile spiegazione di tale costante presenza, è sicuramente utile un confronto con le concentrazioni rilevate nello strato superficiale dei sedimenti marini, dove si accumulano queste sostanze (stratificandosi in base ai tassi di sedimentazione), in oltre 20 anni di monitoraggi, dai quali emergono 3 diverse situazioni:
• una diffusa presenza di sedimenti con concentrazioni di mercurio poco superiori agli SQA (valori di fondo 49) in gran parte dei sedimenti costieri della Toscana, compatibile con un’origine naturale;
• un’anomalia geochimica della maremma meridionale (ambito della Provincia Hg-Sb di Klemm et Neumann, 1994 50), che, anche a causa di attività minerarie (in passato) e geotermiche (attuali), ha impattato soprattutto sui sedimenti trasportati a mare dal fiume Albegna e dai canali emissari della Laguna di Orbetello;
• l’impatto degli scarichi dello stabilimento Solvay che hanno immesso in mare questo metallo, attraverso il fosso Bianco, fino ad almeno il 2007 in quantità tra 100 e 400kg/anno 51, determinando, attraverso il trasporto dei solidi sospesi da parte della circolazione costiera locale, valori ampiamente superiori a quelli di fondo naturale nei sedimenti marini compresi tra Antignano (Costa livornese) e Rosignano Lillatro.
La tendenza all’aumento del mercurio nei sedimenti di Rosignano, foce Albegna ed Ansedonia è con ogni probabilità legata alle situazioni di cui sopra, ma se per i corpi idrici meridionali si può considerare ovvio che il processo di arricchimento sia in atto (e continui
49 https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/studio-per-la-determinazione-dei-valori-di-fondonaturale-nei-sedimenti-e-nelle-acque-marine-costiere/attachment_download/pubblicazione
50 Klemm D.D., Neumann N., Ore-Controlling factors in the Hg-Sb Province of Southern Tuscany, Italy. Springer-Verlag, 1984
51 Vedi nota 23
ad esserlo per molto tempo), non si può dire lo stesso per lo scarico Solvay. Infatti, dato che la causa principale dell’immissione nell’ambiente del mercurio era il sistema di celle elettrolitiche a catodo di mercurio nell’impianto di produzione cloro-alcali, sostituito nel 2007 con le celle a membrana, non si comprende come dopo oltre 15 anni si possano ancora osservare degli incrementi di questo metallo nelle acque marine circostanti.
A questa criticità, si accompagna la recente (dal 2016) comparsa dell’esaclorobenzene (HCB) con concentrazioni spesso superiori agli SQA nei sedimenti delle stazioni di Antignano (Costa livornese) e Rosignano (Costa di Rosignano), con una distribuzione analoga a quella del mercurio e, quindi, con una probabile origine comune. Questa stessa sostanza, di sicura origine antropica, è risultata presente in concentrazioni >SQA anche in vari campioni di pesci, tra i quali quelli pescati in Costa di Rosignano e nel corpo idrico vicino di Costa del Cecina.
Si riportano i riferimenti alla normativa citata nella presente Relazione ed ordinata per tipologia (comunitaria, nazionale e regionale) e data di emanazione (decrescente)
2018/229/UE
2013/39/UE
Decisione (UE) 2018/229 della Commissione del 12 febbraio 2018 “che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall’esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2013/480/UE della Commissione”
Direttiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 “che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque”
2008/105/UE
D.Lgs. 172/2015
D.M. 260/2010
Direttiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 “relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”
Decreto Legislativo 13 ottobre 2015 n. 172 “attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque”
Decreto 8 novembre 2010 n. 260 “Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del D.Lgs. 152/06, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo”.
D.M. 56/2009
D.M. 131/2008
Decreto Ministeriale 14 aprile 2009 n. 56 “Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del D.Lgs. 152/06, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo”.
Decreto Ministeriale 16 giugno 2008 n. 131 “ Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del D.Lgs. 152/06, recante: “Norme in materia ambientale”, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 4, dello stesso decreto”.
D.Lgs. 152/2006
DGRT 264/2018
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” - Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”
Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 264 del 20 marzo 2018 “D.Lgs. n. 152/2006 e 172/2015. Aggiornamento dei corpi idrici marino-costieri della Toscana e adozione dei nuovi valori di fondo in acqua e sedimenti. Integrazione dell’allegato “C” alla DGRT n. 608/2015 e sostituzione dell’allegato “A” alla DGRT n. 1273/2016”
DGRT 1273/2016
Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1273 del 12 dicembre 2016 “Determinazione dei valori di fondo naturali per lo stato chimico ed ecologico delle acque marino costiere e modifica del codice regionale dei corpi idrici marino costieri”
DGRT 608/2015
DGRT 550/2014
DGRT 100/2010
Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 608 del 18 maggio 2015 “Monitoraggio dei corpi idrici marino costieri della Toscana – modifiche e integrazioni alla DGR n. 550/14”
Delibera della Giunta Regionale della Toscana n.550 del 7 luglio 2014 “Attuazione D.L.gs 152/2006 e D.Lgs. 30/2009. Monitoraggio dei corpi idrici marino costieri della Toscana. Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta n. 939/2009 e n. 100/2010”
Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 100 del 8 febbraio 2010 “Rete di Monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee della Toscana in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06 e del D.Lgs. 30/09”