Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità:
Critici biosemiotici
Semiotics, life, ecology and sustainability: Biosemiotic critics
a cura di michele dentico
Pontificia Universidad Javeriana
International Association for Semiotic Studies
Instituto Departamental de Bellas Artes
Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità
Semiotics, life, ecology and sustainability
Pontificia Universidad Javeriana
International Association for Semiotic Studies
Instituto Departamental de Bellas Artes
Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità
Critici biosemiotici
Semiotics, life, ecology and sustainability
Biosemiotic critics

Copyright © 2025 by
© Pontificia Universidad Javeriana
© International Association for Semiotic Studies
© Instituto Departamental de Bellas Artes
© Michele Dentico, academic editor
First Editorial Pontificia Universidad Javeriana paperback edition, 2025
isbn (paperback): 978-628-502-063-6
isbn (eBook): 978-628-502-027-8 doi: https://doi.org/10.11144/Javeriana.
9786285020278
Made in Colombia
Facultad de Educación
Carrera 7a No. 42-27
Lorenzo Uribe, S.J. Building Phone: (601) 320 8320 ext. 2635
Visit educacion.javeriana.edu.co/ Bogotá, D.C.
Facultad de Comunicación y Lenguaje
Transversal 4 No. 42-00, 6th floor
José Rafael Arboleda Building Phone: (571) 320 8320 exts. 4563-4566
Visit comunicacionylenguaje.javeriana.edu.co/ Bogotá, D.C.
Instituto Departamental de Bellas Artes
Av. 2 Nte. #7N-66
Phone: (602) 620 3333. Visit www.bellasartes.edu.co Cali, Colombia

Publishing by Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Carrera 7.a n.° 37-25, office 1301
Edificio Lutaima
Phone: (601) 320 8320 ext. 4752 Visit www.javeriana.edu.co/editorial
Book design by Carmen Villegas
Front cover by Carmen Villegas
Printed by Imprime tu Libro
Pontificia Universidad Javeriana | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento de personería jurídica: Resolución 73 del 12 de diciembre de 1933 del Ministerio de Gobierno.
MIEMBRO DE LA RED DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE AUSJAL www.ausjal.org
Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S. J. Catalogación en la publicación
Delupi, Baal, autor Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità : critici biosemiotici = Semiotics, life, ecology and sustainability : biosemiotic critics / autores, Baal Delupi [y otros diez] ; editor académico, Dentico. -- Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2025.
257 páginas ; 24 cm
Incluye referencias bibliográficas.
ISBN (impreso): 978-628-502-063-6
ISBN (digital) : 978-628-502-027-8
1. Semiótica 2. Biosemiótica 3. Semiótica de la comunicación 4. Sostenibilidad 5. Semiótica y cultura 6. Ecología humana 7. Filosofía de la ecología I. Dentico, Michele, editor académico II. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá IV. Asociación Internacional de Semiótica.
CDD 302.2 edición 21
CO-BoPUJ 12/06/2025
No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrival systems, without permission in writing from the Publisher.
Contenuto
Prefazione. La semiotica contemporanea: le poste in gioco del futuro per gli Early Career Researchers ( ecr )
Jorge Eduardo Urueña López 11
Prologo. Semiotica contemporanea: ricerca in cinque lingue. Cinque libri in cinque lingue
Jacques Fontanille e Tiziana Migliore 13
Presenta TION
Paul Cobley 25
Introduzione
Michele Dentico 31
Biosemiotica, semiotica cognitiva e sense-making: un approccio relazionale e pragmatista contro l’antropomorfismo
Luigi Lobaccaro 37
Verso una Biosemiotica Ecosistemica: la soglia semiotica tra vita e non vita
Nicola Zengiaro 67
ias in musica e codesemiotics. Appunti per lo studio da una prospettiva evolutiva
Emiliano Vargas 97
Resistenza artistica e intellettuale nella lotta per l’ambiente
Baal Delupi 115
Ascoltare la foresta amazzonica: paesaggi sonori, ascolti profondi e processi di traduzione intersemiótica tra pratiche biosemiótiche e arti performative
Mónica Torres, Elizabeth Dezeo e Rocco Mangieri 139
Dalla biosfera alla semiosfera: le poetiche biodegradabili nella scena contemporanea argentina
Lucía Stubrin e Eric Hirschfeld 181
Quello che i polpi non dicono: i racconti animali di Vinciane Despret
Beatrice Vanacore 203
L’equivoca transcodifica tra Bíos ed Ethnos. Proposte ecosofiche per una biosemiotica in prospettiva strutturale
Gianluca De Fazio 225
Autori 251
Contents
Preface. Contemporary semiotics: future stakes for Early Career Researchers (ECR)
Jorge Eduardo Urueña López 11
Prologue. Contemporary semiotics: research in five languages. Five books in five languages
Jacques Fontanille and Tiziana Migliore 13
Presentation
Paul Cobley 25
Introduction
Michele Dentico 31
Biosemiotics, cognitive semiotics and sense-making: a relational and pragmatist approach against anthropomorphism
Luigi Lobaccaro 37
Towards an Ecosystemic Biosemiotics: the semiotic threshold between life and non-life
Nicola Zengiaro 67
AI in music and codesemiotics . Notes from an evolutionary perspective
Emiliano Vargas 97
Artistic and intellectual resistance in the fight for the environment
Baal Delupi 115
Listening to the Amazon forest: soundscapes, deep listening and intersemiotic translation processes between biosemiotic practices and performing arts
Mónica Torres, Elizabeth Dezeo and Rocco Mangieri 139
From biosphere to semiosphere: biodegradable poetics in the contemporary Argentine scene
Lucía Stubrin and Eric Hirschfeld 181
What octopuses don’t say: the animal stories of Vinciane Despret
Beatrice Vanacore 203
The ambiguous transcoding between Bíos and Ethnos. Ecosophical proposals for a biosemiotics in structural perspective
Gianluca De Fazio 225
authors 251
La semiotica contemporanea: le poste in gioco del futuro per gli Early Career Researchers ( ecr )
L’Early Career Researchers (ecr in english) è una rete di giovani ricercatori intorno agli studi semiotici, dove l’impegno per un lavoro interdisciplinare e transdisciplinare contribuisce alla diversificazione degli studi semiotici.
Questa comunità accademica è nata sotto la guida di due riconosciuti semiologi: Il professor Paul Cobley (Regno Unito) e il professor Kristian Bankov (Bulgaria), rispettivamente presidente e segretario dell’Associazione Internazionale per gli Studi Semiotici (iass-ais) fino al 2024. Essi hanno riunito un primo gruppo di ricercatori provenienti da lingue, contesti e aree di formazione diversi, al fine di creare e consolidare spazi di discussione teorica e promuovere così nuove generazioni di ricercatori nel campo degli studi linguistici nucleati negli studi semiotici. Questo gruppo è stato formato da Jia Peng (Asia), Damien Tomaselli (Sudafrica), Alin Olteanu (Europa) e Jorge Eduardo Urueña (America Latina).
Questa rete è stata costituita come spazio per i giovani ricercatori per potenziare le diverse iniziative accademiche e professionali, al fine di fare appello a nuovi excursus teorici che garantiscano il dibattito e la discussione su segni, significati e sensi.
L’Associazione Internazionale di Studi Semiotici (iass-ais), secondo l’articolo due del suo statuto, cerca di rafforzare e diversificare i legami internazionali tra i Paesi membri, così come con altre nazioni che possono far parte di questa comunità. In base a questo principio, negli ultimi otto anni questa rete ha cercato di consolidarsi come spazio per lo sviluppo sociale e accademico, per la rinnovata costruzione di legami attraverso la scienza, l’innovazione, la tecnologia, la trasformazione sociale e culturale e, allo stesso modo, per proiettare le carriere accademiche dei futuri semiologi nel mondo.
Questa rete si concretizza in proposte di ricerca, mobilità accademica e formazione continua di giovani nell’area della Semiotica con una prospettiva transdisciplinare. Abbiamo già tenuto tre incontri della rete
nell’ambito dei congressi mondiali di semiotica, organizzati dalla iass-ais nelle città di Buenos Aires (Argentina), Salonicco (Grecia) e Varsavia (Polonia). Questi incontri, riconosciuti dall’associazione, sono stati presentati come il palcoscenico per la formazione completa di tutti i ricercatori che sviluppano la loro carriera accademica nell’ambito degli studi semiotici. L’obiettivo è quello di rafforzare la vocazione scientifica dei giovani ricercatori e di stimolare il collegamento delle nuove generazioni per la crescita e l’espansione della semiotica come prospettiva teorica e approccio metodologico nella scienza contemporanea.
Vi invitiamo a godervi questa prima serie di libri, in cui troverete il futuro della semiotica nelle mani degli Early Career Researchers ecr dell’Associazione Internazionale di Studi Semiotici iass-ais.
prof. jorge eduardo urueña lópez, ph.d.
Professore della Facoltà di Scienze dell’Educazione, Pontificia Universidad Javeriana Colombia
Membro del Comitato Esecutivo per la Colombia dell’Associazione Internazionale per gli Studi Semiotici iass-ais
Prologo
Semiotica contemporanea: ricerca in cinque lingue.
Cinque libri in cinque lingue
Il programma Ricercatori all’inizio della carriera (ecrs)1
Questo programma è stato concepito e realizzato su iniziativa dell’International Association for Semiotic Studies (iass-ais), durante la presidenza di Paul Cobley, e supervisionato dal precedente Consiglio scientifico dell’Associazione. La vicepresidente per le Americhe, Neyla Pardo, ha concepito e guidato l’intera attuazione della fase 1 del programma, con il supporto logistico e finanziario della Pontificia Universidad Javeriana di Bogotà. Gli Ricercatori all’inizio della carriera sono identificati sulla base di criteri internazionali: si tratta di ricercatori che hanno meno di 40 anni e non sono professori o ricercatori di ruolo, sono studenti di formazione post-dottorato, che difendono i loro studi da meno di 6 anni o studenti di studi di dottorato.
Il quadro tematico del programma è molto ampio e riguarda i fenomeni sociali, politici, economici, artistici ed educativi delle società contemporanee a livello globale. L’obiettivo è mostrare quale contributo e impulso possa dare la semiotica ai campi del sapere che si occupano di sfide culturali, politiche ed ecologiche. La semiotica contribuisce con i suoi modelli e metodi esplicativi a riflettere su tutte le principali questioni contemporanee.
Il programma mira inoltre a rafforzare e diversificare i legami internazionali tra i Paesi membri, così come con altre nazioni che potrebbero entrare a far parte della comunità della iass-ais, senza alcuna esclusione. In linea con questo principio, le azioni degli “Ricercatori all’inizio della carriera”, che rappresentano il futuro della semiotica nel mondo, dovrebbero
1 Acronimo del programma Early Career Researchers
Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità
favorire la creazione e il consolidamento di rapporti con le università e gli enti di ricerca di tutto il mondo, in un approccio che vuole essere inclusivo. Infine, dal punto di vista della iass-ais, il programma ha anche un obiettivo pragmatico, che è quello di consentire ai giovani ricercatori di confrontarsi con situazioni accademiche e scientifiche di altissimo livello – seminari, conferenze e congressi, pubblicazioni – nel rispetto di standard internazionali di eccellenza.
Cinque libri in cinque lingue
Grazie all’impegno delle istituzioni colombiane, il programma ecrs ha organizzato un numero considerevole di conferenze, lezioni, “conversazioni” e comunicazioni scientifiche. Qui presentiamo solo la parte più visibile e duratura di queste operazioni, intitolata: “Semiotica contemporanea: ricerca in cinque lingue e cinque libri. Progetto di collana editoriale”.
L’obiettivo principale della collana editoriale è l’ideazione, la produzione e la diffusione di ricerche attuali e discussioni teoriche portate avanti dalla rete ecrs come membro della iass-ais. Le lingue scelte sono non le lingue ufficiali della iass-ais, ma quelle selezionate dal comitato editoriale: spagnolo, portoghese, cinese, italiano, inglese. Per il comitato editoriale, “è prioritario diffondere la conoscenza in ognuna delle lingue in cui si fa ricerca semiotica, come modo per mettere in discussione la produzione di conoscenza nelle lingue egemoniche tradizionali”.
Jorge Eduardo Urueña Lopez è stato il saggio pilota e l’efficace coordinatore di questa serie di libri e del suo comitato editoriale. I cinque libri in cinque lingue sono:
• Pluriversos en la semiótica latinoamericana
• Semiótica da comunicação: novas perspectivas sobre mídia e linguagens
• 艺术产业符号学:在技术、政治与感知之间
• Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità: Critici biosemiotici
• Remodelling narrative spaces: Semiotic insights.
I titoli proposti e tutti gli articoli mostrano chiaramente che non è possibile inglobare, nemmeno in cinque libri, la totalità della ricerca semiotica rilevante a livello internazionale e che è indispensabile proporre un quadro di riferimento per un progetto più efficace, in grado di promuovere le ricerche promettenti in tutto il mondo. L’obiettivo di “mettere in discussione la produzione di conoscenza nelle lingue egemoniche tradizionali” si limita infatti a escludere, tra altre lingue, il coreano, il tedesco, l’arabo, il francese e il russo. Ma non sono solo le lingue a essere escluse dai cinque libri, perché gli stessi giovani ricercatori la cui lingua madre o di lavoro non è contemplata sono quasi del tutto assenti dai cinque libri, anche se avrebbero potuto esprimersi o essere tradotti in una delle lingue selezionate.
I cinque libri coprono una gamma molto ampia di temi semiotici – culture emarginate, comunicazione al futuro, arti industriali, biosemiotica ed ecologia, nuovi spazi narrativi significanti – e adottano ciascuno una strategia specifica.
1. Il libro in spagnolo, intitolato Pluriversos en la semiótica latinoamericana, tratta di identità minoritarie, di gruppi sociali vittima di discriminazione e della multiforme resistenza che essi oppongono; il campo di studio è limitato all’America Latina e la maggior parte degli autori risiede in università colombiane o in Messico. I temi della discriminazione, del dominio e della resistenza incoraggiano l’assunzione di posizioni politiche e militanti. I processi semiotici soggiacenti, nutriti della ricerca antropologica contemporanea, implicano approcci prospettici e soprattutto multiprospettici.
2. Il libro in portoghese presenta un insieme di ricerche nel campo della comunicazione, in termini di Nuove prospettive sui media e sui linguaggi. È un panorama del lavoro attuale di giovani ricercatori brasiliani, molti dei quali vivono a San Paolo. Si spera che i lettori del resto del mondo possano trasporre queste nuove prospettive nell’ambito delle loro culture.
3. Il libro in cinese, dedicato alle Arti industriali, è particolarmente omogeneo e innovativo, sia per l’argomento che per l’approccio, perché l’industrializzazione delle arti mette in crisi i fondamenti stessi della creazione. Gli autori, inoltre, non appartengono tutti alla medesima area geografica: alcuni sono cinesi, altri sono stati tradotti in cinese e lavorano in vari Paesi del mondo. Ciò dimostra che tutti i giovani ricercatori, indipendentemente dalla loro lingua madre o dalla loro lingua professionale, potrebbero partecipare ai libri di una collana di questo tipo.
4. Il libro in italiano copre una tendenza scientifica già affermata nel campo della biosemiotica: l’estensione a tutto ciò che ha a che fare con il vivente. Approcci già sviluppati altrove, in altri quadri teorici, come l’enazione, la cognizione distribuita, l’attore-rete, l’internaturalità, teorie e metodi che sostengono l’incarnazione di istanze, di attanti e di enunciazioni, da tempo presi in considerazione da tutte le scuole della nostra disciplina, sono qui riconfigurati e ben integrati nella biosemiotica. La maggior parte degli autori è italiana, mentre altri provengono dall’America Latina, in particolare dal Venezuela e dall’Argentina. Come nel libro in cinese, autori la cui lingua madre o di lavoro non è l’italiano hanno potuto comunque contribuire con articoli che sono stati tradotti.
5. Il libro in inglese è l’unico il cui tema non sia già istituzionalizzato, di pertinenza di un dominio già assodato e identificabile o derivante da un contesto socio-culturale regionale: affronta un problema semiotico contemporaneo, quello della riconfigurazione degli spazi di presentazione e rappresentazione nelle culture e nelle tecnologie di oggi. Gli autori hanno dovuto ripensare teorie e metodi e cercare nuovi punti di riferimento. Questa sfida ha ottenuto un grande successo: ogni capitolo pone almeno un problema semiotico sollevato dalla riconfigurazione degli spazi contemporanei. Il libro non indica le istituzioni o i Paesi di appartenenza degli autori.
La collana editoriale è poliedrica sotto molti aspetti: è multidisciplinare, multiteorica, multiculturale e multilingue. Dopo aver preso in esame i libri, riteniamo che gli aspetti multiteorici e multilinguistici conferiscano alla collana la sua struttura più forte. La pluralità delle teorie indurrebbe a proporre modelli ibridi. I giovani ricercatori sono invece riusciti, in modo molto apprezzabile, a riunire e omogeneizzare concezioni diverse. La sfida metodologica è notevole, perché la giustapposizione delle teorie si è dovuta comunque accompagnare a metodi coerenti e adatti agli oggetti da descrivere. L’analisi semiotica raggiunge infatti il suo obiettivo primario – l’intelligibilità dei fenomeni, la dimensione della scoperta attraverso il risultato euristico – quando utilizza modelli e strumenti descrittivi coerenti.
Il multilinguismo è una proposta perfettamente coerente con la missione dell’Associazione Internazionale di Semiotica, in un campo di ricerca in cui la traduzione tra le lingue occupa un posto centrale, qualunque sia il punto di vista teorico e metodologico scelto. Ma ci sono due modi di praticare il multilinguismo: (1) tutti gli autori di un libro scrivono in un’unica lingua, anche con traduzione, ed è la collana, non il singolo libro, a essere plurilingue: il lettore di ogni libro può conoscere solo una lingua; e (2) tutti gli autori scrivono gli articoli nella loro lingua madre o nella lingua di lavoro che hanno scelto, a partire da un elenco stilato collettivamente, ed è il singolo libro a diventare plurilingue; in questo caso, ci si aspetta che tutti leggano e comprendano le lingue degli altri.
È evidente che la prima soluzione non favorisce il multilinguismo e il dialogo interculturale e porta a esclusioni difficili da giustificare. Anche la seconda soluzione presenta alcuni svantaggi, ma sono gli svantaggi del mito di Babele, che come hanno dimostrato eminenti semiologi, Lotman e Fabbri in particolare, possono essere trasformati in vantaggi in termini di risemantizzazione e arricchimento dei saperi.
La fase 2 del progetto ecr s trarrà insegnamento dai risultati molto incoraggianti della fase 1. Per rafforzare l’obiettivo del programma ecr s di creare una vasta rete globale di scambi, tenteremo, in continuità con questa serie editoriale, di favorire un multilinguismo dinamico, inclusivo e produttore di senso. E cercheremo di rivolgerci
non solo ai semiologi, ma anche a ricercatori e ai professionisti di altre discipline e campi di indagine.
jacques fontanille Presidente iass-ais, Università di Limoges, Francia
tiziana migliore
General Secretary of the iass-ais, University of Urbino Carlo Bo, Italy
Sémiotique contemporaine:
recherche en cinq langues.
Cinq livres en cinq langues
Le programme Chercheurs en début de carrière (ecrs)1
Ce programme a été conçu et mis en œuvre à l’initiative de l’International Association for Semiotic Studies (iass-ais), pendant la Présidence de Paul Cobley, et supervisé par le précédent Bureau de l’Association. La vice-présidente pour l’Amérique, Neyla Pardo, a conçu et porté toute la réalisation de la première phase du programme, avec le soutien logistique et financier de la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá. Les Chercheurs en début de carrière sont identifiés sur la base de critères internationaux : ce sont des chercheurs qui ont moins de 40 ans et ne sont pas des enseignants-chercheurs titulaires, soit des postdoctorants qui ont soutenu leur thèse depuis moins de 6 ans, soit des doctorants.
Le cadre thématique du programme est le plus large possible, et concerne les phénomènes sociaux, politiques, économiques, artistiques et éducatifs des sociétés contemporaines dans le monde entier. L’objectif est de montrer quel peut être l’apport et l’impulsion de la sémiotique à l’égard des domaines de la connaissance qui traitent des défis sociaux, culturels, politiques et écologiques. Dans toutes les grandes questions contemporaines, la sémiotique apporte ses modèles d’explication et ses méthodes.
En outre, le programme vise à renforcer et à diversifier les liens internationaux entre les pays membres, ainsi qu’avec d’autres nations qui pourraient faire partie de la communauté de la iass-ais, sans aucune exclusive. En vertu de ce principe, les actions des « Chercheurs en début de carrière », qui représentent l’avenir de la sémiotique dans le monde, doivent
1 Sigle en anglais pour Early Career Researchers
Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità
contribuer à créer et fortifier des liens avec des universités et des entités de recherche du monde entier, dans une démarche qui se veut inclusive. Enfin, du point de vue de l’iass-ais, le programme a aussi un objectif pragmatique, qui consiste à permettre aux chercheurs en début de carrière de se confronter à des situations académiques et scientifiques au plus haut niveau d’exigence – séminaires, conférences et congrès, publications – soumises à des normes d’excellence de niveau international.
Les cinq livres en cinq langues
Le programme ecrs a organisé, grâce aux efforts des institutions colombiennes, un nombre considérable de conférences, d’enseignements, de « conversations » et de communications scientifiques. Ici même, nous ne présentons que la partie la plus visible et la plus durable de ces opérations, intitulée : « Sémiotique contemporaine : la recherche en cinq langues et cinq livres. Projet de série éditoriale ».
L’objectif principal de cette série éditoriale est la conception, la production et la diffusion des recherches actuelles et des discussions épistémiques menées par le réseau ecrs en tant que membres de l’iass-ais. Les langues choisies ne sont pas celles officielles de l’iass-ais, mais celles qui ont été retenues par le comité éditorial : espagnol, portugais, chinois, italien, anglais. Pour le comité éditorial, en effet, « il est prioritaire de diffuser les connaissances dans chacune des langues dans lesquelles cette recherche sémiotique est menée comme une manière de questionner la production de connaissances dans les langues hégémoniques traditionnelles ».
Jorge Eduardo Urueña Lopez a été le pilote avisé et le coordinateur efficace de cette série de livres et de son comité éditorial.
Les cinq livres en cinq langues sont :
• Pluriversos en la semiótica latinoamericana
• Semiótica da comunicação: novas perspectivas sobre mídia e linguagens
• 艺术产业符号学:在技术、政治与感知之间
• Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità: Critici biosemiotici
• Remodelling narrative spaces: Semiotic insights
Les titres proposés, ainsi que les ouvrages, montrent à l’évidence qu’il n’est pas possible d’embrasser, même en cinq livres, la totalité des recherches sémiotiques pertinentes au niveau international, et qu’il est déjà essentiel de proposer un cadre pour un projet plus efficace qui saura valoriser partout dans le monde les recherches les plus prometteuses. L’objectif défini comme « questionner la production de connaissances dans les langues hégémoniques traditionnelles », se limite de fait à exclure notamment le coréen, l’allemand, l’arabe, le français, le russe, parmi d’autres. Mais ce ne sont pas seulement les langues qui sont exclues des cinq livres, car les jeunes chercheurs dont la langue maternelle ou de travail est exclue sont eux-mêmes presque tous absents de ces cinq livres, alors qu’ils auraient pu s’exprimer ou être traduits dans l’une des cinq langues retenues.
Les cinq livres couvrent un très large champ de problématiques sémiotiques : les cultures marginalisées, la communication au futur, les arts industriels, la biosémiotique et l’écologie, les nouveaux espaces narratifs de signification, en adoptant chacun une stratégie spécifique.
1. Le livre en espagnol, sous le libellé «Pluriversos en la semiótica latinoamericana», traite des identités et des groupes sociaux victimes de discriminations et de la résistance multiforme qu’ils leur opposent ; le champ d’étude est circonscrit à l’Amérique Latine, et les auteurs sont en majorité implantés dans les universités colombiennes, les autres étant situés au Mexique. Les questions de discriminations, de domination et de résistance incitent à adopter des positions identitaires et militantes. Les processus sémiotiques sous-jacents, nourris des recherches anthropologiques contemporaines, impliqueraient des approches perspectivistes, voire multi-perspectivistes.
2. Le livre en portugais présente un ensemble de recherches dans le domaine de la communication, caractérisées comme « de nouvelles perspectives sur les médias et les langages ». L’ensemble est conçu comme un panorama des travaux actuels de jeunes chercheurs brésiliens qui sont en très grande majorité implantés à Sao Paulo. Il suppose que les lecteurs du reste du monde
soient en mesure de transposer ces nouvelles perspectives dans leur propre champ culturel.
3. Le livre en chinois, consacré aux « Arts industriels », est particulièrement homogène et innovant, dans ses objets et dans ses approches, car l’industrialisation des arts interroge les fondements mêmes de la création. En outre un effort de diversification des auteurs doit être souligné : tous ne sont pas chinois, et ceux qui ne le sont pas ont bénéficié d’une traduction en chinois, et ils sont situés dans plusieurs pays du monde : c’est bien la preuve que tous les jeunes chercheurs, quelle que soit leur langue maternelle ou de travail, pourraient participer à chacun des livres de la série.
4. Le livre en italien couvre une tendance scientifique déjà bien établie dans le domaine de la biosémiotique : l’extension à tout ce qui a trait au monde vivant. Des approches déjà développées par ailleurs, dans d’autres cadres théoriques, comme l’énaction, la cognition distribuée, l’acteur-réseau, l’internaturalité, les théories et méthodes qui prônent l’incarnation des instances, des actants et des énonciations, depuis longtemps prises en compte par les sémiotiques de tous horizons théoriques, sont ici reconfigurées et bien intégrées à la biosémiotique. Les auteurs sont en majorité italiens, et les autres sont situés en Amérique Latine, notamment au Vénézuela et en Argentine. Là aussi, des auteurs dont la langue maternelle ou de travail n’est pas l’italien, ont pu contribuer à cet ouvrage en italien.
5. Le livre en anglais est le seul qui a choisi un thème qui n’est pas déjà institutionnalisé, fixé dans un domaine bien identifié, ou émanant d’une situation socio-culturelle régionale : il est consacré à un problème sémiotique contemporain, celui de la reconfiguration des espaces de présentation et de représentation dans les cultures et technologies d’aujourd’hui. Il en résulte une difficulté qui a imposé bien des réaménagements pour proposer aux auteurs de nouveaux repères. Mais il en résulte aussi
un beau succès : chaque chapitre pose au moins l’un des problèmes sémiotiques soulevés par la reconfiguration des espaces contemporains. Ce livre n’indique ni les institutions ni les pays de rattachement des auteurs.
La série éditoriale est multiple à maints égards : multidisciplinaire, multi-théorique, multiculturelle, et multilinguistique. Après analyse de chacun des livres, les aspects multi-théorique et multilinguistique nous semblent ceux qui structurent le plus fortement la série. La pluralité des théories conduirait à proposer des modèles hybrides. On reconnait aux jeunes chercheurs la vertu de réunir et homogénéiser des conceptions différentes. Le défi méthodologique est considérable, car il faut que la juxtaposition des théories engendre de nouvelles méthodes cohérentes et adaptées à l’objet d’analyse. En effet, l’analyse sémiotique atteint son objectif premier – l’intelligibilité des phénomènes, la dimension de la découverte à travers les résultats heuristiques – lorsqu’elle utilise des modèles et des outils descriptifs cohérents.
Le multilinguisme, pour une Association Internationale de Sémiotique, est une solution parfaitement cohérente avec son objet, dans un champ de recherches où la traduction entre langages occupe une place centrale, quel que ce soit le point de vue théorique et méthodologique adopté. Mais il y a deux façons de pratiquer le multilinguisme : (1) tous les auteurs d’un livre écrivent dans une seule langue, y compris avec traduction, et c’est la série d’ouvrages, et non le livre, qui est multilingue : le lecteur de chaque livre peut ne connaître qu’une seule langue, celle de chaque livre; et (2) tous les auteurs écrivent leur contribution dans leur langue maternelle ou la langue de travail de leur choix, choisie dans une liste établie collectivement, et c’est chaque livre qui devient multilingue ; dans ce cas, chacun est censé lire et comprendre les langues des autres.
Il est bien clair que la première solution ne favorise pas le multilinguisme et le dialogue interculturel, et qu’elle aboutit à des exclusions difficiles à justifier. La deuxième solution a bien sûr également des inconvénients, mais ce sont ceux du mythe de Babel, dont d’éminents sémioticiens, Lotman et Fabbri en particulier, ont montré qu’ils
vita, ecologia e sostenibilità
pouvaient se transformer en avantages en termes de production de nouvelles significations.
La phase 2 du projet ecrs tirera les enseignements des résultats très encourageants de la phase 1. Pour renforcer l’objectif déclaré du projet ecrs, celui d’un vaste réseau mondial d’échanges, elle visera, en prolongement de cette série éditoriale, à promouvoir un multilinguisme dynamique, inclusif et producteur de sens, et s’efforcera de s’adresser non seulement aux sémioticiens, mais aux chercheurs et professionnels d’autres disciplines et d’autres domaines d’investigation.
jacques fontanille
Président de l’iass-ais, Université de Limoges, France
tiziana migliore
Secrétaire Générale de l’iass-ais Université de Urbino Carlo Bo, Italie
This book is a notable outgrowth of the work of the Early Career Researchers in Semiotic Studies, set up in 2019 by the aiss (International Association for Semiotic Studies). Led by Jorge Eduardo Urueña Lopez, this network was conceived from the outset as an international initiative. Joined by Alin Olteanu (Europe), Pengjia (Asia), Damien Tomaselli (Africa), the team that was assembled with Jorge (the Americas) set to work on galvanising the dynamic early career researcher (ecr) community across the globe. Along with meetings at aiss Congresses and online networking, the ecrs group have foregrounded their work in two major ventures. The first was the cycle of international online conversations, led from Colombia by Jorge and Neyla Pardo, which united the international semiotics community in the midst of the pandemic in 2020. The second is a series of edited collections of work by ecrs in semiotics of which the current volume is one of the first.
Aiming to showcase the research endeavours and theories of emergent scholars in semiotics, the book series is also international in flavour and ecumenical in its semiotic bearing. This is highly evident in the current volume, edited across continents by Michele Dentico. Not only does it appear in Italian, positioning it beyond the basal commitment of the aiss to the Association’s official languages (English, French, German and Spanish), but its focus is biosemiotics: a key development in the study of semiosis which has advanced semiotics some considerable distance from its original heartland of textual analysis.
That this volume on biosemiotics should be an Italian-language one is, however, auspicious for other reasons. Firstly, of course it presents the fecund work of both Italian scholars in biosemiotics, along with scholars from other Romance languages whose work is rendered here in Italian. Secondly, though, the contributions fall within a noble tradition of Italian biosemiotics. This tradition was marked at the 13th Gathering in Biosemiotics in Castiglioncello (2013). Possibly its foremost early figure was the oncologist, Giorgio Prodi (1928-1987). In his discussion of Prodi’s
career in biosemiotics entitled ‘Biosemiotics: its roots and proliferation’, Thomas A. Sebeok (2001), noted that it was catalysed by Prodi’s meeting with both Sebeok and Thure von Uexküll in the early 1980s. Prodi, Director of the Institute for Cancer Research of the University of Bologna, was also a polymath and, as Sebeok called him, a maverick whose contributions to experimental oncology vied with his disposition to write novels as well as his offerings to biosemiotics. With his work championed by Umberto Eco in the 1980s (see also Eco 2018), Prodi’s striking originality, to which Sebeok gives testimony, was directed to immunology specifically and general biosemiotics subsequently (Prodi 1977, 2010). Indeed, in a recent major work on Prodi’s project, Cimatti (2018) places him firmly within a Peircean biosemiotics frame, with an emphasis on the root significance of the natural world and with adherence to a form or ‘semiotic realism’ that echoes that of John Deely.
Prodi has been succeeded by a number of distinguished biosemioticians. Among them are the following. Franco Giorgi is a veteran biosemiotician who has written on systems theory, cognition, mental health, agency, patient care and thick description (see Giorgi 2012, 2022; Fanale, Giorgi and Tramonte 2024). Almo Farina, like Giorgi a regular at the annual Gatherings in Biosemiotics, is a specialist in ecoaccoustics and a researcher into sounds in the landscape (see Farina 2012, 2016, 2021; Farina and Belgrano 2004). Felice Cimatti is a philosopher of language who has written, from a biosemiotic perspective, on pandemics, viruses and the ‘post-animal’, as well as on Prodi (see Cimatti 2019a, 2019b and, again, 2018). Carlo Brentari has written on ethology, human-animal studies, anthropology and the work of Jakob von Uexküll (see Brentari 2009, 2015, 2019; Jaroš and Brentari 2022).
The Italians closest to the gestation of biosemiotics, however, have been the collaborating researchers, Susan Petrilli and Augusto Ponzio. Through a close relationship with Thomas A. Sebeok, including translating his work into Italian (Ponzio and Petrilli 2002), they championed the nascent biosemiotics for decades. In the process, they developed a new conception of globality based on a biosemiotic perspective. Unfolding a philosophy of biosemiotics, they also formulated the idea of semioethics (Petrilli 2014), an extension of their semiotics guided by the principle of
the ‘demand of the other’ (Petrilli and Ponzio 1999), necessarily involving the ethical commitment that humans, as semiotic animals (Deely, Petrilli and Ponzio 2005), bear towards their environment and the planet (Petrilli and Ponzio 2005). Their influence has been such that it touches all of the contributions to the volume for which this is the Presentation.
Coming to the current volume, what you will see, though, is an array of different topics and approaches. When the word ‘biosemiotic’ is used as an adjective for an approach in semiotics, or even a worldview, it is not a unitary phenomenon. Views vary in biosemiotics, particularly on some of the ‘big’ issues which are considered to be urgent even beyond semiotics, such as the status of the non-human animal, the trajectory of the environmental movement, the most efficient methods of farming, the nature of human and non-human cognition, how matter becomes mind, and so on. If one was pressed to isolate a single view that unites biosemioticians, even while conceding that there are others, it would be that the conception of the sign in semiotics which has until recent decades been assumed to be only relevant to the realm of human culture is, in fact, appropriate to nature and even arose and evolved there. This view unites the contributions here.
Thus, in what follows, you will encounter essays from the diversity of biosemiotics: on cognition (Lobaccaro), on life and non-life (Zengiaro), on Artificial Intelligence (Vargas), the environment (De Lupi), the soundscape (Torres, Dezeo and Mangieri), communication between species (Stubrin, Hirschfeld), the significatory status of non-human animals (Vanacore) and ethnosemiotics the semiotic study of ritual, folklore and other anthropological foci – in relation to biosemiotics (De Fazio). Any academic community, whilst initially brought together through commonality, will thrive on diversity. This is where early career researchers such as those represented in this volume are crucial to the survival of the community: not only do they embody ‘new blood’, but they broaden the field, exacerbating and bringing new diversity through their fresh interests, fearless new questions and indications for new directions.
Paul Cobley
Bibliography
Brentari, C. (2009). ‘Konrad Lorenz’s epistemological criticism towards Jakob von Uexküll’, Sign Systems Studies, 37(3/4): 637-60.
Brentari, C. (2015). Jakob von Uexküll: The discovery of the umwelt between Biosemiotics and theoretical Biology. Springer.
Brentari, C. (2019). Il cerchio del possibile: Identità, organismo e persona nella ‘philosophie der natur’ di Nikolai Hartman. Orthotes.
Cimatti, F. (2018). A Biosemiotic Ontology: The Philosophy of Giorgio Prodi. Springer.
Cimatti, F. (2019a). ‘From ontology to ethology: Uexkü ll and Deleuze and Guattari’. In F. Michelini & K. Köchy (a cura di), Jakob von Uexküll and Philosophy (pp. 172-187). Routledge.
Cimatti, F. (2019b). Linguaggio e natura nell’Italian Thought: Il dibattito sulla soglia semiotica fra Umberto Eco e Giorgio Prodi. Amalgama, 38, 60-69.
Deely J., Petrilli, S., & Ponzio, A. (2005). The semiotic animal. Legas.
Eco, U. (2018). Giorgio Prodi and the lower threshold of semiotics. Sign System Studies, 46(2/3), 343-351.
Farina, A. (2012). A biosemiotic perspective of the resource criterion: toward a general theory of resources. Biosemiotics, 5(1), 17-32.
Farina, A. (2016). Animals in a noisy world. In M. Tønnessen, K. Armstrong Oma, & S. Rattasepp (a cura di), Thinking about Animals in the age of the Anthropocene (pp. 37-52). Lexington Books.
Farina, A. (2021). Ecosemiotic landscape: A novel perspective for the toolbox of environmental humanities. Cambridge University Press.
Farina, A. & Belgrano, A. (2004). The eco-field: a new paradigm for landscape ecology. Ecological Restoration, 19, 107-110.
Giorgi, F. (2012). Agency. In D. Favareau, P. Cobley, & K. Kull (a cura di), A more developed sign: Interpreting the work of Jesper Hoffmeyer (pp.13-16). Tartu University Press.
Giorgi, F. (2022). On the role of semiotic bordering in the hierarchical structures of biological systems. International Journal of Psychoanalysis and Education: Subject, Action and Society, 2(2), 125-141.
Fanale, A., Giorgi, F., & Tramonti, F. (2024). Towards a more effective thick description: a biosemiotics approach to meaning in psychotherapy. Biosemiotics, 15, 519-30.
Jaroš, F. & Brentari, C. (2022). Organisms as subjects: Jakob von Uexkü ll and Adolf Portmann on the autonomy of living beings and anthropological difference. History and Philosophy of the Life Sciences, 44(3), 1-23.
Petrilli S. (2014). Sign studies and semioethics: Communication, translation and values. Gruyter Mouton.
Petrilli S. & Ponzio, A. (1998). Signs of research on signs. Semiotische Berichte, 22(3/4).
Petrilli S. & Ponzio, A. (2005) Semiotics unbounded: Interpretive routes through the open network of signs University of Toronto Press.
Ponzio, A. & Petrilli, S. (2002). I segni della vita: La semiotica globale di Thomas A. Sebeok. Spirali.
Prodi, G. (1977). Le basi materiali della significazione. Mimesis.
Prodi, G. (2010). Sign and codes in immunology. In D. Favareau (a cura di), Essential readings in biosemiotics. Springer.
Sebeok, T. A. (2001). Biosemiotics: Its roots and proliferation. In Sebeok (a cura di), Global semiotics. Indiana University Press.
La biosemiotica si è affermata nel tempo come una prospettiva interdisciplinare che, sebbene ormai affondi le radici in una consolidata prospettiva di studi, risulta profondamente attuale anche per la sua capacità di estendere il campo tradizionale di studio dei sistemi di significazione oltre i limiti precedentemente (auto)imposti dalle scienze umane e sociali. Questo ambito di ricerca ha proposto, sin dalla sua teorizzazione, una visione che si potrebbe considerare rivoluzionaria, secondo cui la dimensione culturale e quella biologica dei sistemi viventi non sono più percepite come separate, ma intrinsecamente connesse attraverso i processi di comunicazione e l’interpretazione dei segni. Un legame, quello tra queste due dimensioni, che già si intravedeva nella tradizionale prospettiva di semiosfera articolata da Lotman che pensava i sistemi della cultura come simili, nel loro funzionamento, a quelli della biosfera. Ma la trasformazione del modo di intendere la semiosi che propone la biosemiotica ha, nella sua portata, una profonda valenza politica oltre che epistemologica, e che ci dice molto sul modo in cui gli esseri umani stanno modificando il loro rapporto con la natura, mettendo in discussione le prospettive antropocentriche che hanno caratterizzato le modalità di sapere scientifico e di produzione culturale. La rilevanza di questa metamorfosi concettuale va oltre il mondo strettamente accademico e comprende e riguarda tutto lo scibile e il fare umano, con profonde implicazioni politiche e sociali che riflettono e influenzano direttamente il modo in cui l’umanità, o almeno una sua parte non marginale, sta provando a rivedere e riformulare il suo posto nel mondo. La critica ai paradigmi antropocentrici, egemonici per lungo tempo tanto nel sapere scientifico quanto in quello culturale per secoli, è al centro di questo nuovo approccio, che vede il mondo vivente in una luce completamente nuova. Inoltre, tale trasformazione comporta anche una radicale messa in discussione dell’idea che la vita segua scopi predeterminati e inscritti in un presunto ordine naturale immutabile. La biosemiotica destabilizza
questa visione finalistico-deterministica, mostrando invece come i processi viventi siano frutto di interpretazioni situate, relazionali e contingenti. In questa prospettiva, non esistono fini universali o gerarchie date una volta per tutte, ma traiettorie evolutive aperte, in cui ogni forma di vita costruisce senso nel proprio ambiente in modo creativo, dialogico e non subordinato a un disegno superiore. Questo scardinamento ha implicazioni non solo epistemologiche ma anche profondamente politiche, perché mina alla radice molte delle narrazioni che giustificano disuguaglianze, gerarchie e separazioni tra umano e non umano, naturale e culturale.
Al centro della disciplina biosemiotica vi è l’audace proposta che gli esseri viventi, non solo gli umani, utilizzino segni e simboli per comunicare tra loro, interpretare il mondo circostante e adattarsi ad esso. Questa prospettiva semiotica della vita sottolinea come la comunicazione e l’interpretazione dei segni siano processi fondamentali che avvengono a tutti i livelli biologici, dalla singola cellula agli ecosistemi complessi. In questo contesto, l’obiettivo della biosemiotica è quello di esplorare e comprendere in modo più approfondito come la comunicazione costituisca la base degli scambi essenziali in natura, rivelando le intricate reti di relazioni, desideri e dinamiche che danno significato e forma alla vita su questo pianeta.
La tradizione biosemiotica, dal canto suo, ha spesso osservato solo limitatamente i processi di cooperazione tra materia organica e inorganica negli ambienti, concentrandosi perlopiù sul rapporto tra semiosi e vita. Questa attenzione può limitare lo studio di altre dinamiche, proprio per il fatto che la definizione di ciò che è vita non è né chiara né stabilita in modo definitivo, ma è anch’essa culturalmente determinata, storicamente situata e, forse, anche specie-specificamente intesi. Definire la vita come l’unica caratteristica necessaria alla semiosi appare dunque arbitrario, poiché potremmo non ancora conoscere tutte le possibili forme e sfumature possibili sia della semiosi che della vita, anche e soprattutto nella possibilità che si possano studiare nuovi mondi oltre a quello che abitiamo, dove è plausibile prospettare dei modi in cui i sistemi biologici sono prosperati oltre le condizioni che adesso compongono il nostro sapere e il nostro immaginario. Questa concezione ci spinge a mettere in discussione il confine tra vita e
non vita, un confine spesso difficile se non impossibile da definire. La biosemiotica ci aiuta a estendere i processi semiotici oltre la vita per rimettere al centro del discorso l’esistenza delle soglie semiotiche. Sebbene queste soglie siano utili per organizzare e categorizzare la vita, in una visione più complessa della natura, queste divisioni rappresentano una distinzione ontologica che è possibile mettere in discussione. È legittimo parlare di soglie semiotiche in natura? Qual è lo scopo di separare il semiotico dal non semiotico? La domanda cruciale che possiamo porre alla biosemiotica è come possiamo ridefinirne i confini per aprire la semiosi a tutta la natura. Alla luce di queste considerazioni, in questo volume proponiamo una biosemiotica dell’ecosistema per sfidare le premesse attuali della biosemiotica e offrire una prospettiva più complessa sui processi semiotici e l’organizzazione degli esseri e dei sistemi viventi. Non intendiamo risolvere il problema dell’origine della vita, ma vogliamo evitare di stabilire soglie semiotiche rigide. Un nostro obiettivo ulteriore è esplorare le varie forme di vita e di semiosi, combinando sistematicamente i modi di esistenza possibili per la biosemiotica. Non stiamo sostenendo una natura senza limiti, anzi, ma invitiamo a osservare i confini e a vedere l’indecidibilità come una struttura generativa per entità prive di proprietà specifiche.
L’importanza di queste osservazioni si estende ben oltre le considerazioni teoriche, toccando così questioni pratiche cruciali come la conservazione della biodiversità, la gestione o il rispetto degli ecosistemi e le politiche ambientali sostenibili. Attraverso un’analisi dettagliata delle modalità con cui gli organismi viventi interagiscono tra loro e con l’ambiente, la biosemiotica offre nuove prospettive per affrontare alcune delle sfide ecologiche più pressanti del nostro tempo attraverso un intrinseco e costitutivo dialogo interdisciplinare. A questo proposito, appare rilevante la proficua una connessione tra la biologia e la cultura, in un intreccio che nella biosemiotica trova ampie e profonde riflessioni. Un punto di incontro cruciale e privilegiato che appare rilevante per diverse discipline e ambiti, come l’antropologia, la sociologia e la filosofia, ma anche le scienze cognitive, l’estetica e l’arte, la musica e il suono, così come il tuttora poco esplorato rapporto con l’intelligenza artificiale. Vere e proprie dinamiche di conoscenza intersezionali che in questo volume trovano spazio e vengono sapientemente indagati.
Questo volume, pertanto, non si limita a esplorare le dimensioni biologiche e culturali della biosemiotica, ma si estende a considerare le modalità con cui questa prospettiva disciplinare possa influenzare ed essere influenzata da altre aree del sapere e delle pratiche di conoscenza e artistiche. Attraverso una vasta gamma di contributi da parte di ricercatrici e ricercatori, provenienti anche da diversi campi di studio, il volume si propone di delineare un quadro complesso e multidimensionale della biosemiotica, esaminando sia le sue applicazioni pratiche che le sue profonde implicazioni teoriche. Lo sviluppo della biosemiotica, insomma, oltre che un’esigenza epistemologica, si potrebbe definire esso stesso un segno; il segno del tempo e delle sue urgenze e necessità, un tempo dove il supposto predominio dell’essere umano nei confronti della natura viene messo profondamente in discussione da prospettive differenti che, insieme, rifiutano di vedere questa relazione come unidirezionale; dove non si vuole più intendere questa connessione come una spietata e teleologica forma di subalternità; dove il pensiero scientifico non si enuncia più nel suo mero e parziale antropocentrismo; dove l’epistemologia viene messa in discussione nei suoi principi affinché non funga più da “stampella” ad un modo di intendere la vita umana nell’ecosistema come un’istanza di dominazione. In altre parole, si tratta di una vera e propria decolonizzazione del pensiero e degli assunti da esso derivanti, che hanno spesso portato l’essere umano a intrattenere una relazione con la natura profondamente problematica, predatoria e, spesso, esiziale. Questo volume, con i contributi al suo interno, appare dunque necessario: nel coltivare questo cambiamento attraverso la parola, giovani ricercatrici e ricercatori, con entusiasmo, passione e dedizione, predispongono una rassegna di interventi di rilevante interesse sia per chi conosce questa disciplina ma anche per chi vi si affaccia solamente adesso. Otto contributi che, insieme, si propongono di diffondere la necessità epistemologica, politica e, nondimeno, semiotica di un cambio di sguardo e di paradigma. Come si vedrà, tutte queste questioni trovano spazio nei successivi capitoli di questo volume e vengono affrontate attraverso prospettive e lenti vengono esplorate con accuratezza e sperimentazione. In questo senso, nel primo capitolo, Luigi Lobaccaro ha il pregio di connettere in modo aperto, costruttivo e allo stesso tempo critico, le due
maggiori anime della semiotica, quella interpretativa e quella generativa – che, soprattutto nel panorama italiano della disciplina, continuano a confrontarsi in modo serrato ma genuino – e indica la via per una nuova teoria biosemiotica fondata sulle lenti dell’enattivismo.
Nel secondo capitolo, Nicola Zengiaro affronta l’ambiziosa proposta di una “biosemiotica ecosistemica”: partendo dal presupposto che “semiotica e vita sono coestensive”, critica le fondamenta di alcuni dei caposaldi della concettualizzazione non solo scientifica ma anche politica, sociale e culturale del cosiddetto Occidente, ridefinendo i confini di una questione tanto radicata da diventare naturalizzata come la vita e il vivente.
Nel terzo capitolo, Emiliano Vargas discute delle implicazioni biosemiotiche nelle attività dell’Intelligenza Artificiale nella produzione di forma di vita musicali, secondo un tentativo di esplorazione innovativo del fenomeno dell’ia soprattutto nel porre le basi per un dialogo teorico che si propone di indagare la relazione biosfera/semiosfera/tecnosfera.
Col quarto capitolo si prosegue sul solco audio-musicofilo. Mónica Torres, Elizabeth Dezeo, Rocco Mangieri indagano la preziosa dinamica dei processi di traduzione intersemiotica, nell’incrocio tra pratiche scientifiche di registrazione dei suoni della foresta amazzonica e le creazioni intermediali e performative di un gruppo di artisti contemporanei, tra i quali figurano anche alcuni degli autori del capitolo, seguendo un intreccio sperimentale tra le arti performative, la biosemiotica e la bioacustica.
In continuità col precedente contributo, Baal De Lupi mette al centro della sua indagine il cambiamento climatico, i suoi effetti e come questi abbiano influenzato e stimolato alcune performance di arte pubblica in Argentina, specialmente nella città di Cordoba, e di come queste abbiano la capacità di tematizzare alcune questioni come la lotta ai disastri ambientali e la possibilità di articolare di una “communitas del dolore”.
Nel sesto capitolo si rimane sempre in ambito artistico e nella semiosfera Argentina grazie al contributo di Lucía Stubrin ed Eric Hirschfeld, che si concentrano invece sulla bioarte, un tipo di pratica artistica che coinvolge intenzionalmente lo sguardo della scienza con quello dell’arte. In particolare, essa si sviluppa secondo una prospettiva biologica relazionandola col fare artistico, producendo ad esempio la capacità di rendere significative
le caratteristiche ambientali e le trasformazioni che insistono sui materiali con cui viene concepita e creata un’opera d’arte. Il settimo contributo, di Beatrice Vanacore, amplia la discussione sul futuro e sull’immaginario del rapporto e delle interazioni tra esseri umani e animali non-umani a partire dallo sguardo che la filosofa e psicologa Vinciane Despret che, nel suo scritto Autobiografia di un polpo e altri racconti animali, confrontandolo con Il libro degli esseri immaginari di Jorge Luis Borges. A differenza di quest’ultimo, Despret parla di animali veri e non fantastici, anche se ad essere immaginate delle vere e proprie prospettive di ricerca che ad ora appaiono impossibili ma che si pongono su un piano di plausibilità e interrogano la relazione tra umani e non-umani e su un piano epistemologico complesso e aperto.
A chiudere il volume c’è il capitolo di Gianluca De Fazio, che riprende alcune questioni della tradizione biosemiotica e, nel porre le basi per una proposta che dialoghi con la prospettiva ecosofica, le riarticola attraverso uno sguardo sperimentale e spiccatamente interdisciplinare che si fonda nell’incontro tra semiotica, antropologia, pragmatica e fenomenologia, tutti campi di studio che fanno parte del bagaglio dell’autore.
Biosemiotica, semiotica cognitiva e sense-making
Biosemiotica, semiotica cognitiva e sense-making: un approccio relazionale e pragmatista contro l’antropomorfismo Luigi Lobaccaro
Abstract
Il presente capitolo propone un tentativo di integrazione tra biosemiotica e semiotica cognitiva alla luce degli approcci enattivisti alla cognizione. Si mostrerà come le idee dell’enattivismo, secondo cui la cognizione è fondata su processi di sense-making e su una strong life mind continuity thesis, rendano questa teoria una candidata ideale per discutere i limiti di una “soglia inferiore della semiotica”. Tuttavia, si evidenzierà come tali idee inquadrate attraverso la filosofia di Hans Jonas rechino tracce di antropomorfismo che limitano pesantemente ogni possibile integrazione con un approccio semiotico. Per questa ragione il capitolo proporrà una ridiscussione critica e una riconcettualizzazione dell’enattivismo attraverso le nozioni semiotiche di abito, di sinechismo e di sistema semiotico.
In questo modo sarà possibile individuare una continuità tra processi semiotici biologici, cognitivi e culturali.
Introduzione: abbassare la soglia. L’impresa comune della biosemiotica e della semiotica cognitiva
Generalmente quando studiosi e persone di cultura sentono nominare la parola “semiotica” pensano allo studio dei segni e dei processi di significato circolanti in una determinata cultura. Ciò non dovrebbe rappresentare un mistero: la semiotica è conosciuta presso il vasto pubblico come quella disciplina che si occupa della dimensione sociale e culturale del significato. Per quanto tale concettualizzazione possa risultare banale per gli addetti ai lavori, essa mette in luce una cristallizzazione teorica e metodologica della disciplina frutto di processi storici e politici che ancora oggi frena quelle ricerche che tentano di allargare il campo semiotico oltre i suoi confini.
Una tale concezione esclusivamente culturalista della semiotica sarà proprio il punto di partenza della nostra riflessione, viste le ricadute profonde che tale visione ha sulla capacità della stessa disciplina di avventurarsi su nuovi percorsi e di aprire nuove frontiere d’indagine. Partiremo da un’osservazione semplice ma di frequente dimenticata: l’idea per cui la semiotica debba occuparsi quasi esclusivamente dello studio dei fenomeni culturali non è nata da una reale esigenza interna di assestare e circoscrivere la propria indagine attorno a oggetti o fenomeni determinati, ma è stata il frutto di una serie di cautele politiche ed epistemologiche preliminari alla definizione del campo e del metodo semiotico. Come è perfettamente evidente dal Trattato di Semiotica Generale di Umberto Eco (1975), quelli che sono considerati “i limiti naturali” della disciplina sono tali solo in virtù dell’esigenza da una parte di salvaguardare la specificità di un approccio semiotico che negli anni ‘70 possedeva molti meno strumenti di quanto ne abbia attualmente, e dall’altra di evitare invasioni di altri campi disciplinari senza un giusto equipaggiamento teorico e metodologico. Ne deriva che se si può ancora oggi parlare di una “soglia inferiore della semiotica” è necessario farlo inquadrando tale soglia come un confine politico che gli strumenti epistemologici della disciplina non hanno ancora la maturità di spostare senza minacciare la specificità del proprio dominio. I limiti della disciplina sono quindi da intendersi come confini politici, arbitrari, contrattabili; essi non si fondano affatto su una geografia fisica delle discipline, non si presentano come dati di fatto, montagne invalicabili e mari innavigabili. Credere in una rigida distinzione tra soglie e segnare un limite non contrattabile all’indagine semiotica significherebbe assumere una consistenza data e oggettiva o degli steccati disciplinari, o di una realtà fatta in un certo modo che li seleziona, o, ancora, significherebbe porre il fondamento della semiotica in sé stessa. Queste operazioni sono le stesse che un approccio semiotico ha da sempre criticato come forme di realismo ingenuo, di pregiudizio ideologico o di idealismo, con la conseguenza che sposare una di queste posizioni metterebbe la disciplina nella triste condizione di predicare da un pulpito che traballa sotto il peso della stessa predica e a condannare in pubblica piazza gli stessi vizi che coltiva in casa.
L’idea, quindi, che la semiotica non debba occuparsi di fenomeni “naturali”, “psicologici” o legati alle modalità di significazione biologiche deve essere discussa primariamente a partire dallo stato delle conoscenze della disciplina in un dato momento, dall’esigenza di rispondere a delle domande interne e dalla necessità di dover legittimare e rafforzare la propria esistenza e i propri obiettivi in una ecologia di domini che continuamente contrattano i loro confini (a volte con intesa, altre con incursioni, altre volte con vere e proprie invasioni di campo). Negli anni ‘70 e per buona parte degli anni ‘80, “quando la ‘mente’ era considerata una brutta parola” (Eco 2006), un tale equilibrio si è assestato sulla rivendicazione di una semiotica a trazione culturologica. Invece, a partire dagli anni ‘90, in parallelo alla crisi della semiotica e degli studi culturali in favore di svolte biologiche, cognitive, e naturaliste delle scienze umane, si è assistito a un progressivo riassestamento di tale equilibrio e a una seria ridiscussione del potere epistemologico della disciplina che, per rivendicare i domini che si è a fatica guadagnata (e che continuano a essere produttivi), ha intrapreso indagini nuove. La semiotica ha dovuto cioè legittimare la propria esistenza e l’efficacia dei propri strumenti a partire da due domande fondamentali che prima si era posta soltanto di rado: la domanda sull’origine dei processi semiotici che indaga e la domanda sui processi cognitivi che permettono tale indagine. Non è allora un caso che gli ultimi 30 anni abbiano visto un incremento di pubblicazioni, di ricercatori, di centri di ricerca in tutto il mondo dedicati a indagini semiotiche sul “sotto soglia”, in cui è possibile annoverare due movimenti che hanno interagito relativamente poco sinora: la biosemiotica (Barbieri 2006) e la semiotica cognitiva (Brandt 2020; Konderak 2018; Paolucci 2021).
La prima, a partire dalle riflessioni di Sebeok (2001; Ponzio, Petrilli 2002), punta a fornire una descrizione semiotica dei processi vitali, dell’emergere della soggettività biologica e dei processi chimico-fisici che la sostengono (Hoffmeyer 2008; Barbieri 2008), spiegando i legami tra semiosi biologica e semiosi culturale come un passaggio tra diverse scale di complessità della semiosi (Kull 2018; Cobley 2016).
La seconda, invece, si sviluppa negli anni ‘90 in diversi centri europei, come Aahrus, Lund e Bologna, con la convinzione che per
comprendere meglio i fenomeni di significazione sia necessario indagare i meccanismi cognitivi che ne sono alla base attraverso una serie di metodologie incrociate capaci mostrare come la cognizione coinvolga processi semiotici (cfr. Daddesio 1994). In Italia proprio Umberto Eco, che per anni ha cercato di difendere la soglia inferiore che aveva tracciato nel Trattato, ha proposto una ridiscussione dei limiti della semiotica in chiave cognitiva anche alla luce dei dibattiti con la biosemiotica di Giorgio Prodi (1977; Cimatti 2000). In Kant e l’Ornitorinco (1997), Eco torna sulla questione della soglia inferiore indagando quali siano i limiti che è possibile tracciare per poter parlare di semiosi. Qui, Eco mostra come la percezione umana sia sempre una fusione tra una dimensione pre-semiotica di stampo diadico (stimolo-risposta) ed elementi interpretativi di natura triadica. Individuando elementi semiotici nella percezione umana, Eco fonda una semiotica cognitiva che, se da una parte esclude ancora i processi biosemiotici, dall’altra allarga di molto i confini che lui stesso aveva posto. Tale quadro è tuttavia rapidamente cambiato.
Mentre, infatti, la semiotica cognitiva italiana, tra stalli e ripartenze, stentava a decollare, lo stesso Eco (2009) decide di abdicare all’idea che la percezione si fondi su processi diadici ammettendo che vi è una triadicità (e quindi semiosi) anche nei processi cognitivi subcoscienti che permettono la percezione1. Gli sviluppi che ne seguono sono del tutto ovvi, anche se non opportunamente esplorati né tanto meno pertinentizzati dalla letteratura sul tema. Se infatti la percezione non è più sorretta da una diadicità di base, la semiosi invade l’intera forma della cognizione umana; così la semiotica, che indaga “l’essere umano come animale che interpreta il mondo” (Eco 2006), deve ora occuparsi con le sue metodologie e i suoi strumenti delle modalità attraverso cui la semiosi si annida nell’intera vita cognitiva dell’animale umano.
Proprio da questo passaggio nell’alveo della semiotica cognitiva nasce l’esigenza di definire quali siano le differenze e le comunanze tra gli umani e gli altri animali e se gli strumenti elaborati per studiare la dimensione del significato nella cognizione, nella percezione e nell’esperienza
1 Su questo punto e sullo sviluppo della semiotica cognitiva italiana cfr. Lobaccaro, 2022.
umane ci mettono nelle condizioni di escludere la vita e la cognizione animale dal novero dei possibili oggetti di studio, o se al contrario è proprio sulla base di una continuità tra umano e animale che è possibile comprendere meglio le modalità semiotiche umane. Deve essere chiaro che, se la cognizione e la corporeità umane sono integralmente permeate dalla semiosi e la sfruttano sin dal primo vagito del bambino (Violi 2007), diventa impossibile separare le riflessioni della semiotica da considerazioni che riguardano anche le forme di cognizione e di vita altre, a meno di postulare contro ogni evidenza una totale discontinuità della cognizione umana da quella animale. Dunque, ci troviamo oggi al punto in cui semiotica cognitiva e biosemiotica devono nuovamente ritrattare le proprie soglie di pertinenza e i limiti inferiori della semiotica nel tentativo di mantenerne il potere euristico e la specificità.
Tentativi di riunificazione: da Peirce alla semiotica cognitiva
Per intraprendere un confronto tra biosemiotica e semiotica cognitiva sarà necessario partire da Peirce, mostrando come la sua concezione di semiotica cognitiva esiga nei fatti un incontro con la biosemiotica e spinga a riportare la riflessione sul significato al di sotto della soglia inferiore. Storicamente, infatti, l’etichetta di “semiotica cognitiva” è stata utilizzata per identificare la semiotica di Peirce, in particolare in riferimento alla caratterizzazione che ne viene offerta nei saggi anticartesiani (cp 5.213 - 5.317).
In questi saggi Peirce chiarisce come ogni forma di cognizione sia legata ad un processo semiotico inferenziale, riassumendo questo concetto nelle famose quattro incapacità (cp 5.265). Il significato e i segni non sono nella filosofia di Peirce strumenti in mano a un soggetto, utili solo a fornire un’immagine del mondo, ma principalmente strumenti logici per direzionare l’azione in virtù del principio soggiacente a tutte le forme di semiosi, cioè la famosa massima pragmatica. La semiosi agisce instaurando degli abiti di risposta, cioè tendenze ad agire in modo simile in circostanze simili nel futuro (cp 5.487) che costituiscono il significato di una relazione tra due elementi.
To develop its meaning, we have, therefore, simply to determine what habits it produces, for what a thing means is simply what habits it involves. Now, the identity of a habit depends on how it might lead us to act, not merely under such circumstances as are likely to arise, but under such as might possibly occur, no matter how improbable they may be. (cp 5.400)
In Peirce, il segno non è il risultato di una istanziazione di un piano del contenuto su un piano dell’espressione per qualcuno, ma un processo di produzione continua in cui due elementi non possono essere collegati se non in virtù di un terzo elemento che è il loro significato, espresso attraverso un abito di risposta. La semiosi è quindi un processo sovraindividuale, che non avviene nella mente dei singoli ma è la forma di ogni processo di significazione che fonda la presenza di un soggetto (cp 5.313-5.317): si tratta della dimensione terza che permette la relazione tra un soggetto e un oggetto. Una tale concezione risponde al modello logico di Peirce definito Logica dei relativi (cp 3.45-3.149). Questa Logica dei Relativi nasce come il risultato della riflessione critica di Peirce sul modello Soggetto-Oggetto proposto dalla logica proposizionale classica, che il filosofo pragmatista sostituisce con una visione della proposizione basata su una topologia relazionale. Il modello della Logica dei Relativi porta Peirce a modificare la sua visione della semiosi e a immaginarla come una relazione triadica irriducibile a relazioni diadiche, dove i vari componenti della relazione segnica, cioè il Representamen, l’Oggetto Immediato e l’Interpretante, non sono più elementi autonomi collegati da rapporti inferenziali, ma delle posizioni interscambiabili garantite dalla forma della semiosi: dei posti da occupare2. Tale logica si insinua così anche nella semiotica cognitiva di Peirce, che consiste, ricordiamolo, nell’idea che la cognizione sia il risultato di una processualità di relazioni segniche e che deve essere reinterpretata alla luce di una forma topologica della semiosi. Ne emerge un principio di funzionamento della cognizione definito Law of Mind (cp 6.102-164) per cui ogni nuova cognizione si staglia sempre su uno sfondo di interpretanti che la codificano e che ne permettono l’emergenza come qualcosa di nuovo. Ogni
2 Per una trattazione più esaustiva si rimanda a Paolucci 2010, 2015, 2017.
nuova conoscenza è così un evento nuovo (Primità) che si staglia su una regolarità di abiti (Terzità) da cui si distingue relazionalmente (Secondità): è insomma una breccia che rende instabile la regolarità degli abiti e che spinge ad un riequilibrio, ad una ricomprensione del nuovo nella struttura regolare da cui si separa. Questa legge si ribatte poi specularmente sullo studio del processo di manifestazione delle impressioni nella vita cosciente che nella teoria di Peirce prende il nome di Faneroscopia3 .
Phaneroscopy is the description of the phaneron; and by the phaneron I mean the collective total of all that is in any way or in any sense present to the mind, quite regardless of whether it corresponds to any real thing or not. (cp 1.284)
È importante sottolineare che questa nozione di semiosi e di mente, proprio a partire dalla logica dei relativi, si regge sull’idea che la tendenza della novità ad emergere da un continuum sia essa stessa una Terzità, una Legge: la legge del Sinechismo (cp 6.185-6-209). L’idea di Peirce è che tutto il reale obbedisca a questa legge di Continuità, come forma di Generalità relazionale (cp 6.190). C’è cioè un ordine cosmologico fondato sulle tre categorie di Primità, Secondità e Terzità, che si riflette poi anche nel modo in cui le idee vengono alla mente, o del modo in cui un fenomeno (per Peirce un phaneron) arriva alla coscienza. C’è insomma continuità anche tra la legge del Sinechismo (cp 6.102-6.163), la legge della mente e la faneroscopia. Quindi, proprio a partire dalla logica dei relativi, che costituisce la forma stessa della sua idea di semiosi, Peirce per primo si pone come ideale punto di riferimento per tenere insieme una semiotica cognitiva (Law of Mind ) e dell’esperienza (Faneroscopia) con l’idea di una semiosi che attraversa forme di vita non umane e che regola le modalità attraverso cui la semiosi assume le forme che assume (Sinechismo).
Non deve quindi sorprendere che qualsiasi tentativo di operare una riflessione sulla semiotica cognitiva in senso peirciano incontrerà necessariamente il bisogno di chiarire come essa si interfacci con la
3 Cfr. Sini 2017, p. 45-94; Luisi 2017; Fabbrichesi 2018.
biosemiotica. Tra i vari tentativi operati in questa direzione, è possibile annoverare il recente volume di Paolucci (2021). In questo testo, l’autore tenta di fondare un’idea di semiotica cognitiva riprendendo appieno il pensiero peirciano, ma limitandone il fondamento cosmologico: alla base della riflessione, infatti, non vi è il pansemioticismo di Peirce (dove, per intenderci, si verifica semiosi anche “in the work of bees, of crystals, and throughout the purely physical world”, cp 4.551), ma l’idea che la riflessione peirciana possa essere uno strumento utile per indagare il funzionamento dei processi cognitivi. Tale impostazione viene però giustificata attraverso un confronto con le teorie cognitive delle 4E cognition e in particolare con la teoria cognitiva dell’enattivismo. Proprio quest’ultimo approccio individua la cognizione come una caratteristica compresente alla vita che si manifesta nella sua forma più elementare con la creazione di un Umwelt significativo per un organismo. Si tratterà ora di mostrare come questa scelta possa risultare particolarmente adatta a una ridiscussione dei limiti della soglia inferiore della semiotica, e a gettare un ponte tra semiotica cognitiva e biosemiotica, pur presentando delle difficoltà che tenteremo di superare.
Enattivismo, semiosi del vivente e sense-making
L’enattivismo nasce con la pubblicazione del libro The embodied mind (Varela, Thompson e Rosch 1991), presentandosi come una teoria della cognizione fondata sulla biologia teorica in forte opposizione con le teorie rappresentazionaliste sostenute dalle scienze cognitive classiche. Tale teoria può essere riassunta nell’idea fondamentale per cui la cognizione si caratterizza come un fenomeno auto-organizzato che emerge dai processi di interazione tra corpo, cervello e mondo. L’enattivismo prende in considerazione il corpo situato in un ambiente come fattore imprescindibile per l’emersione dei processi cognitivi, proponendo una versione di embodiment radicale della cognizione vista come fenomeno principalmente anti-rappresentazionale.
Questi elementi fondamentali vengono poi ulteriormente sviluppati dalle ricerche successive che fondono le riflessioni enattiviste di Varela con i modelli di biologia teorica che lo stesso aveva sviluppato con
Maturana negli anni ‘80 (Maturana e Varela 1980). L’idea principale di questo approccio, definito come enattivismo autopoietico (ea), è che la formazione dell’organismo come un sistema autonomo in accoppiamento strutturale con l’ambiente dipenda da processi biologici definiti di autopoiesi, definita come:
a peculiar aspect of the organization of living organisms, namely, that their ongoing processes of material and energetic exchanging with the world, and of internal representation and metabolizing, relate to each other in such a way that the same organization is constantly regenerated by the activities of the processes themselves, despite whatever variations occur from case to case (Di Paolo e Thompson 2014, p. 69)
Questi processi biologici generano una forma di cognizione primordiale rintracciabile nei processi di auto-produzione e auto-mantenimento dell’autonomia del sistema (Thompson 2007) definita come “the property that describes a far-from-equilibrium, precarious, operationally closed system in any domain. Autonomous systems are self-individuating and depend on their associated milieu, which nevertheless does not fully determine its states” (Di Paolo, Cuffari, De Jeagher 2018, Glossary, v. autonomy).
Tali processi autopoietici creano una chiusura operazionale (in un sistema chiuso ogni processo è attivato da e attiva un altro processo all’interno di quel sistema) e contemporaneamente distinguono il sistema da un esterno che si carica di significance e values negativi o positivi a seconda che l’ambiente favorisca o minacci l’autonomia precaria del sistema, e quindi la sua stessa vita. La teoria è stata inoltre innovata con concetti che permettono di specificare come la cognizione dell’organismo possa assumere delle forme più elastiche e superare la semplice opposizione vita-morte che caratterizza la significazione instaurata dall’autopoiesi: è il caso dell’idea di adattività (Di Paolo 2005), che nasce dal tentativo di riconoscere che l’organismo non è in grado solo di autoindividuarsi, ma anche di modificare attivamente il proprio accoppiamento strutturale con l’ambiente per favorire le proprie condizioni di vitalità (viability). In funzione del mantenimento della propria autonomia e attraverso le sue funzioni adattive, l’organismo è in grado
di selezionare le proprie possibilità di azione nell’ambiente, creando così un proprio Umwelt significativo4. Tali operazioni sono definite appunto di sense-making (Weber e Varela 2002):
An autopoietic system always has to make sense of the world so as to remain viable. Sense-making changes the physicochemical world into an environment of significance and valence, creating an Umwelt for the system. (Thompson 2007 p. 146)
Insieme, Autonomia, Adattività e Sense-Making creano quindi la possibilità per un’Agency dell’organismo (Di Paolo, Buhrmann e Barandarian 2017). L’organismo, infatti, per mantenere il proprio precario stadio di autonomia, in virtù della propria adattività, ricerca le condizioni migliori virtualizzate nell’ambiente attraverso il sense-making e agisce sullo stesso modificando attivamente quello stesso accoppiamento strutturale che ne permette in prima istanza l’auto-individuazione. Così, l’equilibrato coupling strutturale tra l’organismo autoindividuato e l’ambiente si sbilancia in favore dell’organismo che è capace di autoregolare la propria precaria chiusura operazionale, creando una forma di asimmetria interazionale5 . Appare quindi del tutto naturale che una semiotica cognitiva interessata ai processi di significazione non possa che ritrovare nell’enattivismo soluzioni alle domande riguardanti la soglia inferiore. L’enattivismo con il suo concetto di sense-making si configura, infatti, immediatamente come una unione tra dimensione biologica e cognitiva capace di fondere e fondare contemporaneamente le basi per una biosemiotica e una semiotica
4 Si noti come l’enattivismo riprenda il concetto di Umwelt proprio dagli studi di von Uexküll (1926), autore fondamentale per la ricerca biosemiotica al punto da essere definito un criptosemiotico (Sebeok 1977).
5 Gli interventi sull’ambiente non avvengono quindi in maniera casuale, bensì in virtù di obiettivi (che almeno nelle forme di vita elementari si limitano alla sopravvivenza) e di norme. Tali concetti sono molto importanti, perché permettono di allontanare lo spettro del comportamentismo dal modello: i fenomeni di stimolo-risposta sono caratterizzati da necessità causale, mentre l’organismo vivente agisce secondo norme e obiettivi contestuali generati internamente, esso tende cioè a ripetere comportamenti che favoriscono la sua autonomia ed evita condizioni che la minacciano (Di Paolo, Buhrmann, Barandarian 2017, p. 122-124).
cognitiva nel rispetto dei limiti epistemologici che la stessa semiotica si pone per salvaguardare la propria specificità. Grazie al concetto di sense-making, l’enattivismo permette agilmente di superare quelle condizioni minime per parlare di interpretazione, che Eco e Violi avevano già ridiscusso durante la “nato Advanced Research Workshop on The Semiotics of Cellular Communication in the Immune System” del 1986 tenuto a Lucca. In questa sede Eco propose di inserire come elemento dirimente per distinguere tra processi diadici stimolo-risposta e processi triadici semiotici, ovvero la presenza di uno Spazio-C:
è sufficiente riferirsi a due diversi modelli astratti: i) un modello triadico, in cui fra A e B c’è una serie impredicibile e potenzialmente infinita di spazi C, e ii) un modello diadico in cui A provoca B senza alcuna mediazione. C’è uno spazio della scelta e dalla supposta indeterminazione, mentre il nonspazio fra A e B è uno spazio di cieca necessità e di determinazione inevitabile. (Eco 1990, p. 222)
Uno spazio C è insomma uno spazio di scelta tale per cui un elemento x può stare per un contenuto che sarà y in un contesto 1 e z per un contesto 2, e che necessita di una memoria capace di immagazzinare delle occorrenze di x tali da poter produrre un type y o z, a cui ricondurre le nuove occorrenze di x a seconda del contesto. Questa per Eco diviene la nuova condizione minima della semiosi: una certa elasticità contestuale e una possibilità di scelta potenzialmente indeterminata. Nella stessa sede, Patrizia Violi tenta invece di ridefinire le caratteristiche principali di una nozione non-restrittiva per poter parlare di semiosi grazie al concetto di intenzionalità. Qui, Violi spiega come qualcosa per poter essere un segno necessita di essere intenzionata e dotata di valori (Violi 1988:20-21). Ad esempio, per parlare di significazione nel mondo animale non possiamo avere solo la selezione di elementi salienti consequenzialmente legati al soddisfacimento di bisogni, è necessario che tali salienze siano individuate come valori da ricercare e quindi riconosciute come valevoli per la sopravvivenza. Insomma, per Violi può esserci una forma elementare di semiosi
se e solo se è presente una capacità di individuare qualcosa come un valore differente rispetto a un altro.
La teoria enattivista di Varela, in questo senso, caratterizza i processi biologico-cognitivi in ottica semiotica perché permette di inquadrare gli esseri viventi come agenti autonomi capaci di distribuire valori e significati in un ambiente, ma anche di operare delle scelte contestuali (spazio-C) fondate sulla storia delle proprie interazioni con un certo grado di elasticità (Varela 1988, p. 151-162). La teoria di Varela ci spiega perfettamente come un sistema autopoietico non sia mai riducibile a relazioni causa-effetto predeterminate, ma il frutto di un aggiustamento costante e storicamente sviluppato tra l’organismo e il suo ambiente, regolato proprio da una selezione di significati (intenzionalità) che mutano al variare del contesto e che permettono interpretazioni locali e situate (riconoscimento):
The system recognizes out of its own autonomy what is significant and how it is so. I have used the words significance, relevance, and meaning advisedly. Meaning involves necessarily a form of interpretation in an encounter. […] This is the interpretive capacity upon which the creativity of life hinges (Varela 1988, p. 160).
In definitiva, la scelta di Paolucci di rintracciare nell’approccio enattivista un possibile campo di confronto tra semiotica cognitiva e biosemiotica è stringente. Il passo successivo è quindi quello di annodare questi approcci attorno alla nozione fondamentale di sense-making (Paolucci 2021, p. 11). Quella che è per l’enattivismo l’operazione cognitiva fondamentale, la struttura stessa di ogni cognizione comune a tutti gli esseri viventi, dai batteri agli uomini, ci dice qualcosa di profondamente semiotico: per mantenere il proprio stadio di autonomia precaria l’organismo deve allestire un proprio mondo di significazioni (brings forth its own world ). L’idea di sense-making enattivista è che l’organismo autoindividuato e l’ambiente emergano insieme, e che al variare dello stato di autonomia del sistema (che ricordiamo è sempre un processo dinamico e trasformativo), varino anche i valori distribuiti nell’ambiente.
Tuttavia, l’identificazione tra i concetti di semiosi utilizzati nella biosemiotica e nella semiotica cognitiva e quello di sense-making utilizzato dall’enattivismo potrebbe risultare problematica se si scendesse sotto alcune somiglianze di superficie tra gli approcci che le propongono. Vi sono infatti nel concetto di sense-making alcuni pericoli nascosti per la semiotica che andrebbero invece svelati ed emendati verificando le condizioni per l’assunzione di tale concetto. D’altra parte, il concetto di semiosi e significato di alcuni approcci biosemiotici mal si adatta a un approccio come quello enattivista. Insomma, è necessario chiedersi se realmente, il concetto di sense-making possa essere importato nell’epistemologia semiotica senza un’opportuna ritrattazione e se d’altra parte le riflessioni della semiotica possano in qualche modo adattarsi a un approccio enattivista.
Il sense-making tra immediatezza e antropomorfismo
Se da una parte il sense-making è descritto come un processo co-emergente interazionale e topologico, dall’altra bisogna prendere in seria considerazione la sua genesi e le modalità attraverso cui esso è pensato: spesso, infatti, nella letteratura esso è accostato a concetti fenomenologici come quello di soggettività, di teleologia, di esperienza, che rendono il concetto difficilmente maneggiabile al di fuori dell’ea.
L’aspetto problematico del sense-making per una semiotica è che esso è elaborato a partire da una particolare posizione filosofica che è quella dell’esistenzialismo biologico di Hans Jonas (Jonas 1966; Weber e Varela 2002). La base epistemologica per l’individuazione di una tale capacità è una forma di inferenza fenomenologica sul modo di esistere e di esperire dell’organismo dai caratteri decisamente antropomorfi. Viene cioè pensata come l’azione cognitiva di un soggetto che deve esperire il mondo in un certo modo (Thompson 2007, p. 49).
Ci sembra, allora, che il concetto di sense making giochi fin troppo tra una sua componente puramente relazionale e dinamica, che lo rende una condizione di possibilità della costruzione di un Umwelt, e una componente che invece lega la costruzione dell’Umwelt ad una necessità teorica per descrivere l’autonomia come individuazione di una soggettività. La continuità tra mente e vita proposta dall’enattivismo, nota come
strong life mind continuity thesis (slmct), è quindi caratterizzata anche da una continuità di carattere fenomenologico. Partendo infatti da quella che viene definita un’inferenza jonasiana (Villalobos, Ward 2016), gli enattivisti autopoietici difendono l’idea che il carattere fenomenologico degli organismi viventi è direttamente percepibile grazie al fatto che “la vita prepara l’osservatore a riconoscere la vita” (Jonas 1966, p. 91): è cioè possibile rintracciare l’esperienza esistenziale degli altri organismi grazie al suo essere comune alla nostra. L’autonomia dell’organismo appare allora già legata ad una forma di soggettività metabolica, ad un autopoietic self, che permette un affetto vitale dell’organismo, un feeling of being (Weber 2016).
L’introduzione dell’esistenzialismo bio-fenomenologico di Jonas ha portato in realtà a un ribaltamento totale di prospettiva e un rimescolamento degli elementi in gioco nel campo dell’enattivismo. Se in Varela, Thompson e Rosch (1991) la fenomenologia aveva un ruolo fondamentale ma sussidiario rispetto al modello teorico dell’enattivismo, con l’introduzione di Jonas i rapporti si ribaltano tanto che la teoria dei sistemi, i concetti di autonomia, adattività, chiusura operazionale etc. diventano uno strumento per affermare e confermare una teoria filosofica sulla continuità fenomenologica tra vita e mente. Il sense-making è lo strumento attraverso cui l’organismo distribuisce la propria cura (Sorge) nell’ambiente per poter agire in esso efficacemente (Weber e Varela 2002). Così facendo, come è stato fatto notare in diversi articoli (De Jesus 2016a, 2016b; Villalobos e Ward 2016), l’intero impianto teorico dell’ea ricade in un antropomorfismo che lo limita pesantemente. Dal punto di vista filosofico, infatti, l’attribuzione di una teleologia intrinseca, di una cura, di un’esperienza alle forme elementari di vita è una mossa che si fonda su un’inferenza di tipo analogico che può essere tranquillamente estesa a tutti i sistemi fisici: cosa ci impedisce di attribuire l’intenzione di raggiungere il mare ad un fiume che è un sistema autoindividuato e che mira a conservare la sua autonomia attraverso scambi con l’esterno (Villalobos, Ward 2016)? O ad una fiamma che vuole mantenere le proprie condizioni di stabilità? La critica allora mossa consiste fondamentalmente nell’affermare che, cercando nelle forme di vita elementari le strutture comuni alla cognizione umana, l’enattivismo autopoietico finisca per leggere le prime sotto la lente delle seconde, senza che
questa estensione sia sostenuta da salde basi epistemologiche. È su questa ambiguità che una semiotica può e deve riflettere, cercando altrove un fondamento del significato, non estendendolo sulla base di una intuizione fenomenologica al vivente.
La nostra impressione è che con Jonas si cada in una circolarità viziosa, nel senso che la necessità di costruire il modello della cognizione elementare per dare conto dell’esperienziale, finisca per ricorrere all’esperienza per spiegare come si forma la vita. A ben vedere, il paradigma di Jonas non porta effettivi vantaggi una volta inserito nell’enattivismo autopoietico, anzi costringe a utilizzare categorie validissime nell’ambito della biologia per spiegare fenomeni calati dall’alto di un punto di vista umano. Questa attribuzione, oltre che non necessaria, è anche dannosa perché costringe un modello epistemologicamente valido a un claim metafisico che potrebbe essere tranquillamente stemperato.
Oltre a presentare delle criticità interne, il modello jonasiano dell’enattivismo lo allontana drasticamente da un approccio semiotico, proprio perché parte da una nozione autoevidente di esperienza che non viene e non può essere spiegata. Se, infatti, la semiotica è una disciplina che pone il primato del dire sul mostrare (Paolucci 2010), e se all’evidenza immediata fenomenologica vuole fornire una spiegazione faneroscopica di come l’evidenza si formi a partire da delle categorie che la presentano sotto un certo rispetto, allora non può accettare una nozione che si fondi su un concetto tutto sommato magico, come quello che vede la vita riconoscibile dalla vita. Una tale affermazione sarebbe tutta da dimostrare non solo per la relazione che instaura, ma soprattutto per la consistenza dei suoi funtivi. Vengono infatti completamente tralasciate le condizioni di possibilità di questa stessa attribuzione. Se da una parte le scienze cognitive classiche pongono una forte discontinuità tra vivente e umano, il modello jonasiano si fonda su un’altra discontinuità stereotipica ben più radicata e invisibile a fondamento della epistemologia biologica occidentale, cioè la macro-differenziazione tra non-vita e vita. È seguendo un modello gerarchico ed arborescente che divide i non-viventi dai viventi, e poi gli stessi in generi e specie, che Jonas può avallare il tipo di esistenzialismo di cui si fa portavoce. In poche parole, è la sua stessa cultura che ha già spezzettato e costruito
una griglia concettuale che funge da base dell’estensione jonasiana di tratti e caratteristiche umane ai viventi. Siamo cioè per cultura, generalmente, disposti a rintracciare una continuità tra la l’E. coli e noi. “La vita prepara l’osservatore a riconoscere la vita” (Jonas 1966, p. 91) è un’affermazione che non tiene conto del fatto che sia un modello epistemologico (per quanto motivato da caratteristiche del mondo fisico, cfr. Morin 1980) ad assegnare le caratteristiche inserite nel termine ‘vita’. Non c’è nulla di immediato nella nostra interazione con piante e funghi che ci permetta di segnare una discontinuità con il fuoco o i fiumi. L’estensione dell’esperienza come tratto caratteristico dei sistemi viventi è certamente comprensibile, ma si basa su una serie di conoscenze precedenti circolanti nella nostra cultura di cui Jonas non tiene conto. Perché allora non affermare la “materia può essere conosciuta solo dalla materia” generalizzando, o “i cani possono essere conosciuti solo dai cani” specificando. Probabilmente su questo punto una semiotica può risultare molto utile, perché essa almeno nella formulazione peirciana della semiosi illimitata sposerebbe più un pensiero così formulato: “La semiosi pone le condizioni di conoscibilità della semiosi, e riconoscendole crea altra semiosi da riconoscere”. Sono esigenze di carattere pratico ed epistemologico quelle che ci portano a distinguere tra vita e non-vita, e comunque sempre inserite in una ecologia culturale (Descola 2005). Il punto che vogliamo sollevare non è che queste distinzioni siano infondate o da superare, anzi riteniamo al contrario che esse siano fondamentali per continuare l’indagine scientifica sul mondo e sulla natura. Si tratta piuttosto di rilevare come tali distinzioni siano frutto di un lavorio semiotico altamente specializzato e raffinato che non giustifica in nessun modo operazioni come quelle proposte dall’inferenza jonasiana. Non riconosciamo i caratteri della vita sulla base di un’esperienza immediata di comunanza con essa, li riconosciamo sulla base di criteri specialistici che permettono di investigare meglio alcuni ordini di fenomeni. L’E.coli è riconosciuto come vivente e come agente cognitivo non per un senso di empatia nei suoi confronti (se fosse così nulla vieterebbe di riconoscere nel fuoco la stessa potenza vitale), ma sulla base di un sistema di sapere e di tratti osservabili che separano il comportamento del fuoco da quello dell’E. coli. La possibilità di osservazione e di categorizzazione della vita dipende
Biosemiotica, semiotica cognitiva e sense-making
sempre da un metodo di osservazione, dipendente da un’epistemologia che a sua volta dipende da una cultura e da una ecologia di significazione in continuo riassestamento (Basso Fossali 2017).
Verso un enattivismo biosemiotico e i suoi limiti
La prima mossa da attuare per superare tali problemi consiste nel sottolineare come le critiche alla nozione di sense-making per come formulato nell’ea non inficiano il resto delle categorie utilizzate per descrivere la cognizione elementare, incluso il carattere di identità tra vita e cognizione. È possibile, infatti, pensare la slmct in modi che non necessariamente coinvolgono la filosofia di Hans Jonas e in questa operazione una perfetta candidata è proprio la semiotica perché:
• La semiotica, grazie al concetto di Sinechismo Peirciano, offre una forma di continuità tra le forme di cognizione più elementari e quelle di più alto livello compatibile con la slmct. In particolare, la biosemiotica parte dall’assunto fondamentale che i processi biologici e i processi semiotici siano coestensivi: dove c’è vita c’è semiosi (Sebeok 2001; Kull 2015; Prodi 1977).
• Il sense-making intrattiene con la biosemiotica un rapporto privilegiato (Weber 2001) sin dalla sua individuazione nella prima elaborazione del concetto a opera di Varela e Weber:
We may add to these converging ideas those originating from the emerging science of biosemiotics, which takes seriously not only the teleological, but also the crypto-semiotical discourse of adaptionism (in speaking of codes and information) by referring to the organism as a subject in its Umwelt (Hoffmeyer 1996; Kull 1999; Weber 2001). (Weber, Varela 2002, p. 111-112)
Se allora l’identificazione tra sense-making e semiotica può essere produttiva, essa deve essere ripensata alla luce della critica alla
fenomenologia jonasiana. Anzi, sin da subito ci si può rendere conto che nell’idea di sense-making coesistono un’anima fenomenologica e una biosemiotica: nel momento in cui la prima viene meno, la seconda è la candidata ideale per occupare il posto rimasto vacante.
Verso questa direzione si muove la recente proposta di un Biosemiotic Enactivism (De Jesus 2016b). Secondo De Jesus un approccio biosemiotico grazie al suo radicamento nella teoria dell’Umwelt e della semiosi è perfettamente in grado di bypassare la necessità di una inferenza jonasiana e il ricorso ad un antropomorfismo forte per comprendere l’esperienza degli organismi non umani. La biosemiotica, infatti, parte dal presupposto che tutti gli organismi viventi attraverso un processo incarnato e materiale di semiosi formano un sistema accoppiato con un ambiente intrinsecamente significativo (Umwelt) (Kull 1998; 2009), ma si differenzia dall’ea per il modo di concettualizzare l’istanziazione del punto di vista soggettivo: non è possibile stabilire la forma di esperienza dell’organismo a partire dalla sola osservazione del modo in cui agisce in un habitat che di fatto è creato dall’osservatore umano. L’unico modo che abbiamo per avvicinarci al modo in cui un ambiente è significativo per l’organismo è lo studio dei particolari cicli funzionali tra segnali effettori e ricettori, idea che la biosemiotica ha importato dalla biologia teoretica di von Uexküll (De Jesus 2016b, p. 17). In sostanza, solo studiando la struttura evolutiva e biologica di ogni organismo, oltre che il suo comportamento, è possibile avvicinarsi alla ricostruzione del suo Umwelt (von Uexküll 1926). Si deve partire quindi dallo studio dell’organismo per determinarne la forma del sense-making e non partire dall’esperienza umana per spiegare quella non-umana. Non c’è alcun bisogno, se si usa una prospettiva biosemiotica, di proiettare verso altri organismi la forma dell’esperienza umana con il suo centro di referenza soggettivo da cui si propagano i significati, si deve al contrario partire dall’assunto che ogni organismo ha il proprio particolare accoppiamento con l’Umwelt la cui forma significativa è ancorata alla sua struttura biologica ed è differente da specie a specie. La proposta di De Jesus è allora quella di indicare nella semiosi la forma generale del sense-making in modo tale da definire la cognizione come “the active and creative process of bio-semiosis by bio-semiotic systems” (De Jesus 2016b, p. 25).
Si dovrebbe notare, però, che la biosemiotica presenta anche degli aspetti problematici per l’enattivismo e la sua ispirazione anti-rappresentazionalista. Infatti, se è vero che per la biosemiotica l’organismo attraverso la semiosi produce il suo stesso mondo, è altrettanto vero che in seguito diventa l’interprete dei segni che produce: cioè, il processo semiosico che vede nel segno una relazione tra oggetto-representamen-interpretante si declina come una funzione di traduzione tra interno ed esterno dell’organismo. Il segno interpretante che permette di mettere in relazione il segno con il suo oggetto è un segno che appartiene all’interprete cioè all’organismo biologico “Signs, in other words, refer to something else by eliciting an interpretative process in an organism” (Hoffmeyer 2012, p. 106). Seppure questa nozione di semiosi effettivamente metta in luce la matrice attiva di ogni cognizione attraverso l’atto di interpretazione, essa mantiene una forma rappresentazionale della cognizione elementare e non umana, come si può capire da alcuni esempi:
Thus, when a deer senses smoke it is immediately “seized by alarm” (the interpretant) and flees away. The deer may or may not understand that smoke signifies fire but it certainly knows that smoke signifies danger (the object). Likewise, when a macrophage (a cell from the immune system) lets hiv virus into its interior, this is caused by the cell falsely interpreting the virus as belonging to the body itself. (Hoffmeyer 2012, p. 107)
Il fatto che un cervo possa riconoscere il fumo come un segnale di pericolo presuppone una semantica elementare che include “pericolo” come interpretante cognitivo del fumo: c’è, cioè, una operazione di categorizzazione dei segni dell’Umwelt, che permette una determinata azione dell’organismo. De Jesus, nel suo tentativo di integrazione biosemiotica dell’enattivismo, scivola in questa ambiguità. La biosemiotica effettivamente concepisce la semiosi come il processo di produzione e di interpretazione dei segni e la usa per spiegare la cognizione animale; tuttavia, non individuando la sovrapposizione tra semiosi e cognizione, questi due termini assumono un valore diverso nell’approccio biosemiotico rispetto a quello che possono avere in un approccio enattivista. Se, nel primo, il concetto di
interpretazione dei segni è una sorta di metafora (Kull 2015) che spiega il funzionamento logico-semiotico della vita, nel secondo caso, con l’introduzione della cognizione nel binomio vita-semioisi, il rischio è quello di ritornare a un approccio rappresentazionale che è quello che in tutti i modi l’enattivismo cerca di evitare. Un conto è dire che l’organismo interpreta dei segni in senso semiotico, un’altra è dire che l’organismo è un “adaptive (autopoietic) behaviourally plastic system with the (bio-semiotic) ability to recognise something as standing for something else” (De Jesus 2016b: 27). L’idea che la vita sia coestensiva alla semiosi e che il sense-making funzioni attraverso la distribuzione di segni in un ambiente è effettivamente una mossa che permette di salvaguardare il sense-making da ricadute antropomorfiche, ma non può essere tentata a partire da una nozione di interpretazione ancora troppo legata ad una prospettiva rappresentazionale (come, tra l’altro, è stato notato da Hutto e Myin 2017, p. 80). Dire che l’organismo interpreta i segni “come segni di qualcosa” significa allontanarsi dalla nozione di sense-making trascinandola verso una nozione semantica della cognizione. Questo non vuol dire che il tentativo di una integrazione biosemiotica dell’enattivismo debba essere abbandonato, ma che debba essere ripensato alla luce di una maggiore consapevolezza dall’apparato teorico della semiotica e delle sue divisioni interne.
La tradizione semiotica, fortunatamente, ha elaborato già una differenziazione simile a quella che stiamo cercando. Nella riflessione biosemiotica si è in effetti sin da subito posto il problema di come differenziare il tipo di semiosi umana e culturale dalla semiosi che interviene negli organismi più elementari: una risposta efficace in tal senso è a nostro parere quella di John Deely. Deely distingue due tipi di semiosi: per tutti gli animali (o piante) si parla di uso dei segni, mentre l’uomo è l’unico animale che riconosce la dimensione segnica e usa i segni come tali.
Now it is an interesting fact that all animals perforce make use of signs, but only human animals come to know that there are signs. And this fact is a consequence of another fact, namely, that the being proper to signs does not belong to the subjective order because it consists formally in a relation, though a relation of a certain type – a relation that is irreducibly triadic, in
Biosemiotica, semiotica cognitiva e sense-making
contrast to, for example, relations of cause and effect which are dyadic in nature. (Deely 2014, p. 30)
Da questo punto si può partire per allontanare una biosemiotica enattivista dal pericolo rappresentazionalista: l’organismo non interpreta gli elementi del mondo come se fossero qualcos’altro, ma li usa sulla base di processi semiotici a cui non ha accesso. Una nozione più incentrata sul carattere pratico della semiosi, non impostata sulla cognizione intesa come comprensione e interpretazione del segno in quanto segno, ma su una nozione di uso del segno, può essere vincente e può permetterci di identificare quella discontinuità tra cognizione umana e altri tipi di cognizione. La riflessione di Paolucci (2021) può essere allora estrememamente utile su questo livello dal momento che essa connette il concetto di sense-making al pragmatismo e allo stesso tempo coniuga il processo di semiosi dell’organismo con una impostazione radicalmente enattivista.
Pragmatismo, semiotica e sense-making
Partendo da una impostazione pragmatista, Paolucci (2021) è in grado di servirsi della riflessione sul sense-making dell’ea definendo il sense-making come un processo semiotico. I significati che costituiscono l’Umwelt dell’individuo non sono processati e interpretati a partire da rappresentazioni, ma sono salienze del mondo che fungono da forme di un’espressione il cui contenuto consiste nelle azioni che generano. Il significato di un determinato elemento dell’ambiente si incarna così negli abiti di azione che esso genera. Il mondo-ambiente, imbevuto di significati volti a mantenere l’autonomia del sistema, è rappresentato in una prospettiva semiotica come uno spazio topologico in cui i significati sono distribuiti, interrelati e in continuo scambio valoriale, cioè in costante movimento (cfr. Basso Fossali 2009). L’azione dell’organismo nel suo ambiente è volta a calibrare e monitorare questa instabilità del movimento valoriale e si esprime attraverso abiti, cioè pattern di azioni che esprimono un quadro di relazione determinato tra organismo e ambiente. La differenza sostanziale con il sense-making nella sua radice fenomenologica è che, in un’ottica semiotica, la distribuzione di valori nell’ambiente non dipende solo da una azione
cognitiva dell’organismo, ma costituisce anche lo sfondo e la possibilità di una tale azione. In questa ottica, gli organismi sono un elemento in un sistema più vasto, ne occupano uno spazio e rispondono a determinati tipi di organizzazione di valori all’interno dell’ambiente di cui essi stessi fanno parte: ovvero, di fronte ad una data relazione globale e sistemica, agiscono sulla base di un abito.
Prendiamo l’esempio classico del batterio di Escherichia Coli, il cui sense-making nella letteratura enattivista è descritto così:
Escherichia coli (E. coli) is a kind of bacteria that has motile, rod-shaped cells. When swimming in the presence of a sucrose gradient, these cells will tumble about until they hit upon an orientation that increases their exposure to sucrose. At this point they will swim forward, up-gradient, propelled by their flagella, toward the zone of greatest sucrose concentration. While sucrose is a real and present condition of the physicochemical environment, the status of sucrose as a nutrient is not. Being a nutrient is not intrinsic to the physicochemical structure of the sucrose molecule; it is a relational feature, linked to the bacterium’s metabolism. In Merleau-Ponty’s terminology, the status of sucrose as food is virtual. It is something actualized at another level. […] Sucrose belongs to the physical order; sucrose as-nutrient belongs to the living order. Sucrose has meaning and value as food but only in the milieu that “the system itself brings into existence” or “constitutes for itself”. (Thompson 2007, p. 74)
La descrizione relazionale dello statuto del saccarosio come nutriente è perfettamente in linea con l’idea topologica e relazionale alla base di un approccio semiotico. Ma vediamo come l’ea spiega questa proprietà a partire dalla fenomenologia: il valore di nutriente è virtuale, ed è realizzato ad un altro livello rispetto a quello chimico-fisico, cioè la dimensione del vivente. Il saccarosio ha valore di nutriente solo nel milieu che l’organismo instaura. C’è quindi una divisione tra virtuale e reale: il saccarosio è realmente una molecola chimico-fisica, ma la sua proprietà virtuale è quella di essere un nutriente. Se, invece, si considera il campo di significazione come una dimensione a cui l’organismo ha accesso, e che non crea ex-novo,
allora non possiamo più supportare questa distinzione. L’organismo non crea un campo virtuale di significazione, al massimo si ritrova inserito in esso, con le conseguenze che:
• la dimensione chimico fisica del saccarosio semplicemente non è più reale di altre e non si oppone alla virtualità del valore “nutriente”, in quanto la dimensione chimico-fisica del saccarosio è pertinentizzata solo dall’essere umano che riesce a schedarla sotto quel rispetto. Non c’è pertanto una dimensione del saccarosio più o meno virtuale dell’altra: sono tutte virtuali alla stessa maniera. Ci sono solo organismi che reagiscono in maniera diversa a determinati stimoli laddove questi stimoli fanno effettivamente parte dell’Umwelt di un organismo. È la modalità attraverso cui l’organismo accede alla virtualità dei significati che ne permette un’attualizzazione prima e una realizzazione poi6.
• la dimensione virtuale “nutriente” in realtà non è il significato che l’E. Coli attribuisce al saccarosio, ma è la modalità attraverso cui noi interpretiamo l’abito d’azione che si instaura nell’E.
Coli ogni volta che esso ha un deficit energetico e trova nel suo ambiente quella superficie significante che noi chiamiamo “saccarosio”. Il valore “nutriente” del saccarosio è il risultato di una relazione che si attualizza grazi all’accoppiamento dinamico tra l’E. Coli e il suo ambiente e si realizza attraverso l’azione di fagocitazione della molecola di saccarosio: il significato del “saccarosio” è per l’E. Coli l’atto stesso della sua assimilazione.
L’organismo è dunque sempre inserito in una topologia di rapporti virtuali che costituiscono lo sfondo dell’azione, e il sense-making altro non è che la funzione di attualizzare questi rapporti e realizzarli attraverso una agency volta a stabilizzare l’autonomia dell’organismo. Da osservatori, possiamo notare l’attualizzazione di questi rapporti virtuali attraverso lo
6 Su questi passaggi semiotici tra virtuale, attuale e realizzato cfr. Paolucci 2020.
studio delle strutture biologiche e delle tendenze di comportamento degli organismi non umani, evitando di individuare nella virtualità una forma di rappresentazione interna del quadro di rapporti in gioco nell’interazione ambientale. Tale virtualità deve essere piuttosto vista come la forma delle possibili relazioni che si possono istaurare tra un determinato organismo e un determinato ambiente, il ritaglio e la selezione dei significati virtuali è attualizzata dall’organismo sulla base dei suoi abiti, “a tendency actually to behave in a similar way under similar circumstances in the future” (cp 5.487). L’abito viene quindi identificato tout court con il risultato di un processo di semiosi e, quindi, con l’interpretante attraverso cui l’organismo produce il suo mondo “in order to act in the world in an effective way” (Paolucci 2021, p. 4).
Dal soggetto autopoietico al sistema semiotico
La prima conseguenza di questa mossa è che la semiosi non può essere il risultato dell’acquisizione di una soggettività autoindividuata, come nell’impostazione fenomenologica della slmct. Piuttosto, dobbiamo concepire la semiosi come fenomeno co-emergente al sistema vita-ambiente: non c’è nessuna operazione di creazione dell’Umwelt da parte del soggetto autopoietico, al contrario c’è l’accesso ad un Umwelt garantito dalle stesse condizioni che determinano l’autopoiesi. Le strutture biologiche dell’organismo e l’ambiente in cui esso si forma e si sviluppa costituiscono il sistema semiotico nel quale può avvenire un processo di sense-making.
La semiotica ha sempre posto al centro la natura sistemica della semiosi (Eco 1975, Paolucci 2010; 2017) come elemento terzo che permette di individuare e comprendere la struttura oppositiva e diadica delle relazioni tra soggetto e oggetto. Tale natura sistemica è perfettamente compatibile con il claim dell’enattivismo autopoietico sulla formazione e sullo sviluppo della cognizione con la vita. Utilizzando la semiotica e il concetto di abito (Fanaya 2020), non abbiamo bisogno di nessuna categoria fenomenologica come quella di soggettività per poter descrivere l’intenzionalità, la prospetticità e la dimensione significativa della cognizione elementare (Basso Fossali 2009). Inoltre, in questo quadro non si ha la necessità di impostare
semiotica cognitiva e sense-making
il sense-making come un’operazione che si muove dall’organismo soggetto verso il mondo trasformandolo in un ambiente carico di valori. L’ottica semiotica rende onore alla dimensione sistemica e interattiva dell’enattivismo autopoietico, in cui l’ambiente ha un ruolo attivo nella strutturazione del senso e in cui la cognizione è intesa come una proprietà estensiva del sistema tout court (Di Paolo 2009). Semiosi e sistema coincidono, distribuiscono i posti per l’agente e il suo mondo significativo, e fanno emergere la possibilità stessa della cognizione.
Il superamento dell’antropomorfismo e dell’estensione del concetto di esperienza a forme di vita elementari può quindi reggersi su una logica dell’abito e della semiosi, che permette di mantenere la continuità tra vita e cognizione e allo stesso tempo di specificarne i domini sulla base di una biosemiotica. Eliminare l’idea di un soggetto dalla cognizione elementare permette di sorpassare definitivamente l’idea che sia l’organismo a distribuire i significati (e in effetti verrebbe da chiedersi da dove questi significati provengano), e a sposare l’idea che il sistema stesso emerga esattamente come l’accoppiamento tra un organismo e un mondo significativo. L’Umwelt non deve essere perciò pensato nei termini di un accesso soggettivo alla realtà che la dota di un significato, ma come un insieme di relazioni che connettono l’organismo e il suo proprio mondo. Esso è il risultato di una storia evolutiva che seleziona relazioni pertinenti tra l’ambiente circostante e un organismo: altro non è che il mondo a cui l’organismo risponde attraverso un attunement. Eliminando l’idea di soggettività, ci troviamo di fronte ai soli sistemi accoppiati, ad agenti autopoietici in grado di instaurare abiti di azione in un ambiente già carico di una significazione virtuale, da gestire e calibrare in vivo e non da creare ex novo
Sense-making come sottrazione di virtualità
Proprio grazie alla componente sistemica, che l’enattivismo autopoietico già pensava come elemento fondamentale per descrivere la cognizione, è possibile inquadrare il sense-making da una prospettiva semiotica piuttosto che fenomenologica.
Non è un caso allora che Paolucci, parlando del sense-making, lo descriva come una forma di ritaglio di un continuum pre-semiotico, una
forma di selezione di valori. Tale visione, che avvicina il sense-making alla nozione di ritaglio del continuum hjemsleviano (legato a un sistema e non a un soggetto), porta a superare completamente la nozione di creazione di virtualità che è alla base della lettura fenomenologica di questa operazione cognitiva. Se il soggetto autopoietico fenomenologico istituisce il suo mondo attraverso la creazione di un campo virtuale, il sistema autopoietico semiotico istituisce il suo mondo tramite attualizzazione (selezione e stabilizzazione) e realizzazione delle virtualità che si originano dai processi di autoindividuazione. L’operazione è diversa perché in un caso, quello fenomenologico, c’è un’aggiunta di senso che crea un Umwelt, nell’altro, quello semiotico, c’è una aggiunta di sottrazioni di senso che accede ad un Umwelt, sulla base di abiti precedenti.
sense making is an adding subtraction activity which carves out its own subwhole of relevant interactions from within a dynamic coupling between organism and environment which have value for the system and the organism which has been built as detached from its environment world. In brief, sense making is an activity involving adding subtractions which carve out a world of values and meanings (an environment world) from the starting point of other possible environment worlds. (Paolucci 2021, p. 24)
A testimonianza del fatto che una nozione semiotica e pragmatista del sense-making non tolga nulla ad una sua formulazione enattivista, salvandola anzi dalle critiche che vengono indirizzate alla sua ispirazione fenomenologica, dobbiamo prendere in considerazione una recente definizione di sense-making offerta in Di Paolo et al. (2018). In questo testo, dopo aver fornito definizioni di sense-making classiche e in linea con tutta la corrente dell’enattivismo autopoietico, gli autori, in una sezione in cui cercano di difendere il sense-making da alcune critiche, tentano una spiegazione nuova:
However, sense-making is not an act of “adding meaning” to a physical coupling with the environment, as if the latter was a vehicle of information that must be communicated to the agent. Quite the opposite: […],
Biosemiotica, semiotica cognitiva e sense-making
sense-making does not “add” anything to the rich coupling with the environment, it “subtracts” from it by monitoring and responding to only a small and relevant subset of all the influences that impinge on the organism, a subset out of which the organism constitutes itself as a sensemaker. (Di Paolo et al 2018, p. 36)
È evidente allora che, sin dall’inizio, la logica sistemica che vede la co-emergenza di organismo e sense-making sia concepita come una forma di “sottrazione” o di “aggiunta di sottrazioni”: un processo costante di calibrazione del coupling strutturale attraverso una valorizzazione di alcune salienze e soppressione di altre. Resta da chiedersi a questo punto quale senso abbia appoggiarsi ad una nozione di soggettività e all’idea di una distinzione forte tra interno ed esterno da cui si dipanano le significazioni: fondare la nozione di sense-making sulla filosofia di Hans Jonas significa snaturarne il fondamento strutturale e dinamico. È conveniente invece ancorarla al pragmatismo semiotico di Peirce e ad una biosemiotica riformulata enattivamente. Già De Jesus (2016b) è riuscito a dimostrare la validità della biosemiotica nel superare i problemi dell’antropomorfismo jonasiano, ma con forti conseguenze sull’antirappresentazionalismo dell’approccio. Noi crediamo di aver mostrato come una biosemiotica retta sul pragmatismo e su una semiotica cognitiva, attraverso la sua nozione di abito, di sistema semiotico e di semiosi come aggiunta di sottrazioni riesca a mantenere intatta l’efficacia del sense-making (garantita dalla nozione di abito) e a salvaguardare una componente esperienziale (garantita dalla nozione di Umwelt), senza cadere in una forma di rappresentazionalismo.
Conclusioni
La nostra argomentazione dovrebbe quindi aver mostrato come ci siano ottime ragioni per poter ripensare e affrontare i problemi posti dalla soglia inferiore della semiotica attraverso uno sguardo federato tra semiotica cognitiva e biosemiotica che rintracci nell’enattivismo e nella sua teoria dei sistemi un terreno di gioco valido, aperto anche all’analisi sperimentale. Una riflessione di questo tipo deve sicuramente ruotare attorno al concetto
di sense-making come operazione fondamentale capace di tenere assieme vita, semiosi e cognizione; tuttavia, tale concetto dovrà essere utilizzato in una chiave pragmatista e biosemiotica in sostituzione della sua ingombrante (quanto per noi poco utile) ascendenza esistenzialista. Solo così la semiotica potrà passare da essere la disciplina che studia come l’animale umano interpreta il mondo (Eco 2006) a essere la disciplina che indaga come gli esseri viventi costruiscano il loro ambiente carico di virtualità semiotiche da gestire.
Riferimenti
Barbieri. M. (2006). Introduction to biosemiotics. Springer
Barbieri, M. (a cura di). (2008). The codes of life. Springer. Basso Fossali, P. (2009). La tenuta del senso: Per una semiotica della percezione Aracne.
Basso Fossali, P. (2017). Vers une écologie sémiotique de la culture. Perception, gestion et réappropriation du sens. Lambert-Lucas. Brandt, P. A. (2020). Cognitive semiotics. signs, mind, and meaning. Bloomsbury. Cimatti, F. (2000). Nel segno del cerchio: L’ontologia semiotica di Giorgio Prodi LeEscheo.
Cirla, A. (Luglio 31, 2019). Umberto Eco. Semiotica: Origini, definizione, sguardo sul presente, intervista di Leonardo Romei a Monte Cerignone [video]. YouTube. https://youtu.be/VJi6vxYz6cI?si=DtNraAjCNwvpLm8t
Cobley, P. (2016). Cultural implications of biosemiotics. Springer.
Daddesio, T. C. (1994). On minds and symbols. De Gruyter.
De Jesus P. (2016a). Autopoietic enactivism, phenomenology and the deep continuity between life and mind. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 15(2), 265-289.
De Jesus P. (2016b). From enactive phenomenology to biosemiotic enactivism. Adaptive Behavior, 24(2), 130-146.
Deely J. (2014). Semiotic entanglement: The concepts of environment, Umwelt, and Lebenswelt in semiotic perspective. Semiotica, 199, 7 - 42
Descola, P. (2005). Par-delà nature et culture. Gallimard.
Di Paolo, E. A. (2005). Autopoiesis, adaptivity, teleology, agency. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 4(4), 429-452.
Di Paolo, E. A. (2009). Extended life. Topoi, 28, 9-21.
Di Paolo, E. A., Buhrmann, T. e Barandiaran, X. E. (2017). Sensorimotor life: An enactive proposal. Oxford University Press.
semiotica cognitiva e sense-making
Di Paolo, E. A., Cuffari, E. C. e De Jaegher, H. (2018). Linguistic bodies: The continuity between life and language mit Press.
Eco, U. (1975). Trattato di semiotica generale. Bompiani.
Eco, U. (1990). I limiti dell’interpretazione. Bompiani.
Eco, U. (1997). Kant e l’ornitorinco. Bompiani.
Eco U. (2009). Dall’albero al labirinto. Bompiani.
Fabbrichesi R. (2018). Come la fenomenologia diventò faneroscopia: Il progetto di Peirce di una “Filosofia Suprema”. Bollettino Filosofico, 33, 217-225.
Fanaya P. F. (2020). Autopoietic enactivism: Action and representation re-examined under Peirce’s light. Synthese.
Hoffmeyer, J. (2008). Biosemiotics: An examination into the signs of life and the life of signs. University of Scranton Press.
Hoffmeyer, J. (2012). The natural history of intentionality. In T. Schilhab, F. Stjernfelt, T. Deacon (a cura di), The symbolic species evolved (pp. 76-116). Springer. Jonas, H. (1966). The Phenomenon of life: Toward a philosophical Biology. University of Chicago Press.
Konderak, P. (2018). Mind, cognition, semiosis: Ways to Cognitive Semiotics. Marie Curie-Skłodowska University Press.
Kull, K. (1998). On semiosis, umwelt, and semiosphere. Semiotica, 120(3/4), 299-310.
Kull, K. (2009). Vegetative, animal, and cultural semiosis: The semiotic threshold zones. Cognitive Semiotics, 4(Spring), 8-27.
Kull, K. (2015). Introduction to Biosemiotics. P. Trifonas (a cura di), International handbook of semiotics (pp. 521-534). Springer.
Kull, K. (2018). Choosing and learning: Semiosis means choice. Sign Systems Studies, 46(4), 452-466.
Lobaccaro, L. (2022). Cognitive semiotics. Zeitschrift fur Semiotk, 44, 157–182.. Luisi, M. (2017). Peirce e la fenomenologia. Soveria Mannelli.
Maturana, H. e Varela, F. (1980). Autopoiesis and cognition: The realization of the living. D. Reidel Publishing Company.
Morin, E. (1980). La Méthode 2. La Vie de la Vie. Editions du Seuil.
Paolucci, C. (2010). Strutturalismo e Interpretazione. Bompiani. Paolucci, C. (2015). Logica dei relativi, semiotica e fenomenologia: Per un Peirce “Non-Standard”. In M. Bonfantini, R. Fabbrichesi, S. Zingale (a cura di), Su Peirce. Interpretazioni, ricerche, prospettive (pp. 197-126). Bompiani.
Paolucci, C. (2017). Semiotics, schemata, diagrams and graphs: A new form of diagrammatic kantism by Peirce. In K. Hull e R. Kenneth (a cura di), Peirce on perception and reasoning: From icons to logic. Routledge. Paolucci, C. (2020). Persona: Soggettività nel linguaggio e semiotica dell’enunciazione Bompiani.
Paolucci, C. (2021). Cognitive semiotics: Integrating signs, minds, meaning and cognition. Springer
Peirce, C. S., Hartshorne, C. e Weiss, P. (a cura di). (1935). Collected papers of Charles Sanders Peirce (vo. i-vi). Harvard University Press.
Ponzio, A. e Petrilli, S. (2002). I segni e la vita: La semiotica globale di Thomas A. Sebeok. Spirali.
Prodi, G. (1977). Le basi materiali della significazione. Bompiani.
Sebeok, T. A. (1977). The sign & its masters. University of Texas Press.
Sebeok T. A. (2001). Global semiotics. Indiana University Press.
Sini, C. (2017). Lo spazio del segno: Semiotica ed ermeneutica (vol. i). Jaca Book
Thompson, E. (2007). Mind in life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind. Harvard University Press.
Thompson, E. e Di Paolo, E. A. (2014). The enactive approach. In L. Shapiro (a cura di), The Routledge handbook of embodied cognition (pp. 68-78). Routledge.
Varela, F. J. (1988). Structural coupling and the origin of meaning in a simple cellular automation. In E. Sercarz, F. Celada, N. A. Mitchison, T. Tada (a cura di), The semiotics of cellular communication in the immune system. Springer.
Varela, F., Thompson, E. e Rosch, E. (1991). The embodied mind: Cognitive science and human experience mit Press.
Villalobos, M. e Ward, D. (2016). Lived experience and cognitive science reappraising enactivism’s Jonasian turn. Constructivist foundations, 11(2), 204-212.
Violi, P. (1988). A nonrestrictive semiotics of the immune system. In E. Sercarz, F. Celada, N. A. Mitchison, T. Tada (a cura di), The semiotics of cellular communication in the immune system. Springer.
Violi, P. (2007). Semiosis without consciousness? An ontogenetic perspective. Cognitive Semiotics, 1(fall), 65-86
Von Uexküll, J. (1926). Theoretical Biology. Brace & Co.
Weber, A. (2001). The ‘surplus of meaning’. Biosemiotic aspects in Francisco J. Varela’s philosophy of cognition. Cybernetics & Human Knowing, 9(2), 11-29
Weber, A. (2016). Biopoetics: Towards an Existential Ecology. Springer
Weber, A. e Varela, F. (2002). Life after Kant: Natural purposes and the autopoietic foundations of biological individuality. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 1, 97-125.
Verso una Biosemiotica Ecosistemica: la soglia semiotica tra vita e non vita
Abstract
Il presente saggio prende le mosse dalla premessa di Sebeok secondo il quale “la semiosi e la vita sono coestensive”. Partendo da tale assioma si mostrerà che, nonostante la biosemiotica abbia esteso la soglia inferiore della semiotica al di là della sfera umana, emerge una soglia che cerca di separare nettamente il vivente dal non vivente sorretta da un’impostazione biocentrica. Il primo obiettivo è di mostrare come tale soglia sia sfumata, facendo emergere la continuità e l’emersione del significato esistente in natura tra entità eterogenee. Il secondo scopo è dimostrare che la nozione di “vita” è per la biosemiotica un termine non marcato e indecidibile. Per fare ciò ci avvarremo delle teorie della complessità e dell’ecosemiotica come metodologie per tenere insieme la necessaria pertinentizzazione della semiotica e una semiotica del continuum. Tale visione sarà denominata “Biosemiotica Ecosistemica”, ossia una biosemiotica che indaga le forme di vita, la loro relazionalità e dipendenza semiosica da elementi non viventi, cercando di ipotizzare una semiosi al di là del regno organico.
If we wish to sum up the relation between sign-science and life-science, we may say that each extends beyond the other in the knowledge that it typically achieves. Life is more than semiosis; conversely, semiosis is more than life. But of the two, semiosis is the more general process, and broader overall. Moreover, when it comes to living beings, the causality proper to signs is so completely interwoven with the fabric of interactions whereby life develops, so delicately maintained in the specification of the other channels of causality that structure that interaction, that to separate it in analysis from vital activity is already an achievement of intellectual abstraction in the
scientific sense. Whence the life-science is not the sign-science, even though, without semiosis, there would be neither life nor science of whatever kind.
Jhon Deely 1992
Introduzione
Il termine biosemiotica è stato utilizzato, come ha recentemente argomentato Kalevi Kull (2022), per la prima volta da Vincent Kletzinsky, professore di chimica a Vienna, in un articolo del 1855. Il termine veniva utilizzato per indicare sostanze chimiche significative per alcune patologie della vita animale e vegetale. Tuttavia, la nozione ha assunto il suo significato più influente grazie a un articolo dello psichiatra Friedrich Rothschild (1962), in cui definiva un certo tipo di significato che collegava il linguaggio alla vita. Rothschild coniò questa terminologia per dedurre tre leggi che contemplavano il programma degli esseri viventi (in quanto soggettività costruite su una polarizzazione tra sé e non sé) di mantenere la loro unità in quanto coerenti, di costruire una comunicazione tra organismo e oggetti nel mondo e una nuova intenzionalità emergente da processi precedenti1 Un anno dopo, Thomas Sebeok (1963) introduceva il concetto di “zoosemiotica”. È grazie al semiologo di origine ungherese che la biosemiotica è diventata un campo di studi autonomo volto a indagare la relazione tra segno e significato negli organismi viventi (Kull 2003). Nella prima parte del suo lavoro, Sebeok vedeva la semiosi come la base di tutti i processi vitali, ma in seguito identificò la semiosi con la vita stessa (Ponzio, Petrilli 2002). Per questo motivo, la proposta fondamentale della biosemiotica è quella di suggerire che i processi semiosici non appartengono solo all’uomo, ma anche agli animali (Sebeok 1988), alle piante (Krampen 1981), fino alla cellula come unità minima di base (Hoffmeyer 1996)2.
1 Il discorso di Rothschild è rimasto a lungo chiuso all’interno del dibattito della psichiatria e quindi poco esposto all’attenzione dei semiologi. Si veda (Kull, 1999). Come è risaputo il termine “biosemiotica” è stato usato da Juri Stepanov nel 1971, Marcel Florkin e parallelamente da Walter Koch nel 1974 e, infine, da Rudolf Jander nel 1981.
2 La cellula è utilizzata dalla biosemiotica proprio come unità semiotica minima, essendo l’unità di base della vita (Hoffmeyer, 1992).
Negli anni Settanta, anche in Italia si è svolto un importante dibattito sulle soglie semiotiche tra Giorgio Prodi e Umberto Eco (Eco 1997, 2018; Kull 2018; Cimatti 2000, 2018, 2019), che è stato ripreso dalla biosemiotica per impostare un nuovo discorso sui processi semiotici dei non-umani. La biosemiotica ha avuto l’effetto di spostare la soglia inferiore della semiotica, livello in cui possiamo riferirci a un’azione segnica in opposizione a un’attività non semiotica (Rodriguez Higuera, Kull 2017). L’ampliamento delle soglie, per definire cosa includere nella semiosi, ha portato a un arricchimento e a una maggiore libertà per la biosemiotica a livello interdisciplinare (Nöth 1990). La condizione per cui ogni forma vivente utilizza dei processi semiotici ha dato voce a una moltitudine eterogenea di prospettive. Tuttavia, anche la biosemiotica ha dovuto definire la sua soglia inferiore, mostrando come la semiosi emerga esclusivamente all’interno di ciò che viene definito “vita”. La vita è la soglia inferiore della biosemiotica. Lo scopo del presente saggio è quello di rimettere in discussione le premesse della biosemiotica, mostrando come questo campo di ricerca sia coordinato da una prospettiva biocentrica. Successivamente, si cercherà di mostrare che i sistemi viventi non possono essere estratti dal loro contesto, motivando a considerare una differente semiotica che si estende al di là della vita. I sistemi viventi3, come vedremo, non sono limitati alle sole funzioni biologiche, ma sono aperti alle opportunità offerte dal significato dei materiali che compongono l’ambiente o Umwelt. La vita produce e si produce in relazione ad un contesto interno (Innenwelt) ed esterno. In questo senso, la vita è un processo ibrido che emerge da forze collettive eterogenee, processi che manifestano l’emersione del significato anche nel dominio materiale non vivente. Infine, a partire da quella che definiremo “visione ecosistemica della vita”, un punto di vista che interseca le teorie della complessità, la semiotica e l’ecologia, si proporrà una ridefinizione dell’ecosemiotica da una prospettiva olistica e integrata. La metodologia
3 Quando mi riferirò a “sistemi viventi” intendo i sistemi materiali, organismi caratterizzati da un grado di complessità e organizzazione, classificati come sistemi aperti che scambiano con l’ambiente esterno materia ed energia. Mentre con “vita” indico la condizione degli esseri viventi che permette loro di crescere, svilupparsi, muoversi autonomamente, autoregolarsi, adattarsi, reagire agli stimoli e riprodursi.
di indagine si avvarrà delle teorie della complessità per rendere conto dei sistemi viventi come sistemi non lineari, non deterministici, auto-organizzativi, dinamici, storici e produttori di novità. I sistemi complessi sono sistemi altamente connessi al loro interno e aperti all’ambiente, con il quale scambiano materia, energia e messaggi. Si tratta di ripensare la nozione di vita partendo dalle relazioni ecologiche, integrando in esse differenti processi semiosici che producono e sostengono i sistemi viventi. Tale prospettiva si presenta come un’indagine di ricerca ancora in fase germinale, nella quale si desidera meramente porre in questione le soglie semiotiche tra ciò che viene definito vita e ciò che resta al di fuori, indagando l’insorgenza del senso nel dominio della natura. La speranza è quella di offrire una prospettiva feconda per il dibattito biosemiotico contemporaneo, seguendo le tracce di quella semiotica italiana minore che si era affacciata nel dibattito della seconda metà del Novecento e che ha avuto una risonanza maggiore all’estero. Il seguente scritto si presenta dunque come un primo impianto di una rinnovata biosemiotica italiana o quella che potremmo pensare di battezzare come Biosemiotica Ecosistemica 4 .
Le premesse della biosemiotica
La biosemiotica, insieme alle sue diverse branche emerse a partire dagli anni Sessanta, è stata ripensata in modo omogeneo nel 2004 grazie a una serie di conferenze e incontri. L’idea generale alla base di questa unificazione era la necessità di avere delle premesse comuni per far comunicare in modo proficuo i diversi campi, unendoli tutti sotto un’ottica condivisa. Il desiderio di lavorare insieme necessitava di alcuni presupposti che dovevano essere accettati per evitare lo sconvolgimento di un campo di studi che, se confrontato con quello più solido e istituzionalizzato della semiotica culturale, mostrava alcune fragilità. Ovviamente non si tratta qui della nascita della biosemiotica in senso stretto, né della formulazione dei suoi principi fondanti, che erano già stati chiariti nella seconda metà del Novecento da autori come Thomas A. Sebeok, Thure von Uexküll, Jesper
4 Questa tesi è stata presentata come ipotesi di lavoro durante il XXIII Gatherings in Biosemiotics tenutosi a Copenaghen, dal 31 luglio al 4 agosto 2023.
Hoffmeyer, Claus Emmeche, Kalevi Kull, e Anton Markoš. Piuttosto, si fa riferimento al momento in cui si iniziarono a esplicitare per iscritto alcune premesse condivise, in grado di tenere insieme una pluralità di approcci. Un aspetto raramente menzionato nelle ricostruzioni canoniche della storia della biosemiotica riguarda proprio le difficoltà incontrate agli inizi degli anni Novanta, quando il termine “biosemiotica” fu talvolta utilizzato in ambienti pseudoscientifici o legati al pensiero New Age. Hoffmeyer stesso racconta che, nonostante il successo della conferenza del 2002, alcuni interventi tentarono di utilizzare la biosemiotica per giustificare ipotesi non corroborate da basi scientifiche, come nel caso dell’efficacia dell’omeopatia (Hoffmeyer, 2012, p. 58). Da quell’episodio, la selezione dei contributi venne progressivamente regolata in modo più stringente. Il timore che il campo potesse essere percepito come una speculazione non scientifica portò molti biosemiotici a insistere su ipotesi chiaramente falsificabili, nel tentativo di legittimare la disciplina nel contesto delle scienze della vita. Secondo quanto riportato da Kalevi Kull durante una conversazione privata nel corso del mio soggiorno di ricerca a Tartu, anche le modalità di organizzazione dei primi Gatherings riflettevano un atteggiamento volutamente decentralizzato, spesso autogestito, in linea con lo stile pacifico e non gerarchico di Hoffmeyer e dei suoi collaboratori. In questo senso, la frammentazione iniziale della biosemiotica non fu solo il risultato di una diversità epistemologica, ma anche dell’approccio dialogico e poco istituzionale scelto dai suoi fondatori. Kull stesso ha osservato, nel contesto del XXIII Gatherings del 2023, che i tentativi di mettere in discussione alcune premesse della biosemiotica contemporanea incontrano ancora oggi resistenze, proprio a causa della percezione diffusa della fragilità strutturale di questo campo. È forse anche per tale ragione che, a partire dagli anni Duemila, si è sentita l’esigenza di formulare criteri più rigorosi, nel tentativo di preservare l’integrità scientifica della biosemiotica ed evitarne derive speculative. Le premesse della biosemiotica furono dunque definite in occasione del quarto Gatherings in Biosemiotics organizzato da Anton Markoš a Praga. Dopo quell’incontro, figure di rilievo come Jesper Hoffmeyer, Claus Emmeche, Kalevi Kull, Anton Markoš e Marcello Barbieri cominciarono a stabilire delle premesse semplici per ridurre la complessità dei discorsi
biosemiotici che proliferavano all’inizio del XXI secolo. È in questa congiuntura e sotto questa spinta che i confini della biosemiotica sono stati costruiti in modo più chiaro e uniforme (Stjernfelt 2002; Kull et al. 2009) (nonostante la grande diversità con cui se ne parla ancora oggi).
Per unificare ogni discorso sotto un certo aspetto identificativo, il riferimento era la famosa affermazione di Thomas Sebeok secondo cui “vita e semiosi sono coestensive”. Questa affermazione è stata estratta da uno dei suoi discorsi5, ma trova una connotazione molto più generale in vari scritti: “semiosis is at the heart of life” (Sebeok 1991, p. 85); “semiosis is the criterial attribute of life” (Sebeok 1991a: 124); “all, and only, living entities incorporate a specie-specific model (Umwelt) of their universe; signify; and communicate by […] signs” (Sebeok 1996, p. 102); “semiosis presuppose life” (Sebeok 2001).
Il criterio che accomuna i vari discorsi è l’identificazione della semiosi con la vita (Anderson et al. 1984; Hoffmeyer 1997): la semiosi esiste in tutti e solo gli esseri viventi. Questa identificazione è al centro del “progetto biosemiotico” (Kull, Emmeche, Favareau 2008). Come vedremo, tuttavia, la nozione di vita non è né così ovvia né così autoevidente da permettere di confinarla entro certi limiti. Questa nozione, di per sé ibrida, mostra spesso la sua indecidibilità.
Possiamo partire dalle premesse che Barbieri, in un articolo del 2009, seguendo le considerazioni già esposte nel suo libro del 2008, individua come necessarie per il discorso biosemiotico.
Today there are still differences between the schools, but there is also a ‘minimal unity’ in the field because of two basic principles, or postulates, that are accepted by virtually all biosemioticians.
5 Per quanto mi è stato possibile rilevare attraverso l’analisi delle fonti primarie, tale proposizione non compare in forma esplicita in nessuno degli scritti ufficialmente pubblicati da Thomas A. Sebeok. È verosimile che si tratti di una riformulazione postuma di un suo intervento orale tenuto il 1° ottobre 1990 presso l’Accademia Ungherese delle Scienze a Budapest, oppure di una sintesi interpretativa elaborata da autori successivi a partire da concetti precedentemente espressi da Sebeok stesso.
1. The first postulate is Thomas Sebeok’s idea that “life and semiosis are coextensive”. This implies that semiosis appeared at the origin of life, and sharply differentiates biosemiotics from ‘pansemiotics’ and ‘physiosemiotics’, the doctrines that semiosis exists also in inanimate matter and therefore everywhere in the universe. It also differentiates it from the views that semiosis exists only in animals or only in human beings.
2. The second postulate is the idea that signs, meanings and codes are natural entities. This sharply divides biosemiotics from the doctrine of ‘intelligent design’, and from all other doctrines that maintain that the origin of life on Earth was necessarily the product of a supernatural agency. (Barbieri 2009, p. 230)
In queste premesse, osserviamo dei termini che vengono utilizzati per unificare un discorso eterogeneo molto ampio. Inoltre, emerge la dimensione normativa delle premesse, che pretendono di orientare l’intera sfera semiotica secondo un modello che obbliga a scegliere tra vita (concetto unitario e specifico) e non vita (modi indeterminati, trascendentali e olistici di rappresentare i fatti bruti). Le premesse danno per risolto un problema che è tuttavia ancora irrisolto, ossia comprendere fino a che punto si estende la vita - al di là del discorso riguardante ciò che si intende con la nozione di “entità naturali” e quali entità rimangono al di fuori di questo concetto6. Ciò significa, in un certo senso, che si è già trovata una risposta a cosa sia la vita. Tuttavia, è molto difficile stabilire dove inizia la vita, e questo è attualmente un dibattito in corso7. Ancora più complicato è cercare di dimostrare che dove inizia la semiosi. Le premesse della biosemiotica
6 Nonostante l’importanza di questo confine tra entità naturali e tutto ciò che è fuori dalla natura (Marrone 2011), non ci soffermeremo su questo punto, concentrandoci invece sulla prima premessa riguardante la vita e la semiosi. Tuttavia, un recente articolo ha cercato di articolare una “xenosemiosi” (Tenti 2022), prendendo come punto di partenza quella che viene definita “xenolife artificiale”.
7 Attualmente esiste un’ampia letteratura sulle ipotesi relative a come è emersa la vita e a come possiamo descriverla nella sua complessità. Tutte le teorie accettate concordano nell’identificare questa emersione dall’organizzazione di materiali inorganici. In questo senso, va notato che è possibile ipotizzare un’evoluzione pre-biologica, come dimostrato da Manfred Eigen (1971), in cui i processi di selezione avvengono nella sfera molecolare quale proprietà della materia. Tale
sembrano ergersi su corollari basati sulla definizione di limiti e soglie, che la distinguono dagli approcci pansemiotici e fisiosemiotici (Brier 2003). La storia della biosemiotica testimonia proprio questo continuo movimento della soglia inferiore. La soglia che separava il semiotico dal non semiotico si è costantemente ristretta (Nöth, Kull 2001), diventando quasi trasparente (Thompson, Stapleton 2009). Di fatto, abbiamo una sorta di estensione costante che segue la complessità dei sistemi viventi. Ma ciò che va tenuto in considerazione è che non esiste un grado zero di complessità; in altre parole, anche a un livello minimo come la composizione atomica dei materiali, esiste un certo grado di complessità (McShea, Brandon 2010). Voglio suggerire che bisogna tenere conto di un dispiegamento di emergenze dalla crescente complessità – molecole, cellule, organismi multicellulari, corpi senzienti. Ogni livello di emergenza forma la propria “gestalt” olistica che modifica e unifica una sinergia collettiva di gestalt preesistenti (come l’organismo multicellulare unifica una sinergia collettiva della gestalt cellulare). L’emergenza8, tra complessità e semiosi, è creativa. Ogni livello emergente unisce e, in un certo senso, completa il precedente. Attraverso l’emergenza c’è convergenza, per usare il linguaggio di de Chardin (2014), un rivolgimento interiore dell’agire su se stesso che approfondisce l’interiorità e accresce la reattività.
Da questi presupposti, che articoleremo successivamente senza tuttavia dipanare ogni incertezza, possiamo iniziare proponendo delle domande di indagine: da quale livello di complessità emerge la semiosi?9 Dove possiamo collocare il cominciamento della vita? Dove si trova la soglia che separa la vita dalla non vita?
evoluzione avviene attraverso sistemi di reazione noti come “cicli catalitici” o “ipercicli”. Gli ipercicli studiati da Eigen si auto-organizzano, si auto-producono e si evolvono.
8 Di particolare interesse è la ridefinizione data da Onnis (2021) della nozione di “emergenza come cluster ”, laddove il concetto di emergenza rimane aperto ad una prescrizione arbitraria dell’analisi orientata a un gruppo o a un “grappolo” aperto di proprietà che si trovano in natura secondo principi variabili e contestuali.
9 Per quanto concerne la semiogenesi nel campo della biosemiotica si veda: (Koch 1982; 1984; Nöth 1994; Bacigalupi 2022).
Quello che cercheremo di argomentare è che la nozione di vita è una forma ibrida che emerge da un processo che non può essere limitato al regno del biologico. Tale dimostrazione si avvarrà delle teorie della complessità come metodologia di analisi10 e una reinterpretazione dell’ecosemiotica da un punto di vista olistico, proponendo una inscindibile interazione tra elementi biotici e abiotici, tra organico e inorganico, vita e non vita, mostrando una continuità che tende a rendere porosa ogni soglia semiotica. Una continuità che, come cercheremo di mostrare, appartiene a una pertinenza semiotica, prodotta da una determinata aspettualizzazione, quale base di una modellizzazione generale del divenire (oltre che come fenomeno caratteristico del piano discorsivo).
L’invocazione da parte della biosemiotica della nozione di vita, che avrebbe dovuto stabilizzare, pacificare, rassicurare e accordare i dibattiti, sembra tuttavia aver perso questa capacità, con l’emergere di entità indefinibili, non categorizzabili e non umane che appaiono ovunque nel mondo sociale e naturale11. Nella presente argomentazione critica, tali ibridi formano un collettivo semiotico che si estende oltre il biologico, dando vita ad attori che non rientrano nella categoria di “vivente”.
La vita come problema semiotico
Nel considerare se un oggetto è vivo o meno, dobbiamo mostrare come sono state definite queste soglie di separazione. Dobbiamo collocare storicamente questa demarcazione e questa separazione, considerando anche le
10 Metodologia che rileva le caratteristiche di interconnessione, non-linearità, emergenza, capacità di generare meccanismi di feedback, auto-organizzazione e auto-similarità.
11 Gli ibridi, infatti, sono dimenticati e non pensati come agenti semiotici dalla biosemiotica (Zengiaro 2023). Eppure, continuano a pervadere la vita, la società, la cultura, la natura in modo stratificato. Spesso, riflettendo sulla realtà biologica, siamo tentati di tracciare una linea netta tra ciò che è vita e ciò che non lo è. Vi sono però altre forme di quasi-vita che si collocano a uno stadio intermedio tra l’organico e l’inorganico (Nurse 2020). Consideriamo il classico esempio del virus. Il virus è un ibrido che si colloca tra il vivente e il non vivente, modificando attraverso la sua agency (lo spillover) la società, l’economia, la politica, le relazioni sociali, ma anche il corpo delle forme di vita (a livello polmonare, di sangue, di temperatura corporea, di morte dell’individuo). Da un lato è vivo quando è chimicamente attivo e si riproduce nelle cellule ospiti, dall’altro è non vivente quando esiste come entità chimicamente inerte al di fuori della cellula.
cause e gli effetti che le hanno prodotte, le narrazioni e le negoziazioni delle soglie di demarcazione della biosemiotica così come delle scienze della vita (Latour, Woolgar 1986; Fabbri, Latour 2000; Bastide 2001). Nessun oggetto, sia esso considerato “naturale” o “sociale”, ha una natura così ferma e stabile da poter essere assegnato senza ambiguità all’una o all’altra sfera (Latour 2021a). L’interazione tra gli attanti che porta all’attualizzazione degli eventi viventi presuppone una competizione di forze che ibrida i risultati. Il biocentrismo, su cui si basa la biosemiotica, ha effetti significativi sulle categorie ibride e sull’agency 12, così come sulla produzione della nozionespesso autoreferenziale - di vita.
Concentrarsi sulla vita come discorso semiotico significa tentare di pertinentizzare una figura che è essa stessa ibrida (Emmeche 1994, 1998). Ogni entità vivente dipende da un contesto ecologico che intreccia vita e non vita. Ogni forma di vita biologica è legata all’inorganico da una reciproca intertestualità esistenziale13 . La storia del pianeta ci mostra una storia continua tra non-vita e vita, così come tra inorganico e organico. È il caso, ad esempio, della varietà di minerali presenti sulla Terra, frutto dell’azione degli organismi viventi; a sua volta, la varietà di minerali ha contribuito alla varietà di organismi. È un ciclo continuo che
12 Per la biosemiotica, l’agency al di fuori della vita non è considerata, se non introducendo altre paraterminologie che avvicinano determinati sistemi complessi alla vita (Sharov, Tønnessen 2021).
13 “Intertestualità esistenziale” vuole far riferimento, per quanto riguarda il primo termine, alle teorie di Julia Kristeva, mentre il secondo si ispira alla semiotica esistenziale di Eero Tarasti. La nozione indica un contagio, una contaminazione costante, in cui elementi eterogenei di un dato ambiente dialogano tra loro in una polifonia. Si tratta di mettere in relazione forme di vita e non vita in un testo ecologico, mostrando che l’intertestualità esistenziale può essere ricercata in una ecologia delle relazioni. Basti pensare alle tracce lasciate da elementi organici in quelli inorganici, come i resti fossili; la dipendenza degli organismi da elementi inorganici come l’ossigeno; il rimando ereditario e genetico da una generazione all’altra; la creazione di molteplici elementi chimici inorganici per il proprio sostentamento, la protezione, la caccia, lo spostamento, la sensorialità, come la mineralizzazione delle ossa, gusci, artigli, ecc. Mentre ad un livello di complessità maggiore possiamo indicare attività di mimesis, camouflage, simbiosi, forme esistenziali rappresentate da olobionti o superorganismi. È un’ecologia delle relazioni che può essere letta attraverso continui rimandi intertestuali. Banalmente l’exaptation, il codice genetico, la biomineralizzazione, la decomposizione organica, sono tutte intertestualità esistenziali fatte di riscritture, memorie, interpretazioni, traduzioni. Ogni forma esistenziale costituisce un mosaico di citazioni, ogni corpo è assorbimento e trasformazione di un altro corpo.
crea un’ecologia delle relazioni. Dobbiamo osservare i sistemi complessi da una visione ecosistemica di integrazione. Una cellula, una foresta, un uragano, una società sono sistemi complessi collegati in una comunicazione ecologica. Allo stesso modo, le forme di agency legate al vivente provengono dalle relazioni materiali. Esistono, nel mondo non vivente, catene processuali di senso che danno origine ad agency che intaccano, modificando, i sistemi viventi, ma che li eccedono tramite istanze di difficile categorizzazione. Questi strati, che la biosemiotica tende a separare, sono in realtà parte di un’interdipendenza che ibrida i termini e allo stesso tempo non permette un’analisi semiotica profonda, se non strutturata su una costruzione altamente arbitraria del significato14 . Riconoscere che la separazione tra vita e non vita è determinata da un certo tipo di organizzazione materiale, è già un primo passo per comprendere che esiste una continuità tra vivente e non vivente.
Per evitare di rimettere in discussione le proprie premesse, la biosemiotica si occupa solo di quelle entità che hanno un certo tipo di agency ed entro un certo tipo di soglia semiotica. Quando affermiamo che esiste, da un lato, un mondo vivente e, dall’altro, un mondo non vivente, stiamo semplicemente suggerendo che, a posteriori, una porzione arbitraria di attori sarà priva di ogni agency e che un’altra, altrettanto arbitraria, degli stessi attori sarà dotata di semiosi (Latour 2015). Con questo vogliamo sottolineare che, nonostante l’allargamento delle soglie semiotiche dal mondo culturale a quello naturale, la biosemiotica si ripresenta come una semiotica che usa la vita in modo non marcato: per la biosemiotica la vita non è un problema e non è un elemento di attenzione15. Così
14 Per “arbitrario” si intende quello che per René Thom sta a fondamento di ogni teoria. Per il matematico ogni teoria poggia su una “aporia fondamentale”, la cui risoluzione tramite postulati equivale a un atto arbitrario di fondazione (Thom 1989). Rendere evidente tale aporia fa parte della nostra argomentazione critica.
15 Anton Markoš (Švorcová 2019) e Marcello Barbieri (2003; 2015) si sono occupati del tema della vita, ma da un punto di vista strettamente biologico e composizionale (spesso molto distante l’uno dall’altro e criticandosi vicendevolmente), cercando i suoi fondamenti in una serie di riduzionismi e scomposizioni. Ciò che stiamo cercando è il fenomeno della vita nel suo senso semiotico, ossia fin dove si espande la vita e cosa vuol dire pensare la vita da un punto di vista semiotico.
come Umberto Eco fu criticato per la sua nozione di soglia inferiore dai biosemiotici (Nöth 1994, 2000), accusandolo di discriminazione arbitraria per le altre forme di vita, allo stesso modo la biosemiotica si presenta ora come una semiotica biocentrica che non tiene conto del non vivente. Invece di abituarci a determinare principi di differenza, dobbiamo piuttosto dare luogo a un’analisi delle catene continue di processi semiosici che partono dal vivente e si estendono al non vivente, e viceversa (Latour 2012). Non si tratta di costruire una semiotica basata sulle non-differenze (poiché sarebbe per definizione, o almeno storicamente, una non semiotica), bensì di stabilire tanto una distinzione quanto una continuità in un principio che faccia apparire non tanto l’identità dei termini né la loro eterogeneità, quanto la contiguità esistente. Possiamo, in termini generali, fare riferimento alla nozione di “trasduzione” di Simondon (2020), la quale permette di porre in risonanza ordini di realtà tra loro incommensurabili16. La trasduzione semiotica in tal senso mostra nei processi di continuità e discontinuità semiosica una dimensione che le articola dando luogo ad un ordine di commensurabilità più ricco rispetto alla mera considerazione del processo semiosico nei soli sistemi viventi e nella sola relazione differenziale. La posta in gioco non è tanto quella di postulare una verità nei riguardi del limite della vita, quanto quella di mostrare dove emerge la significatività17. In altre parole, il problema della vita è un problema di composizione. Dal nostro punto di vista, la vita nella sua costruzione di senso deve essere riarticolata a partire da un’analisi ecologica (come scienza delle relazioni) e non più strettamente biologica (come scienza della vita). Il
16 L’esempio paradigmatico di riferimento è quello dei cristalli nei quali un germe si estende in tutte le direzioni generando una presa di forma, ossia la genesi di una struttura. Ciò si lega anche al concetto di comunicazione, come carica affettiva e trasduttiva di informazione, facendo della nozione di informazione e segnale un uso trasversale che si avvicina alla biosemiotica. Tuttavia, in modo assai più ampio la semiotica simondoniana investe il dominio dell’organico come quello dell’inorganico.
17 Peirce ha affrontato tale questione cercando di comprendere come dal continuum sorga la discontinuità. Utilizzando l’esempio della macchia d’inchiostro per tracciare l’indecidibile e il tracciamento della linea di gesso su di una lavagna, Peirce sembra affermare che la discontinuità è sempre un effetto del dispiegamento di un continuum. Lo stesso argomento viene analizzato in (Paolucci 2004; Fabbrichesi 2014).
rischio che vogliamo evitare è di cadere in entità cartesiane estrapolate dal loro contesto, senza tener conto della costituzione ibrida e interdipendente dei sistemi viventi.
Distribuire l’agency attraverso la risonanza
La prospettiva che proponiamo cerca di mettere in discussione i valori di veridizione18 della biosemiotica nei confronti della nozione di vita (Zengiaro 2024), mostrando l’esistenza di agenti che continuano a scambiarsi tra loro in base alle attività agentive delegate in una serie di concatenazioni di azioni di feedback loop. Nel contesto ecologico gli agenti non sono nemmeno individui, ma sempre collettivi che agiscono sulla base di istanze eterogenee. Si pensi agli eventi complessi che hanno macro effetti diretti e indiretti sul sostrato ambientale e sociale: dal cambiamento climatico all’acidificazione degli oceani, dallo scioglimento dei ghiacciai alla diffusione planetaria dei virus (Latour 2015, 2021). Pensare che la semiosi si fermi dove esiste l’agency del vivente significa non vedere l’intervento di sistemi complessi nella scena del naturale e del sociale, dell’umano e del non umano. E non si tratta di dare vita a eventi non viventi o di animare la materia, non si tratta di aggiungere, ma di distribuire l’agency. In tal senso, l’evento è ciò che accade e diventa segno quando ha la possibilità di indicare una direzione19.
L’attante, nel contesto ecologico che stiamo tracciando, può provenire dall’universo geofisico in cui la materia, composta da atomi e molecole, è organizzata secondo degli schemi narrativi e dei pattern articolati in modo significante. In questo senso, quando parliamo di materia che si organizza, ci riferiamo a ciò che John Deely (1990, 2001), con il termine fisiosemiosi, ha indicato: la disposizione attraverso la quale la materia diventa più facilmente disponibile per una successiva organizzazione. “Physiosemiosis may also be defined as that process whereby matter organizes itself (as “irrelevant” habit structures) so as to make itself more readily available for
18 Si tratta di mostrare come il discorso biosemiotico costruisce effetti di verità, attraverso le proprie pratiche discorsive.
19 Un argomento simile viene esposto in (Sharov, in stampa) con il concetto di “potential meaning”.
inclusion in biosemiosis and anthroposemiosis” (Coletta 2016, p. 77). Ciò significa che il modo in cui la materia non vivente diventa significante per un organismo (entrando a far parte della sua Umwelt) deriva dalla disposizione20 segnica della materia stessa (come un “habitus naturale”). È una sorta di feedback, un’eco o una risonanza dello “sguardo interpretativo” che a contatto con gli oggetti del mondo, vibrando, ritorna portando con sé un significante denotato dal tipo di materia21 (Zengiaro 2022a). La risonanza è un fenomeno di oscillazione o vibrazione che organizza in modo non intenzionale un sistema con la sua capacità di adattarsi e rispondere a un ambiente in continua evoluzione22. La nozione di risonanza dev’essere intesa come un processo semio-materiale in cui un sistema è in grado di disporre il proprio “comportamento” in una dinamica di traduzione e adattamento. L’agente e l’intorno (attanti intercambiabili) si sincronizzano in tal modo stimolandosi vicendevolmente e innescando un sistema di relazioni, di agency reciproche che si alimentano. D’altra parte, se gli agenti che entrano in relazione si modificano a vicenda, proprio sulla base del loro incontro e della loro influenza, allo stesso tempo anche la significazione è una proprietà di tutti gli agenti, poiché essi non cessano mai di avere una
20 Per “disposizione” intendiamo una sorta di “disposizione a rispondere” in termini segnici a uno stimolo. La disposizione vuole riferirsi alle teorie di Giorgio Prodi (1977, 1988, 2010) in senso stretto e di Charles Morris (1946) in senso lato, in cui due elementi eterogenei si dispongono in una composizione che dipende da dinamiche di complementarità. Si tratta di individuare nella disposizione una sorta di rilevanza (o interesse) basata sulle relazioni che derivano dalle capacità e dalle qualità degli attori all’interno della relazione. In questo senso la nozione di disposizione si avvicina molto al concetto di enamblement di Stuart Kauffman (2023) che si riferisce alle condizioni di esistenza che abilitano o permettono, ma non causano. Recentemente ho presentato una teoria della corrispondenza , costruita sulle teorie di Prodi (Zengiaro 2022b).
21 Una sorta di morfogenesi differenziale che emerge in ogni piano dell’interazione tra attanti.
22 Tale nozione è erede della semiofisica di René Thom (2006), laddove a partire da una pregnanza, intesa come discontinuità su di un piano immanente, emerge contemporaneamente una salienza di tipo semiotico, in cui la discontinuità si riempie di un contenuto semantico. Solo quando un oggetto trova la propria corrispondenza, la risonanza si ramifica in una relazione eterogenea di corrispondenze. In questo senso, il modello dell’essere vivente viene interpretato come il risultato di meccanismi regolatori interagenti. Un’altra prospettiva molto interessante, invece, può riguardare la nozione di risonanza in semiotica come una disposizione affettiva delle potenzialità della percezione e dunque dell’attivazione dei meccanismi di conoscenza (Finocchi 2020).
agency (Latour 2012). Si tratta di indagare allora una fisica del senso o la significazione dei processi naturali attraverso una “semiofisica”23. La vita, che sta alla base delle indagini biosemiotiche, è propriamente sia un processo, che quindi predilige il cambiamento continuo (vita-morte), sia una rete, che si integra e interagisce con la non-vita (organico-inorganico). In queste proprietà (essere un processo in divenire e comporre una rete eterogenea) possiamo leggere la vita come un dispositivo ibrido che forma un modello reticolare di risonanza semiotica. Le differenti semiosi, la vita e la non vita, la natura e la cultura, sono portate all’interno di questo modello ibrido e reticolare in modo immersivo e pervasivo; ciò che possiamo, in modo complementare, definire come un unico, grande sistema di traduzione che dà luogo a un regime di significazione appartenente a una semio-fisica (Fabbri 2012).
A questo proposito, possiamo parlare di agency della natura (Zengiaro 2020). Per “agency della natura” intendiamo una proprietà pervasiva inerente alla materia, diversa dall’intenzionalità umana ma capace di esercitare un’influenza sui fenomeni umani e non umani (Iovino, Oppermann, 2014). In questo senso, è la materia stessa, organica e inorganica, a manifestare la capacità di agire in modo attivo e trasformativo a seconda del contesto. Infatti, l’agency assume molte forme, tutte caratterizzate da una prerogativa importante: materiali e significati producono un’influenza sull’esistenza della natura umana e non umana 24. In effetti, si può anche parlare di produzione di comportamenti auto-organizzati in relazione a eventi fisici complessi. Swenson e Turvey (1991) descrivono tali organizzazioni con il termine “autocatakinetics” (l’etimologia della parola si riferisce al moto dei corpi materiali e delle forze e dell’energia ad essi associati per provocare il movimento). Questo termine è usato per descrivere uno stato di ordine o di auto-organizzazione. Il comportamento degli eventi fisici nei sistemi complessi, paragonabile alla direzionalità dell’evoluzione di un
23 Come nota Fabbri nell’introduzione, la “semiofisica” “non pretende di spiegare, ma cerca i modi per rappresentare la molteplicità e la singolarità naturale di stati, processi e di effetti di senso” (Fabbri 2006, p. 14).
24 L’agency mantiene in questo senso le cinque proprietà dell’iperoggetto: viscosità, non località, ondulazione temporale, sfasamento e interoggettività (Morton, 2013).
organismo in base a determinate intensità e interazioni: “an autocatakinetic system [that] maintains its “self” as a state constituted by, and empirically traceable to, a set of nonlinear (circular causal) relations through the dissipation or breakdown of field potentials (or resources) in the continuous coordinated motion of its components”. In questo senso, possiamo ridefinire la nozione di agency per includere gli eventi che emergono da determinate attività organiche e inorganiche con effetti e direzionalità specifici. L’agency, nella nostra definizione, è la forza derivante da relazioni che portano con sé eventi che prima non esistevano (Zengiaro 2022b). La nozione di “forza” è usata come quantità fisica vettoriale che si manifesta nell’interazione reciproca di due o più corpi sia a livello macroscopico sia a livello di particelle elementari. Gli eventi creano segni virtuali (Deely, 1999) che emergono, attualizzandosi, da concatenazioni complesse di altri eventi (Morin 1972).
L’agency, quindi, non può essere esclusivamente associata agli esseri umani e all’intenzionalità, né ai soli sistemi viventi, ma è una proprietà pervasiva della materia, come parte del suo dinamismo generativo. Da questo dinamismo, la realtà emerge come un flusso intrecciato di forze materiali e discorsive, piuttosto che come un complesso di forze gerarchiche o un complesso di attori individuali gerarchicamente organizzati. Cercare di fornire un quadro più accurato della realtà e della nozione di vita richiede una ridistribuzione dell’agency nel campo della semiotica della natura.
Un’ecosemiotica estesa
Secondo la prospettiva ecosemiotica contemporanea (Farina 2012; 2021; Maran 2019; 2020; 2021; Maran, Kull 2014), che studia le interazioni e i processi segnici come fenomeni ecologici, ogni funzione e risorsa sono necessariamente mediate da una interfaccia semiotica chiamata ecofield (Farina Belgrano, 2004; 2005), la quale serve all’organismo per interpretare correttamente come utilizzare una risorsa. L’ambiente è parte attiva e dinamica dei processi cognitivi25 dell’individuo. In questo nuovo campo di
25 Per “cognizione” ci riferiamo alla terminologia di Maturana e Varela (1980).
studi, ogni attività dell’organismo viene studiata come una costante interazione tra gli schemi dell’individuo e le proprietà dell’ambiente. Tuttavia, grazie all’ecosemiotica e alle teorie della complessità, è possibile integrare gli ecosistemi in senso più ampio in una semiotica della natura (Zengiaro 2024a). Si tratta di un nuovo territorio semiotico. Nonostante l’innovazione dell’ecosemiotica, essa risulta, secondo il nostro punto di vista, frenata nel considerare le relazioni tra gli organismi viventi e l’ambiente, intendendole spesso come entità separate, isolate o estraibili26. Questo ci porta a provare ad ampliare l’ecosemiotica per offrire uno sguardo più complesso delle relazioni che compongono un ecosistema e i sistemi viventi. Questo perché ogni ecosistema non è costituito solo da agenti organici, ma è soprattutto una rete di elementi eterogenei interdipendenti. In tutti i modelli emergenti che coinvolgono le scienze della vita dev’essere esplicita l’attenzione alla complessità della co-occorrenza e del contesto27. Gli organismi coesistono, coevolvono, attraverso una semiosi che, come aveva già descritto Giorgio Prodi (1977), emerge dalle basi materiali della significazione. Una significazione che emerge come discontinuità, un guizzo (Greimas 1988), che articola il senso. La semiotica contemporanea si è interessata fino ad oggi della pertinentizzazione di tali pieghe, senza però mostrare che l’emersione del senso si dà solo in un continuum della natura materiale28. La materia “is not completely dead, but is
26 Penso che questa separazione sia stata tacitamente accettata dalla maggior parte dei biosemiotici a partire dalla nozione di Howard Pattee (1997, 2001) di “epistemic cut ”. Quest’ultima non è precisamente una rinnovata versione del dualismo cartesiano, però si presenta come un dualismo descrittivo che separa sempre il conoscitore e il conosciuto. Tuttavia, quando si indaga la nozione di vita questa divisione non è chiara, soprattutto perché emerge in questa ricerca una necessaria pratica fenomenologica. E sembra che questo l’avesse intuito anche Jesper Hoffmeyer (2008) quando, affrontando il tema dell’epistemic cut, scrive: “The semiotic apsect of life is, so to say, just a glimmer that we cannot think ourselves apart from because we are, in an existential sense, wrapped up in it” (p. 94).
27 Un lavoro molto simile, anche se per certi versi meno radicale, lo sta realizzando Timo Maran (2023).
28 Può sembrare che in questa direzione ci stiamo dirigendo verso un’impasse logico, verso un regresso all’infinito. L’allargamento epistemologico sembra far scivolare la questione della vita, nella natura materiale, per sfociare in una “teoria del Tutto”. In realtà, stiamo seguendo la dottrina della continuità di Peirce, in cui egli mostra come la conoscibilità non è composta di spiegazioni ultime e definitive, così come la realtà non è data una volta per tutte. Il synechismo opera
merely mind hidebound with habits. It still retains the element of diversification; and in that diversification there is life” (cp 6.158). La semiosi della natura si compone di continuità, corrispondenze e affinità (Santaella 2001).
L’ecosistema è un’unità funzionale che comprende l’insieme di organismi viventi e sostanze non viventi con cui i primi stabiliscono uno scambio di materiali ed energia in un’area definita (Capra, Luisi 2014).
Nel modo in cui stiamo sviluppando un’ecosemiotica più ampia, la creazione di significato non avviene solo tra individuo e ambiente, cioè tra un organismo e altri organismi. Per comprendere la complessità dei processi semiotici che avvengono nei sistemi viventi, dobbiamo offrire uno sguardo ecosistemico. Tale punto di vista è molto diverso dall’analisi ecosemiotica classica, ma riteniamo che sia necessario amplificarne la portata teorica grazie alle teorie della complessità. L’interpretazione ecosistemica deriva dal pensiero contestuale, in cui è possibile parlare delle proprietà essenziali di un sistema vivente guardando alle proprietà dell’insieme, cioè dell’ambiente in cui e da cui emerge. Le proprietà, infatti, non sono possedute da nessuna delle parti costituenti, ma emergono dalle interazioni e dalle relazioni tra di esse. Secondo questa visione, le proprietà delle parti possono essere comprese solo studiando l’organizzazione dell’insieme. In questo senso, è il concatenamento con l’ambiente a determinare gran parte del comportamento e dell’evoluzione delle parti. A ogni livello, i sistemi viventi sono interpretati come reti, e in queste maglie semiotiche ci sono molteplici elementi che si trovano tra il vivente e il non vivente, tra l’organico e l’inorganico.
proprio come principio regolativo che divide le ipotesi scientifiche rilevanti perché esplicative e quelle inutili e non esplicative. Le prime sono ipotesi che spiegano qualcosa attraverso qualcosa di ulteriormente spiegabile (all’infinito), mentre le seconde spiegano tramite qualche cosa che non è spiegabile a sua volta (rendendolo per questo inspiegabile) (Calcaterra 2011; Brioschi 2022). Perciò non abbiamo alcun timore di affrontare la continuità della natura, cercando di definirne i piegamenti, gli interstizi, gli intervalli delle forme in un tracciamento perpetuo e continuo. Ciò che indaghiamo è la salienza e la pregnanza della natura nelle sue relazioni di continuità.
“In short Synechism amounts to the principle that inexplicabilities are not to be considered as possible explanations; that whatever is supposed to be ultimate is supposed to be inexplicable; that continuity is the absence of ultimate parts in that which is divisible; and that the form under which alone anything can be understood is the form of generality, which is the same thing as continuity” (cp 1.178).
Tale pensiero era stato abbozzato anche da John Deely (2015) che ha sostenuto con forza la continuità dei processi semiosici dalla materia ai sistemi viventi. Di particolare interesse è l’utilizzo che Deely fa del “semiotic scaffolding”, termine che fa riferimento alle teorie di Hoffmeyer (2008a, 2015) riguardo all’impalcatura semiotica, cioè una struttura relazionale complessa a più livelli che permette una maggiore capacità di risposta alla molteplicità di segni presenti nell’ambiente – dando luogo al semiotic freedom. È una struttura che permette l’evoluzione, consentendo la creazione di regole (habit29) che aiutano l’organismo a interfacciarsi al mondo (Kull 2015; Bernardi della Rosa, Zengiaro 2025). Tuttavia, Deely reinterpreta lo scaffolding come una impalcatura semiotica che tiene in piedi le relazioni semiotiche degli organismi, la quale è essa stessa principio di una semiosi che si estende nei sistemi viventi ma che si origina da altre forme della natura. Allo stesso modo l’ecosistema composto di parti viventi e non viventi forma una impalcatura, una rete semiotica relazionale tra i vari strati di complessità, qualcosa come un principio di sineddoche. Una continua sineddoche30, simile ad un frattale ma corrispondente ad un incassamento di strati differenti e coesistenti, stratificati eppure ibridi. Infatti, ogni livello entra in relazione con quello precedente che funge da base per configurarlo. Si tratta della parte conservativa dell’interazione31, la quale risulta imprescindibile per far emergere ulteriori atti di semiosi e di interpretazione. È questo il processo eterogeneo di continua complessità, nella combinazione tra casualità (chance) e vincoli (constraint) in una serie di pattern di iterazione, che emergono le novità in natura e l’acquisizione degli habits (Wheeler 2006).
29 Il termine qui si riferisce in termini generali – e parziali – alla nozione di Peirce secondo cui l’ habit è la disposizione naturale alla cristallizzazione di determinati fenomeni naturali. (cp 5.538)
30 L’immagine di un principio di sineddoche continua mi è stata suggerita dal collega Niccolò Monti, a cui sono grato per aver colto la profondità di ciò che cercavo di esprimere.
31 Manuel de Landa (2003) ha offerto una panoramica molto simile nel narrare la stratificazione che gli organismi mantengono del loro stadio inorganico precedente (ossa, gusci, corazze, ecc.).
E questa struttura che segna una continuità tra vita e non vita può essere mostrata in ogni sostrato esistente, dal più piccolo dei viventi fino alle città, dal naturale al sociale, senza possibilità di definire una separazione tra i vari livelli.
Un ecosistema è un’unità funzionale e complessa che interseca organismi viventi e sostanze non viventi in un continuo scambio di materiali ed energia. Questi scambi apportano un valore semiotico alla nostra analisi perché, come già detto, c’è bisogno di un’interfaccia semiotica per mettere in relazione due elementi naturali. Semiotica, complessità, vita e materia appaiono così intrecciate in ciò che possiamo chiamare “Biosemiotica Ecosistemica”, ossia una semiotica che sia incentrata sull’emersione del significato nei sistemi viventi tenendo conto dei processi ecologici e materiali nei quali la vita emerge ed evolve. Questo permette di rimuovere ogni soglia netta tra organico e inorganico, artificiale e naturale, cultura e natura, vita e non vita, mantenendo tuttavia uno sguardo sulla vita come la complementarità di unità e molteplicità, ossia come unità globale (Morin 2001). Per questo motivo, a nostro avviso, è possibile spiegare ogni fenomeno legato all’evoluzione in termini ecosistemici e le relazioni tra organismo e ambiente, in un processo di continuità, interdipendenza e covarianza. La vita, come la semiosi, non può essere pensata singolarmente, ma sempre in modo eco-sistemico. La vita è vita eco-sistemica. La complessità ecologica, infatti, ci mostra una sorta di molteplicità di soglie che non separano ma connettono, proprio come le interfacce necessarie per una comunicazione continua. L’interfaccia è una prospettiva semiotica proprio perché funziona come un processo di traduzione continua tra strati differenziali (Thom 1972; Sarti, Citti, Piotrowski 2022). Infatti, i processi semiosici, anche a livello di ecosistema in generale, esistono per gli organismi che devono interpretarli correttamente per utilizzare le risorse. E queste risorse modificano attivamente l’organismo perché hanno effetti retroattivi (Uexküll 1982). In questo senso, anche l’ambiente è un operatore attivo nei processi di significazione (Zengiaro 2022). Questa prospettiva sfuma i binari ideologici rispetto a ciò che consideriamo un ecosistema: vita e materia, vivente e non vivente, natura e cultura si intrecciano lungo i confini.
L’ecosemiotica ha sottolineato che i segni ambientali e la creazione di significato da parte dell’organismo si incontrano in un processo sempre dinamico. Nella nostra proposta, vogliamo estendere le interazioni non solo alla sfera del vivente, ma anche al non vivente. Questo ci permette di
definire in modo ampio una semiotica della natura. Le teorie della complessità, infatti, offrono un modo di pensare agli oggetti del mondo in una continuità (Capra 1996), così come la semiotica si occupa di cogliere il senso delle cose e di ciò che produce significato. Integrando questi campi del sapere possiamo scorgere uno strumento per individuare la costruzione del senso in un dato ecosistema-testo che produce significato. Tutto è inserito in una rete di significati che possiamo chiamare “semiotica dell’ambiente” o Biosemiotica Ecosistemica.
Conclusione
In conclusione, abbiamo potuto osservare che la biosemiotica spesso trascura il fatto che l’ambiente come sistema complesso è strutturato in una continua collaborazione tra materia organica e inorganica, tra organismi viventi e attori non viventi. A partire dall’identificazione della semiosi con la vita, infatti, è possibile individuare un problema con la visione biocentrica. La soglia inferiore posta sulla nozione di vita appare in questo senso arbitraria per diversi motivi: in primo luogo, non è possibile determinare a priori cosa sia vita e cosa no. Infatti, la categoria di vita non è stata fissata una volta per tutte. In secondo luogo, non è possibile risalire chiaramente all’origine della semiosi e della vita (che dovrebbero essere coestensive), se non considerando la complessità come una condizione sufficiente e necessaria che emerge da una continuum. Infine, definire la vita come unica caratteristica necessaria per la semiosi è arbitrario, perché non sappiamo quali altre forme di semiosi (e di vita) esistono32. Questi aspetti non sono sconosciuti ai biosemiotici, ma sono semplicemente non indagati. Con la nostra proposta, ossia quella di una Biosemiotica Ecosistemica, desideriamo solo porre in questione l’apertura delle premesse della biosemiotica. Il primo scopo è di avere una prospettiva più complessa dei processi semiotici e dell’organizzazione del vivente. Ciò non significa risolvere il problema della semiogenesi o dell’emersione della vita, ma semplicemente cercare
32 Basti pensare al fatto che la biologia sintetica tenta di estrarre modelli dalla vita eliminando i processi di continuità. Seguendo questo filone riduzionista della vita, la xenobiologia ha pensato di riprodurre la vita come un assemblaggio di componenti con biochimica diversa (Budisa, Kubyshkin, Schmidt 2020).
di non irrigidire le soglie semiotiche. Il secondo obiettivo è di dare luogo a un possibile sviluppo: un’indagine sulle forme di vita (invece di vita) e sulle forme di semiosi (invece di semiosi), in un tipo di sistematica combinatoria dei possibili modi di esistere biosemioticamente. E non facciamo riferimento ad un “tutto si tiene” della natura, ma all’invito ad osservare linee di frontiera scorgendo l’indecidibilità quale struttura generativa di entità prive di proprietà determinate.
Questo ci porta a una visione critica verso la biosemiotica contemporanea, cercando di portare alla luce l’utilità e l’inutilità di pensare il confine che divide la vita dalla non vita. Quello che abbiamo voluto sottolineare è che questo confine è molto labile, spesso indecidibile. Come affermiamo che non è possibile stabilire con esattezza dove la vita inizia e finisce una volta per tutte, allo stesso modo non è possibile fissare a priori una soglia semiotica. Pensare a una Biosemiotica Ecosistemica ci aiuta ad attivare una strategia teorica per ridistribuire i processi semiosici oltre la vita. In questo senso, le linee di demarcazione (le soglie alte e basse della semiosi) rimangono porte girevoli (o finestre) che lasciano costantemente entrare e uscire nuovi attori. La mossa teorica non consiste tanto nel ridefinire ciò che si trova al di qua e al di là delle soglie33, ma nel mettere in discussione l’esistenza stessa e la legittimità di queste soglie. Certamente per una determinazione teorica le soglie sono convenienti, permettono di categorizzare e coordinare i vari domini della vita. Tuttavia, in una visione più complessa della natura, tali divisioni appartengono solo a una distinzione ontologica che stiamo cercando di dirottare attraverso la proposta di una diversa epistemologia. Inoltre, questi effetti di separazione provengono da costruzioni che cercano di pertinentizzare la vita come evento speciale in un mondo costellato da una materia apparentemente inanimata, passiva e muta. Dunque, il nostro obiettivo è quello di domandarci quanto sia lecito parlare di soglie semiotiche all’interno della natura metamorfica (Latour 2020; 2021). Quali soglie esistono in natura?
33 Le soglie così intese, potrebbero essere ricondotte, in termini simili, in ciò che Hoffmeyer, Deacon, Emmeche e Stjernfelt hanno cercato di definire con il concetto di “semiotic threshold zones” (Kull 2009).
Qual è lo scopo di tracciare una linea netta tra ciò che è semiotico e ciò che sta al di là?
La domanda che si può porre alla biosemiotica come questione critica è dove possiamo, a vent’anni dalla costruzione delle sue premesse, ricollocare i bordi per aprire la semiosi a tutta la natura nella sua interezza. In che modo articolare una semiosi aperta? Questo discorso si inserisce in un dibattito che utilizza le categorie per svolgere facilmente l’indagine semiotica (Emmeche 1994; Kull, Emmeche, Favareau 2004) e anche per offrire alle scienze una “definizione operativa” (Bich, Green 2017). Tuttavia, se queste categorie non riflettono le relazioni tra i sistemi viventi, all’interno di un ecosistema complesso e stratificato, il discorso sembra spostarsi sempre più verso una metafisica sostanzialista. La biologia, l’ecologia e la semiotica, ci costringono a mostrare l’instabilità della vita e delle sue forme ibride.
La nozione di vita deve essere rispettata nei suoi caratteri versatili, multidimensionali, metamorfici, incerti, ambigui, persino contraddittori: sono appunto per noi i segni della sua complessità. Ed è proprio tale complessità che dovremo ora affrontare direttamente. (Morin 2004, p. 418)
Riferimenti
Anderson, M., Deely, J., Krampen, M., Ransdell, J., Sebeok, T., von Uexküll, T. (1984). A semiotic perspective on the sciences: Step toward a new paradigm. Semiotica, 52(1/2), 7-47.
Bacigalupi, J. A. (2022). Semiogenesis: A dynamic system approach to agency and structure. Biosemiotics, 15(2), 261-284.
Barbieri, M. (2003). The organic codes: An introduction to semantic Biology. Cambridge University Press.
Barbieri, M. (2008). The codes of life: The rules of macroevolution. Springer.
Barbieri, M. (2009). A short history of biosemiotics. Biosemiotics, 2, 221-245.
Barbieri, M. (2015). Code Biology: A new science of life. Springer.
Barlett, S., Wong, M. L. (2020). Defining lyfe in the universe: From three privileged functions to four pillars. Life, 10(41). https://doi.org/10.3390/life10040042
Bastide, F. (2001). Una notte con Saturno: Scritti semiotici sul discorso scientifico Meltemi.
Bernardi della Rosa, S. e Zengiaro, N. (2025). The biosemiotic glossary project: Habit. Biosemiotics, 18(1), 1-26. https://doi.org/10.1007/s12304-025-09594-1
Bich, L., Green, S. (2017). Is defining life pointless? Operational definitions at the frontiers of biology. Synthese, 195(9).
Brier, S. (2003). The cybersemiotic model of communication: An evolutionary view on the threshold between semiosis and informational exchange. Triple C, 1(1), 71-94.
Brioschi, M. R. (2022). Adbuction and Metaphysiscs. In L. Magnani (a cura di), Handbook of Abductive Cognition . Springer. https://doi. org/10.1007/978-3-030-68436-5_68-1
Budisa, N., Kubyshkin, V., & Schmidt, M. (2020). Xenobiology: A Journey towards parallel life forms. ChemBioChem, 21, 2228-2231.
Calcaterra, R. M. (2011). Varieties of synechism: Peirce and James on mind-world continuity. The Journal of Speculative Philosophy, 25(4), 412-424.
Capra, F. (1997). The web of life. Anchor.
Capra, F., Luisi, L. (2014). The system view of life: A unifying vision. Cambridge University Press.
De Chardin, P. (2014). Il fenomeno umano. Queriniana.
Cimatti, F. (2000). Nel segno del cerchio: L’ontologia semiotica di Giorgio Prodi. Il Manifesto Libri.
Cimatti, F. (2018). A biosemiotic ontology: The philosophy of Giorgio Prodi. Springer.
Cimatti, F. (2019). Linguaggio e natura nell’Italian Thought: il dibattito sulla soglia semiotica fra Umberto Eco e Giorgio Prodi. Amalgama, 38, 60-69.
Coletta, J. (2016). The ‘irrelevance’ of habit formation: Stjernfelt, Hofstadter, and Rocky paradoxes of peircean physiosemiosis. In D. West e M. Anderson (a cura di), Consensus on Peirce’s concept of habit (pp. 65-81). Springer.
De Landa, M. (2000). A thousand years of nonlinear history. Swerve Editions.
Deely, J. (1990). Basic of semiotics. Indiana University Press.
Deely, J. (1999). Physiosemiosis and semiotics. In C. W. Spinks, J. Deely (a cura di), Semiotics. Peter Lang.
Deely, J. (2001). Physiosemiosis in the semiotic spiral: A play of musement. Sign Systems Studies, 29(1), 27-47.
Deely, J. (2015). Building a scaffold: Semiosis in nature and culture. Biosemiotics, 8, 341-360.
Eco, U. (1997). Kant e l’ornitorinco. Bompiani.
Eco, U. (2018). Giorgio Prodi and the lower threshold of semiotics. Sign System Studies, 46(2/3), 343-351.
Emmeche, C. (1994). The computational notion of life. Theoria – Segunda Epoca, 21(9), 1-30.
Emmeche, C. (1998). Defining life as a semiotic phenomenon. Cybernetics & Human Knowing, 5(1), 3-17.
Emmeche, C. (1999). The biosemiotics of emergent properties in a pluralist ontology. In E. Taborsky (a cura di), Semiosis, evolution, energy: Towards a reconceptualization of the sign. Shaker Verlag.
Eigen, M. (1971). Molecular self-organization and the early stages of evolution. Quarterly Reviews of Biophysics, 27 (11), 149-212.
Fabbri, P. e Latour, B. (2000). La retorica della scienza. In P. Fabbri, G. Marrone, G. (a cura di), Semiotica in nuca (vol. i). Meltemi.
Fabbri, P. (2006). Introduzione. In Thom, R. (a cura di), Morfologia del semiotico (pp. 9-23). Meltemi.
Fabbrichesi, R. (2014). Peirce e Wittgenstein. Un incontro: Immagine, prassi, credenza. Mimesis.
Farina, A. (2005). Complexity theory and landscape ontogenesis: An epistemological approach. Int. J. Risk Assessment and Management, 5, 159-166.
Farina, A. (2012). A biosemiotic perspective of the resource criterion: Toward a general theory of resources. Biosemiotics, 5(1), 17-32.
Farina, A., Belgrano, A. (2004). The eco-field: A new paradigm for landscape ecology. Ecological Restoration, 19, 107-110.
Farina, A., e Belgrano, A. (2005). The eco-field hypothesis: Toward a cognitive landscape. Landscape Ecology, 21, 5-17.
Farina, A. (2021). Ecosemiotic landscape: A novel perspective for the toolbox of environmental humanities. Cambridge University Press.
Finocchi, R. (2020). Isotopie e pertinenza: Un problema di risonanza? Studi di estetica, XLVIII(IV), 77-91.
Hoffmeyer, J. (1992). Some semiotic aspects of the psycho-physical relation: The endo-exosemiotic boundary. In T. Sebeok e J. Umiker-Sebeok (a cura di), Biosemiotics: The semiotic web 1991 (pp. 101-123). Mouton de Gruyter.
Hoffmeyer, J. (1996). Signs of meaning in the universe. Indiana University Press. Hoffmeyer, J. (1997). Biosemiotics: Towards a new synthesis in biology. European Journal for Semiotic Studies, 9(2), 355-376.
Hoffmeyer, J. (2008). Biosemiotics: An examination into the signs of life and the life of signs. University of Scranton Press.
Hoffmeyer, J. (2008a). Semiotic scaffolding of living systems. In M. Barbieri (a cura di), Introduction to biosemiotics: The new biological synthesis (pp. 149-166). Springer.
Hoffmeyer, J. (2012). A short history of gatherings in biosemiotics. In T. Bennett e S. Rattasepp (a cura di), Gatherings in biosemiotics (pp. 55-61). University of Tartu Press.
Hoffmeyer, J. (2015). Semiotic scaffolding of multicellularity. Biosemiotics, 8, 159-171.
Iovino, S., e Oppermann, S. (a cura di) (2014). Stories come to matter. In Material ecocriticism (pp. 1-21). Indiana University Press.
Kauffman, S. (2023). L’infinita creatività dell’universo. Mimesis.
Koch, W. A. (1982). Semiogenesis. Lang.
Koch, W. A. (1984). Art: Biogenesis and semiogenesis. Semiotica, 49, 283-304.
Koch, W. A. (1987). A plea for evolutionary cultural semiotics. In A. Eschbach e W. Koch (a cura di), A plea for cultural semiotics. Brookmeyer. Krampen, M. (1981). Phytosemiotics. Semiotica, 36(3/4), 187-209.
Kull, K. (1999). On the history of joining bio with semio: F. S. Rothschild and the biosemiotic rules. Sign Systems Studies, 27, 128-138.
Kull, K. (2003). Thomas A. Sebeok and biology: Building biosemiotics. Cybernetics And Human Knowing, 10(1), 7-20.
Kull, K. (2009). Vegetative, animal, and cultural semiosis: The semiotics threshold zones. Cognitive Semiotics, 4, 8-27.
Kull, K. (2015). Evolution, choice, and scaffolding: Semiosis is changing its own building. Biosemiotics, 8, 223-234.
Kull, K. (2018). Umberto Eco on the biosemiotics of Giorgio Prodi. Sign Systems Studies, 46(2/3), 352-364.
Kull, K. (2022). The term ‘Biosemiotik’ in the 19th century. Sign Systems Studies, 50(1), 173-178.
Kull, K., Emmeche, C., e Favareau, D. (2008). Biosemiotic question. Biosemiotics, 1(1), 41-55.
Kull, K., Deacon, T., Emmeche, C., Hoffmeyer, J. e Stjernfelt, F. (2009). Theses on biosemiotics: Prolegomena to a theoretical biology. Biological Theory, 4(2), 167-173.
Latour, B., e Woolgar, S. (1986). Laboratory life: The construction of scientific facts. Princeton University Press.
Latour, B. (2012). An inquiry into modes of existence: An anthropology of the moderns. Harvard University Press.
Latour, B. (2015). La sfida di Gaia: Il nuovo regime climatico. Meltemi.
Latour, B. (2020). Critical zones: The science and politics of landing on earth. mit Press.
Latour, B. (2021). After lockdown: A metamorphosis. Polity Press.
Latour, B. (2021a). Politiche del design: Semiotica degli artefatti e forme della socialità. In D. Mangano e V. Bordenca (a cura di), Mimesis. Insegne.
McShea, D., e Brandon, R. (2010). Biology’s first law: The tendency for diversity and complexity to increase in evolutionary systems. University of Chicago Press. Maran, T. (2019). Deep ecosemiotics: Forest as a semiotic model. Semiotic Inquiry, 38/39(3), 287-303.
Maran, T. (2020). Ecosemiotics: The study of sign in changing. Cambridge University Press.
Maran, T. (2021). The ecosemiosphere is a grounded semiosphere: A Lotmanian conceptualization of cultural-ecological systems. Biosemiotics, 14, 519-530.
Maran, T. (2023). Applied ecosemiotics: Ontological basis and conceptual models. In P. Cobley e A. Olteanu (a cura di), Semiotics and its masters ii. Mouton De Gruyter.
Maran, T., e Kull, K. (2014). Ecosemiotics: main principles and currents developments. Geografiksa Annaler: Serie B, Human Geography, 96, 41-50.
Markoš, A. e Švorcová, J. (2019). Epigenetic processes and the evolution of life crc Press.
Marrone, G. (2011). Addio alla natura. Einaudi.
Maturana, H., e Varela, F. (1980). Autopoiesis and cognition: The realization of the living. Riedel Publishing Company.
Morin, E. (1972). Teorie dell’evento. Bompiani.
Morin, E. (2001). Il metodo 1. La natura della natura. Raffaello Cortina.
Morin, E. (2004). Il metodo 2. La vita della vita. Raffaello Cortina.
Morton, T. (2013). Hyperobjects: Philosophy and ecology after the end of the world University of Minnesota.
Morris, C. (1946). Signs, language, and behavior. Prentice Hall.
Nöth, W. (a cura di), (1994). Origins of semiosis: Sign evolution in nature and culture Mouton de Gruyter.
Nöth, W. (1990). Handbook of semiotics. Indiana University Press.
Nöth, W. (1999). Ecosemiotics and the semiotics of nature. In E. Taborsky (a cura di), Semiosis, evolution, energy: Towards a reconceptualization of the sign. Shaker Verlag.
Nöth, W. (2000). Umberto Eco’s semiotic threshold. Sign System Studies, 28(1), 50-61.
Nöth, W. (2001). Protosemiotics and physicosemiosis. Sign System Studies, 29(1), 13-27.
Nöth, W. e Kull, K. (2001). Introduction: Special issue on semiotics of nature. Sign Systems Studies, 29(1), 9-11.
Nurse, P. (2020). What is life? Understanding biology in five steps. David Fickling Books.
Onnis, E. (2021). Metafisica dell’emergenza. Rosenberg & Sellier.
Paolucci, C. (2004). Piegature della continuità: semiotica interpretativa e semiotica generativa. Versus, 97, 111-149.
Pattee, H. (1997). The physics of symbols and the evolution of semiotic controls. In Coombs, M. (a cura di), Proc workshop on control mechanism for complex systems. Addison-Wesley.
Pattee, H. (2001). The physiscs of symbols: Bridging the epistemic cut. Bio Systems, 60(1-3), 5-21.
Peirce, C. S., Hartshorne, C. e Weiss, P. (a cura di). (1931). Collected papers of Charles Sanders Peirce. Harvard University Press.
Ponzio, A. e Petrilli, S. (2002). I segni della vita. La semiotica globale di Thomas A. Sebeok. Spirali.
Prodi, G. (1977). Le basi materiali della significazione. Mimesis.
Prodi, G. (1988). La biologia come semiotica naturale. In M. Herzfeld e L. Melazzo (a cura di), Semiotic theory and practice. Proceeding of the Third International Congress of the iass Palermo (vol. i). Mouton de Gruyter.
Prodi, G. (2010). Sign and Codes in Immunology. In D. Favareau (a cura di), Essential readings in biosemiotics. Springer.
Rodríguez Higuera, C. e Kull, K. (2017). The Semiotic Threshold. Biosemiotics, 10, 109-126.
Rothschild, F. S. (1962). Laws of symbolic mediation in the dynamics of self and personality. Annals of New York Academy of Sciences, 96, 774-784.
Santaella, L. (2001). “Matter as effete mind”: Peirce’s synechistic ideas on the semiotic threshold. Sign Systems Studies, 29(1), 49-61.
Sarti, A., Citti, G. e Piotrowski, D. (2022). Differential heterogenesis: Mutant forms, sensitive bodies. Springer.
Sebeok, T. A. (1963). Communication among social bees; porpoises and sonar; man and dolphin. Language 39, 448-466.
Sebeok, T. A. (1988). Communication, language and speech: Evolutionary considerations. In M. Herzfeld e L. Melazzo (a cura di), Semiotic theory and practice: Proceedings of the Third International Congress of the aiss Palermo (vol. ii). Mouton de Gruyter.
Sebeok, T. A. (1991). Sign is just a sign. Indiana University Press.
Sebeok, T. A. (1991a). American signatures: Semiotic inquiry and method. University of Oklahoma Press.
Sebeok, T. A. (1996). Signs, bridges, origins. In J. Trabant (a cura di), Origins of language (pp. 89-115). Collegium Budapest.
Sebeok, T. A. (2001). Global semiotics. Indiana University Press.
Sharov, A. (2024). Semiotic of Potential Meanings. In R. Gordon (a cura di), Pathways to the origin and evolution of meanings in the universe. Scrivener.
Sharov, A., e Tønnessen, M. (2021). Semiotic agency: Science beyond mechanism Springer.
Simondon, G. (2020). L’individuazione alla luce delle nozioni di forma e d’informaizone. Mimesis.
Stjernfelt, F. (2002). Tractatus Hoffmeyerensis: Biosemiotics as expressed in 22 basic hypotheses. Sign Systems Studies, 30(1), 337-345.
Swenson, R. e Turvey, M. T. (1991). Thermodynamic reasons for perception-action cycles. Ecological Psychology, 3(4), 317-348.
Tenti, G. (2022). Xenosemiotics: Toward an alienist materialism. Linguistic Frontiers, 5(3), 49-55. https://sciendo.com/pdf/10.2478/lf-2022-0021
Thom, R. (1972). Stabilité structurelle et morphogenèse. Essai d’une théorie générale des modèles. Benjamin Inc.
Thom, R. (1989). Thèmes de Holton et apories fondatrices. In J. Petitot-Cocorda (a cura di), Logos et catastrophes: A partir de l’oeuvre de René Thom . Patiño-Stendhal.
Thom, R. (2006). Morfologia del semiotico. Meltemi.
Thompson, E., e Stapleton, M. (2009). Making sense of Sense-Making. Reflections on enactive and extended mind theories. Topoi, 28(1), 23-30.
Von Uexküll, J. (1982). The theory of meaning. Semiotica, 42(1), 1-87.
Wheeler, W. (2006). The whole creature: Complexity, biosemiotics and the evolution of culture. Lawrence&Wishart.
Zengiaro, N. (2020). Eco-realism at the time of catastrophe: Imagining multispecies points of view to photograph the history of the world. International Journal of Anthropology, 35, 23-35.
Zengiaro, N. (2022). Ecosemiotics of the City: Designing the post-Anthropocene. European Journal of Creative Practices in Cities and Landscapes, 5(2), 204228. https://cpcl.unibo.it/article/view/14623/15802
Zengiaro, N. (2022a). From biosemiotic to physiosemiotics: Towards a speculative semiotics of the inorganic world. Linguistic Frontiers, 5(3), 37-48. https:// sciendo.com/article/10.2478/lf-2022-0019
Zengiaro, N. (2022b). The time of materials: Rethinking the anthropocene from stones. Versus, 135(2), 283-300.
Zengiaro, N. (2023). Latour and Biosemiotics: The hybrid notion of life. Rivista della Società Italiana di Semiotica, 37, 130-145. https://mimesisjournals.com/ojs/ index.php/ec/article/view/2758/2177
Zengiaro, N. (2024). Exploring life’s boundaries: Biosemiotics and the challenge of defining life. Linguistic Frontiers, 7 (3), 1-17. https://doi.org/10.2478/ lf-2024-0024
Zengiaro, N. (2024a). Persprective in materialist ecosemiotics: Coexisting with other life and non-life forms. Rivista della Società Italiana di Semiotica, 41, 511-515.
ias in musica e codesemiotics.
Appunti per lo studio da una prospettiva evolutiva
Emiliano Vargas
Abstract
Questo saggio fa parte di un approccio esplorativo al fenomeno dell’ias, stabilendo alcune connessioni teoriche tra biosemiotica e ias applicatE alle forme di vita musicali.
La domanda che guida il lavoro riguarda le possibilità di comprendere le ias come fenomeno co-evolutivo a partire dall’uso di processi di semiosi non interpretativa che permettono di realizzare descrizioni metatestuali per la comprensione di un fenomeno vario e mutevole.
In primo luogo, vengono presentati i concetti implementati, quindi viene mostrata una sintesi della traiettoria evolutiva delle ias nella semiosfera, evidenziando alcuni aspetti emergenti nella sua dimensione diacronica e stabilendo collegamenti con il paradigma biosemiotico attraverso la codesemiotics.
Si tratta di connessioni che emergono tra la nozione di intelligent agents proveniente dal campo delle ias con le nozioni di Umwelt, autodifferenziazione, manufacturing semiosis e signalling semiosis.
L’obiettivo è quello di testare proposte teoriche e metodologiche che contribuiscano all’approccio dei fenomeni che hanno luogo nella complessa relazione biosfera/tecnosfera/semiosfera.
Introduzione
Questo saggio non si propone di affrontare le questioni relative alle prospettive o possibilità di esistenza o generazione di coscienza, vita o autopoiesi nelle ias. Lo scopo è piuttosto quello di ragionare su alcuni punti di contatto teorico tra la biosemiotica e il ampio campo delle ias per fare
doppio clic su dove sia possibile oppure probabile l’intervento della nostra disciplina per lo studio del comportamento delle ias e delle loro modalità di interazione e autocomunicazione.
Prendiamo come punto di partenza alcuni aspetti intrinseci al fenomeno che, come vedremo più avanti, sono stati opportunamente definiti dai colleghi del nostro settore disciplinare come limitanti per lo studio delle ias. Ci interroghiamo su questioni immanenti e condivise tra agenti biologici e macchine che nascono dalla relazione agente-mondo, consapevoli che, nella sua diversità, la traiettoria storica delle ias è stata influenzata da autori provenienti da campi diversi come la biologia enattivista o le scienze cognitive, per citare alcuni esempi.
Dall’altro lato, gli studi sociali sulla scienza e la tecnologia comprendono anche un campo interdisciplinare sugli effetti culturali, etici e politici della conoscenza scientifica e dell’innovazione tecnologica1
In questo contesto, notiamo che la traiettoria evolutiva delle ias ha un percorso specifico all’interno delle forme di vita della musica e del suono che deve essere tracciato, organizzato e caratterizzato.
La proposta teorico-metodologica ha senso se si tiene conto che la relazione agente-mondo proposta dalle ias, almeno nei termini proposti da Turing, è incentrata sull’inganno della percezione umana (Natale 2021).
In altre parole, sono tecnologie orientate a emulare la struttura dell’intelligenza umana e le sue produzioni culturali con l’obiettivo di generare interventi che eguaglino o superino le capacità cognitive della nostra specie in modo più o meno autonomo. Ma questa capacità di autonomia viene utilizzata anche per intervenire, con obiettivi e performance measure che variano a seconda degli ambienti specifici. Ad esempio, i processi di produzione culturale operati da umani.
Quindi, parlare di intelligenza artificiale non significa necessariamente riferirsi all’emulazione dell’intelligenza umana, ma anche a forme di intelligenza meno complesse che servono a lavorare in ambienti specifici gestiti da agenti umani.
1 Da qui si evidenzia l’influenza di diversi autori come Gregory Beatetson (1979), Paul Watzlawick (1995), o più recentemente Bruno Latour e la sua teoria dell’attore di rete (2012).
Pertanto, un sistema di intelligenza artificiale che produce pezzi musicali completi in grado di creare una fruizione in un ascoltatore oppure di svolgere una funzione specifica in una mediatizzazione, soddisferà una performance measure richiesta da un processo che lo contenga.
Considerando che i concetti tratti da entrambi i paradigmi riguardano la relazione agente/mondo, la domanda che sorge è se la codesemiotics possa fornire elementi per descrivere metatestualmente processi di autocomunicazione e interazione delle ias in diversi contesti socioculturali.
La letteratura specializzata mostra che il campo delle ias è stato multidisciplinare dalla sua nascita, e con un alto grado di atomizzazione (Rusell & Norvig 1995; Crawford 2021). Forse questo spiega perché oggi si parla al plurale: intelligenze artificiali, anche se ci sono pubblicazioni che si sono fatte carico di stabilire collegamenti comuni tra i diversi sottocampi.
Pensare alle ias in musica attraverso una lente biosemiotica fa parte di un tentativo di comprendere sistemi che generano o emulano aspetti della creatività umana, combinando a livello di produzione aspetti quantitativi (la dimensione matematica e fisica della musica) con aspetti qualitativi, come la capacità di automatizzare la produzione di testi, prendendo come riferimento specifici codici culturali2 .
Non è una novità, infatti, che Jakob Johann von Uexküll, biologo e uno degli autori più influenti della biosemiotica, abbia ispirato parte della sua teoria alle analogie tra il regno biologico e le strutture formali della musica, influenzando generazioni di scienziati e accademici3. ias in musica. Biosemiotica e creazioni non abduttive?
Guido Ferraro (2023) ha sottolineato come aspetto problematico dello sviluppo del fenomeno il fatto che le ias non siano ancora in grado di generare interpretazione di significato. In altre parole, l’autore sostiene che per dare vita a forme più avanzate di ias sarà necessario che i sistemi, a un certo
2 Ad esempio, quando si tratta di creare musica tra generi e stili diversi.
3 Jackob Johann Von Uexk ü ll intendeva, ad esempio, le funzioni del corpo come co-dipendenti in un’armonia interna che permette di portare avanti l’esistenza, così come le diverse partiture compongono un’opera (1926, p. 10).
punto del loro sviluppo, acquisiscano una qualche capacità che permetta di emulare o avvicinarsi alla dimensione della generazione di significato. Si tratta di un processo interpretativo o di terzietà in termini peirciani.
Per Ferraro, se ciò fosse possibile, significherebbe il più importante salto qualitativo nella storia evolutiva delle ias. Ovvero, “passare dal livello dell’esecuzione delle operazioni al livello della comprensione del significato” (ivi: 79).
Carlos A. Scolari (2023, traduzione nostra) riprendendo Peirce, sostiene inoltre che, all’interno dell’ampio spettro di conoscenze che compongono il campo delle ias, il ragionamento abduttivo è uno step che difficilmente verrà raggiunto finché le tendenze passate e attuali, come il machine learning e il deep learning, continueranno a basarsi su metodi induttivi e deduttivi.
Dal suo punto di vista, le reti neurali e le reti neurali profonde, almeno finora, mancano di una capacità abduttiva (un processo logico formale attraverso il quale si passa dall’osservazione di fatti particolari alla formulazione di regole o ipotesi che tentano di spiegarli). Si tratta di una capacità che esiste negli organismi complessi e multicellulari che funzionano sulla base della generazione di rappresentazioni mentali o cerebrali.
In sintesi, entrambi i punti di vista suggeriscono che alle ias manca ancora una teoria dell’inferenza abduttiva su cui costruire una terzità peirceana (ibidem). Al di là del mistero dell’origine dell’abduzione come processo generativo, è legittimo chiedersi se i processi esistenti oggi possano essere considerati come processi di semiosi di altro ordine.
In fondo, la codesemiotics sostiene che limitare la semiosi a un processo dipendente dall’interpretazione del significato è una caratterizzazione riduzionista e sincronistica di un fenomeno evolutivo. La codesemiotics concepisce infatti la semiosi interpretativa come un risultato evolutivo di altre forme di semiosi preesistenti e coesistenti.
Si tratta di una corrente che si è sviluppata in ambito accademico a partire dalla scoperta del codice genetico e della sua ontologia e si basa sull’affermazione empirica che le regole del codice genetico sono praticamente le stesse in tutti i sistemi viventi e in tutti gli ambienti fin dall’origine della vita.
Un sistema semiotico è quindi composto da almeno tre entità distinte: segni, significati e codice, ma anche dalla presenza di un agente che li produce, chiamato da Barbieri codemaker (2009, p. 21, traduzione nostra).
Il modello del codice ci permette di riconoscere l’esistenza di molti codici organici nei sistemi viventi e di dividerli in due tipi di semiosi che ci interessa sottolineare: la semiosi di produzione (manufacturing semiosis) e la semiosi di segnalazione (signalling semiosis)4, entrambe esistenti su scala micro nel regno biologico.
Secondo Barbieri, la manufacturing semiosis è un tipo di semiosi che esiste, ad esempio, nella sintesi proteica o in processi come lo splicing5. Lo scopo di questo tipo di semiosi è la produzione di oggetti che non possono esistere in nessun altro modo all’interno del regno biologico. Si tratta di forme di semiosi non basate sull’interpretazione del significato, ma sulla produzione di oggetti. D’altra parte, la signalling semiosis è un tipo di semiosi che non ha la funzione di interpretazione o di fabbricazione di oggetti, ma il suo ruolo è l’organizzazione di oggetti in sovrastrutture funzionali, ad esempio a livello molecolare (2009, p. 24, traduzione nostra).
Barbieri utilizza l’esempio della signal transduction, sostenendo che si tratta di una semiosi perché crea una corrispondenza tra il primo messaggero e il secondo messaggero per mezzo di molecole recettoriali, ma non è una manufacturing semiosis perché i secondi messaggeri esistono già nell’agente e non sono fabbricati dal processo di trasduzione.
Mentre alcuni oggetti, come le proteine, sono creati dalla semiosi di produzione, la signalling semiosis genera segnali specifici che permettono l’associazione tra gli oggetti per raggruppare strutture supramolecolari. Entrambi i processi sono coinvolti nella creazione e nell’organizzazione degli oggetti in modo complementare.
4 I codici organici delle singole cellule sono apparsi nei primi 3 miliardi di anni della storia della vita e sono stati coinvolti nella produzione della semiosi o segnalazione.
5 Lo splicing dell’rna è un processo post-trascrizionale di maturazione dell’ rna dal quale vengono rimossi alcuni frammenti sequenziali.
ias in musica. Aspetti coevolutivi nel XX e XXI secolo.
È importante sottolineare che, al di là del mito mediatico che circonda i giornali digitali o la fantascienza, i sistemi generativi di ia s sono in uso da molto tempo, e si tratta di una direzione di sviluppo di quegli stessi strumenti informatici che oggi ci sono familiari nella vita quotidiana, sia in termini di utilità e miglioramento dei nostri modi di vita, ma anche dando origine a narrazioni sugli esiti futuri della coesistenza umano/macchina.
Nel corso del XX secolo, la storia delle ias ha potuto iniziare a essere narrata con i contributi della cibernetica e della teoria dell’informazione negli anni Quaranta e Cinquanta. In altre parole, le ias sono nata nell’intersezione dei campi occupati dalle relazioni tra il creativo, il formale, l’espressivo, l’interattivo e il tecnologico.
Warren McCulloch e Walter Pitts (1943) sono considerati gli autori del primo lavoro di ias6. Gli scienziati hanno attinto da tre fonti: la conoscenza della fisiologia di base e del funzionamento dei neuroni nel cervello, l’analisi formale della logica proposizionale di Russell e Whitehead e la teoria della computazione di Alan Turing 7
Anche se sul piano musicale il rapporto tra musica e algoritmi può essere fatto risalire ai tempi di Guido D’Arezzo8 (ca.991-1033), per quanto riguarda l’evoluzione del fenomeno nel corso del XX secolo e di parte del XXI si può affermare che all’inizio si trattava di un insieme di contributi che, pur provenendo da ambiti accademici diversi, si intrecciavano come vasi comunicanti tra gli studi musicali e i paradigmi dominanti delle
6 L’articolo si intitola “Un calcolo logico delle idee immanenti nell’attivit à nervosa” ed è stato pubblicato nel 1943 su The bulletin of mathematical biophysics, 5.
7 A quest’ultimo autore viene attribuita la visione delle ias nel suo articolo Computing Machinery and Intelligence, dove emergono il test di Turing, l’apprendimento automatico, gli algoritmi generici e l’apprendimento per rinforzo.
8 Guido D’Arezzo è stato un monaco benedettino noto per i suoi vari contributi alla scrittura musicale. Ma Guido è anche un riferimento fondamentale nella creazione dell’antico connubio tra musica e algoritmo: progettò infatti un sistema di generazione automatica di melodie basato su testi in cui le vocali venivano mappate alle diverse note della scala, creando un metodo di composizione melodica.
scienze della comunicazione e dell’informazione dell’epoca, in parte grazie alle proprietà fisiche e matematiche della musica.
Ad esempio, Experimental Music: Composition With an Electronic Computer (Hiller, Isaacson 1957) è considerato una delle prime esperienze di generazione di musica da parte di un computer digitale, che prende in considerazione sia la natura della comunicazione musicale sia la sua relazione con le strutture musicali formali. Gli autori cercarono di rispondere a domande fondamentali sulla possibilità di esprimere principi musicali ed estetici in forme adatte al trattamento informatico.
In termini teorici, le grammatiche generative sono emerse come potenti metodi di composizione algoritmica e di analisi musicale. Il modello linguistico di base, sviluppato da Noam Chomsky (1979), è il punto di partenza per l’applicazione di questo e di altri principi generativi più diffusi nei compiti musicali9.
Attualmente, i campi che più comunemente utilizzano le grammatiche generative sono la musica d’arte tradizionale europea, il jazz e l’etnologia musicale. Formalismi correlati, come le reti di transizione aumentata, sono utilizzati, ad esempio, negli approcci di David Cope per generare automaticamente composizioni o sequenze di accordi in un determinato stile musicale.
Un’altra notevole svolta si ebbe nel 1963, quando Lejaren Hiller10 e Robert Baker progettarono un nuovo software per la generazione automatica (basata su particolari regole) di partiture musicali, il Musicomp (acronimo di Music Simulator-Interpreter or Compositional Procedures), per la composizione musicale al fine di creare la Computer Cantata, un metodo di composizione elettronica digitale generata al computer come
9 In questo senso, il lavoro di Roads, Steedman, Sundberg, Lerdahl, Jackendoff e altri a partire dagli anni ‘70 ha portato a un grande interesse nell’applicazione delle grammatiche generative alla produzione e all’analisi delle strutture musicali (Nierhaus 2009).
10 Nel 1957 collabora con Leonard Isaacson al suo Quartetto per archi n. 4, Illiac Suite, il primo uso significativo di un computer per comporre musica. Nel 1958 Hiller fonda gli Experimental Music Studios presso l’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign. Originariamente formatosi come chimico, ha lavorato come ricercatore per DuPont a Waynesboro, in Virginia (1947-52).
Vargas
parte del programma di studio Experimental Music Studio dell’Università dell’Illinois (1963).
Da segnalare anche i contributi concettuali di P. Schaeffer (1966), nella sua opera Trattato degli oggetti musicali si possono trovare alcune delle nozioni più rilevanti del suo pensiero, ad esempio (i) oggetto sonoro, inteso come entità definita dall’ascolto e a cui vengono attribuite caratteristiche proprie e che può essere descritta; (ii) morfologia e tipologia degli oggetti sonori, con la creazione di un vocabolario descrittivo degli oggetti sonori, dove si può stabilire chiaramente un legame con il lavoro di Abraham Moles; (iii) oggetti e strutture: la percezione musicale e la nozione di ascolto ridotto; (iv) correlazioni tra il segnale fisico e l’oggetto musicale, basate sulla descrizione fisica dei suoni e dei parametri musicali. Con il passare della seconda metà del secolo scorso, è possibile osservare un progressivo sviluppo nello studio dell’automazione della creatività musicale. Questo processo ha iniziato a intensificarsi negli anni ‘80, periodo in cui è nata l’industria delle ias. In questo contesto, si evidenzia un accentuato interesse per la nozione di stile e un conseguente sviluppo del suo utilizzo come variabile per la definizione della specializzazione di diversi ambiti culturali.
Il lavoro di Leonard Meyer (1989) Style and Music ha avuto una notevole influenza. Meyer considera lo stile come la replica di un modello (quest’ultimo inteso come oggetti o processi ricorrenti), sia nel comportamento umano sia negli artefatti prodotti dal comportamento umano. In altre parole, lo stile si configura come il risultato di “una serie di scelte fatte all’interno di un insieme di vincoli” (ivi: 3). Per l’autore, lo stile di un individuo che parla o scrive è in gran parte il risultato di scelte lessicali, grammaticali e sintattiche fatte entro i limiti della lingua e del dialetto che ha imparato a usare, ma che non crea lui stesso. Dal suo punto di vista, si tratta di processi che a un livello meta funzionano allo stesso modo nella musica, nella pittura e nelle altre arti. Più in generale, pochi dei vincoli che limitano la scelta sono inventati o escogitati ex novo da chi li impiega.
Un altro autore che si distingue è David Cope (1991, 2004), non da ultimo per i suoi contributi alla codifica della stilistica. Cope sostiene che i
computer possono essere di grande aiuto per trovare le firme musicali, ovvero gli schemi spesso utilizzati che segnalano lo stile di un compositore. In effetti, si è occupato della codifica stilistica, occupandosi ad esempio della ricreazione dei compositori classici dell’Europa occidentale.11
Diversi lavori riportano uno sviluppo tecnologico che, partendo da un approccio stilistico di genere, produce frammenti musicali in modo autonomo. L’approccio stilistico di genere si è progressivamente sviluppato verso attributi sempre più specifici e individualizzabili, spostando l’asse del genere (Steedman 1984; Baggi 1992), verso la cattura di caratteristiche di maggiore parzialità tra cui il ritmo, il contorno melodico12 e le relazioni polifoniche. In altre parole, lo sviluppo della specificità stilistica come attributo organizzativo. Il crescente interesse per la segmentazione delle caratteristiche estetiche da modelli individualizzabili ha portato ad occuparsi degli stili personali di esecuzione strumentale (Assayag, Dubnoy, Delerue 1999; Lartillot et al. 2001).
Lavori successivi mostrano l’integrazione di improvvisazioni umane in improvvisazioni eseguite da sistemi generativi (Biles 1998). A questo punto diventa evidente che, a volte, l’emulazione e la automatizzazione della musica a partire da modelli stilistici generici concepisce anche le situazioni musicali della vita culturale fisica, fenomeni che sono intessuti in sottosistemi discorsivi e le cui proprietà come sottosistema differiscono da altre forme di improvvisazione esistenti (Zicarelli 1987).
A livello macro, il campo delle ias inizia un processo di sistematizzazione e unificazione negli ultimi due decenni del secolo scorso. Un esempio di tale processo è rappresentato dal libro di Stuart Russell e Peter Norvig, Artificial intelligence: A modern approach del 1995. Questo saggio costituisce uno dei più importanti tentativi di unificare in un’unica narrazione interdisciplinare i diversi campi delle ias e le relazioni tra le prospettive che li studiano. Da una prospettiva integrativa, sia il campo delle
11 Ad esempio, alcuni lavori di Cope (1991, 1996) si basano sulla creazione di musica a partire da schemi caratteristici del periodo che va dal barocco al medio romanticismo (dal 1700 al 1860).
12 Il contorno melodico è il tracciato strutturale delle altezze e delle posizioni della melodia di un’opera musicale.
ias che quello della codesemiotics concepiscono l’indice e l’agente come effettori nella creazione della complessità.
Per Russell e Norvig uno dei concetti rilevanti per l’unificazione delle ias è quello di agente razionale (intelligent agents). Secondo gli autori, lo studio delle ias è lo studio di agenti che ricevono percezioni dall’ambiente e compiono determinate azioni. In altre parole, ogni agente implementa una funzione che struttura sequenze di percezioni in azioni. Un agente razionale è definito anche sulla base della percezione di un ambiente, un processo effettuato per mezzo di sensori con l’obiettivo di agire in quell’ambiente per mezzo di attuatori, ossia elementi che reagiscono a uno stimolo eseguendo un’azione specifica. A sua volta, un agente razionale non deve necessariamente equivalere all’intelligenza umana, ma può operare in sistemi fisici o virtuali che fanno parte di un processo che li richiede in base al tipo di percezione che questi agenti presentano su un ambiente specifico13.
Da questo punto di vista, l’agente razionale non è interessato a una distinzione tra mezzi reali o artificiali, ma al “tipo di relazione che stabilisce tra il comportamento dell’agente, la sequenza di percezione generata dal mezzo e la sua misura di rendimento” (Russel, Norvig 1995, p. 74, traduzione nostra).
Alcune specificità del tempo presente
Il XXI secolo ha visto un’iperspecializzazione degli approcci, sia in termini di metodologia che di approccio al fenomeno, in gran parte dovuta all’esplosione delle ias in termini commerciali.
La letteratura specializzata indica che gli approcci basati sullo stile guidano almeno in parte la direzione in cui gli approcci si specializzano, in alcuni casi con risultati significativi rispetto ai decenni precedenti (Hakimi, Bhonker, El-Yaniv 2020).
La specializzazione sulla base di approcci stilistici può comportare, ad esempio, l’emulazione di tracce sonore con elementi che costituiscono singoli pattern espressivi a contenuti polistrumentali in cui si intrecciano
13 Gli autori usano questo termine per indicare elementi che reagiscono a uno stimolo eseguendo un’azione.
strutture melodiche armoniche, aspetti ritmici e persino intrinseci della tessitura sonora, nonché le diverse gamme di frequenze più o meno previste per ciascuna dimensione.
Anche se a priori non sembrano aver raggiunto i risultati ottenuti dalle produzioni convenzionali, esistono sistemi che mostrano alcuni progressi nella specializzazione delle ias all’interno di usi specifici. Ad esempio, attraverso sistemi generativi che offrono servizi di composizione musicale in ambienti virtuali, come nel caso di modelli quali Mubert o MusicLM14. Entrambi i modelli sono in grado di generare musica ad alta fedeltà a partire da descrizioni testuali.
L’offerta di Mubert, ad esempio, comprende servizi di creazione musicale per contenuti audiovisivi, podcast e app, creazione applicata agli artisti, tra gli altri15. L’utilità delle produzioni di Mubert può variare a seconda dell’ambiente per cui sono richieste. Le sue produzioni sono orientate all’uso in mediatizzazioni in cui il suono non è un aspetto fondamentale del discorso. In altre occasioni, possono essere utilizzate come materiale testuale di partenza per un’ulteriore elaborazione oppure samplings16 .
ias in musica. Interdisciplinarietà a vari livelli
È necessario sottolineare che all’interno della vita produttiva della musica, l’intelligenza artificiale svolge un ruolo attivo non solo attraverso i suoi sviluppi tecnologici orientati alla creazione musicale, ma anche attraverso sistemi orientati alla generazione di testi in altre materialità. Ad esempio, i sistemi applicati alla creazione di immagini che accompagnano i testi sonori. Generalmente utilizzati per la produzione di immagini che accompagnano un brano musicale oppure orientati all’immagine in movimento per la realizzazione dei videoclip. Un altro esempio sono i vari usi artistici
14 MusicLM è un modello di creazione musicale sviluppato da Google per generare musica ad alta fedelt à da descrizioni testuali.
15 Per visitare il sito di mubert il lettore può accedere attraverso questo link https://mubert.com/
16 In musica, l’anglicismo sampling è usato per indicare la pratica di campionare un suono registrato su qualsiasi tipo di supporto per essere riutilizzato in seguito come strumento musicale o per una diversa registrazione sonora.
del deepfake, una tecnologia che, in termini ontologici, serve a emulare le caratteristiche morfologiche della voce umana, ma che comincia a essere incorporata nelle produzioni artistiche. Mentre nell’ordine scritturale, l’emergere di pratiche di assimilazione come il Chatgpt in generi musicali popolari come il rap17.
In altri termini, si tratta di tre campi che conducono una vita indipendente dallo sviluppo della musica, ma con i quali interagiscono regolarmente.
In questo modo, si nota come l’interdisciplinarità costituisce un aspetto essenziale delle ias nella musica, sia dal punto di vista della sua genesi scientifica, dei suoi studi accademici, sia nei suoi campi d’azione.
Auto-differenziazione
Il celebre biologo e filosofo Jakob von Uexküll (1934), oltre a essere considerato un pioniero in vari campi come l’etologia, la zoologia del XX secolo e la cibernetica, è un autore che ha gettato ponti tra biologia, cibernetica, semiotica e studi musicali. Uno dei suoi contributi teorici fondamentali è il concetto di Umwelt, ovvero lo spazio semiotico e cognitivo di un agente biologico.
L’Umwelt è tutto ciò che l’organismo percepisce e configura come suo mondo percettivo e tutto ciò che costituisce il suo mondo effettore.
Ed esiste lì, dove il mondo percettivo e quello effettore formano un’unità chiusa e autodifferenziata (Uexküll 1982; 1992; Gómez 2021; Kull, Favareau 2022). La nozione di Umwelt condivide con il concetto di agente razionale una delimitazione fisica che permette l’esistenza di cerchi funzionali (Funktionkreiss).
Come definito dallo stesso Uexküll, il circolo funzionale è l’integrazione di percezione-azione di un organismo e si configura come un’integrazione temporale di cicli funzionali che creano e sostengono l’Umwelt nel tempo. In altre parole, l’organismo percepisce determinate qualità
17 Un esempio può essere trovato in Can Chat- gpt Rap: Analyzing the ability of Chat- gpt to replicate and analyze the lyrical style of Young Thug, di France, E. (2023). Recuperato dal seguente link: https://digital.kenyon.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=dh_iphs_ai
dell’ambiente da un veicolo segnico, cioè da qualsiasi tipo di oggetto che possa essere afferrato dall’agentività sensoriale fisica dell’organismo. Successivamente, l’elaborazione e la ricezione di queste qualità produce un segnale percettivo, grazie al quale l’organismo può attivare una risposta, istintiva o appresa.
Ciò che viene appreso emerge dal processamento dell’organismo, cioè dall’autorganizzazione del suo mondo interno (Innenwelt) a partire dalle affordance, o dagli organi effettori (Wirkorgane), ossia dalla parte della sua agentività fisica che gli permette di compiere azioni nell’ambiente. In questo modo si stabilisce un sistema di feedback tra l’agente e il mondo.
Sia nel regno biologico che nelle tecnologie di ias18 esiste un dominio di possibilità percettive date dalle condizioni corporee di un’agentività sensoriale e un dominio di possibili azioni da compiere sulla base di determinate possibilità di contatto e manipolazione dell’ambiente da parte di organi effettori o affordances. Questo implica almeno un altro punto di connessione tra l’idea di agente razionale e la biosemiotica: la nozione di autodifferenziazione. Una volta definito un interno per l’agente, si delimita anche un’alterità spazio-temporale. È allora che l’agente comincia ad avere una posizione rispetto alla sua alterità, e quindi comincia ad avere una temporalità che regola la sua percezione-azione19 (Gómez 2021, traduzione nostra).
La nozione di autodifferenziazione si basa sulla differenziazione agente-mondo che definisce sia l’autopoiesi che l’idea di circolo funzionale. Si tratta di un tipo di attributo osservato nelle cellule, attraverso la creazione di una membrana che configura un interno - dove avviene il metabolismo - e un esterno - dove si trova l’ambiente - e che nella nozione di agente razionale di Russell e Norvig è assunto dall’architettura fisica o virtuale che contiene e organizza il funzionamento degli organi sensoriali ed effettori.
18 Per Russell e Norvig (1995), un sistema di ia si basa su un insieme di agenti razionali.
19 Nel contesto della semiotica agentiva, l’autodifferenziazione è una delle condizioni fondamentali dell’agency.
Entrambi i paradigmi condividono l’esistenza temporale degli agenti di un circolo funzionale in un ambiente specifico che Russell e Norvig chiamano proprietà degli ambienti (properties of environments)20. Il circolo funzionale richiede la presenza di processi di autocomunicazione e autorganizzazione, dove la produzione di “significati” diventa un processo di traduzione tra sistemi presenti nella semiosfera/biosfera/tecnosfera (Hartley, Ibrus, Ojamaa 2020, p. 122, traduzione nostra).
Il numero di ambienti in cui le tecniche di ias sono utilizzate nella musica è vasto e si manifesta in diverse materialità che richiedono una progettazione appropriata per la funzione di ciascun agente.
Riflessioni e nuove domande
Prendiamo dunque in considerazione la biosemiotica, e in particolare la codesmiotics, prendendo gli attributi che caratterizzano la manufacturing semiosis e la signalling semiosis per descrivere alcuni aspetti immanenti dei sistemi generativi di creazione musicale e ias basate sul concetto di agente razionale.
Non avendo la pretesa di trarre conclusioni di valore esaustivo, il testo recupera le connessioni tra diversi paradigmi per lo studio di fenomeni che si sviluppano rapidamente in ambienti variabili e per scopi diversi. Un primo approccio storico alla sua traiettoria evolutiva ci permette di identificare il fenomeno come un campo che opera in un vasto spettro di materialità. Le ias in musica si occupano, almeno al momento, di produzione notazionale, sonora, visiva, audiovisiva, oltre che di fenomeni sonori che includono e superano il musicale, come ad esempio il deepfake vocale.
Un altro importante aspetto evolutivo ha a che fare con la nozione di stile come variabile che sembra organizzare, almeno in parte, lo sviluppo della specializzazione del fenomeno. Questo aspetto è rilevante non solo perché spiegherebbe le modalità di orientamento di almeno
20 Secondo gli autori, la progettazione di un agente dovrebbe sempre specificare il più possibile l’ambiente di lavoro, per il quale Russel e Norvig utilizzano l’acronimo reas (Performance, Environment, Actuators, Sensors).
una parte della specializzazione delle ias, ma anche perché lo stilistico si costituisce come codice nella produzione di sistemi generativi di composizione musicale. In cui abbiamo descritto, sia pure sinteticamente, alcuni ambiti e limiti.
Dal nostro punto di vista, all’interno delle ias in musica, i sistemi generativi di creazione musicale occupano processi in cui la relazione tra segno e oggetto è veicolata attraverso un codice formale che permette il passaggio dal primo al secondo, strutturando la creazione di oggetti a priori inesistenti.
Gli oggetti creati sono raggruppati in meso e macro strutture che presentano un ordine architettonico, cioè forme di organizzazione sovrastrutturale basate sull’intreccio di materialità sonore nelle dimensioni melodica, armonica e ritmica nell’ambito di un brano sonoro, nel caso di Mubert, di 45 secondi ottenuto sulla base di diversi tipi di valutazioni in cui intervengono variabili di genere stilistico che meritano un approfondimento del caso.
I sistemi generativi di creazione musicale propongono ambienti produttivi in cui il risultato può raggiungere misure di performance soddisfacenti che variano a seconda di ciascun ambiente. Sarebbe allora plausibile stabilire una relazione analogica uexkülliana tra le nozioni di manufacturing semiosis e signalling semiosis e le forme di creazione e ordinamento testuale dei sistemi generativi di creazione musicale, al fine di identificare e descrivere i modi in cui le ias operano in ambienti creativi che presentano una varietà di materialità e segmenti di azione.
In questo senso, si sottolinea che il lavoro svolto ci costringe ad approfondire le relazioni tra codice, stile e interazione per progredire negli aspetti qui sollevati. Questioni che in ambienti specifici analizzano l’autocomunicazione e l’interazione come prodotti di un processo co-evolutivo che ha luogo nella biosfera/tecnosfera/semiosfera/ e in cui si verificano trasformazioni che influenzano le percezioni e le pratiche delle culture contemporanee.
Riferimenti
Acotto, E. e Radicioni, D. P. (2012). Musical relevance: A computational approach. Proceedings of the 34th International Conference of the Cognitive Science Society. University of Huddersfield.
Barbieri, M. (2009). Three types of semiosis. Biosemiotics, 2(1), 19-30.
Barbieri, M. (2003). The organic codes. An introduction to semantic biology. Cambridge University Press.
Bateson, G. (1979). Mind and nature: A necessary unity. Cresskill.
Biles, J. A. (1998). Interactive GenJam: Integrating real-time performance with a genetic algorithm, proceedings. icmc 98.
Baggi, D. L. (1992). Neurswing: An intelligent workbench for the investigation of swing in jazz. Computer, 24(8), 60-64.
Chomsky, N. (1979). Sintáctica y semántica en la gramática generativa. Siglo XXI.
Cope, D. (1991). Computers and musical style (vol. vi). Oxford University Press.
Cope, D. (1996). Experiments in musical intelligence a-r
Crawford, K. (2021). The atlas of ai: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence. Yale University Press.
Dubnov, S., Assayag, G. e Bejerano, G. (2001). Automatic modeling of musical style Proceedings. icmc.
Gómez, S. R. (2021). Organización, experiencia y adaptación. Tres conexiones biosemióticas entre el pensamiento de von Uexküll y la biología enactiva de Maturana y Varela. Revista colombiana de filosof ía de la ciencia, 21(43).
Gómez, J. S., Abeber, J. e Cano, E. (2018, settembre). Jazz solo instrument classification with convolutional neural networks, source separation, and transfer learning proceedings ismir. Fraunhofer.
Hartley, J., Ibrus, I. e Ojamaa, M. (2020). On the digital semiosphere: Culture, media and science for the Anthropocene. Bloomsbury Publishing.
Hakimi, S. H., Bhonker, N. e El-Yaniv, R. (2020, October). BebopNet: Deep neural models for personalized jazz improvisations proceedings ismir
Hiller, L. A. e Isaacson, L. M. (1979). Experimental Music: Composition with an electronic computer. Greenwood Publishing Group.
Kull, K. e Favareau, D. (2022). There is umwelt before consciousness, and learning transverses both. Biosemiotics, 15(3), 491-495.
Latour, B. (2012). We have never been modern. Harvard University Press.
Leone, M. e Santangelo, A. D. M. (2023). Semiotica e intelligenza artificiale. Aracne editrice.
Lewis, E. (2019). Intents and purposes: Philosophy and the aesthetics of improvisation. University of Michigan Press.
McLean, A e Dean, R. T. (2018). The Oxford handbook of algorithmic music. Oxford University Press.
Löthe, M. (1999). Knowledge based automatic composition and variation of melodies for minuets in early classical style [conferenza]. In ki-99: Advances in Artificial Intelligence: 23rd, Bonn.
Lartillot, O., Dubnov, S., Assayag, G. e Bejerano, G. (2001). Automatic modeling of musical style Proceedings icmc. Ben-Gurion University of the Negev.
Meyer, L. B. (1996). Style and music: Theory, history, and ideology. University of Chicago Press.
Natale, S. (2021). Deceitful media: Artificial intelligence and social life after the Turing test. Oxford University Press.
Nierhaus, G. (2009). Generative Grammars. Algorithmic Composition: Paradigms of Automated Music Generation. Springer.
Pachet, F. (2003). The continuator: Musical interaction with style. Journal of New Music Research, 32(3), 333-341.
Reybrouck, M. (2005). A biosemiotic and ecological approach to music cognition: event perception between auditory listening and cognitive economy. Axiomathes, 15(2), 229-266.
Russell, S. J. e Norvig, P. (2010). Artificial intelligence: A modern approach (3rd ed.). Pearson.
Scolari, C. A. (2023, 21 de agosto). El mal que aqueja a las ia es la abducci ó n . Hipermediaciones. https://hipermediaciones.com/2023/08/21/ el-mal-que-aqueja-a-las-ia-es-la-abduccion/ Schaeffer, P. (1966). Traité des objets musicaux: Essai Interdisciplines. Seuil. Steedman, M. J. (1984). A generative grammar for jazz chord sequences. Music Perception, 2(1), 52-77.
Von Uexküll, J. (1934). A stroll through the worlds of animals and men. A picture book of invisible worlds. In C. Schiller (a cura di), Instinctive behavior: The development of a modern concept (pp. 5-80). International Universities Press. Von Uexküll, T. (1982). Introduction: Meaning and Science in Jakob von Uexküll’s Concept of Biology. Semiotica, 42(1), 1-24. https://doi.org/10.1515/ semi.1982.42.1.1
Von Uexküll, J. (1926). Theoretical Biology. Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. Watzlawick, P. (2010). El sinsentido del sentido o el sentido del sinsentido. Herder. Zicarelli, D. (1987). M and Jam Factory. cmj, 11, 13-29. https://www.jstor.org/ stable/3680237
Resistenza artistica e intellettuale nella lotta per l’ambiente
Resistenza artistica e intellettuale nella lotta per l’ambiente
Baal Delupi
Abstract
L’attuale dibattito sull’ambiente assume nuovi significati nelle nostre società contemporanee. L’evidenza scientifica espone i pericoli dell’inquinamento ambientale derivante dalle modalità produttive del capitalismo globalizzato. Gli incendi si ripetono, la siccità colpisce diverse regioni e il problema dell’acqua comincia a preoccupare migliaia di persone in tutto il mondo. Ecco perché negli ultimi anni diversi gruppi di artisti in America Latina hanno realizzato interventi in spazi pubblici affrontando la problematica ambientale come asse centrale. Performance contro l’inquinamento industriale in Argentina, reclami per la distruzione dell’Amazzonia in Brasile, proteste contro la costruzione del treno maya in Messico, tra molti altri, mostrano come la lotta biosemiótica sia un tema ricorrente nei paesi della regione.
Questo lavoro propone, da una prospettiva sociosemiotica, di analizzare come il gruppo di artisti ContraArte, nella città di Cordoba, in Argentina, costruisce sensi politici di resistenza e dissenso, tematizzando ed esprimendo visioni del mondo sulla disputa ambientale. Analizzeremo le registrazioni visive di varie azioni performative per vedere regolarità semiotiche e ricorrenze su una questione fondamentale per il futuro planetario. Sarà possibile identificare, a partire dalle regolarità nella materialità discorsiva, un particolare cronotopo che configura, a sua volta, una communitas del dolore che è sempre marginale rispetto a quanto istituito. L’arte permette l’interpellanza e la creazione di immaginari che altrimenti non potrebbero essere enunciati, configurando scenari liminali di inversione di credenze ed esperienze quotidiane.
Introduzione
Il neoliberismo come forma attuale del capitalismo opera non solo da una logica economica ma anche da quella affettiva, attraverso l’impianto della paura e del terrore patrocinato da organismi internazionali e statali. Queste due logiche sono installate nella nervosità della rete algoritmica per potenziare il suo potere e limitare le vie di accesso ad altri mondi possibili. A loro volta, i sistemi istituzionali e le logiche politiche prevalenti e legittime del XX secolo si incrinano tra l’aumento delle disuguaglianze, la disoccupazione e la dipendenza finanziaria degli stati da organismi come il Fondo monetario internazionale. Infine, va sottolineata la disputa sull’ambiente che è al centro dello stato di discorso sociale contemporaneo, poiché migliaia di aziende senza regolamentazione inquinano il territorio senza rendersene conto, nonostante tutti gli indicatori negativi che mostrano gli scienziati del mondo.
In questo quadro, le resistenze (soprattutto locali che possono anche essere collegate in modo globale) hanno la possibilità di fuggire e fessurare, di stabilire legami a lungo termine e generare alleanze strategiche per operare come confronto al potere dominante (Calveiro 2019), ma anche come creatrici di altre possibili logiche; alcune di esse sono legate ai processi indigeni, altre a rivendicazioni di genere, movimenti ambientali, ecc. Si tratta di gruppi che intervengono nello spazio pubblico per resistere alla guida neoliberale che insiste sull’eliminazione di tutto ciò che è al di fuori del soggetto-norma che si configura nel discorso sociale (Angenot 2010). Di tutti questi spazi di resistenza, questo lavoro si interessa a coloro che realizzano azioni a partire da risorse artistiche poiché a differenza di altri tipi di attivismo mettono in gioco estetici che generano una nuova ripartizione del sensibile sul piano simbolico (Rancière 2009). A loro volta, si differenziano dai modi di protesta con risorse artistiche dei decenni precedenti poiché non si accontentano dell’agitprop, non vogliono solo trasmettere un’idea pedagogica su ciò che accade nel mondo, ma propongono un “nuovo linguaggio artistico con una proposta politica di trasformazione della realtà” (Delgado 2013, p. 2, traduzione nostra). Nonostante le diverse nomenclature, si sceglie di chiamare questi gruppi “attivismo artistico” piuttosto che “artivismo” per evitare che l’“attivismo” sia un aggettivo o
Resistenza artistica e intellettuale nella lotta per l’ambiente
un cognome dell’arte. Ana Longoni, riprendendo la proposta del dadaismo tedesco, lo definisce come un insieme di “produzioni e azioni, spesso collettive, che attingono a risorse artistiche con la volontà di prendere posizione e incidere in qualche modo sul territorio del politico” (2009, p. 1, traduzione nostra). Questi collettivi propongono forme estetiche di relazionalità anteponendo l’azione sociale alla tradizionale visione dell’autonomia dell’arte, esponendo straripamenti artistici verso la politica senza limitarli alla storia dell’arte e ai musei (Aladro-Vico, Jivkova-Semova, Bailey 2018).
Nelle conclusioni della mia tesi di dottorato (Delupi 2022d), ampliate in lavori successivi (Delupi 2022a; 2022b; 2022c), ho potuto notare come le pratiche artistiche fossero legate alla politica (in contrapposizione al potere dominante) non solo in quello che era noto come il “arte impegnata” degli anni ‘60 e ‘70 (Richard 2007), ma anche in manifestazioni del XXI secolo. In questa direzione, questa ricerca si concentra su azioni di attivismo artistico in Argentina, gruppi che hanno in comune la possibilità di contestare l’egemonia dominante svolgendo un ruolo chiave nella lotta per l’imposizione di sensi politici, costruendo nuove pratiche e soggettività dalla resistenza (Verzero 2013).
A partire dall’indagine esplorativa intorno alla bibliografia esistente sul tema, recupero antecedenti che affrontano diverse linee problematiche. Guattari e Rolnik (2019), Rancière (2009) e Groys (2016), da una prospettiva filosofica, sottolineano la potenza politica dell’attivismo a partire da risorse estetiche, mentre discutono sull’istituzionalizzazione dell’arte e della politica. Questo approccio permette di riflettere sull’attivismo artistico su scala micropolitica legato al macro come gioco di tensioni e relazioni (Guattari, Rolnik 2019). Da parte loro, Richard (2007) e Escobar (2020) hanno approfondito l’incidenza di questi spazi in America Latina, con le particolarità politiche della regione. Giunta (2013), Felshing (2001) e Lippard (2006) si concentrano sulle caratteristiche organizzative e sull’identità estetica di questi gruppi in diversi periodi, e sostengono che si tratta di un’arte processuale che acquista senso nella loro realizzazione; a loro volta, le considerano essenzialmente collaborative e legate a movimenti sociali. Verzero (2013) e Longoni (2009), analizzano l’incidenza di questi collettivi in diversi momenti di crisi e di ebollizione sociale, proponendo di osservare il dialogo
che si stabilisce tra le diverse esperienze nel corso della storia argentina. Infine, Gutiérrez-Rubí (2020) e Fuentes (2020) esplorano la potenza comunicativa di queste azioni soprattutto sui social media.
Al di là di questi riferimenti sui gruppi di partito, questo lavoro si propone specificamente di analizzare interventi artistici in difesa dell’ambiente, argomento nodale per un mondo che viene distrutto dalle grandi corporazioni guidate da esseri umani, e che a Cordoba assume un carattere speciale per l’enorme quantità di incendi provocati intenzionalmente e la siccità dovuta al riscaldamento globale. Ci concentreremo sulle azioni che compie un gruppo in particolare, riferiamo al collettivo ContraArte della città di Cordoba, Argentina, contro l’azienda Porta Hnos (produttrice di Vodka, Vinagre, Alcohol etilico), che da anni inquinano del quartiere San Antonio, e le azioni contro la proposta di insediamento della società Monsanto nella località di Malvinas Argentinas. Nonostante le numerose denunce da parte di specialisti del settore e degli abitanti, queste aziende continuano con la loro produzione incessante. È per questo che ContraArte ogni anno effettua diversi interventi insieme ai vicini della zona, riprendendo una pratica simile a quella del teatro comunitario. Ci soffermeremo sulle azioni che il gruppo compie nel 2021 e 2022, dopo la pandemia: la prima riguarda l’azione-murale contro Porta Hnos, mentre la seconda allude al restauro del murale delle Falkland che fecero per la prima volta nel 2013 quando insieme ai vicini riuscirono a frenare l’insediamento della società Monsanto.
Le fotografie che circolano sulla pagina Facebook “Comunità ContraArte”1 saranno analizzate per identificare le regolarità discorsive. Da un punto di vista sociosemiótico l’obiettivo sarà quello di analizzare i sensi politici che emergono dalle immagini che il gruppo ha condiviso sul suo social network Facebook, a seguito dell’intervento contro le aziende Porta Hnos e Monsanto. Sarà possibile identificare, a partire dalle regolarità nella materialità discorsiva, un particolare cronotopo di resistenza e dissenso che
1 Per ulteriori informazioni sulla biografia e le azioni del gruppo, consultare il sito web: https:// www.facebook.com/contraarte
artistica e intellettuale nella lotta per l’ambiente
configura, a sua volta, una communitas del dolore che è sempre marginale rispetto a quanto istituito.
In primo luogo, faremo alcune riflessioni sulla problematica ambientale nella regione latinoamericana. Successivamente, ricostruiremo brevemente la storia del gruppo ContraArte, per poi esporre la prospettiva teorica da cui affrontiamo la discorsività artistica. Infine, sarà sviluppata un’analisi di entrambi gli interventi avvenuti negli anni successivi all’inizio della pandemia di Covid-19.
La disputa ambientale in America Latina
L’attuale dibattito sull’ambiente assume nuovi significati nelle nostre società contemporanee. Le evidenze scientifiche espongono i pericoli dell’inquinamento ambientale prodotto dalle modalità produttive del capitalismo globalizzato. Gli incendi si ripetono, la siccità colpisce diverse regioni e il problema dell’acqua comincia a preoccupare migliaia di persone in tutto il mondo. Ecco perché, negli ultimi anni, diversi gruppi di attivismo artistico in America Latina hanno realizzato interventi in spazi pubblici con la problematica ambientale come asse centrale. Proteste contro l’inquinamento industriale in Argentina, reclami per la distruzione dell’Amazzonia in Brasile, proteste contro la costruzione del treno maya in Messico, tra molti altri, mostrano come la lotta biosemiótica (Muñoz 2020) è un tema ricorrente nei paesi della regione.
Di fronte a questo panorama, gli scienziati di tutto il mondo denunciano l’aggressione contro il pianeta e mettono in guardia contro le conseguenze attuali e di altre che possono venire in pochi anni. Nel 2020 è stato pubblicato un documento intitolato “La tragedia ambientale dell’America Latina e dei Caraibi” che sintetizza l’attuale preoccupazione per l’ambiente. In ambito accademico, e in particolare nelle scienze sociali, ci sono scritti significativi sull’argomento. Un riferimento degno di nota sono i testi di Maristella Svampa che denuncia l’estrazione e lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali in America Latina: A Los fronteras del neoextractivismo en América Latina (2019) o nel suo più recente lavoro insieme a Enrique Viale, El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir de los modelos de (mal)desarrollo (2020), l’autrice sottolinea come il pianeta
venga distrutto anche sotto il discorso di “equità”. Non c’è vita migliore possibile se non si smette di sfruttare indiscriminatamente le risorse che ci tengono in vita, dice l’autrice. Per quanto riguarda l’incrocio tra arte e ambiente, la ricercatrice Lopardo (2020) ha analizzato le azioni dell’artista drag Maximiliano Mamani: Bartolina Xixa, una drag queen jujeña che denuncia l’estrattivismo a partire da vari interventi performativi; oppure, Marín Ruiz (2015) che analizza l’arte ambientale come sinonimo di arte ecologica nel quadro di uno studio critico dei rapporti tra arte ed ecologia. Infine, questo stesso numero della rivista è un altro esempio di come la problematica ambientale viene pensata nel campo dell’arte, in uno stato di discorso attraversato dalla problematica del Coronavirus.
Al di là della scarsa presenza di discorsi a favore dell’ambiente in molti politici e media, è notevole la quantità di attivismo che negli ultimi anni hanno denunciato i pericoli dell’inquinamento. Forse l’esempio più emblematico è quello della svedese Greta Thunberg, famosa per aver denunciato le conseguenze del riscaldamento globale, esortando i leader politici a fare qualcosa. In America Latina, ci sono molti movimenti femministi che hanno come obiettivo principale la lotta per l’ambiente, gruppi sociali che svolgono attività di riciclaggio e cura della città, e referenti come l’argentina Nicole Becker che pronunciano discorsi in spazi di grande potere politico. Cioè, in termini di Bajtín (2005), ci sono discorsi che si incatenano ad altri formando una matrice polifonica e dialogica che cristallizza segni epocali per denunciare il capitalismo vorace che si porta addosso a tutta la specie umana.
La lotta di ContraArte a Córdoba
Nello specifico, ci concentreremo su un gruppo in particolare che ha dedicato alcuni dei suoi interventi di strada alla questione ambientale. Ci riferiamo al collettivo ContraArte creato nel 2009 e che è ancora attivo. Ci proponiamo di analizzare, da una prospettiva sociosemiotica, i sensi politici che emergono dalle immagini che il gruppo ha condiviso sul suo social network Facebook, a seguito dell’intervento contro le aziende Porta Hnos e Monsanto. Sarà possibile identificare, a partire dalle regolarità nella materialità discorsiva, un particolare cronotopo di resistenza e dissenso che
Resistenza artistica e intellettuale nella lotta per l’ambiente
configura, a sua volta, una communitas del dolore che è sempre marginale rispetto a quanto istituito.
Il collettivo è formato da diversi artisti plastici e visivi della città, tra i più riconosciuti si possono nominare Liliana Di Negro, Marcela Majluff, Elia Bisaro e Roberto Riachi. Al di là delle interviste al gruppo e di alcune poche indagini, riteniamo che ci sia scarso materiale di tutti gli interventi che hanno portato avanti in questi tredici anni. Tutte le azioni possono essere trovate sulla pagina Facebook (non hanno un proprio sito web) e il più vecchio si trova su Youtube. È importante sottolineare che questa rete sociale ha funzionato come cassa di risonanza delle manifestazioni di questo spazio artistico-politico, convocando cittadini con questo media.
Tutto è iniziato nel dicembre 2008, quando l’artista Dolores Cáceres e altri colleghi, caratterizzati come contadini cinesi, hanno seminato un ettaro di soia nei giardini del rinomato Museo Caraffa della città di Cordoba. L’opera si chiamava Quién soy, giocando con le parole “soy” (in spagnolo “sono” e soia, in inglese) e “sou” (soia, in cinese antico). Quest’azione si innescò in pieno conflitto con i settori delle campagne per la Risoluzione 125 che generò polemiche a livello nazionale e provocò tagli di rotta da parte dei settori agricoli contro il governo di Cristina Fernández de Kirchner. Da questa rivendicazione nasce il gruppo ContraArte, che decide di scendere in strada per denunciare le disuguaglianze a partire da risorse estetiche.
Da allora, hanno sviluppato azioni con il Movimento Contadino di Cordoba, con i cittadini che resistono allo sfratto di villa La Maternità, i Vicini Uniti in Difesa di un Ambiente Sano (il collettivo vudas, del quartiere San Antonio) e, soprattutto, con l’Assemblea delle Falkland argentine e il blocco che ha resistito all’installazione dell’impianto multinazionale Monsanto, al quale hanno partecipato regolarmente per più di quattro anni. Inoltre, hanno fatto interventi nelle marce del 24 marzo, la marcia del cappello e nelle mobilitazioni per la scomparsa di Santiago Maldonado, tra le altre.
Un aspetto importante da sottolineare è che il gruppo ha portato avanti diversi interventi su questioni ambientali: oltre alle azioni contro l’azienda Monsanto e Porta Fr., ha partecipato alla mobilitazione “il monte si difende” nel 2020 a causa degli incendi nelle Sierras de Córdoba. Per questo
gruppo, il tema ambientale è una delle lotte principali del XXI secolo e nelle loro reti sociali rendono chiaro che l’“ecocidio” sarà l’asse principale degli interventi. Ciò non stupisce, poiché in Argentina, e più precisamente a Cordoba, negli ultimi anni sono emersi diversi gruppi che si occupano del problema dell’incendio delle foreste, della siccità dei fiumi e dell’inquinamento che le imprese producono quotidianamente: un esempio è il gruppo
ArdeCórdoba, che sviluppa proiezioni su diversi murales della città al fine di sensibilizzare i cittadini che attraversano la strada.
Prospettiva teorica
Partiamo dalla proposta del discorso sociale di Angenot (2010) per comprendere gli interventi del gruppo come discorsi epocali che prendono voce sociale e che si collocano in uno stato di particolare società, con un’egemonia singolare. Ci proponiamo di ricostruire uno stato di discorso sociale particolare e per questo è necessario comprendere i discorsi di ContraArte come fatti sociali e storici incatenati ad altri formando una semiosi illimitata. In termini metodologici, abbiamo recuperato la categoria di cronotopo di Bajtín (1989) e la nozione di cronotopie culturali sviluppata da Arán (2016). Basstino afferma che il cronotopo è una configurazione di tempo e spazio di senso che opera come un “centro organizzatore” di elementi compositivi dell’opera, come la trama, il genere e la configurazione dell’eroe-personaggio (Bajtín 1989, p. 400, traduzione nostra). Ciò propone livelli testuali differenziabili, ma a loro volta intrecciati dalla funzionalità tematica di alcune figure semantiche (motivi), formando così un insieme che converge nella messa in scena dello spazio-tempo rappresentato e “l’apparizione di soggetti e discorsi in situazioni cronotopiche, in un’epoca e in un determinato spazio” (Arán 2016, p. 143, traduzione nostra). In questa direzione, Arán (2016) fa una rilettura della nozione bajtiniana e propone la definizione di cronotopie culturali per portare la categoria cronotopo a qualsiasi fenomeno della cultura. Per l’autrice tale nozione implica un
Processo materiale di produzione di senso, che può essere analizzato come un discorso poliglotta, e i cui ancoraggi significativi sono spazi temporalizzati, ad alta densità semiotica (luoghi). La nozione di cronotopia (che
Resistenza artistica e intellettuale nella lotta per l’ambiente
permette di isolare il cronotopo puntuale) può funzionare come categoria di analisi semiotica che si applica ogni volta che interpretiamo le forme storiche di interventi o pratiche che si iscrivono in spazi reali e gli danno la loro fisionomia (fissa e mobile). Le cronotopie tessute dalla cultura si esprimono come racconti: hanno storia, memoria, varianti generiche e argomentali, soggetti e ruoli (ivi: 149, traduzione nostra).
La riqualificazione della categoria ci permette quindi di tracciare, in ogni stato di discorso e specificamente nel campo artistico e politico, cronometrie culturali particolari. Partendo dall’analisi del discorso degli interventi di ContraArte ci renderemo conto dell’apparizione di un cronotopo di dissenso e resistenza. Per questo ci proponiamo di vedere cosa si tematizza (argomento) e quali visioni del mondo si esprimono (Angenot 2010), così come i personaggi, il tempo-spazio e il genere discorsivo in cui si costruiscono contro le imprese Monsanto e Porta Hnos, in difesa dell’ambiente. Infine, riprendiamo il termine communitas, elaborato da Turner (1975) e ripensato da Diéguez (2014) come uno spazio di antistruttura e inversione dell’esperienza e credenza, interstizi di frontiera che generano una situazione liminale di “alto inquinamento e densità esperienziale” (ivi: 25, traduzione nostra). L’attivismo artistico propone nuovi scenari di communitas poiché “la cosa propria dell’arte è operare un nuovo spazio di ritaglio dello spazio materiale e simbolico” (Rancière 2004, p. 33, traduzione nostra). Mostreremo quindi come negli interventi del gruppo si osservi la costruzione di una communitas del dolore come spazio liminale che si discosta dall’idea tradizionale di comunità.
ContraArte nei murales. Analisi delle azioni 2021-2022
Ci concentreremo su due interventi che possiamo considerare “azioni murali” in quanto discorsi nello spazio pubblico che si può analizzare, grazie ai registri, in due istanze: quella del giorno concreto dell’azione, e il murale che rimane come impronta di resistenza contro l’inquinamento ambientale. Questi murales continuano spesso ad essere intercettati da altri vicini e artisti, come nel caso del restauro che fanno nel 2022 rispetto al murale delle Falkland.
È importante rendere conto dei diversi supporti e linguaggi semiotici che abilitano i percorsi di analisi: ci concentriamo specificamente sulle fotografie registrate che circolano sul social network facebook e che mostrano corpi di coloro che intervengono, elementi di lavoro, disegni, dipinti, tra le altre cose. Le fotografie della preparazione e del murale finale funzionano come costruzioni discorsive visive per analizzare l’intervento.
Cominciamo con la prima azione realizzata nell’anno 2021: il gruppo si propone di agire sulla parete di una piazza nel quartiere San Antonio con l’obiettivo di denunciare, come ogni anno, l’inquinamento di Porta Fr. Lo spazio “piazza” è fondamentale per la vita del quartiere, poiché è un luogo attraversato quotidianamente dagli abitanti.
Sulla pagina Facebook è possibile analizzare la registrazione di varie immagini con la seguente descrizione:
Murale di ContraArte nella Primavera senza porta: senza bioetanolo nei nostri quartieri.
Eravamo presenti alla Giornata per la Giustizia Ambientale convocata da vudas fuera porta nel quartiere San Antonio della città di Cordoba. Un settore che viene punito e subisce le conseguenze della negligenza della giustizia e delle autorità a tutti i livelli. Illegalmente, la società Porta Hnos. continua la produzione di bioetanolo, inquinante e rischioso. Non si può respirare nel quartiere… e gli studi rivelano la presenza di veleno nel sangue dei vicini. Il nostro appoggio incondizionato alle vicine, difensori ambientali che continuano a resistere agli attacchi, per le infanzie, per le loro famiglie, per il quartiere e per rendere visibile un anello chiave nella produzione della morte del sistema agroindustriale
#FueraPorta
#SanAntonio
#Inaudi
#BioEtanol
#Vudas
(ContraArte 2021, traduzione nostra)
Resistenza artistica e intellettuale nella lotta per l’ambiente
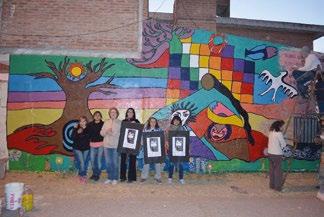
Immagine 1. Azione collettiva ContraArte
Fonte: Comunidad ContraArte. (18 ottobre 2021). — en Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina [Facebook] https://www.facebook.com/photo/?fbid=512889062392681&set=a.866895433658707
In molte delle immagini si osserva la preparazione per la produzione del murale: artisti, abitanti del quartiere e cittadini si propongono di portare avanti l’opera d’arte contro l’azienda. L’idea di collettività (immagine 1) diventa una ricorrenza nelle fotografie, ma anche nella descrizione che accompagna le foto poiché si parla di un nesso tra il gruppo di attivismo artistico con “vudas fuerta porta”, “nuestrxs vecinxs”, “difensori ambientali”, “infancias” e “famiglie”, cioè, c’è un senso di comunità che diventa ricorrente contro la produzione agrotossica di Porta. Questo non è un dato di poco conto perché si comincia a intravedere un immaginario di unità legato all’articolazione di richieste particolari, interessi comuni che implicano “benessere collettivo” contro “l’attività dell’azienda”.
Il murale si sviluppa in una “giornata ambientale”, cioè una convocazione per la partecipazione di un coro di voci; e non si fa ovunque poiché uno spazio pubblico e aperto dice molto sull’intervento. Un altro fatto
significativo è che si sviluppa in una sorta di piazza, spazio cronotopico lavorato da ricercatrici come Arfuch (2005), configurazione tempo-spazio riconoscibile in Argentina, luogo di incontro e richiamo, di protesta sociale, di tracce discorsive che evocano una memoria collettiva delle piazze di Perón, delle madri e nonne di Plaza de Mayo, di Blumberg, tra le altre. La piazza (imaggine 2), quindi, è un palcoscenico con grande carico semiotico, luogo che rende intelligibile il richiamo sociale.
Il cronotopo permette di identificare non solo il tempo e lo spazio, ma anche il genere discorsivo, in questo caso caratterizzato come “protesta”, una matrice generica che rende possibili e intelligibili gli enunciati che si producono e circolano in uno stato di discorso. Sia il formato che il genere definiscono il contenuto: non è la stessa cosa un intervento su un muro che su una foglia o un albero, né è uguale una classica protesta murale con iscrizioni linguistiche come una con disegni. L’idea di protesta in sé è una forma di resistenza e dissenso contro ciò che è stato istituito.
Si possono anche analizzare, a partire dal cronotopo, i personaggi che entrano in scena come in qualsiasi struttura narrativa. I membri del gruppo ContraArte possono essere visti abbracciati da cittadini accanto al murale. Di nuovo l’immaginario di comunità, l’unione come figura in contrapposizione ad un’impresa che casualmente si chiama Porta Fr., un nome che si presenta come familiare, ma che in pratica funziona come un ingranaggio del sistema capitalista senza alcun senso di comunità.
Inoltre, l’immagine dove si trovano i personaggi ha sullo sfondo un albero, simbolo di crescita e ramificazione; più in alto c’è un sole, figura che rimanda alla luce in contrapposizione all’oscurità. A destra c’è una figura antropomorfa che allarga un abbraccio e alla quale si vede il cuore, e più in alto appare la bandiera wiphala, cioè circolano i luoghi comuni dell’amore, il gesto dell’abbraccio affettuoso, la rivendicazione ai popoli originari (che non è un dato di poco conto dal momento che molte aziende agrotossiche si sono scagliate contro di loro) e ciò che cresce (come l’albero). Sono tematizzazioni che esprimono visioni del mondo (Angenot 2010) sia di unità che di amore e crescita collettiva.
L’ultima immagine che abbiamo selezionato per questo lavoro mostra l’intero murale. Metà dell’opera espone amore, gioia, crescita, vita e
Resistenza artistica e intellettuale nella lotta per l’ambiente

Immagine 2. ContraArte realizza il murale nella piazza del quartiere San Antonio
Fonte: Comunidad ContraArte. (18 ottobre 2021). — en Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina [Facebook]
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1559544094382566&set=pb.100064466811905.-2207520000
popoli originari (proprio la parte che hanno scelto per scattarsi la foto), mentre l’altra metà lascia in evidenza la fabbrica che inquina e uccide, i cadaveri sepolti sotto l’azienda e il cielo grigio-viola che rovina il nostro ecosistema. Alcuni teschi sono sott’acqua, fatto importante perché Porta Hnos. inquina per aria e per acqua.
È importante recuperare la frase scritta sul muro (immagine 3): “Tutti gli abitanti godono del diritto ad un ambiente sano, equilibrato, adatto allo sviluppo umano e affinché le attività produttive soddisfino i bisogni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future; e hanno il dovere di preservarlo. Art. 41. Costituzione nazionale” (ContraArte 2021).
Il discorso del gruppo dialoga con quello giuridico quando cita un articolo della Costituzione che evidentemente non viene rispettato. Questa sorta di dialogo tra il discorso ambientale, giuridico, di popoli originari, tra gli altri, interviene il murale.

Immagine 3. Il muro completo Fonte: Comunidad ContraArte. (18 ottobre 2021). — en Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina [Facebook]
https://facebook.com/kontarrate/photos/pb.100064466811905.-2207520000/1559543771049265/?type=3
Passando all’intervento murale del 2022, la prima cosa da sottolineare è il cambiamento di scenario: non è la stessa cosa, come nella prima azione, fare un murale all’interno della città di Cordoba, in un quartiere periferico, che in una località diversa con un altro quadro giuridico normativo. Malvinas Argentinas è una città argentina situata nel dipartimento di Colón e si trova a 14 km a est del centro della città di Cordoba. Negli ultimi due anni questo villaggio di 12.000 abitanti è diventato famoso a livello internazionale per aver condotto una delle principali battaglie ecologiche dell’America Latina, quando i vicini di Malvinas Argentinas hanno raggiunto qualcosa che molti considerano titanico: frenare un’impresa della multinazionale americana Monsanto.
L’azienda, fondata nel 1901, è la più grande produttrice di sementi geneticamente modificate (o transgeniche) al mondo e uno dei principali produttori agrochimici. Diversi gruppi ambientalisti la considerano il nemico pubblico numero uno, anche se i suoi prodotti sono popolari tra un gran numero di agricoltori. Nel 2012, la Monsanto ha annunciato la costruzione
Resistenza artistica e intellettuale nella lotta per l’ambiente
del più grande impianto di sementi di mais transgenico in America Latina, che avrebbe funzionato in Argentina. Tuttavia, la resistenza della comunità, guidata dall’Assemblea dei Vicini Malvinas Lotta per la Vita, è riuscita a frenare questo progetto.
Uno dei gruppi che è intervenuto in questa problematica è stato ContraArte, che nel 2013 ha realizzato un’importante azione murale per gli abitanti delle Falkland. Nove anni dopo, la comunità continua a ricordare l’importanza di resistere alla Monsanto, ecco perché il collettivo di artisti è stato convocato per ripristinare quel murale come elemento chiave della lotta contro la multinazionale (immagine 4).

Immagine 4. Parte del muro con la scritta “agrotossico” in riferimento all’azienda Monsanto Fonte: Comunidad ContraArte. (18 ottobre 2021). — en Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina [Facebook]
https://www.facebook.com/photo/?fbid=8058935694148805&set=pcb.8058936290815412
Nel post di Facebook condiviso dal gruppo il 22 settembre 2022, gli artisti dicono (traduzione nostra):
Murale Semi Liberi Senza Agrotossici
Isole Falkland | Cordoba
Nel 2013 abbiamo dipinto questo murale nelle Falkland, in un momento di pieno conflitto contro la multinazionale avvelenatrice del mondo.
Oggi, 9 anni dopo lo ridipingiamo, per festeggiare un’altra primavera senza monsanto, un trionfo che non dimenticheremo mai, grazie pacha per mostrarci la strada.
Andiamo per una primavera senza porta
#
#FueraMonsanto
#FueraMonsantoDelUniverso
#MalvinasPorLaVida
#SemillasParaLosPueblos
#PrimaveraSinPorta
La data della primavera non è casuale, la comunità festeggia ogni inizio di questa nuova stagione perché espone proprio la necessità che i fiori possano fiorire in un mondo senza inquinamento. Questo dialogo mostra come il discorso della resistenza attraversa quei discorsi ambientali, artistici, giuridici, operando in molteplici saperi: l’uso dei colori, la tipologia delle linee di disegno nonché l’articolazione più generale delle scene rappresentate (aperte vs. chiuse) mettono in scena due tipologie di spazi estremamente diverse.
Ancora una volta, l’azione si realizza in una giornata ambientale, in modo collaborativo senza apparenti gerarchie: non è possibile distinguere, a colpo d’occhio, chi sono le artiste e chi i vicini della comunità (immagine 5). Bisogna conoscere ciascuno di essi per differenziarli
artistica e intellettuale nella lotta per l’ambiente
poiché non si forma una struttura verticale ma piuttosto un’orizzontalità molteplice.
Il murale espone ciò che cresce con colori primaverili, di fronte a un viola che può essere pensato come una fusione di colori allegri, o come ciò che inquina, se si considera che quel colore ha rappresentato, nel murale precedente, la contaminazione di Porta Hnos, che ci porterebbe a pensare a una dualità rispetto a ciò che cresce e ciò che impedisce di crescere. Il nero che si interseca con il verde, colori che coprono il suolo-mondo, potrebbe essere un’altra caratteristica della dualità “vita vs. morte”, o semplicemente una combinazione per illustrare parti con erba e altre senza.
C’è una donna al centro del murale che mostra come l’intervento dialoga con il discorso di genere. Ed è una donna con una lunga treccia e vestiti che oscillano tra l’estetica hippie e quella andina, un’altra somiglianza con il primo murale che recupera la voce dei popoli originari. È, inoltre, una donna senza volto, che ci porta a riflettere se non genera un’identificazione in quanto “tutte possono essere quella donna che cammina libera con la natura”, o se piuttosto produce una depersonalizzazione e disumanizzazione.
C’è un oggetto rosso che avvolge la donna, sarà un cuore come nell’azione precedente? Non lo sappiamo, ma quello che possiamo fare è stabilire alcuni assi semantici che si possono tracciare in contrapposizione: vita - morte / libertà - prigione / vita - agrotossici, tra gli altri.
Un altro aspetto da menzionare: il collegamento con altri gruppi artistici. Sulla pagina Facebook il post è condiviso dall’utente “Malvinas lotta per la vita”, il che espone che l’intervento si completa, in qualche modo, nei social network, arena di lotta di senso. Da molti anni la registrazione degli interventi nello spazio pubblico è fondamentale per la successiva diffusione, esposizione e partnership con altri collettivi. Occorre chiedersi se tali reti possano essere considerate parte di uno spazio pubblico digitale.
Risultati: Cronotopo di resistenza e dissenso
Dipingere un murale con slogan politici non è una novità, ciò che risulta attraente sono due cose: le particolarità che si distaccano da questi interventi (personaggi, luogo e spazio) e il cronotopo che si aggiorna. È proprio

Immagine 5. Murale completato Fonte: Comunidad ContraArte. (18 ottobre 2021). en Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina [Facebook]
https://www.facebook.com/photo/?fbid=465840565574833&set=pcb.465840948908128
seguendo Bajtín (2005) che si può capire come in certi momenti di crisi si cristallizzino i segni ideologici, il che non vuol dire che prima non esistevano, ma ora acquistano visibilità. Di conseguenza, ci sono cronotopos che si rassegnano in momenti storici determinati per funzionare in quelle condizioni come parte della memoria semiotica. In questo modo è possibile identificare nelle produzioni discorsive che qui analizziamo un cronotopo che chiameremo “azione-murale” e che comprende due configurazioni di senso specifiche che si raggruppano nella categoria di “resistenza” e di “dissenso”. Di resistenza, perché si oppone a quanto dato e al potere stabilito per esistere (le imprese che inquinano). Il richiamo delle famiglie, le prove di inquinamento e le risorse artistiche si fondono in un grido di resistenza per sovvertire ciò che è stato stabilito e
artistica e intellettuale nella lotta per l’ambiente
ri-qualificarlo. Pilar Calveiro (2019) afferma che le resistenze hanno sempre un potere, il potere di resistere. Non sono al margine di ogni circuito di potere, piuttosto si oppongono al potere egemonico, ma hanno sempre un potere determinato per cercare di modificare situazioni sfavorevoli.
D’altra parte, diciamo dissenso e ci riferiamo alla già classica distinzione fatta da Rancière (2004) tra dissenso/consenso e polizia/politica: è la polizia che mantiene, mediante il consenso, ciò che è istituito, mentre la politica non è altro che il dissenso, il disaccordo che istituisce qualcosa di nuovo.
Un cronotopo simile può essere rintracciato in antichi interventi di arte e politica nella città di Cordoba, alcuni esempi sono le azioni portate avanti dal gruppo come Urbomaquia (2001), Las chicas del chancho y el corpiño (1996) o Artistazo (1985). Il dissenso è possibile quando si modifica lo spazio materiale e simbolico, qualcosa che l’arte ha saputo fare da tempo immemorabile generando una nuova ripartizione del sensibile.
Seguiamo il lavoro di Fernández (2008) sugli immaginari e le logiche collettive (come potenza) che emergono da gruppi in azione, poiché “quando un collettivo arma macchina in orizzontalità autogestiva e agisce in logica di molteplicità, le sue capacità di invenzione e di azione possono andare ben oltre quanto i suoi membri avrebbero potuto calcolare” (ivi: 300, traduzione nostra). In questo modo, ContraArte costruisce una grammatica di immaginazione politica come potenza collettiva che propone di rovesciare ciò che è stato istituito, intendendo “ciò che è stato dato” come “normale funzionamento” di imprese che inquinano la città e gli abitanti della provincia di Cordoba. E lo fa attraverso un tempo-spazio singolare che si traduce nel cronotopo d’azione-murale che si va aggiornando nel grande tempo bajtiniano.
Communitas del dolore
Inoltre, si espone ciò che Diéguez (2016) chiama communitas del dolore una situazione di antistruttura dove “La perdita come esperienza limite - il più netto dei limiti - che ci lascia soli, ha dato luogo intempestivamente a una communitas che sfidava la struttura di sottomissione alla paura e incarnare il diritto pubblico a piangere la morte” (ivi: 18, traduzione nostra).
In questo senso, il dolore dei parenti delle vittime per la contaminazione è presente nella descrizione linguistica e nei disegni sul murale. Communitas in quanto spazio orizzontale istituente che abbraccia il dolore e la perdita, che sa che il veleno è nel “sangue”, che “non si può respirare” e che i vicini sono vittime del bioetanolo. In nessuna immagine o scritto si vedono gerarchie, non si chiarisce chi appartiene al gruppo e chi le vittime, si mostra semplicemente un “stare insieme” di fronte al dolore, all’impotenza e alla perdita
È importante sottolineare il ruolo dell’Assemblea dei Vicini/i Uniti in Difesa di un Ambiente Sicuro (il collettivo vudas) nel primo intervento, che si è tenuto nel 2012 dopo che i suoi abitanti hanno cominciato a notare odori sgradevoli e irritazioni oculari, dermiche e respiratorie che aumentavano di intensità e anche alcuni/e vicini/e dovevano allontanarsi dal quartiere su raccomandazione dei loro medici. A seguito di ciò, nel maggio 2013 hanno deciso di recarsi all’Ospedale Clinico dell’Università Nazionale di Cordoba per richiedere la partecipazione di specialisti. Nell’agosto dello stesso anno, professionisti delle cattedre di Allergologia e Immunologia e di Clinica Pediatrica della Facoltà di Scienze Mediche dell’unc e membri della Rete Universitaria di Ambiente e Salute (Reduas), hanno condotto uno studio sulla salute ambientale. La valutazione epidemiologica ha raggiunto il 74% degli abitanti del quartiere e ha riferito un’elevata frequenza di disturbi: il 43,2% soffriva di cefalee persistenti, 34,8% congiuntivite e congestione oculare, 33,1% polmonite ostruttiva 26,6% gastrite e/o sintomi compatibili con essa, e il 18,2% soffriva di dermatite da irritazione chimica (il collettivo vudas 2017 par. 2).
Pertanto, non è un dato di fatto che l’azione di ContraArte sia in collaborazione con il collettivo vudas, cioè con vittime e familiari del quartiere che sono attraversati dalla perdita. In questo senso, il collettivo di attivismo artistico e i vicini agiscono nello spazio pubblico esponendo il dolore, l’ingiustizia e l’impotenza; interviene come dispositivo di resistenza, dissenso e territorio comune. Lo stesso vale per l’intervento svolto in Malvinas Argentinas, poiché il rapporto con il collettivo “Malvinas lotta per la vita” è determinante nella forma e nel contenuto (sempre indissociabili per Bajtín) dell’azione murale.
Lungi dalla concezione dell’autonomia dell’arte, ContraArte comprende che ogni discorso nello spazio pubblico deve contare sulla partecipazione attiva della comunità: non più sull’artista che va e interviene la spazialità dalle sue coordinate e pensieri d’artista-Individuo, se non dalla domanda che cosa possiamo fare in questo luogo con voi? In cosa possiamo contribuire? È un lavoro collaborativo che, come abbiamo già visto, si configura come scenario liminale formando una communitas determinata.
L’ultimo dato significativo, per concludere questo paragrafo, è che è proprio lo stesso anno 2013 in cui il collettivo vudas inizia a interiorizzare la problematica ambientale, che ContraArte dipinge il murale contro Monsanto in Malvinas Argentinas. Nello stesso momento, i vicini di quartiere San Antonio e di Malvinas Argentinas stanno intraprendendo azioni per frenare lo sviluppo di imprese che danneggiano l’esistenza dei cittadini.
Conclusioni
Nel corso di questo lavoro ci siamo proposti di analizzare diverse immagini degli interventi murali realizzati dal collettivo ContraArte in quanto discorsi che circolano nel campo artistico e politico all’interno di un’egemonia discorsiva che determina ciò che può essere detto e pensato. È indubbio che i conflitti ambientali, lungi dall’essere finiti, continueranno a essere presenti nella nostra vita quotidiana; se non facciamo qualcosa per combattere i problemi strutturali, potremmo scomparire come specie in pochissimo tempo. In questo senso, la lotta di ContraArte contro l’azienda Monsanto e Porta Fr. deve essere vista come un anello della catena semiotica che combatte l’inquinamento e lo sfruttamento delle risorse.
Il cronotopo si presenta come una categoria metodologia che permette di identificare la particolare configurazione spazio-temporale in cui si intrecciano personaggi, generi discorsivi e argomenti. Crediamo che sia necessario continuare a sviluppare la linea di Aran (2016) sulle cronotopie culturali perché permette di andare oltre gli studi letterari per impiegare la nozione a qualsiasi fenomeno culturale.
I risultati dell’analisi espongono la costruzione di un cronotopo “azione murale” di resistenza e dissenso che genera una communitas del dolore particolare. Di resistenza, perché si oppone a quanto istituito per
esistere; di dissidenza, perché opera come dispositivo politico in contrapposizione alla polizia che ordina, gerarchizza e normalizza. La caratterizzazione dell’intervento come communitas del dolore è resa possibile dalle proprie caratteristiche linguistiche ed extra-linguistiche evidenziate nelle immagini: la convocazione di un collettivo senza gerarchie, l’investimento dell’esperienza in uno spazio congiunto, il dolore (che supera il linguaggio) e la resistenza a quanto dato e normalizzato consentono una configurazione che va oltre la tradizionale comunità organizzata. Questo cronotopo può essere collegato a quello che emerge nell’opuscolo politico di denuncia o ai fanzines, dispositivi estetici e politici che cercano di denunciare e resistere di fronte a una certa cosa. Non vogliamo dire che sono la stessa cosa, ma mostrare che i vari cronotopos che si sviluppano in società sono incatenati in un continuum semiotico che può essere ricostruito dall’analisi dei discorsi.
Infine, vorremmo chiarire il nostro interesse a continuare la ricerca sui collettivi di attivismo artistico perché riteniamo che i loro discorsi operino come mediatori evanescenti, ponti che permettono di immaginare un altro mondo di possibilità e di resistere all’ordine capitalista mondiale. Tessono communitas sempre marginali e riescono a oltrepassare confini delimitati da risorse estetiche che si differenziano dalla protesta tradizionale. In definitiva, l’attivismo artistico contemporaneo, che dialoga con precedenti manifestazioni artistiche politiche, costituisce un’opportunità per denunciare tutte quelle ingiustizie che ci attraversano, in questo caso quelle legate all’ambiente.
Riferimenti
Aladro-Vico, E., Jivkova-Semova, D. e Bailey, O. (2018). Artivismo. Un nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora. Comunicare, 25(57), 9-18.
Angenot, M. (2010). Discurso social. Los límites históricos de lo que se puede pensar y decir. Siglo XXI.
Aran, P. (2016). La herencia de Bajtín. Reflexiones y migraciones. Universidad Nacional de Córdoba.
Arfuch, L. (2005). Afectos y lazos sociales: Plazas Blumberg. Estudios, 17 (primavera). https://rivistas.your/index.pf/Restaurant/Article/View/13500/13675
Resistenza artistica e intellettuale nella lotta per l’ambiente
Bajtín, M. (1989). Teoría y estética del romance. Taurus.
Bajtín, M. (2005). Estética de la creación verbal. Siglo XXI.
Calveiro, P. (2019). Resistir al neoliberalismo. Comunidades y autonomías. Clacso.
Delgado, M. (2013). Artivismo y post-política. Sobre la estetización de las luchas sociales en contextos urbanos. QuAderns-e., 18(2), 68-80.
Delupi, B. (2022a). Performatividad de género en el espacio público. Revista Sociedad, 45, 31-42.
Delupi, B. (2022b). Marginalidad y liminalidad en intervenciones de activismo artístico. Subjetividad contemporánea en las culturas mediatizadas: centros discursivos y periferias edicea
Delupi, B. (2022c). Activismo artístico y crisis planetaria. Resistencia y comunidades de dolor en los discursos de ContraArte. Artilugio, 9, 43-58.
Delupi, B. (2022d). Intelectuales y política. Análisis socio-discursivo de las publicaciones Pasado y Presente y Carta Abierta [tesi di dottorato, Universidad Nacional de Córdoba].
Diéguez, I. (2014). Escenarios liminales. Teatralidad, performatividad, política Paso del gato.
Diéguez, I. (2016). Cuerpos sin duelo. Iconografías y teatralidad del dolor. Documenta escénicas.
Escobar, T. (2021). Aura latente. Estética/Ética/Política/Técnica. Tinta limón.
Feenstra, P. e Verzero, L. (comps.) (2021). Ciudades performativas: prácticas artísticas y políticas de (des)memoria en Buenos Aires, Berlín y Madrid. Clacso. Felshin, N. (2001). ¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo. Maneras de hacer las cosas. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Universidad de Salamanca.
Fernández, A. M. (2008). Lógicas colectivas. Imaginarios, cuerpos y multiplicidades. Biblos.
Fuentes, M. (2020). Activismo tecno-político. Constelaciones de actuaciones. Eterna Cadencia.
Giunta, A. (2013). Activismo. In A. Dumbadze e S. Hudson (a cura di), Arte contemporáneo. Desde 1989 hasta hoy. Wiley-blackwell.
Gligo, N. et al. (2020). La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). repositorio. cepal.org/handle/11362/46101
Guattari, F. e Rolnik, S. (2019). Micropolítica. Cartografías del deseo. Tinta limón. Gutiérrez-Rubí, A. (2020). Artivismo. El poder de los lenguajes artísticos para la comunicación política y el activismo. Universitat Oberta de Catalunya. Groys, B. (2016). Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del arte. Caja negra. Lagos, M. (2019). El fin de la tercera ola de democracias. Latino Barometro. https:// www.latinobarometro.org/latContents.jsp
Lippard, L. (2006). Caballos de Troya. Arte y poder activista. Fotografía y activismo. Gustavo Gili.
Longoni, A. (2009). Activismo artístico en la última década en Argentina: algunas acciones en torno a la segunda desaparición de Jorge Julio López. Revista Errata
Lopardo, L. (2020). Performance, cuerpo y denuncia. El arte contra el extractivismo. Avatar de la comunicación y la cultura, 20. https://publicaciones.sociales. uba.ar/index.php/avatares/article/view/6043
Marín Ruiz, C. (2015). Arte ambiental y ecología. Paradigmas de comprensión, interpretación y evaluación de las relaciones entre arte y ecología (1960-2015) [tesi di dottorato, Universidad del País Vasco].
Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina . unsa Medita.
Svampa, M. e Viale, E. (2020). El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir de los modelos de (mal)desarrollo. Siglo XXI.
Turner, V. (1975). Antropología del performance. Publicación paj Rancière, J. (2004). La distribución de lo sensible. Estética y política. lom.
Verón, E. e Sigal, S. (1986). Perón o la muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista. Eudeba.
Verzero, L. (2013). Teatro militante: radicalización artística y política en los años ‘70. Biblos.
ContraArte (2019). Comunidad ContraArte [Facebook]. https://www.facebook. com/contraarte/ vudas. (2017). Vecinos unidos en defensa de un ambiente seguro. https://vudas. wordpress.com/
Ascoltare la foresta amazzonica
Ascoltare la foresta amazzonica: paesaggi sonori, ascolti profondi e processi di traduzione intersemiótica tra pratiche biosemiótiche e arti performative
Abstract
Mónica Torres, Elizabeth Dezeo e Rocco Mangieri
Tra diverse accezioni, la biosemiotica contemporanea interpreta la vita come un processo semiotico che comporta un aumento e un arricchimento di significato (Farina 2012; Giorgi 2012; Hoffmeyer 1998, 2008a, 2008b; Maran 2019; Kull 2009, Bakker 2022). Questo studio esplora i processi di traduzione intersemiotica tra le pratiche scientifiche di registrazione dei suoni dell’atmosfera sonora amazzonica e le creazioni intermediali e performative di un gruppo di artisti contemporanei. Oltre a proporre uno schema preliminare e descrittivo dei processi di trasformazione, includiamo la descrizione di alcuni dei nostri progetti di performance e arti sonore. La prima parte si concentra sull’esposizione di alcuni risultati preliminari della ricerca. La seconda si focalizza sulle pratiche semiotiche dell’ascolto profondo di Pauline Oliveros e dell´ascolto limpido di Murray Schafer. La terza sezione fornisce una descrizione delle opere immersive e intermediali della compositrice Yfeat Ziv basate su processi di registrazione del suono della foresta Amazzonica. Nell’ultima sezione, oltre alle conclusioni, verrà proposto uno schema preliminare di variabili di analisi qualitativa che ci permetterebbe, in linea di principio, di includere entrambe le pratiche (scientifica ed artistica) in un quadro comparativo e descrittivo1. Il focus principale di questa ricerca in corso
1 In quanto pratiche semiotiche nel senso di Jacques Fontanille (2018, pp. 17-48, 29-47). La dimensione semiotica della pratica include le altre dimensioni semiotiche (segno, codice, testo, oggetto) e a sua volta viene “inglobata” teoricamente nella dimensione delle forme di vita. Per Fontanille le pratiche devono essere riconosciute dal semiologo in primo luogo come processi di organizzazione sintagmatica. Fontanille interdefinisce le pratiche, all’interno del metalinguaggio
Torres, Elizabeth Dezeo e Rocco Mangieri
riguarda le relazioni tra le arti performative, la biosemiotica e la bioacustica , all’interno della creazione di eventi, azioni ed esperienze in cui il nucleo centrale è l’arricchimento del significato attraverso uno sguardo sincretico: ecologico, etico ed estetico.
In the forest, we never easily spot the animals, we notice them by the tracks they leave, or by catching a glimpse of them. Above all, we hear them.
Bruce Albert 2022
Introduzione
Da molti anni, ricercatori provenienti da diverse discipline si dedicano all’ascolto e alla registrazione dei suoni delle foreste, dei boschi e di altri ecosistemi biologici complessi. Questi processi di registrazione sonora possono essere interpretati in almeno quattro modi diversi, senza contraddirsi reciprocamente: (a) innanzitutto, come un processo di riconoscimento di una forma di vita estremamente ricca, la cui complessità è ancora lontana dall’essere completamente compresa; (b) come una fase all’interno di una serie di metodologie scientifiche il cui obiettivo principale è conservare, preservare e ripristinare la ricchezza biosemiotica di questi sistemi ecologici, (c) come pratiche semiotiche volte a creare archivi di memoria degli ecosistemi in via di estinzione e degrado; (d) come un insieme di trasformazioni semiotiche tra registrazioni scientifiche e creazioni artistiche. Ci concentreremo sugli ultimi tre modi d’interpretazione, approfondendo le sue relazioni attraverso la teoria dell’ascolto profondo, dell´ascolto limpido e del paesaggio sonoro (Buzzarté, Bickley 2013; Krause 2012; Mockus 2007; Shafer 1977; Oliveros 2005, 2010), focalizzando sui processi di trasformazione semiotica prodotte attraverso il lavoro creativo di alcuni artisti e performer contemporanei.
Questo contributo è stato concepito considerando almeno tre tipologie diverse di lettori: (a) un primo livello di lettura non specializzato,
della semiotica generativa, come una dimensione che non include necessariamente i processi di testualizzazione.
per un lettore interessato alla semiotica delle arti e al campo della biosemiotica del paesaggio; (b) un lettore “intermedio” con una competenza relativa sulla teoria semiotica e la biosemiotica con esperienze nel campo delle pratiche performative e artistiche; (c) un terzo livello “profondo” per un lettore esperto in biosemiotica e bioacustica, nelle tecnologie di registrazione e rappresentazione sonora. In questa prospettiva è stata adottata una strategia per articolare tre livelli di lettura differenti e, senza dubbio, molto complessi se osservati dalla prospettiva della descrizione e analisi. Poiché non siamo esperti nel campo biosemiotico e bioacustico, abbiamo deciso di affrontare questa prospettiva tenendo conto delle diverse opinioni, concordanze o divergenze che la lettura del testo potrebbe suscitare nel tempo, concentrandoci sul profilo dei lettori del primo e secondo livello. Inoltre, all’interno del campo della ricerca semiotica latinoamericana sulle interazioni tra le arti performative e la biosemiotica rileviamo ancora una fase di sviluppo e le pubblicazioni scientifiche disponibili sono limitate rispetto, ad esempio, alla bibliografia europea e americana. Quasi tutti i riferimenti teorici, con alcune eccezioni (Cunnil Grau 2007), provengono da ambiti culturali geografici non latinoamericani. Infine, abbiamo concordato sul fatto che fosse opportuno accettare l’invito e intraprendere un lavoro relativo a un ecosistema naturale che, come artisti visivi e performativi, ci coinvolge profondamente dal punto di vista etico, epistemologico ed estetico.
La dimensione sensibile ed esperienziale: il corpo avvolto nella biomassa amazzonica
On a number of occasions, I spent the night with the Yanomami hunters, listening to the sounds of the forest. They described to me how some amphibian, or bird, or mammal or insect was joining the chorus, exactly like in Bernie Krause’s soundscapes.
Bruce Albert 2022
Penetrando all’interno nella biomassa della foresta amazzonica, la nostra visibilità viene posta a un livello secondario della percezione, Ci
immergiamo in un’atmosfera sonora di altissima intensità2. Immersi nella vasta potenza energetica della foresta, percepita come una densa copertura verde e infinita che supera la possibilità di individuare un limite formale, un centro del campo visivo o un’emergenza visiva che ci consentirebbe di tracciare un confine. Durante questa esperienza somatica, il corpo dell’esploratore è avvolto nella biomassa viva di una fitta atmosfera sonora tridimensionale (Burt, Vehrencamp 2005). Ricercatori ed esploratori hanno descritto attraverso i suoi percorsi le metodologie che permettono distinguere quanto meno tre livelli o strati sonori, alti, medi e bassi, in cui lo strato o livello più complesso si trova quasi sempre nello spazio superiore e frondoso della chioma della biomassa, quella zona o strato biosemiotico in cui la molteplicità delle specie e degli individui interagiscono più costantemente tra loro (Kark 2013)3. Durante la notte, invece, si verifica un significativo cambiamento polifonico e possono udirsi altri microcosmi sonori concentrati nelle zone basse della foresta. Queste circostanze determinano che i suoni e rumori siano più rilevanti delle immagini per quanto riguarda le informazioni necessarie per i diversi obiettivi di ricerca scientifica o artistica, in particolare per la i processi tecnologici di registrazione ma allo stesso tempo per l’organizzazione dei database sonori delle foreste, boschi e selve del nostro pianeta: un aspetto importante in relazione alle nostre ricerche interdisciplinari (Feld 2012; Rieder 1993). Questa riduzione percettiva della visibilità delle fonti energetiche del suono crea, oltre al
2 Nel 1984, 2003 e 2020, all’interno dei processi di lavoro del nostro laboratorio interdisciplinare integrato da architetti, musicisti, geógrafi e performers, abbiamo compiuto una serie di percorsi di percezione sonora nei boschi locali delle Ande: una prima fase di ricerca divisa in due processi ulteriori (con e senza gli occhi bendati) e una seconda fase attraverso l’utilizzo di alcuni dispositivi tecnologici di registrazione. Questi materiali sono stati ulteriormente utilizzati nella creazione di atmosfere sonore e visive nella Facoltá delle Arti dell’Universidad de Los Andes e in vari seminari e incontri locali (Mangieri 2004). Una breve descrizione di alcune di queste esperienze è stata inserita nella sezione seguente di questo capitolo.
3 La ricerca di Rieder (1993), considerato il fondatore dell’Antropología Sonora, svolta sulla cultura Kaluli della Papua di Nuova Guinea nel contesto della foresta pluviale, costituisce l’esempio di una cultura que vive in un contesto in cui la dimensione sonora è preminente rispetto a quella visiva.
la foresta amazzonica
campo della bioacustica un ulteriore spazio di ricerca all’interno delle una semiotiche acusmatiche4.
Modalità di ascolto e percorsi somatici all’interno dell’atmosfera sonora5
Ci sono diversi suoni, che si fissano nel mio orecchio come un “basso ostinato”: il ronzio continuo dei macchinari di fabbrica in lontananza e il suono sordo dell’acqua che cade in un vicina fontana. Questo sottofondo sonoro è interrotto dal motivo penetrante di un uccello. Un improvviso soffio d’aria spazza il ponte.
Pauline Oliveros 2005
Ero lì con tutto il mio corpo, percependo tutti i sottili cambiamenti ambientali (temperatura, umidità, vento, quantità di luce, ecc.), rendendomi conto che erano gli stimoli esatti che attivavano tutti i suoni nell’habitat.
David Monacchi 2016
Il nostro campo visivo si espande frontalmente di circa 120 gradi, mentre il campo sonoro crea uno spazio tridimensionale che si espande e si contrae dinamicamente avvolgendo l’intero corpo. Questo spazio sonoro può essere considerato come una sfera virtuale che circonda tutto il corpo sensibile e in tutte le direzioni possibili. I nostri corpi abitano il mondo immersi in una sorta di bolla sonora (Fontanille 2004). Nell’Amazzonia,
4 Come insiemi di pratiche semiotiche organizzate e fruite sulla base della percezione di suoni senza rendere visibile la fonte di emissione o produzione. La semiosi acusmática e una prática produttrice di senso all’interno delle nostre forme di vita quotidiana e, allo stesso tempo, una proposta derivata dai studiosi del cinema e della musica, oltre a varie poetiche artístiche del novecento (dadaismo, futurismo, tecniche somatiche del teatro e la danza (Chion 2009).
5 Il concetto e allo stesso tempo le immagini spaziali e culturali dell’atmosfera la configurano come un termine globale che articola le diverse pratiche semiotiche scientifiche ed artistiche impegnate nello studio della significazione dei soundscapes ambientali. Alla fine del capitolo ci soffermeremo su questo aspetto teorico e strategico. “Atmósferas, prácticas y entornos performativos”, Laboratorio de semiótica y socioantropología de las artes, Universidad de Los Andes, a cura di Rocco Mangieri, (In stampa): Caracas, Ministero della Cultura, Edizioni della Compagnia Nazionale di Teatro e Danza, cnt
Torres, Elizabeth Dezeo e Rocco Mangieri
le complesse organizzazioni delle biofonie e geofonie hanno ricondotto gli studiosi a ipotizzare una similitudine delle atmosfere sonore dei boschi e foreste con le complesse organizzazioni polifoniche delle partiture orchestrali e musicali, ma allo stesso tempo anche all’uso di metafore architettoniche e spaziali descrivendo le atmosfere sonore come spazi sferici e domotici6 (immagine 1).Le registrazioni di questi insiemi di suoni polifonici, sia intonati che non intonati, effettuate negli ultimi 20 o 25 anni, forniscono oggi una notevole quantità di informazioni più ampia rispetto ai dati visivi disponibili. Gli spettrogrammi, i sonogrammi, gli archivi sonori e i podcast registrati dai laboratori di ricerca ecologica, dagli artisti e da altri professionisti costituiscono un tesoro di inestimabile valore, contenente le tracce e le impronte di un sistema vivente di altissima complessità7. Recentemente, alcuni accademici dell’Università di Tartu hanno avanzato l’idea di utilizzare la foresta e il bosco come modello teorico di riferimento per la teoria semiotica (Maran 2019).
6 Nel senso architettonico analogo a una cupola o semisfera geodetica che delimita uno spazio vissuto e `percepito sinesteticamente. Un esempio di questo concetto spaziale sono i progetti realizzati dal ricercatore bioacustico italiano Davide Monacchi e le sue s onosfere domotiche ma anche il piú recente dispositivo architettonico di un anfiteatro per l’ascolto profondo dei ecosistemi a Pesaro. https://www.comune.pesaro.pu.it/cultura/teatri-e-arene/ teatri/sonosferar/
7 Abbiamo proposto una differenza tra impronta e traccia , ambedue come modi di produzione segnica che appartengono a processi di riconoscimento (Eco 1975, pp. 285-289). A nostro avviso, è necessario stabilire alcune differenze in relazione al tipo di operazioni intermedie che si producono nel passo tra le materie e le sostanze, in quanto manipolazioni fisiche e materiali sul continuum della materia sonora. Si potrebbe proporre anche una distinzione rispetto agli strumenti o dispositivi che mediano i processi di trasformazione tra materia e sostanza . Una mano impressa sulla sabbia sarebbe una impronta mentre la striscia prodotta dal suo movimento sarebbe una traccia . Quindi, l’impronta ci offre informazioni a partire di un’unica azione, impressione o stampo. La traccia invece basa la sua informazione su una o varie traiettorie di movimento sulle superfici d’iscrizione. Possiamo dire che se l’impronta corrisponde a una operazione d’ incisione o stampo, la traccia corrisponde a operazioni di vettorializzazione e tracciamento spaziale. Se riportiamo parte di questo discorso all’interno degli mps di Eco (Modi di produzione segnica), ambedue i modi semiotici corrisponderebbero a marche indiziali. Per noi questa micro-differenza è molto rilevante in relazione alle nostre pratiche performative di conversione tra il registro sonoro e la sua rappresentazione visiva e grafica.

La foresta amazzonica richiede di una notevole competenza nell’arte e nelle tecniche dell’ascolto e nello svolgimento di queste pratiche semiotiche i dispositivi tecnologici di registrazione e manipolazione ulteriore del suono possono essere considerati come un’estensione del corpo, ma anche come una rete di attanti generativi produttori di senso, come dispositivi che costituiscono un “terzo orecchio” in grado di percepire i ritmi, le vibrazioni, le microvariazioni e i cambiamenti quasi impercettibili dell’energia sonora che emerge dal complesso sistema delle foreste e circonda il corpo. È molto importante, all`interno delle nostre ricerche laboratoriali, distinguere quanto meno due modalità di ascolto: 1) i suoni che vengono interpretati come tracce di forme di vita dell’ambiente amazzonico, quindi come segni e figure di riferimento, e 2) i suoni che vengono percepiti come oggetti sonori e come il risultato di un’esperienza fenomenologica. La prima
Torres, Elizabeth Dezeo e Rocco Mangieri
modalità è legata al processo di riconoscimento e interpretazione semiotica, mentre la seconda è correlata all’esperienza della qualità, e della materialità stessa del suono. Nelle nostre pratiche performative queste due forme si sovrappongono.
In seguito, esamineremo il modo in cui le due forme di ascolto semiotico si fondono attraverso processi di traduzione intersemiotica tra pratiche scientifiche ed artistiche. A titolo di esempio, durante una ricerca condotta nelle foreste pluviali delle Ande (2008, 2010) in un’area limitrofe e ai confini della foresta amazzonica tra il Brasile e il Venezuela (2015), abbiamo messe in atto alcune delle nostre tecniche corporee, tra le quali aprire un piccolo fossato in cui distendersi a occhi chiusi, coprirsi con foglie e rami, bendarsi gli occhi e percorrere la foresta o riprodurre i suoni della sonosfera ambientale con la voice e alcuni strumenti di percussione: l’obiettivo era di poter raggiungere progressivamente l’esperienza di un ascolto limpido e profondo. Durante questi percorsi un operatore registrava i suoni biofonici e i ritmi della nostra respirazione. Successivamente, dovevamo descrivere dettagliatamente i suoni percepiti, le relazioni sensoriali tra suoni, odori, spazio, le tessiture delle foglie e dei rami intorno ai nostri corpi. La fase successiva prevedeva l’organizzazione di una performance acusmatica8 utilizzando le registrazioni, i disegni individuali, le narrazioni dei performer e vari dispositivi intermediali e audiovisivi a disposizione nel nostro laboratorio (Immagini 2, 3).
Abbiamo introdotto un primo modello di variabili sensoriali in cui i concetti di sinestesia e atmosfera sonora avevano molta rilevanza. Il nostro proposito era quello di condurre il corpo verso uno stato di fusione sensibile con i suoni e rumori dell’ambiente9. Lo scopo iniziale del performance era quindi quello di generare in noi una esperienza propriocettiva attraverso
8 Semiótica o semiosi acusmatica ; insieme di pratiche semiotiche, segni, testi, oggetti, in cui il senso si produce fondamentalmente attraverso processi di produzione-emissione-ricezione di rumori, suoni, música, parlato e altre modalitá tecnologiche integrative o non, come la comune pratica di ascolto ad occhi chiusi o con dispositivi personalizzati di audio (smartphones, tecnologie di ascolto di alta definizione, ecc). La lettura a voce di un testo scritto include una semiosi acusmática così come anche un film attraverso la sua colonna sonora.
9 Il termine Atmósfera sonora , riprende i concetti fondamentali di atmosfera di Bohme , Tonino Griffero e altri studiosi (vedi nota 20).

Immagine 2. Percorsi e pratiche di ascolto. Laboratorio di semiòtica delle Arti, cdcht, 2010. Bosco della Culatta, Mérida. Performers: Angelica Morales, Carolina Zerpa, Rocco Mangieri, Mila Sequera, 2010-2015
Fonte: Laboratorio de semiótica y socioantropología. cdcht
l’utilizzo delle tecniche dell’ascolto profondo della Oliveros in cui le prime operazioni fenomenologiche si concentravano sulla nozione di corpo proprio, come descritto da Maurice Merleau Ponty10. Una delle condizioni fondamentali nelle prime fasi delle pratiche d’ascolto era la selezione di una varietà di posture somatiche differenti. Abbiamo ripreso diversi approcci metodologici con l’obiettivo di creare una sequenza narrativa. La prima modalità consisteva nell`uso del corpo in uno stato di quiete attiva e ricettiva, mentre la seconda modalità prevedeva il movimento del corpo. Tuttavia, era essenziale eseguire questi movimenti con un ritmo costante e senza interruzioni.
10 Il concetto di corpo proprio è stato proposto all´interno della fenomenología della percezione da Maurice Merleau Ponty (1999, pp. 165-170).

Immagine 3. Percorsi e pratiche di ascolto.
Laboratorio di semiotica delle Arti, cdcht Selva Ammazzonica, Estado Amazonas, localidad Alto Orinoco, La Esmeralda.
Fonte: fotografia: Laboratorio de semiótica y socioantropologia, cdcht. Performer: Rocco Mangieri.
Invece di interrompere il ritmo del corpo, era necessario metterlo in pausa. Durante queste pause motorie, il performer aveva la libertà di aprire, chiudere o coprire gli occhi, concentrandosi sulla percezione spaziale e sonora dell’ambiente circostante. Abbiamo anche usato la tecnica degli occhi bendati, insieme alle pratiche del tai chi, dello yoga e della dance contact11
In questi percorsi di attenzione somatica, il performer portava con sé un dispositivo di registrazione che registrava il ritmo dei suoi passi, la
11 La Dance contact o Contact Improvisation è considerata, oltre come tecnica ,una modalità stilistica ed espressiva dei corpi in interazione. Proposta dal coreografo Steve Paxton negli anni settanta, consiste in un gioco contínuo, senza interruzione, di azione-reazione tra due o piú corpi danzanti la cui condizione di base e quella di non staccarsi mai completamente dal contatto con l’altro corpo durante tutta l’esecuzione della performance. Steve Paxton, Improvisation Project, https:// danceinteractive.jacobspillow.org/steve-paxton/improvisation-project/#:~:text=Steve%20 Paxton%20is%20perhaps%20best,to%20explore%20relationships%20between%20dancers
respirazione e il rumore prodotto dal corpo quandoad esempio entrava in contatto con un ramo o una pianta, i suoni generati trascinando i piedi sull’erba o attraversando una corrente d’acqua. La seconda fase degli esercizi, prima di pensare all’organizzazione di una mostra intermediale o multimediale, consisteva in uno studio introduttivo delle forme e delle figure di rappresentazione analogica del suono : spettrogrammi o sonogrammi realizzati a mano, disegni tracciati sulla carta o su altre superfici organiche del luogo. La terza e ultima fase comprendeva: 1) la composizione multimediale di un montaggio audiovisivo delle registrazioni sonore dei performers; 2) una serie di immagini digitalmente manipolate di sonogrammi biofonici e antropofonici; 3) l’evocazione poetica e narrativa delle sensazioni emerse durante il processo di immersione sonora del corpo, lette da ciascuno dei performer durante lo svolgimento delle azioni fisiche nello spazio ambientale della mostra.
Ascoltare-ascoltarsi, abitare, vivere l’atmosfera sonora
The profound advantage offered by an Aesthetics of Atmospheres is that it can draw on a large reservoir of daily life experiences. One talks of a pleasant valley, of the depressive mood before a storm, of the tense atmosphere in a meeting [...] If atmospheres are moods, which one feels in the air, then we are describing a phenomenon which is familiar to everyone; moreover, the potential source material for discussing and characterizing atmospheres is nearly inexhaustible.
Gernot Bohme, 2016
Nel corso delle nostre azioni performative sul territorio locale, che si estende tra boschi e foreste della Ande, l’obiettivo era quello di sperimentare in modo somatico la complessità dell’universo sonoro e successivamente tradurre questa esperienza in una serie di rappresentazioni visive o grafiche, che riflettessero l’esperienza individuale dei membri del gruppo (Immagini 4,5).
Abbiamo scelto tre posture somatiche di base e abbiamo coinvolto i partecipanti nello stesso luogo, in modo che ognuno di loro avesse l’opportunità
Torres, Elizabeth Dezeo e Rocco Mangieri
di sperimentare le tre posture fondamentali dell’esercizio della deep listening. Al termine delle pratiche, sia somatiche che grafiche, abbiamo elaborato una lista di risultati preliminari. Una descrizione fenomenologica dell’esperienza ha rivelato un insieme di tratti.
1. L’immersione somatica non si manifesta attraverso processi di collegamento cognitivo lungo una linea temporale cronologica, ma piuttosto con una sospensione del tempo cronologico che porta ad altre forme di attenzione somatica non quotidiana, come definito da Thomas Csordas, in cui la dimensione spaziale che circonda il corpo è essenziale.
2. Si giunge a un processo di sospensione somatica nel quale il senso del tempo si trasforma sinestesicamente all’interno delle sensazioni spaziali che progressivamente avvolgono il corpo del performer.
3. Questi processi richiedono molto tempo per raggiungere uno stato di sospensione. Durante tali processi, il performer utilizza diverse tecniche aggiuntive come il ritmo respiratorio, la postura, la concentrazione.
4. Le descrizioni dell’ambiente sonoro eseguite attraverso le tre posture corporali, coincidono con la percezione figurativa di un’atmosfera sonora avvolgente, uno spazio intorno al corpo senza limiti precisi. Esperienze percettive molto simili alle sensazioni di un “rumore bianco” espansivo, una “nebbia acustica” di densità variabile, la sensazione di essere sommersi come nel fondo del mare. Questa atmosfera sonora viene percepita come uno spazio piú meno indeterminato senza contorni o limiti precisi.
5. Un’altro tratto rilevante: tutti i suoni percepiti vengono immediatamente inseriti all’interno della “bolla sonora” all’interno del quale il corpo si configura come centro di uno spazio inglobante.
6. I suoni vengono percepiti e rappresentati in una relazione di distanza rispetto al corpo (molto vicini o molto lontani), sotto o sopra, o anche come figure visive e tattili che, in un modo diverso alle notazioni grafiche di una partitura musicale tradizionale, si espandono o concentrano, attraversando e tracciando traiettorie, punteggiando o lampeggiando nei bordi dell`umwelt sonoro del performer.12
Una prima interpretazione dei disegni iniziali (Immagine 3) mostra che i partecipanti hanno percepito uno spazio atmosferico avvolgente in tutte e tre le posture somatiche; una dimensione inglobante che si espande o si contrae attorno al corpo come una “sfera personale” di tipo propriocettivo e inoltre una seconda dimensione molto più ampia senza confini distinguibili. I performers fanno riferimento a una “materialità liquida” e atmosferica dei suoni, con alcune punteggiature bio e geofoniche che si inseriscono o “attraversano” lo spazio. Le descrizioni visive sono inserite sotto le tre figure della postura e sono rappresentate da loro non come figure sonore isolate disposte in una sequenza temporale (come in molti tipi di spettrogrammi, sonogrammi e notazioni musicali), ma come figure, traiettorie o punteggiature visive, cromatiche e tattili, organizzate e disposte spazialmente all’interno di un campo multidimensionale13 (Immagini 6, 7, 8. Molte delle descrizioni dei biosemiotici e bioacustici (come alcuni dei protagonisti dei casi di studio che abbiamo incluso in un quadro generale e comparativo verso la fine del nostro capitolo) si possono sovrapporre
12 Rappresentazioni visive molto simili alle notazioni musicali di Murray Schafer, John Cage e altri compositori di musica elettroacustica.
13 Queste rappresentazioni visive (un tipo di traduzione intersemiotica) sono simili a tante altre notazioni grafiche realizzate da artisti visivi, musicisti, poeti visivi. Lo stesso Murray Schafer disegnava le sue partiture fusionando e articolando due sistemi di notazione: uno più autografico e incarnato, l’altro più allografico e oggettivante, seguendo il codice visivo della musica occidentale. Quando osserviamo con calma le partiture di Shaffer, le descrizioni fenomenologiche della Oliveros, le partiture dei compositori di musica elettroacústica como John Cage e tanti altri, percepiamo che il senso del sonoro è fondamentalmente spaziale, si dispone e organizza su tutta la superficie della carta di disegno, nella quale anche i vuoti producono senso. Queste poetiche del suono si producono in relazione alle dimensioni dello spazio, quindi possiamo dire che si tratta, oltre ad altri obiettivi, di organizzare e produrre una esperienza atmosferica e spaziale del suono (riprendiamo la differenza tra autografico/allografico di Nelson Goodman (1976).


Immagini 4, 5. Laboratorio dell’ascolto limpido e profondo. Bosco pluviale del Parco Nazionale della Musuy, Mérida (Venezuela), Giugno 2024.
Fonte: fotografia degli autori. Laboratorio de semiotica e socioantropologia, cdchta, ula. Performers: Juliana Mendonca e Yoya Toro
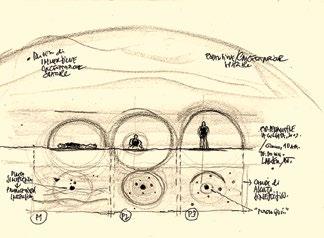
Immagine 6. Rappresentazione grafica dell’esperienza di ascolto. Selva Amazzonica, Estado Amazonas, localidad Alto Orinoco, La Esmeralda, 2015. Laboratorio de semiotica y socioantropología. La zona media della grafica rappresenta la sequenza delle tre posture fisiche del performer. La zona alta, la rappresentazione visiva dello spazio che avvolge il corpo a modo di un dono di limiti diffusi. La zona bassa le mappature o “cartografie sonore” dei performer rispetto ad ogni postura. Le sensazioni sonore che convergono sul livello propriocettivo sono state disegnate come spazi curvi, domotici che avvolgono il corpo. Come detto più sopra, l’esperienza dell’ascolto viene sentita come uno spazio multidimensionale di relazioni tra figure sonore che interagiscono all’interno di un campo spaziale unitario. Fonte: elaborazione propria

Immagine 7. Rappresentazione grafica dell’esperienza di ascolto. Selva Amazzonica, Estado Amazonas, localidad Alto Orinoco, La Esmeralda , 2015. Laboratorio de semiótica y socioantropología CDCHTA. Rappresentazione dell’ environment sonoro del performer dopo l’esperienza di ascolto profondo. Il corpo si percepisce al centro di una sfera che si espande e ritrae rítmicamente . I suoni biofonici e geofonici si dispongono all’interno di questo spazio: si inseriscono punteggiando una zona, una nicchia biofónica che lampeggia ritmicamente.
Fonte: elaborazione propria
alle nostre rappresentazioni visive dell’esperienza fenomenologica del suono del bosco e della foresta: ad esempio Bernie Krause, con la sua metafora delle nicchie acustiche, o Murray Shafer, con la proposta dell’effetto di sintonizzazione come sovrapposizione o inclusione di strati, traiettorie e punteggiature sonore nello spazio di una partitura spaziale e inglobante. Ma anche David Monacchi, con i suoi disegni architettonici che metaforicamente rappresentano l’idea di un ambiente multidimensionale in cui il

Immagine 8. In uno stato somatico di ascolto profondo la percezione dello spazio sonoro ambientale viene rappresentata graficamente dai performers come un’ atmosfera avvolgente di limiti diffusi . Quindi, e all’interno di questa dimensione semiotica si inseriscono, punteggiano le diverse tracce e traiettorie sonore. Questo tipo d’esperienza si potrebbe rappresentare come un insieme di notazioni e costellazioni figurative dei suoni che vengono distribuiti e organizzati all’interno di un campo spaziale tridimensionale . Fonte: elaborazione propria
corpo dell’ascolto è al centro delle emissioni delle energie sonore, o i performance di Yifeat Ziv, che si svolgono in un’atmosfera coinvolgente, ricca di multipli overdubbing biofonici e vocali che si fondono gradualmente, anche
Jean Michel Jareé, che costruisce lo spazio ambientale dell’Amazzonia come una sinfonia contemporanea ed elettroacustica, ma non come una successione lineare di suoni, bensì come un continuum spaziale e atmosférico di segni biofonici, geofonici e oggetti sonori. Attraverso questa panoramica, il lettore potrà comprendere le motivazioni e gli aspetti teorici impliciti
Torres, Elizabeth Dezeo e Rocco Mangieri
nelle nostre pratiche performative. I temi che verranno esposti nelle sezioni successive sono strettamente legati ad alcuni aspetti fondamentali per la nostra ricerca nel campo delle arti performative e delle arti del corpo. Alcuni argomenti potrebbero non essere approfonditi allo stesso modo, poiché abbiamo adottato un approccio che potrebbe risultare dispersivo per i lettori abituati a strutture più rigide. Questa scelta è stata fatta in virtù di un approccio rizomatico che, in diversi punti, si presenta complesso a causa della natura inter e transdisciplinare del nostro ambito di ricerca.
La pratica dell’ascolto e registrazione del paesaggio sonoro come laboratorio semiotico: scienziati e artisti, un limite diffuso
These exercises are intended to calm the mind and bring awareness to the body and its energy circulation, and to promote the appropriate attitude for extending receptivity to the entire s pace/time continuum of sound . This kind of receptivity is essential for creative activity in the arts and can be applicable to any discipline
Pauline Oliveros, 2005
Al giorno d’oggi, così come nei secoli XVIII e XIX, la distinzione tra prospettiva scientifica e artistica è diventata estremamente sfumata, come dimostrato dalle opere di Humboldt e Bompland sugli ecosistemi amazzonici (Lasser 1971;Wulf 2016). Nei più recenti metodi di registrazione e organizzazione visiva dei database sui sistemi viventi del pianeta caricati online, si è mantenuto un legame costante tra prospettiva scientifica e artistica lungo tutta la storia delle scienze biologiche e ambientali. Questo legame ha subito cambiamenti e trasformazioni storico-sociali nei sistemi di rappresentazione e nelle modalità di interpretazione, una fruizione e interscambio delle informazioni. Secondo Bruno Latour, l’esplorazione e la registrazione degli ambienti e dei paesaggi planetari li trasformano oggi in un laboratorio aperto14. I territori e i paesaggi terrestri si trasformano in
14 Nel capitolo 2 del libro “La esperanza de Pandora” dedicato all’Amazzonia e intitolato “Il riferimento circolante”, Bruno Latour sottolinea il valore semiotico dell’indicazione da parte
luoghi di esplorazione al di fuori dei confini di un laboratorio concepito come uno spazio chiuso e sotto controllo del ricercatore, L’Amazzonia si è trasformata gradualmente in una sorta di vasto laboratorio ambientale a livello planetario, per vari motivi legati ai programmi di ricerca scientifica globale, ma anche per gruppi di artisti performativi, visivi e audiovisivi che hanno orientato le loro proposte all’interno delle relazioni tra arte, ecosistema, corpo e forme viventi.
Paesaggi sonori dell’Amazzonia: processi di registrazione e traduzione intersemiotica15
Deep coupled with Listening or Deep Listening for me is learning to expand the perception of sounds to include the whole space/time continuum of sound— encountering the vastness and complexities as much as possible. Pauline Oliveros, 2005
I processi semiotici di ascolto e registrazione a livello scientifico e artistico presentano delle differenze ma tuttavia il loro confine è instabile e diffuso. L’approccio laboratoriale di Bernie Krause, David Monacchi e Richard Mosse rappresenta un esempio in cui le relazioni tra i metodi dei loro laboratori ambientali e le strategie delle proposte artistiche si avvicinano notevolmente fino a fondersi (Krause 2008; Monacchi 2014a; Mosse 2022). Uno degli obiettivi per la semiotica e la biosemiotica potrebbe essere, tra gli altri, lo studio delle relazioni intersemiotiche tra le strategie all’interno del campo di ricerca scientifica e le proposte degli artisti contemporanei in relazione
dello scienziato nelle sue mappe e schemi visivi analogici che gli permettono di tracciare le sue traiettorie nel vasto territorio amazzonico. Con ciò sottolinea la rilevanza pragmatica delle “discipline antiche” come la geometria, la trigonometria e la cartografia. Nella pratica della ricerca sull’Amazzonia prevale “…quel gesto del dito puntato, l’indice per eccellenza” (Latour 2001, p. 44).
15 Utilizziamo il concetto di traduzione intersemiotica o trasmutazione ripreso dalla teoría di Roman Jakobson (Jakobson,1959) per definire i processi di traduzione e di produzione di senso tra le registrazioni scientífiche e quelle artístiche. Particolarmente le operazioni eseguite dai stessi artisti nel percorso di trasmutazione dalle registrazioni tecnológiche (oggettivanti) nella fase di manipolazione estetica dei dati visivi e sonori, nelle sue mostre o ambienti intermediali.
al paesaggio sonoro16. Ciò che ci interessa principalmente in questa sede sono i processi di traduzione intersemiotica tra queste due pratiche sonore e ambientali, le sue differenze e le analogie tra le modalità e le impostazioni teoriche della registrazione scientifica e artistica e, in quest’ultima, i processi di manipolazione e trasformazione del senso del suono17. Questi due gruppi di pratiche si sovrappongono e si ritrovano frequentemente in quattro livelli della produzione biosemiotica contemporanea: 1) all’interno delle stesse scelte tra elenchi di disegno e progettazione ambientale degli scienziati: “oggetti”, mappe, percorsi, dispositivi, attitudini, dimensioni espositive dei risultati; 2) nel rilevamento della presenza di segni di enunciazione estetica e fenomenologica, con diversi gradi di intensità all’interno dei progetti; 3) nei progetti di ricerca in cui il lavoro di produzione viene condiviso sin dall’inizio tra i due ruoli attanziali dell’artista e dello scienziato; 4) nelle stesse proposte dell’artista o performer in cui i database delle scienze ambientali sono selezionati, rielaborati e infine esposti in esposizioni intermediali, transmediali e immersive. I database attuali raccolgono insiemi di dati pronti per la creazione di processi artistici di traduzione intersemiotica, ma anche per interventi di tipo artistico e performativo. Oltre a costituire un materiale prezioso per l’elaborazione di una tipologia delle tracce o impronte sonore del soundscape amazzonico, questa raccolta globale di dati oltre a essere concepita come una mappatura
16 Nel caso di Bernie Krause e David Monacchi la coesistenza di queste due modalità di comunicazione si molto evidente, al punto che crediamo non avrebbe molto senso una differenza radicale tra intenzionalità estetica e intenzionalità scientifica. Analogamente ad altri esempi che abbiamo scelto nel nostro capitolo, percepiamo una notevole somiglianza con lo sguardo semiotico di un naturalista premoderno del XIX secolo come Humboldt, quindi con una visione culturale della natura que la configura un universo ecologico ed estetico, come un modello di stile di vita e come una manifestazione della bellezza. Uno scienziato come Bernie Krause utilizza l’immagine e la metafora dell’orchestra sinfonica per definire i tratti del paesaggio sonoro come una polifonia strumentale (in questo punto è necessario menzionare le analisi semiotiche svolte da Emiliano Battistini 2017, 2018, 2022). Tra gli altri esempi, i ricercatori in biosemiotica della scuola di Tartu hanno ripreso questo sguardo semiotico sulla foresta come un processo fenomenologico implicito all’interno della produzione estetica. Ci sembra, in questa sede, che le esperienze creative di Timo Maran siano per noi esemplari.
17 In questo senso, il quadro comparativo che abbiamo proposto verso la fine di questo capítolo considera alcuni di questi processi di trasformazione e manipolazione.
Ascoltare la foresta amazzonica
dei cambiamenti sostanziali degli schemi somatici abituali dell’ascolto, riconduce a un ripristino del progetto semiotico delle pratiche dell’ascolto.
Ascolti limpidi, ascolti profondi
L’orchestra mondiale sta suonando permanentemente. La ascoltiamo all’interno e al di fuori; da vicino e da lontano. Non esiste il silenzio per gli esseri viventi. Non abbiamo palpebre nelle orecchie.
Murray Schafer, 1977
Any number of persons sit in a circle facing the center. Illuminate the space with dim blue light. Begin by simply observing your own breathing . Always be an observer. Gradually allow your breathing to become audible . Then gradually introduce your voice, Allow your vocal cords to vibrate in any mode which occurs naturally. Allow the intensity to increase very slowly. Continue as long as possible naturally, and until all others are quiet, always observing your own breath cycle. Variation: Translate voice to an instrument.
Pauline Oliveros, 1971
Secondo le prospettive di Murray Schafer e Pauline Oliveros, l’atto dell’ascolto richiede una competenza che si acquisisce tramite pratiche somatiche non convenzionali. Questo implica un approccio non quotidiano dei processi di attenzione somatica del sonoro in cui i nostri corpi sono immersi (Csordas 2010). Schafer fornisce una spiegazione di ciò che intende per ascolto e paesaggio sonoro:
Chiamo paesaggio sonoro l’ambiente acustico e con questo termine intendo il campo sonoro totale, ovunque ci troviamo. È una parola derivata da paesaggio; tuttavia, a differenza di questo, non è strettamente limitato ai luoghi all’aperto. L’ambiente che mi circonda mentre scrivo è un paesaggio sonoro […]. I paesaggi sonori sono incredibilmente variabili e differiscono a seconda dell’ora del giorno e della stagione, del luogo, della cultura. (Schafer 1992, p. 12)
Torres, Elizabeth Dezeo e Rocco Mangieri
Pauline Oliveros, una teorica e strumentista che ha influenzato alcuni degli artisti selezionati per la nostra indagine (in particolare Yifeat Ziv e molto prima a John Cage), descrive l’ascolto profondo come:
for me is learning to expand the perception of sounds to include the whole space/time continuum of sound— encountering the vastness and complexities as much as possible. Simultaneously one ought to be able to target a sound or sequence of sounds as a focus within the space/time continuum and to perceive the detail or trajectory of the sound or sequence of sounds. Such focus should always return to, or be within the whole of the space/time continuum (context). (Oliveros 2005, p. 10)
Gli esercizi proposti da Pauline Oliveros comprendono una serie di attività concepite sulle relazioni tra energia, corpo, respirazione, vocalizzazione, e l’ascolto e rielaborazione dei sogni. Lo scopo di tali esercizi è di favorire la calma mentale, ristabilire la consapevolezza del corpo proprio e della sua circolazione energetica, nonché promuovere un atteggiamento adeguato per espandere la capacità di ricezione all’intero continuum spazio/temporale del suono. Questa forma di ricezione è fondamentale per l’attività creativa nelle arti perfomative ma può essere applicata a qualsiasi disciplina. L’ascolto profondo sarebbe un fulcro di questa pratica ed ogni esercizio ed è concepito per promuovere nel praticante la tecnica di un processo di ascolto non quotidiano, quindi la ripetizione degli esercizi ci offre allo stesso tempo l’opportunità di confrontare la profonditá delle esperienze acquisite tra una sessione e l’altra. Questi confronti contribuiscono a una più chiara comprensione del senso delle pratiche semiotiche di ascolto. nonché ai processi di collegamento tra l’ascolto dei suoni dell’ambiente e i nostri processi propriocettivi: una semiosi della ripetizione proposta dalla Oliveros che potrebbe condurci progressivamente un habitus18.
18 Il discorso della ripetizione di Pauline Oliveros in relazione al senso delle nostre pratiche performative, è allo stesso tempo anche “strategico e operativo” se pensiamo, ad esempio, al fatto che lo stesso scienziato (biosemiotico, bioacustico) lavora effettivamente in base a una retorica sonora della ripetizione in quanto ri-ascolto del suono registrato. Quando un bioacustico come Monacchi o Krause riorganizzano le registrazioni inserendole all’interno di un discorso artistico
Sia l’artista che lo scienziato attivano un processo di interpretazione profonda con obiettivi diversi ma con delle variazioni a livello della percezione propriocettiva non completamente divergenti. L’obiettivo scientifico della registrazione sonora dell’ambiente è principalmente quello di fornire informazioni oggettive attraverso variabili quantitative che riguardano problemi e argomenti ecologici senza introdurre in principio tracce individuali, tracce enunciative personalizzate o incarnate. Le pratiche delle arti performative e sonore introducono altri percorsi di significato, evidenziando il livello dell’espressione attraverso segni personalizzati o incarnati. Sebbene sia quasi inevitabile che in entrambe le pratiche si verifichino stati di incarnazione o embodiment, nel caso della produzione artistica questo livello viene intensificato nella semiosi sonora delle proposte performative (Immagini 9, 10).
Negli ultimi anni siamo stati testimoni di una progressiva interazione tra le due discipline: scienziati che si sono dedicati non solo alla registrazione e all’analisi scientifica dei suoni, ma anche a processi estetici di incarnazione intersoggettiva, e artisti che hanno cercato di dare alle proprie opere un fondamento o carattere scientifico. Questo scambio di significati è stato favorito, tra gli altri fattori, dalla convergenza attuale tra mezzi di comunicazione e tecnologie, ma anche dalla disponibilità attuale di database e dalla creazione di gruppi di ricerca inter e transdisciplinari19.
e avendole sicuramente udite molte volte, le operazioni di ripetizione acquisiscono una nuova dimensione semiotica di arricchimento del senso, avvicinandosi moltissimo al senso dell’ascolto profondo e dell’ascolto limpido. Culturalmente esiste una profonda articolazione sintagmatica e semantica tra udire-registrare-ripetere
19 Nelle nostre esperienze abbiamo utilizzato alcuni tratti di “Teach Yourself to Fly” della Oliveros (1971) in cui si invita il performer a concentrarsi sul ritmo del proprio respiro e a lasciare che la propria voce risuoni all’interno; il titolo del testo di Oliveros fa un paragone tra suoni respiratori ed il rumore di un aereo in decollo. Le sue partiture verbali e gestuali fanno riferimento a una tecnica del sonoro attraverso quello che l’artista denomina Coscienza Cinetica , una pratica respiratoria in cui i suoni vocali si uniscono alla respirazione. Oliveros ha riconosciuto che la coscienza cinetica e quella sonora si fondono.
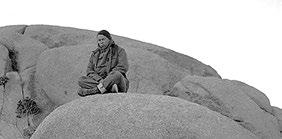
Immagine 9. Pauline Oliveros, musicista e compositrice americana creatrice della tecnica della Deep listening. Photography Daniel Weintraub.
Fonte: Coiro, A. (s. d.). Daniel Weintraub Presents “deep listening,” the story of Pauline Oliveros. Ravelin. https://www.ravelinmagazine.com/posts/daniel-weintraub-presents-deep-listening-story-paulineoliveros/
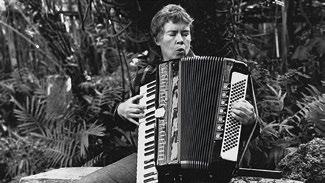
Immagine 10. Pauline Oliveros, photography Becky Cohen. Secondo John Cage: “through Pauline Oliveros and deep listening i finally know what harmony is”.
Fonte: https://www.nonevent.org/concerts/2023-03-16-oliveros
Biofonie, tecnofonie, antropofonie e geofonie
Stavo osservando un’intera comunità biologica che mostrava un comportamento coordinato, in cui ogni segmento emetteva suoni con diversi livelli distinti di disposizione degli schemi, periodicità, regolarità, raggruppamento e interdipendenza complessiva. Le mie prime notti di registrazione nelle foreste allagate dell’Amazzonia sono state in realtà alcune delle esperienze estetiche più potenti che abbia mai avuto.
David Monacchi 2016
Le pratiche di registrazione all’interno della biomassa amazzonica coinvolgono una serie di fasi e processi simultanei e sequenziali. Questi processi interdisciplinari comprendono la selezione delle specie biologiche, delle forme di vita, dei paesaggi o degli ambienti, la scelta dei siti di esplorazione, l’utilizzo di banchedi dati disponibili, l’organizzazione temporale delle registrazioni, la scelta di tecnologie adeguate, il rispetto delle norme e delle regole, l’accesso e l’uso del territorio, la progettazione di un piano di lavoro oltre alla realizzazione di prove preliminari di registrazione. Nell’attuale contesto della documentazione scientifica, le biofonie, geofonie e tecnofonie individuate, ad esempio, da Bernie Krause (MarinGomez, McGregor-Fors 2019) o Davide Morlacchi sono di un’importanza fondamentale. Gli artisti, oltre alle operazioni performative e intermediali sulla base delle geofonie e biofonie, introducono anche segni, figure e tracce di altre tecnofonie a due livelli: 1) tecnofonie generate da dispositivi audiotecnologici come riverberi, echi, sovraincisioni, multistrati; 2) tecnofonie più strumentali, che includono l’uso del corpo come produttore di suoni, vocalizzazioni, modulazioni e variazioni tonali 20. Nel
20 Il concetto di tecnofonía è stato proposto da Bernie Krause (2008) in “Anatomy of the Soundscape: Evolving Perspectives” Journal of the Audio Engineering Society, Vol 56 No 1/2 January/February. Krause aggiunge le tecnofonie come un ulteriore livello di analisi delle registrazioni sonore prodotte dalle tecnologie, incluso , diremo, dalle stesse tecnologie di registrazione. Esistono tecnofonie molto silenziose o rumorose che potrebbero essere interpretate come tracce e impronte sonore referenziali ma anche come oggetti sonori, come sostanze del mondo. Questi strati sonori, assieme alle altre tipologíe biofoniche e tecnofoniche, costituirebbero per noi, operatori
Torres, Elizabeth Dezeo e Rocco Mangieri
campo della biosemiotica e della bioacustica, diversi studiosi si avvalgono delle differenze tra biofonie, antropofonie, tecnofonie e geofonie come un insieme di concetti che possono integrare la vasta complessità delle caratteristiche di un paesaggio sonoro. Questi concetti riguardano le percezioni uditive, (sia con che senza l’uso di dispositivi tecnologici) relative ai suoni prodotti dalle forme di vita umane e non umane, quindi le registrazioni dell’attività umana stessa attraverso l’utilizzo di macchine, artefatti e strumenti che agiscono fisicamente sul territorio, nonché le registrazioni dei suoni geologici e atmosferici come il vento e le correnti d’acqua (Marin-Gomez, McGregor-Fors 2019; Bernie Krause 2008, 2012).
A questo punto, è importante menzionare la ricerca bioacustica italiana condotta da vari studiosi contemporanei come Aldo Farina, Giuseppa Buscaino, Maria Ceraulo e Nadia Pieretti (2014).
Yifeat Ziv: palinsesti sonori tra biofoníe-antropofoníe-tecnofoníe
Questo significa innanzitutto che il pensiero e la comunicazione semiotica non sono più ciò che divide gli uomini tra di loro né quello che divide l’umano dal non umano, ma ciò che rende inseparabili e indistinguibili tutti i viventi
Emanuele Coccia 2021
Ci soffermiamo sulle proposte di Yifeath Ziv che ci risultano particolarmente interessanti poiché si avvicinano molto al campo della nostra attuale ricerca artistica e performativa 21 . Inizialmente avevamo deci-
performativi nel campo delle arti, una sonosfera strutturata in vari strati semiotici a livello della sostanza dell’espressione: in questo punto il concetto di atmosfera sonora ci sembra molto efficace per descrivere i modi in cui gli artisti organizzano gli interventi performativi come ambienti globali di percezione e interazione. Più avanti ci soffermeremo brevemente su questo aspetto, per noi molto rilevante e che attualmente si è configurato progressivamente come un campo teorico centrale della nostra ricerca.
21 Yifeat Ziv è cantante, compositrice e artista del suono. Combina voce, musica elettronica, registrazioni sul campo e testi per creare opere sonore interdisciplinari che derivano dalla sua ricerca sulla voce umana, sul linguaggio, sull’ecologia acustica e sulle pratiche di ascolto. I suoi lavori recenti sono stati eseguiti ed esposti in luoghi come Cafe oto (uk), Wellcome Collection (uk), pq: Prague Quadrennial (cz), Design Museum Holon (il), Eretz Israel Museum (il) e il Centro israeliano per il digitale. Arte (il).
so di scrivere un saggio esclusivamente sul suo lavoro, in relazione ai suoi processi di fusione tra due pratiche semiotiche di registrazione e trasformazione del suono della foresta amazzonica notturna e diurna . (come ricercatrice e come performer). Queste pratiche culminano nella creazione di performances acusmatiche immersive. Tra le varie modalità di traduzione intersemiotica messe in atto da Ziv, siamo stati particolarmente colpiti emotivamente dalle sue personalissime operazioni semiotiche di overdubbing progressivi una volta che, attraverso l’ascolto del silenzio notturno della foresta, l’artista produce una sorta di white noise22 o rumore bianco alla base dello spazio sonoro trasformato. Dopo che avviene questa prima fase atmosferica , nel senso dell’organizzazione di uno spazio sonoro multidimensionale, la performer sovrappone una serie di impronte e tracce alla maniera di un palinsesto: le prime e le ultime impronte sonore si udiscono durante tutta la sua performance sonora. Se ci siamo interessati ad altre proposte artistiche appena menzionate in questa sede, è stato con l’intenzione di esplorare altre strategie artistiche di ascolto, registrazione e manipolazione del suono, oltre alle variazioni intermediali e immersive che ogni artista aveva creato nella sua proposta. Le pratiche di ascolto di Ziv si realizzano in due livelli immersivi successivi: 1) un primo livello immersivo del corpo avvolto fisicamente nelle biofonie e geofonie della foresta amazzonica in base alla tecnica dell’ascolto profondo di Pauline Oliveros ; 2) un secondo livello immersivo che si realizza durante la performance acusmatica in uno spazio di comunicazione e interazione con il pubblico che condivide lo spettacolo attraverso un processo di embodiment sinestesico a partire
https://www.audio-research.com/blog/amazonian-traces-of-self https://www.yifeatziv.com/ amazonian-traces-of-self
22 Rumore bianco (white noise): lo interpretiamo come un sottofondo continuo dei rumori di un ambiente. Suono di una ampiezza costante che ricopre in teoria tutto lo spettro di frequenze udibili. Quindi sarebbe un esempio perfetto del concetto di continuum sonoro (Hjelmslev 1974) che comprende tutte le frequenze tra i 20 e 20 000 hertz. Lo scrittore Don DeLillo è autore del romanzo White noise (1985) adattato poi da Noah Baumbach in un film distribuito da Netflix con Adam Driver e Greta Gerwig. Nelle scienze acustiche il rumore bianco si distingue da altri due tipi: pink noise e black noise https://www.acousticfields.com/white-noise-definition-vspink-noise/ .
Torres, Elizabeth Dezeo e Rocco Mangieri
degli overdubbing sovrapposti. Lungo tutta la performance, l’artista traduce i suoi registri vocali in segni e figure gestuali e kinesiche, e in questo modo Ziv crea progressivamente un universo di strati intessuti tra loro, punteggiature e sequenze acustiche inedite che non seguono la struttura temporale e lineare di una partitura predefinita. La sua azione performativa inizia con una prima fase di attenzione somatica: un lungo silenzio preliminare dell’ascolto delle registrazioni biofoniche e geofóniche notturne effettuate durante i suoi percorsi nella selva ammazzonica 23 . (Immagine 11)
Gli artisti che producono queste atmosfere sonore sono coscienti di questa operazione semiotica. Per noi quindi, come accennato prima, la dimensione semiotica inglobante dell’atmosfera si rende efficace per la lettura e l’interpretazione del senso globale di questi avvenimenti performativi, oltre allo studio delle sue relazioni con altri sistemi semiotici che corrispondono a un`altro livello di analisi24 .
23 Le nostre attuali pratiche performative si inseriscono in parte nelle medesime strategie di Yifeat Ziv, sebbene noi aggiungiamo un altro piano di produzione semiotica molto più focalizzato sulla danza e le arti del movimento.
24 Il concetto di atmosfera è stato ripreso e promosso da vari studiosi nel campo dell’estetica e delle arti, tra i quali le opere di Gernot Böhme. Nell’ambito della cultura italiana dobbiamo riferirci alle opere di Tonino Griffero. Avviare ricerche interdisciplinari delle foreste come atmosfere sonore e polisensoriali, anche se non essendo un approccio biosemiotico, è per noi di notevole interesse (Böhme 1993, 2016; Griffero 2014, 2016. 2017, 2021). Per Griffero, “le atmosfere sono caratteri qualitativi che costituiscono a) un plus di senso comune, tanto connaturato da non essere facilmente tematizzabile, b) uno sfondo costituzionalmente vago sotto il profilo quantitativo-oggettuale anche se epistemicamente inemendabile; c) una base comunque vera (in senso fenomenologico) e oggettiva perché, nella forma di un sentimento spazializzato, situata nello spazio esterno e almeno in una certa misura contesto-dipendente , d) un completamento amodale (sinestesico) emotivo, simile alle affordances, in Aisthesis, rivista on-line del Seminario Permanente di Estetica, anno II, Num.1, p.51 , 2009/1 • www.seminariodiestetica.it . Griffero fa riferimento a James Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception, Erlbaum, Hillsdale 1986, (trad. it. di R. Luccio, Un approccio ecologico alla percezione visiva , introd. di P. Bozzi e R. Luccio, Il Mulino, Bologna 1999). Moltissimi degli esempi utilizzati procedono del campo dell’esperienza visiva ma altri dal campo dell’esperienza del suono.

Immagine 11. Amazonian traces of self, Yifeat Ziv, 2019, Vimeo, SoundCloud. Muperphoto. https://www.improfest.com/eventos/yifeat-ziv https://www.instagram.com/p/B7GUG9-gha5/
Fonte: https://www.improfest.com/eventos/yifeat-ziv https://www.instagram.com/p/B7GUG9-gha5/
Tra fusioni e distacchi enunciativi: suono, spazio, corporeità
C’è qualcosa, insomma, proprio nel tramonto lacustre o nell’ombratilità autunnale di un bosco che rende del tutto impossibile a chiunque ravvisarsi un’atmosfera allegra.
Tonino Griffero 2009
Rileggendo a questo punto il testo, abbiamo individuato un aspetto molto rilevante dal punto di vista descrittivo e comparativo dei processi artistici di traduzione intersemiotica. Un elenco di operazioni e pratiche semiotiche diverse ma sovrapponibili tra loro: 1) la fusione emotiva del corpo con le atmosfere sonore in diversi gradi di intensità e modalità enunciative, come nel caso di Yifeat Ziv, l’esempio più significativo per
noi in quanto i suoi successivi sovraincisioni ed equalizzazioni di strati sonori producono un forte effetto di fusione identitaria e somatica tra i suoni della foresta amazzonica e le modulazioni vocali del corpo, un lavoro simbolico ed estesico per fondere il corpo con lo spazio sonoro amazzonico; 2) un’altra modalità sarebbe quella della mediazione tra l’avvicinamento e il distacco enunciativo dovuto a un tipo di performatività diversa, come nella serie Amazonia di Jean Michel Jarre, in cui si crea una connessione intermediale tra musica e fotografia del paesaggio ma non derivata da concrete esperienze somatiche dell΄artista 25; 3) infine, si evidenzia una strategia enunciativa di distacco critico come in Richard Mosse nella sua proposta multimediale Brocken spectre, in cui si mette in primo piano la distanza critica dello spettatore , mentre la fusione e l’immersione occupano un secondo piano enunciativo26
Proposta di un quadro comparativo
Il quadro comparativo è per noi un esercizio descrittivo preliminare delle opere visionate o fruite, piuttosto che un’analisi esaustiva (Immagine 11).
Alcune di queste opere sono state percepite fisicamente nel contesto di una mostra, performance o spettacolo. Nel caso di alcune proposte, come la performance di Yifeat Ziv, ci siamo soffermati sull’analisi di alcuni aspetti particolari che riguardano elementi della nostra ricerca attuale. Lo scopo di questo tipo di schemi è quello di offrire agli operatori ecologici e agli artisti una rete preliminare di variabili qualitative che potrebbero essere inserite nello studio e creazione delle loro pratiche performative (intermediali, multimediali o immersive). Le variabili sono state applicate in base a gradi di intensità e non in base a opposizioni (Immagine 12). Uno degli obiettivi di questo lavoro preliminare sarebbe la condivisione di uno spazio teorico sulle base delle relazioni tra arti performative, biosemiotica e bioacustica, orientato finalmente alla produzione di avvenimenti, azioni ed esperienze
25 Si veda: France 24. (1 luglio 2021). Sebastião Salgado et Jean-Michel Jarre défendent l’Amazonie à la Philharmonie [YouTube]. https://www.youtube.com/watch?v=l1vSE2yVG24&t=3s&ab_channel=FRANCE24
26 Si veda: https://www.youtube.com/watch?v=1CmeqMe48MQ&ab_channel=PhotoElys%C3%A9e e https://www.youtube.com/watch?v=7kUm8MrRgB4&t=599s&ab_channel=unobtainiumphotobooks
la foresta amazzonica
performative nelle quali il núcleo centrale è l’arricchimento di uno sguardo ecologico, estetico ed etico. Come abbiamo accennato nell’abstract, abbiamo oggi piú che mai, la responsabilità di produrre attraverso le nostre creazioni un incremento e arricchimento del significato ecologico e semiotico della vita.
Opere visionate e fruite nello spazio delle mostre auidiovisive27
1. The Great Animal Orchestra, Bernie Krause and United Visual Artists, Installation view at Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris, 2016 (**)
2. Fragments of Extinction: il patrimonio delle foreste primarie, Davide Monacchi, Installation/Performance, in Rome in January 2014, at the international festival Visitazioni. (*)
3. Amazonia, Jean Michel Jarre e Sebastiao Salgado. Philharmonie de Paris, 2021 *
4. Brocken Spectre, Richard Mosse, Video installation, Produced in Brazil and Ecuador. Installation view, 180 Studios, London, 2022. (**)
5. Phantoms, Daniel Steegmann, The Contemporary Art Centre (cac), Vilnius 2018 (*)
27 Bernie Krause: https://www.youtube.com/watch?v=btrinTDDjnQ&t=7s&ab_channel=JosephPallamidessi e https://www.youtube.com/watch?v=5LWEy44-YrE&t=2s&ab_channel=PeabodyEssexMuseum
Davide Monacchi: https://www.fragmentsofextinction.org/ e https://www.youtube.com/ watch?v=_uktZkTB58M&t=7s&ab_channel=TEDxTalks
Jean Michel Jareé: https://www.youtube.com/watch?v=pRrBErtY9js&t=3s&ab_ channel=PhilharmoniedeParis e https://www.youtube.com/ watch?v=A1EmGAAmy34&ab_channel=Jean-MichelJarre-Topic
Richard Mosse: https://www.180studios.com/exhibitions-and-performances/richard-mosse
David Steegmann: https://danielsteegmann.info/works/41/index.html e https://vimeo. com/124466166, Yifeat Ziv: https://www.yifeatziv.com/amazonian-traces-of-self , https://vimeo. com/514304245 , https://www.yifeatziv.com/ e https://various-artists.com/lawrence-english/
Torres, Elizabeth Dezeo e Rocco Mangieri
6. Amazonian Traces of self, Yifeath Ziv, 2019, 2020 (**)
(*) Visionata (**) Fruita
Variabili di descrizione e analisi
L’elenco delle 16 variabili stabilisce gradi di intensità in ciascuna delle proposte artistiche e rende possibile una lettura verticale ed orizzontale delle relazioni.
1. Scopo scientifico: proposta orientata esclusivamente all’ambito della ricerca scientifica.
2. Dimensione performativa: grado di interazione e partecipazione del pubblico.
3. Grado di riferimento: le tracce e impronte sonore possono fare riferimento a forme viventi, specie o paesaggi sonori esistenti geográficamente negli ambienti naturali.
4. Oggettualità: la traccia o impronta sonora non si riferisce ad ambienti sonori esistenti ma alla sua stessa costituzione materiale come “oggetti sonori” (Schaeffer 2008)
5. Focalizzazione/singolarità: la traccia o impronta sonora si riferisce ad un particolare essere o forma vivente, come un singolare e non come rappresentante di una specie o phylum.
6. Atmosfere/ambienti: la proposta genera un ambiente, un’atmosfera di interazione suono-corpo di carattere situazionale.
7. Narratività: uso di modalità e strutture narrative, storie sequenziali o parallele, strutture episodiche.
8. Collegamento/contatto: enfasi sulle situazioni di collegamento e contatto emozionale tra i partecipanti.
9. Intermedialità: utilizzo di strategie e ambienti audiovisivi e sensoriali intermediali.
10. Transmedialità: articolazioni della proposta con altri media visivi, audiovisivi e stampati.
11. Immersione: grado di immersione somatica in relazione al pubblico. Modalità di attenzione, ascolto profondo e possibili altri stati alterati di coscienza.
12. Stratificazione: utilizzo di stratificazioni o strati sonori realizzarti al di sopra di una prima registrazione sonora biofonica, geofonica o tecnofonica. Intensità del overdubbing digitale e analogico.
13. Serialità: opera singola o seriale.
14. Database: utilizzo di database precedenti e/o creazione di nuovi database sonori.
15. Ritmi circadiani: marche o segnali della differenza oraria delle registrazioni effettuate all’interno del paesaggio sonoro: all’alba, una piena giornata, tardo pomeriggio, nella notte.
16. Modi di produzione segnica: produzione materiale, visiva e audiovisiva di tracce, impronte e traiettorie, tra altri modi di produzione in riferimento teorico al modello dei Modi di produzione segnica di Umberto Eco (1975, p. 285-324).
La lettura orizzontale ci ha consentito di valutare i cambiamenti dei gradi di intensità delle variabili in relazione all’insieme delle opere, mentre la lettura verticale ha reso visibile il grado di intensità interno di ogni proposta individuale. Abbiamo elencato una serie di valori o tratti semiotici (16), ipotizzando la presenza di variazioni nelle modalità del piano dell’espressione, pur mantenendo similitudini all’interno del gruppo di artisti: Krause e Monacchi condividono molti tratti intensivi comuni, tuttavia i montaggi immersivi di Krause risultano più articolati in relazione all’insieme delle variabili. Steegmann e Mosse, nonostante alcune differenze nell’espressione del discorso performativo, coincidono in molti aspetti, ad eccezione di alcuni. Ziv e Jarreé potrebbero essere accomunati, ma non completamente a causa dei tratti semiotici molto di più incarnati della Ziv ( il suo particolare modo di un embodiment sonoro), oltre al modo
Torres, Elizabeth Dezeo e Rocco Mangieri
Variabili (gradi di intensitá)
Finalitá scientifica
Dimensione performativa*
Gradi di riferimento
Oggettualitá
Focalizzazioni / singolaritá**
Atmósfere / environments
Narrativitá**
Vincolo / contatto
Intermedialitá
Transmedialitá
Immersione
Stratificazioni (overdubbing)
Serialitá
Database****
Variabili (gradi di intensitá) B. Krause Y. Ziv
J. M. Jarré D. Monacchi
D. Steegmann R. Mosse
Ritmi circadiani
Modi di produzione segnica
Fonte: Elaborazione degli autori
12
in cui esegue le sue pratiche di registrazione e sovrapposizione di tracce (overdubbing vocale). Nel complesso, Steegmann crea un distacco a livello dell’enunciazione, sia per il grado e l’intensità delle immersioni attraverso la tecnologia vr, sia attraverso la modalità critica e ironica a livello narrativo. Le variabili di alta intensità ed estensive a tutte le proposte artistiche sono: atmosfera, contatto, modi di produzione segnica, immersione, dimensione performativa.
Alcune conclusioni: spazio, corpo, suono, atmosfera
Il suono crea uno spazio ambientale nella stessa misura in cui l’ambiente crea il suono. Diversi sono i punti di partenza, diverse le motivazioni ad un interesse di progettazione ambientale/sonora, una diversità che va oltre la specificità delle discipline. Nell’ambito musicale propriamente detto, per quanto “contaminato” esso sia, è possibile rilevare la centralità della linea cageana , dove giunge positivamente a compimento un filone del pensiero musicale moderno genericamente rivolto all’equiparazione estetica di suono e rumore e che comporta la concezione dell’ambiente inteso nella sua assoluta fisicità di spazio acusticamente agibile
Masotti, F.; Rizzardi, V.; Taroni, R. 1985
Torres, Elizabeth Dezeo e Rocco Mangieri
Il lettore potrebbe aver percepito che abbiamo cercato di concentrare questo studio sulle pratiche semiotiche di registrazione e traduzione intersemiotica in uno spazio teorico di intersezione tra il ruolo tematico dello scienziato e quello dell’artista, ma poi ci siamo resi conto che una pratica dell’ascolto si articola con altre pratiche semiotiche: registrare-ripetere-riscrivere28. Nonostante le differenze nei metodi di lavoro, abbiamo descritto alcune analogie tra due tipi di laboratori che condividono un territorio teorico comune, un laboratorio comune ecologico ed estetico di esplorazione del senso della vita. I paesaggi sonori registrati e documentati vengono poi elaborati dagli artisti attraverso strati di tracce e impronte personalizzate che si sovrappongono al sottofondo biofonico, geofonico o tecnofonico. Queste tipologie di produzione semiotica generano nuove puntuazioni, oggetti sonori e sequenze narrative intermediali e multimediali inedite, variazioni inter-polifoniche che creano “secondi universi sonori”, porzioni di materia e sostanza del mondo sensibile che vengono percepite sinestesicamente, collegandosi ad altri spazi oltre a quello organico e minerale a cui tutti noi apparteniamo. Sia la pratica semiotica della creazione artistica che quella della ricerca scientifica sono laboratori semiotici territoriali aperti (nel senso proposto da Bruno Latour e altri studiosi), in quanto condividono un nucleo di interessi comuni, un impegno etico nei confronti di un territorio planetario oggi tragicamente minacciato nella sua integrità biosemiotica ed ecosistemica 29. Le proposte artistiche che abbiamo descritto si situano in questo incrocio estetico, epistemologico ma altrettanto politico. Ulteriori analisi sullo schema proposto potrebbero condurci a diverse ipotesi di lavoro, come l’approfondimento delle relazioni tra le modalità di produzione materiale segnica, le specifiche tipologie di intermedialità o serialità, i livelli di intensità performativa delle opere artistiche (Kull,
28 Questa sequenza sintagmatica e narrativa ci sembra rilevante. Avremo opportunitá di studiarla in altra sede.
29 Riprendiamo l’idea di Bruno Latour (2001) sul processo storico ed evolutivo di conversione ed espansione della pratica laboratoriale scientifica come un insieme di pratiche territoriali. Questo spostamento espansivo, oltre alla ricerca delle scienze naturali, corrisponde anche alla ricerca artística. D’altra parte, sappiamo che molto prima delle “rivoluzioni scientífiche” della modernitá lo sguardo della scienza si fondeva con quello dell’arte.
Levmezova 2012), le semiotiche basate sui sistemi viventi e la proliferazione dei database (Dondero, Basso, Ioka 2022) o, infine, a una più ampia indagine sull’estetica dell’oggetto sonoro, specialmente in relazione ai processi di embodiment intersoggettivo che emergono nelle interazioni tra le polifonie ambientali e le pratiche performative degli artisti e dei scienziati contemporanei. La ricerca, una volta inserita all’interno di un campo provvisorio di relazioni e interdefinizioni di almeno quattro campi diversi ma articolati a livello inter e transdisciplinare (Immagine 13), potrebbe risultare efficace a due livelli paralleli: 1) innanzitutto, a livello di una presa di coscienza più profonda, quindi come coscienza semiologica dei significati delle specifiche pratiche trasformative) degli attori che assumono ruoli semiotici all’interno delle ricerche scientifiche, una presa che si configura oltre o insieme alle metodologie di lettura e di interpretazione, come una costellazione di emergenze fenomenologiche ed estetiche; 2) in secondo luogo, a livello degli individui, gruppi, laboratori degli artisti che ritrovano nello sguardo scientifico conoscenze, schemi di rappresentazione, categorie e modelli interdefinibili in relazione alle loro pratiche performative.30 Per ora proporremo il concetto (figurativo e sensoriale) di atmosfera come un asse semantico che potrebbe articolare l’insieme di pratiche appartenenti ai campi disciplinare che abbiamo messo in relazione. Una metafora epistemologica di collegamento inter e transdisciplinare che, a nostro parere, sarebbe efficace. In quanto ricercatori e interpreti, ci dedichiamo alla creazione di esperienze fenomenologiche ed estetiche all’interno del mondo dei suoni ambientali. Questo tipo di lavoro teorico non solo potrebbe offrire prospettive complementari di ricerca nel campo della scienza sperimentale, come la biosemiotica e la bioacustica, ma anche all’interno delle stesse pratiche artistiche.
30 Un primo approccio a un percorso di interdefizioni possibili sarebbe ad esempio: biofonía-corpoatmosfera sonora-sinestesia-ascolto profondo-propiocettivitá-spazio.
Arti performative
Soundscape theory
Immagine 13. Schema delle relazioni per una ricerca inter e transdisciplinare. Il concetto e metáfora epistemológica di atmosfera si propone come una articolazione tra le diverse discipline
Fonte: Elaborazione degli autori
Riferimenti
Bakker, K. (2022). The sounds of life: How digital technology is bringing us closer to the worlds of animals and plants. Princeton University Press.
Battistini, E. (2017). La grande orchestra degli animali. In Zoosemiotica 2.0, forme polítiche dell´animalitá, nuovi quaderni del Circolo Semiologico siciliano Universitá degli studi di Palermo e Edizioni Museo Pasqualino.
Battistini, E. (2018). Sound around you (isay): rappresentare e condividere il paesaggio sonoro tra mobile e web. Rivista On-line dell’Associazione Italiana di Studi Semiotic, 12(23).
Battistini, E. (2022). L’ipotesi delle nicchie acustiche: Un modello biosemiotico per le sfide dell’Antropocene. versus, 135, 247-266.
Böhme, G. (1993). Atmosphere as the fundamental aspect of a new aesthetics. Thesis Eleven, 36(31).
Böhme, G. (2016). Acoustics atmosphere: A contribution to the study of ecological aesthetics. In J. Thibaud (a cura di), Aesthetics of atmosphere. Routlege.
Bruce, A. (2022). Delve into the Amazon rainforest: A 60-minute sound immersion with Bernie Krause. Foundation Cartier. https://www.fondationcartier. com/en/online-projects/plongez-vous-au-cur-de-lamazonie-60-minutesdimmersion-sonore-avec-bernie-krause
la foresta amazzonica
Burt, J. e Vehrencamp, S. (2005). Dawn chorus as an interactive communication network. In Animal Communication Networks (pp. 320-343). Cambridge University Press.
Buzzarté, M. e Bickley, T. (2013). Anthology of essays on deep listening. Pop&MoM. Chion, M. (2009). Guide to sound objects. Buchet/Chastel.
Csordas, Th. (2010). Modos de atención somática. In S. Citro (a cura di), Antropología desde los cuerpos. Biblos.
Cunnil Grau, P. (2007). Geohistoria de la sensibilidad en Venezuela. Fundación Polar.
Delgado, S. (2015). In focus: Daniel Steegmann Mangrané. Frieze-Contemporary Art Culture, 171, 204-205.
Delillo, D. (1985). White noise. Viking Press.
Dondero, M. G., Basso, P. L. e Yoka, L. (a cura di). (2022). Semiotic approaches to big data visualization. International Journal of Semiotics, 8(1). https:// punctum.gr/volume-08-issue-01-2022-semiotic-approaches-to-big-datavisualization/2022-0001/
Eco, U. (1975). Trattato di semiotica generale. Bompiani.
Farina, A. (2012). A biosemiotic perspective for a resource criterion: Toward a general theory of resources. Biosemiotics, 5, 17-32.
Feld, S. (2012). Sound and sentiment: Birds, weeping, poetics, and song. Duke University Press.
Fontanille, J. (2004). Sémiotiques du corps l’enveloppe et le mouvement. In Soma et Séma: Figures du Corps (pp. 159-174). Maisonneuve e Larose.
Fontanille, J. e Basso, P. (a cura di). (2018). Pratiche semiotiche: Efficienza ed etica dell’agire. ets.
Gibson, J. (1986). The ecological approach to visual perception. Routledge-Psychology Press.
Giorgi, F. (2012). Agency. In D. Favareau, P. Cobley e K. Kull (a cura di), A more developed sign: Interpreting the work of Jesper Hoffmeyer (pp. 13-16). University of Tartu.
Goodman, N. (1976). Los lenguajes del arte. Seix Barral.
Griffero, T. (2014). Atmospheres: Aesthetics of emotional spaces. Routledge.
Griffero, T. (2016). Atmospheres and felt-bodily resonances. Studi di Estetica , 44(1), 1-41.
Griffero, T. (2017). Quasi-things: The paradigm of atmospheres. Suny Press.
Griffero, T. (2021). El nicho atmosférico: sentimientos espaciales y cuasi-cosas. Estudios Filosóficos, 70, 237-264.
Hjelmslev, L. (1974). Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Gredos.
Hoffmeyer, J. (1998). Surfaces inside surfaces: On the origin of agency and life. Cybernetics & Human Knowing, 5, 33-42.
Torres, Elizabeth Dezeo e Rocco Mangieri
Hoffmeyer, J. (2008a). Biosemiotics: An examination into the signs of life and the life of signs. University of Scranton Press.
Hoffmeyer, J. (2008b). The semiotic niche. Journal of Mediterranean Ecology, 9, 5-30.
Jakobson, R. (1959). On linguistic aspects of translation. In R. A. Brower (a cura di), On translation. Harvard University Press.
Kalevi, K. e Ekaterina, V. (2012). Biosemiotics in a gallery. Biosemiotics, 5(3), 313-317.
Kalevi, K. (2009). Biosemiotics: To know, what life knows. Cybernetics and Human Knowing, 16(1-2).
Kark, S. (2013). Ecotones and ecological gradients. In R. Leemans (a cura di), Ecological Systems: Selected entries from the encyclopedia of sustainability science and technology ecological systems (pp. 147-160). Springer.
Kohn, E. (2019). Come pensano le foreste: Per una antropologia oltre l’umano. NotteTempo.
Kohn, E. (2021). Introduction: Runa Puma. In How forests think: Toward an anthropology beyond the human (pp. 1-27). University of California Press.
Krause, B. (2008). Anatomy of the soundscape: evolving perspectives. Journal Audio Engineering Society, 56, 73-80.
Krause, B. (2012). The great animal orchestra. Brown and Company. Lasser, T. (1971). Los viajeros científicos en Venezuela. Boletín de la Asociación
Cultural Humboldt, 6.
Latour, B. (2001). La esperanza de la caja de Pandora. Gedisa.
Mangieri, R. (2006). Significazione dello spazio e modi di produzione segnica nell’Isola del giorno prima di Umberto Eco. signa, 15, 369-399. https://revistas.uned.es/index.php/signa/article/view/6140/5873
Mangieri, R. (2018). Efecto Gainsborough: en los bordes del acontecimiento. In J. Bañuelos e V. Castellanos (a cura di), Designis. La Crujía.
Mangieri, R. (2004). Recrear el sonido, reinventar la imagen, construir la atmósfera.
Cuadernos de Investigación cdcht.
Mangieri, R. (2020). The semiotics toolbox. In J. Urueña e L. Alzate Suárez (a cura di), Estudios semióticos. Abordajes metodológicos. Universidad Antioquia-Colombia.
Mangieri, R. (2022). Acusmatics semiotics. Laboratorio de Semiotica y Socioantropologia de las Artes e Universidad de Los Andes.
Mangieri, R. e Urueña, J. (a cura di). (2023a). Las artes del cuerpo como encuentro y celebración de la vida. Universidad del Rosario.
Mangieri, R. (2023b). Elementos para una semiotica acusmática. Cuadernos de Investigación cdchta e Universidad de los Andes.
Mangieri, R. (2024). Atmosferas, prácticas y entornos performativos. Laboratorio de semiótica y socioantropologia de las artes e Universidad de Los Andes.
la foresta amazzonica
Maran, T. (2019). Deep ecosemiosis, forest as a ecoisemiotics model. Recherches Sémiotiques, 38/39(3/1-2), 287-303.
Marin, O. e Mc Gregor, I. (2019). Tras las huellas sonoras de los ecosistemas. Ciencia y Luz e Universidad Veracruziana. https://www.uv.mx/cienciauv/blog/ tras-las-huellas-sonoras-de-los-ecosistemas/ Merlau Ponty, M. (1999). Fenomenología de la percepción. Anaya.
Masotti, F., Rizzardi, V. e Taroni, R. (1982). Sonorità prospettiche. Suono, ambiente, immagine. Comune di Rimini.
Metcaf, O. (2021). Acoustic monitoring of Amazonian wildlife in human-modified landscapes [tesi di dottorato, Manchester Metropolitan University].
Mockus, M. (2007). Sounding out: Pauline Oliveros and lesbian musicality. Routledge.
Monacchi, D. (2008). Eco-acoustic compositions [album]. emf Media.
Monacchi, D. (2013). Fragments of extinction: Acoustic biodiversity of primary rainforest ecosystems. Leonardo Music Journal, 23. Monacchi, D. (2014a). Fragments of extinction: An eco-acoustic music project on primary rainforest biodiversity. me.
Monacchi, D. (2014b). Fragments of extinction a periphonic audio-video concert based on 3D soundscape field recordings of ecosystems. Proceedings of the eaa Joint Symposium on Auralization and Ambisonics. Fragments of extinction. Monacchi, D. (2016). A philosophy of eco-acoustics in the interdisciplinary project fragments of extinction. In F. Bianchi e V. J. Manzo (a cura di), Environmental Sound Artists (pp. 158-167). Oxford University Press.
Monacchi, D. (2019). L’arca dei suoni originari. In Salvare il canto delle foreste dall’estinzione. Mondadori.
Mosse, R. (2022). Broken spectre. Loose Joints and 180 Studios. https://loosejoints. biz/products/broken-spectre.
Oliveros, P. (1971). Teach yourself to fly: 5 sonic meditations. Norient. https://norient. com/pauline-oliveros/teach-yourself-fly-5-sonic-meditations.
Oliveros, P. (2005). Deep listening: A composer’s sound practice. Barnes & Noble e I Universe.
Oliveros, P. (2010). The sounding the margin: Collected papers 1992-2009. University of San Diego Library. https://library.ucsd.edu/dc/object/bb3658215z https:// www.agostofoundation.org/sites/default/files/upload/oliveros_pauline_ deep_listening_a_composers_sound_practice_2005.pdf
Pieretti, N. (2014). The soundscape approach for the assessment and conservation of mediterranean landscapes: Priciples and case studies. Journal of Landscape Ecology, 7 (1).
Riede, K. (1993). Monitoring biodiversity, analisys of Amazonia rainforest sound. ambio, 22.
Torres, Elizabeth Dezeo e Rocco Mangieri
Schafer, M. (1977). The tuning of the world. Destiny Books. Schafer, M. (1992). Hacia una educación sonora. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Schaeffer, P. (2008). Tratado de los objetos musicales. Alianza Editorial.
Steegmann, D. (2019). A leaf-shaped animal draws the hand. Pirelli Angar Bicocca. http://www.danielsteegmann.info/works/downloads/pdf/FOUR_WALLS_ english.pdf
Wulf, A. (2016). The invention of nature: Alexander von Humboldt’s new world. Vintage.
Dalla biosfera alla semiosfera
Dalla biosfera alla semiosfera: le poetiche biodegradabili nella scena contemporanea argentina
Lucía Stubrin e Eric Hirschfeld
Abstract
In questo capitolo proponiamo di pensare alla dimissione di pratiche come il bioarte, che possono essere analizzate dal punto di vista della biosemiotica, sotto il profilo del trasferimento che impone la nuova era che stiamo attraversando come umanità: l’Antropocene. Da questa prospettiva, le tensioni tra la visione della semiotica della cultura e i principi fondamentali della biosemiotica diventano convergenti. Intendiamo quindi problematizzare la suddetta tensione, a partire da esempi concreti di bioarte situati, cioè di pratiche interdisciplinari in cui la comunicazione interspecie viene sostenuta a partire da strumenti artistici di ascolto, contemplazione e collaborazione. Pensando alla bioarte come a un caso che trasforma in discernibili le tensioni tra la semiotica della cultura e la biosemiotica, le opere che si iscrivono in un certo senso o aspetto di questa pratica si trasformano in un valido supporto per riflettere sulle potenzialità del concetto di testo artistico e del significato biologico.
L’Argentina, in particolare, si è trasformata negli ultimi decenni in un ambiente di riferimento per la sperimentazione bioartistica (Yeregui 2017). Da una prospettiva situata che si inscrive in una presa di coscienza artistico-politica sulla responsabilità della specie umana nella conservazione e preservazione del medio ambiente, si sono consolidate delle linee di lavoro specifiche che ci interessa sottolineare.
Il campo dei biomateriali è, in particolare, un ambito fertile per riflettere sulle tensioni menzionate che la biosemiotica presenta da una prospettiva teorica. In questo senso, le esperienze artistiche di Verónica Bergottini e Ana Paula Hall possono essere analizzate come esempi chiave per analizzare i processi di significato innovativi.
Osservazioni preliminari
Gli sviluppi presentati in questo capitolo fanno parte di un progetto di ricerca in corso intitolato “Bioarte situado: relecturas semióticas desde el arte contemporánea argentino (2010-2020)”, la cui rilevanza si colloca in un’area di esplorazione vacante nelle coordinate geo-politiche argentine: un’area vuota che prevede la ricostruzione di uno specifico campo dell’arte contemporanea sulla base di cataloghi, istituzioni e altri materiali che permettono di stabilire registrazioni sull’emergere della bioarte negli spazi di consacrazione artistica. Un’altra esplorazione, di natura teorica e concettuale, mira a strumentalizzare i più recenti sviluppi della filosofia postumanista (Braidotti 2023; Haraway 2016) con contributi fondativi per pensare semioticamente il rapporto natura-cultura, tra cui spiccano i postulati della semiotica della cultura e della biosemiotica. La struttura di questo capitolo cerca di mettere in luce gli aspetti di queste due esplorazioni che, come si vedrà nelle pagine successive, non sono esenti da tensioni di ordine categoriale e istituzionale, trattandosi di temi che collegano sia la crisi ambientale che quella rappresentativa.
Una prima parte di questo capitolo è dedicata alla presentazione di due casi operativi per riflettere su una prospettiva interdisciplinare tra studi semiotici e proposte filosofiche volte a deautomatizzare le visioni incentrate sul canone antropocentrico. In questo quadro, le proposte di due bioartisti argentini mettono in gioco le tensioni tra la pratica artistica e i suoi molteplici spazi di contatto e circolazione. La scelta dei casi, lungi dall’essere rappresentativa, permette di analizzare e discutere alcune delle dimensioni che verranno affrontate in questo sviluppo.
L’analisi del corpus selezionato, a sua volta, richiede di delineare le caratteristiche di un particolare campo artistico, in questo caso corrispondente alla bioarte argentina, dove il rapporto tra scienza e tecnologia è fondamentale per pensare alla possibilità di una bioarte situata. Questa possibilità, come si vedrà in seguito, si allontana dalla “purezza” dei profili iperspecializzati. La definizione della pratica bioartistica è costituita invece principalmente da profili che oscillano tra formazione artistica e scientifica.
La seconda parte di questa produzione avanza le possibilità analitiche che una visione semiotica può sostenere su questo insieme di fenomeni, senza escludere le tensioni e le transizioni epistemiche che queste teorie rendono visibili. L’ingresso della semiosfera come nozione dinamica di analisi artistica implica un insieme di presupposti e antecedenti metodologici la cui spiegazione traduce una preoccupazione legata alla visione antropomorfica del significato. La costruzione concettuale che si realizza nel momento successivo alla presentazione dei casi mette sul tavolo alcuni dei possibili punti di contatto tra semiotica della cultura, biosemiotica e filosofia postumanista.
Infine, le conclusioni di questo capitolo mirano a stabilire un punto di fuga in cui gli elementi convergono sia nella creazione artistica sia nella produzione teorica. La biosemiotica, come la bioarte, fanno parte di un futuro che si lega al processo storico e sociale globale che include crisi ed esplosioni culturali che a loro volta richiedono la trasformazione dei modi di comprendere certi processi, anche quelli che provengono da tradizioni di lunga durata.
Introduzione alla bioarte in Argentina
L’emergere della bioarte nel mondo è avvenuto negli anni Novanta del secolo scorso, attraverso il lavoro di artisti di primo piano che hanno concepito la manipolazione di entità viventi in condizioni di laboratorio come la caratteristica principale del genere. Referenti come Eduardo Kac installarono il concetto di “arte transgenica” (Kac 1998) che divenne mainstream, tralasciando altre forme poetiche di rappresentazione e sperimentazione di processi artistico-scientifici legati all’intervento sulla vita.
La confluenza degli sviluppi scientifici e tecnologici legati alla ricerca nel campo delle biotecnologie e la vasta tradizione artistica di esperimenti arte-scienza-tecnologia che l’Argentina vanta per quanto riguarda la storia dell’arte locale del XX secolo (Kozak 2012) hanno insieme generato anche le condizioni per la proliferazione del genere bioartistico, con caratteristiche e influenze proprie.
Il modo in cui gli artisti concepiscono oggi l’installazione artistica, in particolare nel contesto argentino, è lontano dalle prime esperienze
identificate come fondanti del genere a livello globale. Mariela Yeregui, artista e ricercatrice, afferma che tra gli artisti latinoamericani c’è una tendenza ad “star-essendo” [estar-siendo] nella natura e, inoltre, ad abbandonare i presupposti della bioarte mainstream delineando altri scenari di “azione/creazione”. Nelle sue stesse parole:
Di fronte all’esteriorità dell’artista-biologo e persino di fronte alla posizione critica del bio-attivista (in particolare in relazione ai processi di manipolazione della scienza), queste strategie rendono conto di un’altra dimensione: generano punti di vista propri che trascendono la ragione strumentale che regge la tecno-scienza: generano e collegano processi da uno scenario meticcio che si appropria della logica tecnologica “moderna” e la trasforma in dispositivi incorporati e situati nel contesto naturale, attivando relazioni di dialogo e coabitazione profonda. (Yeregui 2017, pp. 10-11, traduzione a cura degli autori)1.
Dalla creazione del primo Laboratorio di Bioarte in America Latina nel 2008, situato presso l’Universidad Maimónides nella città di Buenos Aires, l’Argentina si è affermata come luogo di riferimento per la tecnopoesia bioartistica. All’interno dell’insieme di gruppi e artisti che si dedicano alla pratica di quella che chiameremo bioarte situata, possiamo individuare quattro tendenze principali (ma non esclusive): la comunicazione interspecie (in cui si combinano tecnologie hard, soft e wet); lo sviluppo di biomateriali (a partire da funghi, batteri, lieviti, cellule di mammiferi o alghe); la casualità nei processi viventi (in cui le opere artistiche attendono una trasformazione organica per essere successivamente registrate); la
1 “Frente a la exterioridad del artista-biólogo e incluso, frente a la postura crítica de los bioactivistas (particularmente en relación a los procesos de manipulación de la ciencia), estas estrategias dan cuenta de otra dimensión: generan miradas propias que trascienden la razón instrumental que sostiene a la tecnociencia; generan y articulan procesos desde un escenario mestizo que se apropia de “lo moderno” tecnológico y lo transforma en dispositivos embebidos y situados en el propio contexto natural, activando relaciones de diálogo y de profunda cohabitación” (Yeregui 2017, pp. 10-11).
simulazione organica (in cui le opere artistiche ricreano forme di vita in un’ottica speculativa digitale).
La bioarte come disciplina artistica, dunque, ha trovato le sue linee guida in ambiti e formati di vario tipo, sia istituzionalizzati nelle università che in residenze e spazi autogestiti, proponendo in qualche modo un’interazione tra un progetto creativo e il vivente. Questo solleva, come sottolineato in un altro articolo (Stubrin, Cattaneo 2023), la necessità di collegarsi con altri agenti sociali come i laboratori (sia pubblici che privati) e l’incrocio interdisciplinare con il territorio in cui questi progetti sono inscritti.
L’idea di artista-biologo sollevata da Yeregui è interessante per misurare il campo d’azione di questa pratica, così come le possibili tensioni, quando si colloca tra le intersezioni del canone artistico e scientifico.
In questo lavoro ci concentreremo su due casi di artiste che affrontano la ricerca poetica sui biomateriali, combinando conoscenze scientifiche, metodologie collaborative di open knowledge ed esperienze situate che attualizzano problemi sociali locali.
La prima di esse è Ana Paula Hall, che si cimenta con i biomateriali come artista discografica di formazione, specializzata in arte tessile tradizionale, arti elettroniche e manager culturale della città di Coronel Suárez (provincia di Buenos Aires). La sua linea di lavoro si inscrive all’interno della pratica del fai-da-te (diy) e del riciclo dei rifiuti organici nel territorio, recuperando il concetto di memoria come tema comune del suo processo creativo.
Veronica Bergottini, invece, rappresenta un approccio dal punto di vista scientifico, in quanto la sua formazione accademica la posiziona in modo particolare verso il trattamento dei rifiuti organici scartati dalle industrie di yerba mate. Il suo punto di vista sulla creazione di biomateriali è attraversato dall’economia circolare e dalla possibilità di progettare un prodotto con un’identità nazionale a partire dal riutilizzo delle vestigia di yerba mate.
Date le caratteristiche di questo capitolo, l’obiettivo di lavorare con dei casi risponde alla necessità di mostrare le caratteristiche invariabili che il gruppo di ricerca ha rilevato nelle opere bioartistiche sistematizzate
nell’indagine nazionale2. Per questo motivo, la lettura delle proposte di Hall e Bergottini in entrambi i casi ci permette di individuare che le opere instaurano un singolare dialogo sia con l’ambiente in cui sono prodotte sia con i materiali, totalmente o parzialmente organici. L’articolazione teorico-metodologica che si leggerà in queste pagine cerca di cogliere un insieme di pratiche che dichiarano la necessità di essere lette in modo interdisciplinare e multidimensionale.
Biotessili, memoria vegetale e territorio
Ana Paula Hall si considera una bioartista. Dal 2017 sviluppa e prototipa biomateriali e biotessili. Il suo progetto di ricerca si concentra sull’ibridazione tra biomateriali e arte tessile, esplorando nuove forme di espressione artistica attraverso la tecnologia e la biologia. Gestisce e coordina Viento Casa de Bioarte, un’officina-laboratorio da cui propone un percorso di bioarte a partire dall’utilizzo di materie prime organiche che individua nel suo territorio, generando anche un legame pedagogico e identitario con la comunità in cui vive, Coronel Suárez.
La sua esperienza con l’arte tessile la orienta verso la problematizzazione del supporto come strumento e mezzo di espressione organica. Tecniche di stampa, sound art, video performance, installazioni in situ fanno parte dell’universo del suo lavoro. Si tratta di sperimentazioni creative che combina nell’ambito della poetica tecnologica e dell’indagine sulle materie prime, mescolando tecniche innovative con conoscenze biologiche ed estetiche provenienti dalla natura circostante.
Nell’opera Matices foliares. Memorias vegetales entramadas en los biomateriales (2013), Hall propone un ampio arazzo costruito in più sezioni da cerchi uniti che possono essere appesi sovrapposti o in linea. L’opera dà l’impressione di essere un grande sipario di toni, texture e traslucenze variabili, dove il contrasto di colori è il protagonista principale. Ciò è dovuto
2 Va notato che a livello internazionale è possibile trovare pratiche simili come Biopoliméricalabva (Cile), Biology Studio (Messico) e Fibra Biolab (Perú), dove esistono anche spazi di riflessione sull’uso di biomateriali per la creazione di tessuti.
all’uso di pigmenti naturali nell’elaborazione di ogni cerchio che integra l’arazzo. Nelle parole dell’artista:
La sperimentazione di varie formule per generare uno spettro discorsivo di colori e texture intessute nel materiale porta alla creazione di una narrazione arricchente di esperienze. Queste esperienze si intrecciano con la memoria collettiva dell’uso delle tinte e delle proprietà delle piante. Elementi come le bucce di agrumi, le noci raccolte in ambienti rurali, la polvere di yerba mate, una varietà di condimenti e tinte ottenute da altre fonti vegetali contribuiscono a creare sfumature cromatiche uniche. (Hall 2013, traduzione a cura degli autori)3
Il recupero delle informazioni vegetali accumulate nelle piante che compongono il paesaggio in cui l’artista vive, così come l’esercizio di testare e adattare le ricette in base agli ingredienti disponibili e alle condizioni ambientali di quel territorio, mostrano una preoccupazione per la ricerca di un sapere situato. Allo stesso modo, prevale una consapevolezza durante il processo artistico che non si conclude nel momento della presentazione al museo ma, al contrario, ne registra la fine al momento della degradazione biologica di quel materiale. Degradazione che garantisce la circolarità di un’economia delle risorse compatibile con lo stato di crisi ecologica che abitiamo nell’Antropocene (Haraway 2016).
Hall dialoga, quindi, con materiali inerti ed entità non umane di diverso tipo. Da un lato, il paesaggio circostante le offre piante, cibo e spezie di cui ha bisogno per estrarre consistenza e colore. Dall’altro, durante il processo di cottura, impara a lavorare insieme a microrganismi come funghi, lieviti, batteri che consolidano la produzione di biomateriali, in condizioni ambientali che Hall deve controllare artigianalmente nella sua cucina domestica.
3 “La experimentación con diversas fórmulas para generar un espectro discursivo de colores y texturas tejidas en el material conduce a la creación de un relato enriquecedor de experiencias. Estas experiencias se entrelazan con la memoria colectiva de la utilización de tintes y propiedades de las plantas. Elementos como cáscaras de cítricos, nueces recolectadas en entornos rurales, polvo de yerba mate, una variedad de condimentos y tintes obtenidos de otras fuentes vegetales aportan matices cromáticos singulares” (Hall, 2013).
In questo modo, ogni cerchio che integra l’arazzo diventa non solo una parte dell’opera d’arte, ma anche un’unità di vita interspecifica sottoposta all’azione del tempo e alle condizioni spaziali del luogo che la ospita. L’artista propone in Matices foliares un’estetica dinamica in cui l’opera non nasconde la propria decadenza ma la esibisce come parte del suo processo vitale.
Sostenibilità, yerba mate e moda
Un altro caso di interesse è attualmente sviluppato dall’ingegnere Verónica Bergottini (Misiones, Argentina), che ha realizzato la produzione di un biomateriale incentrato sul design dell’abbigliamento. In questo progetto, la creazione di un pezzo artistico è legata alla soluzione sostenibile di problemi industriali con l’uso di un materiale organico frequentemente utilizzato in Sud America: la yerba mate. Questa erba viene prodotta in aree parziali di tre Paesi, tra cui il nord dell’Argentina, il sud-est del Brasile e l’est del Paraguay, poiché richiede un clima esclusivamente umido per impollinare i suoi fiori.
Il progetto di Bergottini, secondo il suo percorso creativo4 , nasce da un mix tra la sua formazione di Dottore in Scienze Biologiche (Université de Neuchâtel) e la partecipazione a corsi e workshop sul design e la produzione di abbigliamento. L’uno e l’altro hanno permesso alla ricercatrice di approfondire la sperimentazione di materiali compostabili per trovare una bi-pelle che fosse sostenibile e allo stesso tempo suscettibile di essere inserita nel circuito dell’abbigliamento e degli accessori firmati. È così che ha creato Tilex, un gioco di parole tra il nome scientifico del materiale biologico con cui lavora (Ilex paraguariensis St. Hil.) e l’iniziale della parola tela , che in castellano conserva lo stesso significato che ha in italiano.
4 I racconti di Ana Paula Hall e Verónica Bergottini sono stati realizzati nell’ambito di Mañanas de bioarte, un ciclo di conferenze pubbliche finalizzate alla divulgazione e al dibattito sui progetti bioartistici. L’edizione 2022 è stata dedicata in particolare ai progetti legati alla produzione e alla sperimentazione di biomateriali. Le interviste e le mostre, organizzate in parte dagli autori di questo capitolo, possono essere consultate su: https://www.fcedu.uner.edu.ar/2022/11/28/ finalizo-el-seminario-sobre-biomateriales/
Tilex è un supporto tessile generato da microrganismi che si nutrono della pianta di yerba mate e ne convertono i componenti chimici in un materiale con caratteristiche simili alla carta o alla pelle. Invece del suo uso convenzionale (ossia la preparazione di infusi o bevande di vario tipo), la scommessa scientifico-artistica della ricercatrice traduce una serie di elementi appartenenti a un circuito di consumo specifico come quello alimentare per creare pezzi tessili.
Sia la consistenza che i colori del materiale prodotto dalla yerba mate consentono un’esplorazione visiva sul corpo: sia come accessorio che come capo formale, l’uso del Tilex acquisisce una proprietà che ne consente un utilizzo in relazione alle ultime tendenze della moda e anche una risposta allo sfruttamento di un componente al di là dell’uso tradizionale. Per questo lavoro segnaliamo uno dei suoi progetti intitolato Karu (2019). Basandosi sullo sviluppo del nuovo biomateriale creato con Ilex paraguariensis, Bergottini presenta un’ampia gamma di biodesign consapevole. Il suo catalogo è visibile sul suo profilo Instagram, dove la dimensione sperimentale della creazione artistica è spiegata in dettaglio. Sculture umane trasportabili come leggere collane in biopelle, originali gilet e accessori di ogni tipo come borse, portafogli, spille, fibbie, fasce per capelli, ecc.. Il suo lavoro propone, quindi, due modalità di presentazione: può essere esposto come oggetto scultoreo; oppure può essere trasformato in una performance nel momento in cui questi progetti di biodesign passano da uno stato di riposo a diventare parte di una figura umana. A questo punto, il Tilex non si limita a essere un oggetto di decorazione o un semplice accessorio grottesco, ma aggiorna i sensi intorno alle future forme di abbigliamento, facendo scivolare una critica verso l’industria della moda.
Dimensione(i) metodologica(e)
Sebbene i casi presentati in questo capitolo non costituiscano un campione rappresentativo dell’indagine in corso, essi mostrano la diversità delle materialità, dei progetti e delle proiezioni che le opere bioartistiche hanno a livello nazionale e internazionale. È che la pratica bioartistica si basa su un fondamento che, emergendo in istanze che superano gli spazi canonizzati
della circolazione dell’arte, implica un’irruzione nella sua osservazione e analisi. Per questo motivo, la competizione delle categorie legate alla biosemiotica trova la sua strumentalizzazione nei modi in cui non si studiano più unità chiuse di significato ma processi, senza perdere di vista il potenziale della dimensione testuale come risorsa esplorativa. Come sottolinea il semiologo argentino Pampa Arán a proposito dei paradigmi semiotici che si allontanano dallo strutturalismo, assumendo che il testo costituisce un “ dispositivo pensante” si prende anche posizione sulle caratteristiche invariabili in cui questi testi possono essere analizzati. Se comprendiamo che il testo occupa il posto del segno come unità culturale che media tra la molteplicità dei sistemi semiotici (Arán 2019, p. 52), allora si può supporre che il loro posto resiste alla loro iscrizione in almeno un genere, una tipologia, un archetipo. Questa caratteristica dinamica, a sua volta legata alla pura potenza sia nella biosfera che nella semiosfera, è utile per analizzare le opere bioartistiche in base al loro luogo di mediazione. Né interno, né esterno: ogni elemento di un’opera bioartistica costituisce un’unità suscettibile di essere analizzata come un sistema, poiché, come sottolinea Arán,
perché un testo “funzioni” deve accettare l’inclusione di un altro testo, di un altro meccanismo intelligente, sia esso nella forma di un lettore, di un ricercatore, di un contesto culturale […]. Il testo funziona quando si connette con un altro testo o coscienza semiotica che interagisce in modi molto diversi, che può essere o meno omogeneo con esso e che può “tradurlo” (interpretarlo, passarlo a un altro codice). (Arán 2019, p. 53-54, traduzione a cura degli autori)5
Presentato in questo modo, potremmo chiederci: qual è il testo nel lavoro di Hall e Bergotini? Sono solo i tessuti che devono essere contemplati
5 “Para que un texto ‘trabaje’ debe aceptar la inclusión de otro texto, otro mecanismo inteligente, ya sea en forma de lector, de investigador, de contexto cultural […]. El texto trabaja cuando se conecta con otro texto o conciencia semiótica que interactúa de muy diferentes formas, que puede ser o no homogénea con él y que puede ‘traducirlo’ (interpretarlo, pasarlo a otro código)” (Arán 2019, pp. 53-54).
nell’analisi o anche il processo di creazione e il legame che questi tessuti hanno con un quadro che li supera?
Le scelte metodologiche presentate in questo capitolo intendono delineare un possibile arco il cui unico presupposto è relazionale: leggere i testi come meccanismi intelligenti che si connettono ad altri testi al di fuori del piano verbale implica la progettazione di uno strumento in grado di sistematizzare questa molteplicità di materialità. Nell’indagine generale sulle pratiche bioartistiche, è stato possibile individuare almeno tre modi principali in cui questi testi stabiliscono legami tra loro: a) attraverso dispositivi che stabiliscono una comunicazione interspecie; b) attraverso lo sviluppo sperimentale di materiali organici; e c) attraverso l’esplorazione di processi viventi. In ognuna di queste modalità è possibile trovare modi unici in cui i bioartisti stabiliscono una relazione con agenti organici o inorganici non umani.
Date queste coordinate di lettura, l’analisi delle opere selezionate deve essere governata da principi processuali che permettano di leggere la molteplicità degli stati della cultura nel suo complesso. Questa continuità, che diventa leggibile sia concettualmente sia nelle riflessioni satellitari che le compongono, si manifesta nella natura dell’oggetto da analizzare nella misura in cui stabilisce una comunicazione con almeno due sfere di significato: la natura e l’arte. È quindi possibile organizzare una tipologia che segmenta gli stati in cui avvengono i passaggi da una sfera all’altra.
• L’identificazione dei materiali organici (la loro origine, l’habitat naturale e l’eventuale uso convenzionale).
• L’intervento su elementi organici che l’agente (bioartista, scienziato, ecc.) effettua su quel materiale organico.
• La traduzione di questi materiali in un altro universo di significato o gruppo di testi.
Di conseguenza, è possibile individuare sia nelle Matices foliares di Hall che nelle Tilex di Bergottini una serie di effetti di significato legati da quello spostamento che comporta in particolare un lavoro di trasferimento
di significati: da quei testi appartenenti all’ordine organico come la yerba mate alle sue implementazioni nella semiosfera: come indumento o come tessuto deperibile.
Il concetto di testo artistico come perno teorico
Lotman afferma che “Tiutchev […] pone con precisione filosofica una questione che lo ha sempre tormentato: quella della doppia natura dell’uomo come essere inserito nella natura e che non trova posto in essa” (Lotman 1993, p. 44). E d’altra parte, sostiene che “La cultura possiede quindi un processo dinamico ininterrotto di nascita e rinascita del significato il cui meccanismo è proprio l’arte” (Lotman 1994, p. 71, traduzione nostra).
Natura, cultura, arte e uomo come “canna pensante” sono alcuni dei concetti che Lotman riunisce nella sua prospettiva semiotica. In linea con il pensiero di Ilya Prigogine, adotta una visione critica della linearità del processo storico in cui gli eventi accadono in modo causale (Arán 2023).
Lotman inoltre concepisce la costruzione culturale come uno scenario dinamico, in movimento permanente, in cui l’arte gioca un ruolo centrale nei processi di significato.
Le idee di “traduzione” ed “esplosione” in Lotman ci permettono di avvicinarci al significato dell’opera come a una duplice operazione. Da un lato, la capacità di raccogliere conoscenze provenienti da diverse discipline e differenti ordini di percezione sensibile in un testo originale (che non va inteso solo come manifestazione letteraria) di natura metadiscorsiva per la sua condizione poetica, cioè per la sua possibilità di raccogliere il sapere e di esprimerlo in modo universale. Dall’altro lato, il funzionamento dell’opera d’arte come esplosione, nella misura in cui la sua comparsa nella semiosfera produce una catena infinita di semiosi che non è possibile controllare. Questo caso di esplosione ci permette di incorporare il ruolo del caso nei processi di significazione, dove la traduzione artistica articola i segni e la creazione di significato secondo una propria logica che non risponde alla tradizione epistemologica scientifica, ma alle possibilità pragmatiche di riconoscimento degli aspetti dell’opera d’arte che la comunità di menti identifica come prioritari e funzionali in base al contesto.
Per Lotman c’è un’istanza precedente alla formazione della semiosfera, che è lo stadio della biosfera. In questo margine di significato, tra il sistema culturale e quello extra-culturale, egli colloca la “doppia natura” a cui si accennava in precedenza. La “specie umana”, come si dice oggi, presenta questa tensione dovuta alla sua condizione organica e culturale.
Pensando a quel confine che Lotman “risolve” passando dalla biosfera alla semiosfera, la biosemiotica contribuisce nel suo sforzo di pensare il significato biologico anche da un punto di vista semiotico. Il tentativo ha i suoi limiti, come giustamente sottolinea Claudio Rodríguez Higuera:
All’espressione di questi problemi si aggiunge la possibile divergenza tra le nozioni di significazione che possono essere applicate, ad esempio, al codice genetico (Barbieri 2008) e ai codici culturali. Nel primo caso si tratta di un tipo di biosemiotica che non cerca di implementare le nozioni peirciane per stabilire l’esistenza della significazione a favore di un sistema di corrispondenze organiche in grado di rendere conto della significazione biologica (Barbieri 2014). D’altra parte, i codici culturali non sembrano collocarsi in un quadro simile, richiedendo l’esistenza di sistemi di segni di fondo per essere efficaci (Posner 2004). Mentre le corrispondenze e i sistemi di regole possono presentare un isomorfismo superficiale, non c’è una chiara mossa per impalmare i cosiddetti sistemi semiotici senza una teoria intermedia. (Rodriguez Higuera 2017, p. 134, traduzione a cura degli autori)6
6 “A la expresión de estos problemas se le añade la divergencia posible entre las nociones de significación que puede aplicarse, por ejemplo, al código genético (Barbieri 2008) y a los códigos culturales. En el primer caso estamos hablando de un tipo de biosemiotica que no busca implementar nociones peirceanas para establecer la existencia de la significación a favor de un sistema de correspondencias orgánicas capaces de dar cuenta de la significación biológica (Barbieri 2014). Por otra parte, los códigos culturales no parecen situarse dentro de un marco similar, requiriendo la existencia de sistemas de signos de trasfondo para ser efectivos (Posner 2004). Si bien las correspondencias y los sistemas de reglas pueden presentar isomorfia superficial, no hay un movimiento claro para el andamiaje de los sistemas llamados semióticos sin una teoría de por medio” (Rodríguez Higuera 2017, p. 134).
Come sostiene Rodríguez Higuera, è ancora necessario costruire una teoria semiotica che risolva queste differenze tra la semiotica della cultura e la biosemiotica. Tuttavia, per quanto riguarda la concezione del ruolo dell’arte, entrambe coincidono nella loro funzione differenziale nel quadro dell’Umwelt. Forse possiamo pensare a questo punto in comune come a un inizio di avvicinamento e complementarità, a partire da esperienze interdisciplinari come quelle proposte dalla bioarte, dove il significato esplode creando ponti inaspettati.
Ponti epistemici
Nonostante questi limiti, il valore epistemico della teoria di Lotman rivela una serie di premesse che tendono a smontare le tesi dominanti della scienza occidentale del XX secolo, da cui il carattere di ponte epistemologico (Gherlone 2013) che la sua semiotica può assumere con strumenti provenienti da teorie e quadri intellettuali diversi. L’approdo alla nozione di semiosfera come risultato metodologico di una serie di intersezioni tra le scienze naturali, le scienze sociali e le scienze umane si inserisce sia in una discussione sul valore delle discipline in una transizione scientifica, sia in un’autentica preoccupazione di definire la cultura come organismo accessibile da studiare. La risorsa categoriale del semiologo slavo permette quindi di collegare concetti apparentemente disparati, oltre a quelli già citati: “cervello” e “cibernetica” rivelano la matrice fondante della semiotica di Lotman, una semiotica che opera attraverso l’analogia e il ragionamento, che si installa in un continuum e che, come sottolinea Laura Gherlone, fa parte di una preoccupazione trasversale alle discipline scientifiche in un momento di transizione:
Tra il XIX e il XX secolo l’orizzonte delle scienze, soprattutto in Occidente, ha visto (e vede tuttora) il passaggio da una visione “monoculare” (meccanicistica e deterministica) della scienza a una visione complessa e multiprospettica. Nel campo delle scienze formali e fisico-naturali, si è riconosciuta la necessità di una revisione radicale dei presupposti attorno ai quali la scienza tradizionale si definiva e si riconosceva. L’epistemologia ha dovuto fare i conti con l’ideale positivista del “massimo della datità”, che richiedeva una
scienza unificata, quantitativa, matematica e assiomatica (Gismondi 2002).
La risposta del mondo scientifico a questa definitività è stata un cambiamento di prospettiva, che ha visto l’emergere di una scienza basata su una pluralità di modelli e metodi euristici e sull’assunzione dell’analogia come categoria epistemologica per la comprensione dei diversi livelli di realtà attraverso cui l’oggetto (della ricerca scientifica) può manifestarsi. (Gherlone 2013, p. 325)
Come quadro intellettuale, questo ponte epistemico ha continuità con una tradizione filosofica che mette in tensione la posizione dell’osservatore per de-antropomorfizzare lo sguardo scientifico e, con esso, le sue metodologie e assunzioni di analisi. L’idea di Antropocene sviluppata da Rosi Braidotti (2013) si basa su una critica del capitalismo avanzato e della mercificazione delle forme di vita con l’obiettivo di denaturalizzare la visione dicotomica degli scambi umani e non umani. “Nell’era del capitalismo biogenetico e del continuum natura-cultura – scrive Braidotti (2013, p. 112) – la zoe/vita è diventata una forza infraumana e tutta l’attenzione è ora rivolta all’emergenza della scomparsa della natura”. Il capitalismo biogenetico, come fase recente dello sfruttamento neoliberale, è responsabile della trasformazione delle forme organiche (Braidotti utilizza l’espressione greca zoe per definire le forme di vita umane e non umane) in una merce pronta in qualsiasi momento allo scambio e al beneficio. Questa dinamica porta, sempre nei termini di Braidotti, ad assumere che tutti i materiali siano solo per il consumo e, con ciò, vengono cancellati tutti i loro segni di identità: come sono stati prodotti, con quali materie prime, ecc. Il meccanismo con cui si sostengono domanda e offerta ha, nella dimensione biologica, la cancellazione delle tracce che si possono leggere in un rapporto natura-cultura. Questa cancellazione è ciò che le proposte di Braidotti e Haraway cercano di discutere per rivitalizzare un possibile continuum tra questi due stati semiotici, la biosfera e la semiosfera. In queste circostanze, la semiotica della cultura che Lotman definisce si installa come punto di incrocio tra le teorie immanentiste ed esternaliste dell’analisi dell’arte. Se il funzionamento della cultura è governato principalmente da relazioni di analogia, allora le sue operazioni
di lettura e decodifica si svolgono attraverso unità relativamente stabili di informazione (testi) che permettono il passaggio di queste unità in materialità significative di natura diversa. Questo viene affermato all’inizio di Tesi sullo studio semiotico della cultura (Lotman et al. 1968) dove, al di là della specificità del materiale di lavoro, la sua proposta delimita la premessa iniziale in cui una cultura fa circolare i suoi testi, e che tutta l’attività umana dedicata all’elaborazione, allo scambio e all’immagazzinamento di informazioni ha una certa unità e, a sua volta, né l’elaborazione, né lo scambio, né l’immagazzinamento sono regolati in modo da poter funzionare in modo isolato. Il carattere “relativamente autonomo” di questa doppia ipotesi è ciò che permette a Lotman di presentare le zone di confine che le discipline semiologiche predominanti dell’epoca (soprattutto lo strutturalismo francese) scartano in base al principio di immanenza. È quanto sottolinea Jorge Warley (2013) a proposito della definizione di Lotman, non solo dell’oggetto di studio ma anche della prospettiva scientifica, quando evidenzia che “era a disagio per il fatto che questa dottrina ufficiale [che si basava su formalismo e strutturalismo] era in realtà il contrario di ciò che predicava di essere” (Warley 2013, p. 73). Il carattere contraddittorio è ciò che porta Lotman a generare una teoria che stabilisce un dialogo tra entrambe le dimensioni alla ricerca di una sistematizzazione dei modi in cui i testi circolano in una data cultura. Su questa base, la definizione di testo ottiene una definizione che si basa sugli sviluppi legati alla biologia e alla teoria dell’informazione. In entrambe le discipline, il problema della trasmissione dell’informazione (sia genetica che documentale) rappresenta uno degli oggetti di studio che permette a Lotman di definire i testi come soggetti che integrano, in qualche senso o aspetto, una struttura che immagazzina informazioni e le trasforma. “Il testo – scrive Lotman (1996, p. 56) – ci viene presentato non come la realizzazione di un messaggio in una singola lingua, ma come un dispositivo complesso che immagazzina vari codici, capace di trasformare i messaggi ricevuti e di generarne di nuovi”. Lotman pensa i testi non più come entità isolate o autosufficienti, ma piuttosto in generatori di informazioni con una propria capacità intellettuale. Questa caratteristica si accentua quando si pensa al testo artistico, poiché, come si è detto, le possibilità di significato acquistano maggiore forza ed
esplosione. Questo dibattito raggiunge il suo punto più forte nei contributi di Struttura del testo artistico (1996).
Ogni testo artistico può svolgere la sua funzione sociale solo se esiste una comunicazione estetica nella comunità contemporanea a questo testo. Poiché la comunicazione semiologica richiede non solo un testo, ma anche un linguaggio, l’opera d’arte, presa da sola senza un certo contesto culturale, senza un certo sistema di codici culturali, è simile a un “epitaffio in una lingua incomprensibile”. Ma poiché l’atto di comunicazione artistica, come ogni comunicazione, presuppone l’esistenza di una comunità specifica che comunica attraverso sistemi di segni, si pone la questione dei due possibili tipi di relazione tra testo e codice: la sintesi e l’analisi. (Lotman 1996, p. 345, traduzione a cura degli autori)
Come si vede, ciò che Lotman definisce comunicazione artistica non risiede nella purezza di un’opera artistica, ma nella sua attivazione: da meccanismo di lettura o trasmissione di informazioni che mettono in gioco ciò che il testo permette di decodificare. In questo modo, la visione di Lotman sul funzionamento del testo artistico permette di articolare le riflessioni di Braidotti e Haraway come “contesto culturale” in cui le opere di bioarte di Hall e Bergottini acquistano significato. Nel pensarlo sia come quadro teorico che come pratica artistica, è possibile riconoscere punti di contatto che tentano di rendere “leggibile” un insieme di fenomeni che in un altro periodo non avrebbero acquisito il significato e gli effetti che conosciamo.
Dalla semiotica della cultura alla biosemiotica
La biosemiotica può essere letta come il risultato di uno sviluppo teoricometodologico fondato sulla semiotica lotmaniana, in quanto si nutre del carattere cibernetico e de-antropomorfizzante dello sguardo semiotico. Occupandosi direttamente della comunicazione interspecifica, questa disciplina acquisisce una singolare rilevanza nell’insieme delle teorie e delle pratiche artistiche sopra citate, in quanto pensa in modo frattale la circolazione del sapere: la distinzione tra scienza e pratica artistica o filosofica si fonde in un’unica trama per studiare il potere dei segni come semiosi
che non deve necessariamente passare attraverso l’intelletto umano. Come sottolinea Adrian Pablé (2020) nella sua ipotesi di integrazione biosemiotica, il punto di vista di chi assume una prospettiva biosemiotica comprende che la semiosi (come relazione triadica e processuale) si manifesta in termini empirici: i batteri, per riformulare il caso dell’autore, si sono trovati in una semiosi molto prima dell’essere umano, essendo anch’essi parte dello scambio di messaggi. Come si può supporre, questa ipotesi rappresenta una sostanziale distanza dalle basi fondanti della semiologia proposta da Ferdinand de Saussure nella sua proposta di studiare i segni all’interno della vita sociale, poiché la prospettiva biosemiotica si concentra sullo studio dei segni che superano il livello della semiosi sociale.
L’evoluzione del formato delle opere d’arte come oggetti inerti, tradizionalmente associato a dipinti e sculture, si è orientata verso la presenza di opere viventi nella scena contemporanea, costringendo la teoria dell’arte a ripensare le proprie categorie per comprendere la dimensione performativa (e vitale) di queste espressioni. In questo senso, la tradizione epistemologica della semiotica della cultura e della biosemiotica forniscono una visione più ampia che comprende la dimensione biologica e i processi di significazione come tipici di qualsiasi sistema naturale o artificiale autonomo.
L’Umwelt esperienziale è radicato nel corpo materiale e semiotico dell’organismo, che è di nuovo situato in una parte specifica dell’habitat a seconda della sua nicchia (eltoniana). Una vera teoria dell’Umwelt non deve porre alcun potere spirituale o vitalistico occulto per “spiegare” l’emergere delle Umwelten nell’evoluzione, ma deve riconoscere la ricchezza e la realtà dei fenomeni del sentire, dell’agire e del percepire organismici. (Emmeche 2001, p. 659, traduzione a cura degli autori)7
7 “El Umwelt experiencial está enraizado en el cuerpo material y semiótico del organismo, que nuevamente está situado en una parte específica del hábitat dependiendo de su nicho (eltoniano). Una teoría real del Umwelt no debe plantear ningún poder oculto espiritual u oculto vitalista para “explicar” el surgimiento del Umwelten en la evolución, sin embargo, debe reconocer la riqueza y la realidad de los fenómenos de detección, actuación y percepción organísmicas” (Emmeche 2001, p. 659).
Le opere di bioarte hanno una condizione originale poiché lavorano con materiali organici che hanno un margine di autonomia in ogni fase del processo artistico: ideazione, produzione, esposizione. Questo perché i biomateriali, in particolare, non smettono di trasformarsi essendo sensibili alle modificazioni ambientali. Lo stesso protocollo potrebbe non essere utile se non si prendono le necessarie precauzioni per preservare le condizioni di temperatura e umidità in cui sono stati preparati in origine. C’è sempre un margine di errore che deriva dalla dimensione artigianale di questa pratica, o quella che chiamiamo la dimensione situata della sperimentazione.
D’altra parte, lo stesso può accadere nel caso della mostra, dove l’esposizione in un ambiente chiuso, con temperature variabili, illuminazione artificiale, movimento di persone e altri elementi che non possiamo controllare nello spazio del museo o della galleria, sono tutti elementi che concorrono ad influenzarsi vicendevolmente. Questa affettazione tipica delle opere di bioarte che abbiamo citato può essere associata alla condizione di autonomia che esse mantengono in quanto sistemi qualitativi o, in termini di biosemiotica, organismi qualitativi.
L’opera Tilex, ad esempio, ha un’autonomia di sei-dodici mesi. Una volta completato questo ciclo, inizia a biodegradarsi. Durante questo processo che fa parte della poetica bioartistica, la struttura formale perde la sua solidità, l’odore della putrefazione dei microrganismi che la sostengono altera anche l’ambiente percettivo originario. Allo stesso modo, il biomateriale può diventare un ospite per altri microrganismi che generano colonie visibili all’occhio umano sul tessuto, modificandone il design e la texture. In questo modo, l’opera muta di fronte agli stimoli ambientali esterni e di fronte alla propria condizione biologica, dando luogo alla visibilità del significato biologico non solo come elaborazione di informazioni e stimoli che riproducono la vita, ma anche come meccanismo complesso che testimonia la finitudine dell’entità (altra condizione condivisa tra le specie umane e non umane).
Lo stesso può accadere con il lavoro di Hall. A differenza di Bergottini, che è una scienziata e produce in condizioni di laboratorio, Hall crea i suoi biomateriali in modo artigianale, incorporando in tutto il processo creativo la dimensione biosemiotica che risiede nell’autonomia comportamentale della materia vivente. La comunicazione con la materialità
risalta ancora di più nell’ambiente di lavoro domestico, poiché le variabili da considerare per la creazione artistica sono maggiori. La cura nella selezione e nella raccolta delle materie prime, così come l’osservazione attenta durante l’intero processo di cottura, costringono l’artista a uno stato di riconoscimento permanente. Le reazioni prodotte dagli stimoli artificiali che vengono tentate da Hall accumulano una conoscenza specifica, frutto della negoziazione biosemiotica tra tutte le variabili coinvolte.
Sia nel caso della yerba mate, che Bergottini utilizza come materia prima principale del suo lavoro grazie alla sua origine geografica, sia nel caso di Hall, che raccoglie noci, agrumi, frutta e spezie dal suo ambiente rurale, la categoria dell’Umwelt può essere identificata operando sia nelle condizioni semiosferiche degli artisti sia in quelle biosferiche degli elementi originali. Entrambe le dimensioni generano le condizioni perché il testo artistico emerga e l’Umwelt presente in ogni istanza biologica (dai microrganismi agli organismi superiori) funga da ponte epistemico tra il quadro teorico della semiotica della cultura e la tradizione biosemiotica.
Conclusioni
In questo capitolo abbiamo cercato di utilizzare alcuni elementi teorici di matrice lotmaniana, che prevedevano un quadro interdisciplinare in cui sia le scienze che le produzioni artistiche concorrono a fornire condizioni di esplorazione e conoscenza. La teoria di Lotman, oltre a essere una teoria della cultura, rappresenta anche una teoria della conoscenza e di come i testi, lungi dall’essere materiali statici, cambino nel tempo e nello spazio. Il caso dei biomateriali rende trasparente questa condizione di trasformazione, ma è importante sottolineare che si tratta di una caratteristica di tutti i testi: anche quelli appartenenti al campo classico delle lettere e delle arti che non utilizzano materiali organici, contengono comunque una componente che entra in gioco nella circolazione di una semiosfera. Nel caso dei tessuti, questa trasmissione di informazioni si raddoppia, poiché vengono trasferite informazioni legate alla genetica e alla risignificazione di una pratica antica per la conservazione dell’umanità, come la creazione di tessuti per proteggersi o ripararsi. Nei casi di Hall e Bergottini possiamo osservare che c’è un impegno a riorientare i modi di pensare il posto dei
tessuti non solo nella loro funzione più iniziale (quella di coprire il corpo) ma anche a pensare al loro ingresso nel campo delle discipline artistiche. Questi due elementi, se letti in un continuum di pratiche significative, sono strettamente legati alla riflessione sulla risignificazione delle pratiche considerate artistiche in sé, poiché il lavoro di pezzi bioartistici propone l’uscita dall’“atelier” nel suo senso più tradizionale per occupare altri luoghi come il laboratorio o addirittura, a livello domestico, la cucina di casa. Questa transizione è anche ciò che codifica il passaggio dalla bioarte definita come mainstream alla bioarte situata, in quanto evidenzia la singolarità delle pratiche e dei processi di creazione in un determinato momento e luogo. Allo stesso modo delle opere tessili, questa produzione rappresenta solo alcuni frammenti del tessuto che compone questa pratica artistica, così come i cambiamenti di prospettiva che vengono mobilitati sia a livello individuale che sociale.
Infine, dovremmo tornare concettualmente all’idea di degradazione, tipica dei biotessili, come marchio che mira a costruire un’esperienza estetica a partire dalla decomposizione. Questa caratteristica non rappresenta forse un modo unico di osservare ciò che il capitalismo biogenetico assume come rifiuto? Quali domande suscita la disciplina bioartistica riguardo alle condizioni di biodegradabilità non solo di questi componenti, ma anche di tutte le forme di vita? In una prospettiva lotmaniana, è ora possibile capitalizzare questo apparente stato di perdita come momento di produzione di senso e che, lungi dal rappresentare un ostacolo, costituisce un passaggio che può essere recuperato come la principale caratteristica della biosfera: la costante circolarità delle manifestazioni vitali, delle relazioni comunitarie e dei segni.
Riferimenti
Arán, P. (2023). Temporalidades humanas. La dinámica de los sistemas culturales y su interpretación histórica. In Designis Hors Serie 02. Semiótica de la Cultura. De Yuri Lotman al futuro. unr.
Arán, P. (2019). Bajtín y Lotman. Paradigmas y nuevos espacios culturales. In La herencia de Bajtín. Reflexiones y migraciones unc-cea Braidotti, R. (2013). The inhuman: Life beyond death. In The Posthuman. Polity. Emmeche, C. (2001). ¿Tiene un robot un Umwelt? Reflexiones sobre la semiótica cualitativa de Jakob von Uexküll. Semiotica, 134(1/4), 653-693.
Stubrin e Eric Hirschfeld
Facultad de Ciencias de la Educación e Universidad Nacional de Entre Ríos. (2022). Finalizó el seminario sobre biomateriales. Autore. Auhttps://www.fcedu. uner.edu.ar/2022/11/28/finalizo-el-seminario-sobre-biomateriales/ Gherlone, L. (2013). Lotman’s epistemology: Analogy, culture, world. Sign Systems Studies, 41(2-3), 312-338. https://ojs.utlib.ee/index.php/sss/article/view/ SSS.2013.41.2-3.09
Hall, A. P. (2023). Matices foliares. Ana Paula Hall. https://anapaulahall.cargo.site/ Haraway, D. (2016). Antropoceno, Capitaloceno, Plantacionoceno, Chthuluceno. Generando relaciones de parentesco. Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales, 3(1), 15-26.
Kac, E. (1998). El arte transgénico. Leonardo Electronic Almanac, 6(11). Karu [@Somos Karu]. (2019). Biodiseño consciente [porfilo]. https://www.instagram. com/somoskaru/?hl=es
Kozak, C. (a cura di). (2012). Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando y de arte y tecnología. Caja Negra.
Kull, K. (2016). Ecosemiótica del arte. ¿Puede la naturaleza ser embellecida? En J. Allora e G. Calzadilla, Puerto Rican Light (Cueva Vientos). Catalogue (pp. 103-113). Dia Art Foundation.
Lotman, J. M., Uspenski, B., Viachesklav, I., Piatigorski, A. e Todorov, V. (2007). Tesis para el estudio semiótico de las culturas (aplicadas a los textos eslavos). Entretextos, Revista Electrónica Semestral de Estudios Semióticos de la Cultura, 6-11(7), 1-16. (Pubblicato originariamente nel 1968).
Lotman, J. M. (1993). La semiótica de la cultura y el concepto de texto. Escritos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje, 9, 15-20.
Lotman, J. M. (1993). Cultura y explosión. Lo previsible y lo imprevisible en los procesos de cambio social. Gedisa.
Lotman, J. M. (1996). Estructura del texto artístico istmo. (Pubblicato originariamente nel 1970).
Pablé, A. (2020). Integrating biosemiotics: From a semiological point of view. Sign Systems Studies, 48, 125-145. https://ojs.utlib.ee/index.php/sss/article/view/ SSS.2020.48.1.07
Rodríguez Higuera, C. (2017). Integración jerárquica de la biosemiótica hacia la significación cultural. Revista Chilena de Semiótica, 6
Stubrin, L. e Cattaneo, M. J. (2023). Biosemiótica y las explosiones de sentido del bioarte. Revista Designis, 38, 99-108. https://www.designisfels.net/wpcontent/uploads/2023/05/designis-i38p99-108.pdf
Warley, J. (2013). Yuri Lotman. La semiótica de la cultura. In Entre Semióticas. Bosque de signos, animales simbólicos. Biblos.
Yeregui, M. (2017). Prácticas co-creativas. Decolonizar la naturaleza. Artelogie, 11. http://journals.openedition.org/ artelogie/1601
Abstract
Quello che i polpi non dicono: i racconti animali di Vinciane Despret
Autobiografia di un polpo e altri racconti animali è una tappa importante nel lavoro di Vinciane Despret: filosofa e psicologa che da oltre vent’anni si interroga sugli animali e su chi li osserva. Un’etologia degli etologi che trova il proprio complementare in quella che, nell’introduzione italiana al libro, Emanuele Coccia definisce “un’etnografia del non umano”. I tre racconti che compongono Autobiografia di un polpo sono uniti da un filo conduttore: alcuni scienziati facenti parte dell’Associazione di Terolinguistica (la linguistica degli animali selvatici) si interrogano su una serie di casi bizzarri ma non implausibili. Quello adottato è uno sguardo che immagina ciò che saranno, più che gli animali, le nuove prospettive di ricerca nell’ambito dell’etologia. In questo quadro, ragni, polpi e vombati sembrano veramente, come li definisce Marrone (2022), creature “para-borgesiane”: questo lavoro, come Il libro degli esseri immaginari (Borges 1967), è per sua natura un “libro dei sogni” (Scarano 2014). Ma la terolinguistica non è così lontana dalla realtà. Gli animali sono inquadrati dall’autrice come dei creatori la cui opera diviene visibile nell’interazione. Questo contributo lavorerà su Autobiografia di un Polpo in comparazione a Il libro degli esseri immaginari di Jorge Luis Borges. Il focus è sul tema della trasformazione nel rapporto uomo-animale: sarà indagata la dimensione somatica (declinata nella percezione, nella spazialità e nell’aspetto patemico), la differenza fra diveniranimale (Deleuze, Guattari 1980) e ibridi, nonché una breve riflessione sulle ontologie dominanti (Descola 2005) all’interno dei testi. Quello
Beatrice Vanacore
Introduzione
Vinciane Despret è una filosofa e psicologa belga che ha dedicato oltre vent’anni della sua vita a indagare l’affascinante tema del rapporto fra umani e animali e che ha divulgato il suo lavoro con un piglio pungente e spesso ironico. Al fine di avere una visione quanto più completa e sfaccettata del comportamento animale e della complessa relazione che può stabilirsi nell’incontro con gli umani, durante il corso della sua carriera Despret ha avuto modo di confrontarsi con diversi attori, animali e non: ha frequentato laboratori, fattorie e habitat di ogni sorta per osservare da vicino uccelli, elefanti, cavalli e scimmie e ha collaborato a stretto contatto con accademici, artisti, esperti, appassionati1. A prescindere dal caso, l’approccio della filosofa è caratterizzato da un’apertura verso il suo oggetto di studio: Despret non è strettamente ancorata a posizioni teoriche e metodologiche. Aspetta, piuttosto, che siano gli animali a mostrarle cosa valga la pena osservare: “Pensa con, da e come loro, li segue, osserva e impara da loro e in questo processo viene costantemente trasformata da loro. Cosa hanno da dire? Come si comportano? Che domande fanno? Com’è influenzato il loro comportamento dalla presenza di un osservatore?” (Buchanan 2015, p. 17).
Le sue fonti sono variegate: oltre all’osservazione sul campo, in laboratorio, negli zoo, nei centri di recupero per esemplari a rischio, in fattorie, ha raccolto informazioni utilizzando anche sorgenti quali YouTube, filmografia, letteratura e testi di storia e filosofia. Ogni storia che tratta non riguarda una sola specie ma è estendibile a più individui. Allo stesso tempo, però, l’autrice non generalizza: non vi è un singolo animale che possa parlare per la totalità della sua categoria2. Al centro vi è sempre l’interazione fra attori umani e animali e il mutamento reciproco che ne deriva.
1 Fra questi, sono incluse collaborazioni proficue con Isabelle Stengers, Jocelyne Porcher, Didier Demorcy, Luc Petton (Buchanan, Chrulew, Bussolini 2015).
2 E così, ad esempio, il caso della consapevolezza del sé attraverso l’atto del riconoscimento allo specchio, già identificata da Lacan (1974) come momento in cui è possibile vedere l’emergere dell’Io, viene trattato sia nel caso degli elefanti che in quello delle gazze ma non in quello di tutti gli elefanti e di tutte le gazze (Despret 2012). Queste ricerche dicono qualcosa sugli individui, non sulla specie. Anche l’insuccesso degli altri soggetti sperimentali dimostra che la buona riuscita dello studio non dipende strettamente dal setting o dallo strumento utilizzato:
Questo pensiero non equivale all’antropomorfismo, agli animali non sono attribuite caratteristiche umane: è un aggiustamento - nell’accezione landowskiana del termine (2008) -, una trasformazione mutua e costante, nessuno è neutro nell’osservazione. Questo tema è ben trattato in un capitolo dedicato a quelle che Despret identifica come “pratica gentile delle abitudini” in Quando il lupo vivrà con l’agnello (2002, p. 106), dove l’autrice parla dell’esperienza di ricerca di Jane Goodall e altri primatologi. In questi casi, caratterizzati da lunghe osservazioni sul campo, emerge il tema della trasformazione: se cambiamo le nostre abitudini, diamo modo agli animali di fare lo stesso con le loro. L’etologia, nella sua accezione etimologica, vale a dire una pratica delle abitudini, permette a Despret di esplorare delle relazioni fra prassi consolidate. Sono i primati a trasformare i loro ricercatori; la conoscenza ci porta a modificare le nostre abitudini intellettuali e, così, uno scimpanzé può portare un primatologo a evolvere in qualcosa di nuovo. L’uomo si fa interessare da ciò che interessa a coloro che interroga.
Despret è una studiosa molto preziosa per quella visione di una zoosemiotica da intendersi come meno naturalistica quanto piuttosto “come un’analisi semiotica a tutto campo, senza distinzioni pregiudiziali, dove a essere pertinenti, semioticamente, non sono le essenze (‘animale’, ‘uomo’…) ma le relazioni reciproche e le trasformazioni narrative, le trasfigurazioni uomo → animale e viceversa animale → uomo.” (Marrone 2017, p. 25). Questo perché, come abbiamo avuto modo di vedere, Despret non abbraccia un’osservazione neutra, anzi. Il problema, e a questo punto sarà chiaro, non è studiare gli animali ma studiare le società in cui gli animali sono inseriti.
Come afferma Marrone, “dire che ‘degli animali non sappiamo nulla’ ha un significato possibile solamente in un’ontologia naturalista che intende la conoscenza come risultato evidente di esperimenti scientifici puri i quali, per principio, danno luogo a verità uniche e a leggi indiscutibili. Se invece, ritraducendo Despret, si utilizza uno sguardo
la possibilità di fallimento rende vero il successo ed esclude la possibilità di trovarci di fronte a un condizionamento.
semiotico, questa affermazione appare assai fallace” (ivi: 32-33). Le pratiche sociali implicano necessarie forme di sapere e di valorizzazione, sono esplicitabili grazie all’analisi dei percorsi e dei valori della narrazione. Possiamo, insomma, ricostruire le motivazioni e l’interiorità dei personaggi, fittizi o meno, umani o non umani. Questa forma di sapere, per Vinciane Despret, non può derivare dal punto di vista di un osservatore obiettivo, distaccato: la sua soggettività deve essere presente sul campo. L’etologia è inquadrata, non come il rapporto asimmetrico fra un soggetto e il suo oggetto di studio, ma come quello fra due soggetti: include la relazione intersoggettiva fra di essi, dove ognuno cambia, e può cambiare, in connessione con l’altro.
Autobiografia di un polpo e altri racconti animali è una tappa importante nel lavoro di Despret. Fra scienza e fantascienza, il libro si compone di tre racconti uniti da un filo conduttore: i membri dell’Associazione di Terolinguistica (la linguistica degli animali selvatici) si interrogano su una serie di casi bizzarri ma non implausibili. Despret immagina l’Associazione partendo dal racconto di Ursula K. Le Guin (1974) in cui l’autrice racconta della traduzione, da parte di alcuni membri dell’ente, di messaggi lasciati con secrezioni ghiandolari su semi di acacia dalla loro autrice, una formica operaia; nello stesso racconto, Le Guin parla anche del nuoto dei pinguini (o meglio, del loro volare in acqua) come forma comunicativa prettamente cinetica e, chiaramente, non verbale. In tutti e tre i racconti vi è una presenza che aleggia, in maniera più o meno evidente, sulle vicende narrate: i rischi del cambiamento climatico.
Questo saggio lavorerà su Autobiografia di un polpo e altri racconti animali di Vinciane Despret in comparazione con Il libro degli esseri immaginari, di Jorge Luis Borges. Il focus sarà sul tema della trasformazione che incorre nell’instaurarsi del rapporto fra uomini e animali: sarà trattato l’aspetto della corporeità (declinata nella percezione, nel rapporto fra corpo e spazio e in quello fra corpo e passioni), quello della differenza fra ibridi e divenire animale - facendo riferimento a Mille Piani (Deleuze, Guattari 1980) - e sarà, infine, fornita una breve riflessione sulla visione ontologica (Descola 2005) che emerge nelle due opere.
Etologi e altri esseri immaginari
Forniamo una sinossi essenziale di Autobiografia di un polpo. Nel primo racconto, L’indagine sugli acufeni o i cantori silenziosi, Despret racconta una strana epidemia di acufeni che sembra colpire i ricercatori che svolgono i propri studi su ragni utilizzando il diapason e provocando, dunque, delle vibrazioni percepibili dagli aracnidi. Gli acufeni, emerge poi, altro non sono che le urla dei ragni stessi:
Nella parte superiore dell’atmosfera si sarebbe creata una vera e propria ‘fonosfera’ satura di vibrazioni, ‘una rete invisibile di onde che avvolge il pianeta’ e si riverbera sulla superficie della Terra. Di conseguenza, i ragni, così sensibili alle vibrazioni trasportate dall’aria, dagli alberi e dalle piante, dalla terra e dalle rocce, si trovano in quel che sarebbe l’equivalente nel sistema sonoro di una continua cacofonia […] I ragni ora gridano in onde. E noi siamo, con i nostri cosiddetti acufeni, camere d’eco della disperazione dei ragni (Despret 2022, p. 29-30).
Il secondo racconto, La cosmologia del vombato comune (Vombatus Ursinus) e del vombato dal naso peloso (Lasiohinus Latifrons), esplora le ragioni dietro alla principale particolarità dei vombati: piccoli marsupiali australiani, noti, appunto, per produrre in natura feci dalla forma cubica. A lungo i ricercatori si sono interrogati prima sul come e, in seguito, sul perché di tale peculiarità: la teoria maggiormente diffusa vede i cubi come più funzionali alla costruzione di pareti all’ingresso dei lunghi cunicoli sotterranei in cui i vombati vivono. Despret immagina queste strutture, invece, come esistenti per due ipotesi. La prima è quella di segnalare riparo ad altri animali per gli incendi che hanno devastato l’Australia negli ultimi anni: “Sono state del resto queste solide e vistose pareti a guidare molti animali verso le tane dei vombati per cercare rifugio durante i tragici incendi che devastarono l’Australia ed eradicarono gran parte dei suoi abitanti altri che umani alla fine della seconda decade del XXI secolo” (ivi: 44). L’altra ipotesi è quella che vede le pareti come “narrazioni polifoniche” (ivi, 60) investite di un alto valore simbolico: “I vombati avrebbero una cosmologia. […] le pareti fecali sarebbero una maniera di rivolgersi a entità di
cui i vombati avevano intuito, sentito, percepito, immaginato e convocato l’esistenza — divinità o antenati, o forse divinità e antenati che avrebbero, loro stessi, lasciato tracce, ancora presenti e attive, delle proprie pulsioni creatrici” (ivi: 59-60).
L’ultimo racconto, Autobiografia di un polpo o la comunità degli Ulisse, tratta del ritrovamento da parte di alcuni pescatori di un’iscrizione eseguita da uno o più polpi su un pezzo di vasellame. Evento assai insolito dato che, ci ricorda l’autrice, i polpi, data la loro natura di creature furtive, maestre di mimesi, non dovrebbero voler lasciare tracce. Per fornirne una traduzione fedele al messaggio ritrovato, una ricercatrice dell’Associazione di Terolinguistica svolge uno studio immersivo in una comunità in cui umani e polpi vivono in simbiosi. I polpi, però, da anni sono assenti, prossimi all’estinzione, a causa della pesca intensiva e dell’inquinamento delle acque: “C’erano ancora durante le prime generazioni, mi è stato detto, ma il loro numero è diminuito fino all’estinzione […] La comunità ha fatto tutto quel che poteva per proteggerli, ma l’acqua è diventata sempre più tossica, i molluschi sempre più scarsi, senza che ciò peraltro scoraggiasse la pesca intensiva che ha continuato a imperversare” (ivi: 90-91).
Come è già stato accennato, Despret fa molti riferimenti al racconto fantascientifico del 1974 di Le Guin; eppure, apparirà a questo punto chiaro, gli animali di cui tratta non fanno nulla di fantastico. Non ci troviamo di fronte a creature chimeriche: sappiamo che i ragni sono sensibili alle vibrazioni, le speculazioni dietro alle feci cubiche dei vombati alimentano le ricerche degli etologi da tempo, i polpi, da che mondo è mondo, hanno sempre prodotto inchiostro. Ciò che è fantascientifico, in questo libro, è l’interpretazione che i ricercatori danno a tali comportamenti. Ancora più precisamente: più che fantascienza, sarebbe più corretto affermare che, quella descritta dall’autrice, è l’anticipazione di un futuro possibile. Il titolo originale – Autobiographie d’un poulpe et autres récits d’anticipation – svela, infatti, la natura di questa raccolta di racconti: una prospettiva che immagina ciò che saranno, più che gli animali, i nuovi orizzonti di ricerca nell’ambito dell’etologia. Ragni, polpi e vombati, in questa ottica, diventano veramente, come li definisce Marrone, creature “para-borgesiane” (2022, p. 161). Il riferimento è ovviamente a Manuale di zoologia fantastica, di Jorge
Luis Borges e Margarita Guerrero, del 1957. Dopo la prima pubblicazione, l’opera viene revisionata da Borges e ripubblicata dieci anni dopo con un nuovo titolo: Il libro degli esseri immaginari. In questa riedizione, vengono aggiunte trentatré nuove voci e viene, inoltre, sostituito il prologo originale mantenendo, tuttavia, il carattere composito e inevitabilmente incompleto del libro, il quale invita i propri lettori a ispirarsi a chi “gioca con le forme mutevoli svelate da un caleidoscopio” (Borges 2006, p. 15) per poterlo fruire nel modo prescritto dai due autori.
L’opera si presenta come una raccolta enciclopedica di esseri fantastici: incluse citazioni di autori che descrivono animali particolari (per citarne alcuni: Plinio, Ovidio, Erodoto, Shakespeare), animali provenienti dal mondo onirico3, la rielaborazione di altri bestiari, sia orientali che occidentali (Yelin 2008). Possiamo, inoltre, trovare animali come la pantera o il pellicano4 descritti, tuttavia, producendo un’immagine che si discosta radicalmente da quelli della zoologia comune. Borges stesso lo precisa: “Nei bestiari medievali, la parola pantera designa un animale assai diverso dal ‘mammifero carnivoro’ della zoologia contemporanea” (Borges 2006, p. 165); e, ancora, “Il pellicano della zoologia comune è un uccello acquatico, di due metri d’apertura d’ali, di becco molto lungo e largo, e che ha fra le branche della mascella inferiore una larga sacca in cui ripone i pesci predati; quello della favola è più piccolo, e il suo becco è breve e acuto” (ivi: 167). Siamo di fronte a casi che richiamano quello del rinoceronte di Dürer, il pittore che, nel 1515, disegnò un rinoceronte pur non avendone mai visto uno in vita propria basandosi in parte sulla cultura classica (Plinio e Aristotele e molti altri hanno descritto i rinoceronti), in parte su una lettera – e uno schizzo – ricevuta dall’amico Valentim Fernandes, che aveva avuto modo di vederne uno di persona, Ulisse, regalato al re del Portogallo (Eco 1975). L’incisione di Dürer mostra una creatura che ricorda, inequivocabilmente, un rinoceronte ma di cui alcuni dei tratti salienti in natura sono assolutamente inesistenti: su tutti, le squame.
3 “Un animale sognato da Kafka”, “Un animale sognato da C.S. Lewis”, “Un animale sognato da Poe” (Borges 2006, pp. 30; 31-32; 33-34).
4 “La pantera”, “Il pellicano” (Borges 2006, pp. 165-166; 167-168).
Con Il libro degli esseri immaginari di Borges (1969), Autobiografia di un polpo condivide la natura di “libro di sogni” (Scarano 2014, p. 254): siamo però di fronte a due lavori profondamente diversi. La più evidente delle differenze è la natura degli animali presenti all’interno delle opere. Gli animali descritti da Borges e Guerrero sono veramente immaginari. Quelli di Despret, al più, sono immaginati5 in quanto fittizi (alla stregua di Argo nell’Odissea): sono animali plausibili che mettono in atto, in linea generale, comportamenti da animali interpretati, però, da umani che hanno subito (o stanno subendo) una trasformazione.
La seconda differenza sostanziale fra le due opere sta proprio nel rapporto uomo-animale presentato all’interno dei testi e alla conseguente trasformazione di cui, con essa, entrambe le parti sono investite. Come già accennato, uno dei punti centrali nella teoria della filosofa belga è il concetto di trasformazione strettamente legato alla più generale idea di una società basata su in intersoggettività di attori umani e animali in costante interazione e mutamento. Per Despret, è essenziale lavorare sulle comunità composte da umani e animali che intrattengono fra loro relazioni di vario tipo a partire da circostanze e pratiche variegate. Va, insomma, studiata la società e gli attori che in essa prendono parte. L’etologia degli etologi, sempre presente nel lavoro di Despret (e particolarmente evidente in Autobiografia di un polpo), rende manifeste le entità complesse – ma non per questo ibride – che ne risultano, entità umanimali (Marrone 2019).
Così, nel racconto di Autobiografia di un polpo o la comunità degli Ulisse, questo concetto viene portato all’estremo: sono descritte comunità di “coabitazione multispecie” (Despret 2022, p. 75) in cui umani e una specie animale vivono in maniera simbiotica (in questo caso i polpi ma nel racconto si fa accenno a una comunità che vive interconnessa alle farfalle). Ad ogni nuovo nato umano (simbambino), ne è assegnato uno animale affinché questi possano vivere in una comunione perfetta, talvolta facendo persino ricorso a modifiche genetiche. Il punto, però, non è quello di una trasformazione da uomo ad animale (né, tanto meno, il contrario): quello
5 Per approfondire la differenza fra animali immaginari e animali immaginati, Spinicci (2021) propone un interessante criterio di classificazione.
descritto da Despret in questo lavoro, e ampiamente discusso in altre sedi, è una trasformazione in qualcosa di altro. Un divenire reciproco che si ha nell’interazione e, proprio perché in essa avviene, non può che essere continuo: “Era con i polpi, e per loro, che ogni simbambino diventava sé stesso, cioè altro. Così diceva mia nonna, ha ripetuto Ulisse: diventavamo noi stessi diventando altri” (ivi: 93). Questa trasformazione vede al centro di essa, ovviamente, il corpo: non solo è una trasformazione che implica un cambiamento corporeo ma avviene proprio perché vi è un’intersoggettività in cui i corpi si influenzano reciprocamente6
Corpi in trasformazione
Marrone (2005) delinea tre campi di interesse, per la semiotica, che riguardano il corpo. Il primo è lo studio della figuratività e dell’estesia, per cui il significato (linguistico o semiotico) non necessita solamente di specifiche competenze cognitive per essere compreso ma esige operazioni interocettive ed esterocettive (figurative, collegate alla percezione del mondo); è la percezione a permettere l’individuazione di una soggettività (me) e di un’oggettività (altro) ed è nel momento in cui questo meccanismo – normalmente, talmente naturalizzato da essere dimenticato – torna a imporsi che si ha la presa estetica (Greimas 1987).
Il secondo campo di interesse è quello della spazialità e lo è in maniera duplice: da una parte, lo spazio significa a partire da chi lo vive, un soggetto dotato di corpo (o più corpi) che interpreta le proprietà di tale spazio come significante sulla base dei propri programmi d’azione; dall’altro, è lo spazio, in virtù delle sue proprietà, a essere dotato di articolazioni significanti e a determinare (o almeno, incoraggiare) certe azioni piuttosto che altre. Inoltre, le categorie semantiche proprie dello spazio (alto/basso, destra/sinistra, aperto/chiuso…), a seconda dei singoli testi e delle influenze culturali, sono investiti di una valenza timica. E così, per esempio, il basso può essere disforico e l’alto euforico.
6 Per approfondire la sua visione, Despret parla del rapporto corpi e interazione in Che cosa rispondono gli animali… se facciamo le domande giuste? nella sezione dal titolo “Corpi. Va bene urinare davanti agli animali?” (Despret 2012).
Abbiamo, infine, la prospettiva della dimensione passionale (Greimas, Fontanille 1991). Le logiche narrative organizzano azioni e affetti. Se le prime sono legate a un aspetto cognitivo, le ultime si trovano nel corpo, lo prendono producendo comportamenti somatici ben riconoscibili. Sebbene questi tre orizzonti non siano scindibili, l’analisi proposta in questa sede si concentrerà singolarmente su ognuna di queste pertinenze, relazionandole al tema della trasformazione.
Corpo e percezione
Nel primo racconto, Indagine sugli acufeni o i cantori silenziosi, quella che viene presentata è un’epidemia di acufeni che interessa gli aracnologi che svolgono ricerche sui ragni mediante l’uso di diapason, uno strumento costituito da due rebbi e che, colpito, vibra producendo una frequenza stabile. La ricerca consiste in quanto segue: appoggiando il diapason sulla ragnatela o sul corpo stesso del ragno, i ricercatori osservano e analizzano i comportamenti degli oggetti di studio: alcuni si avvicinano, altri scappano. Ciò che è particolare, però, non sono i comportamenti dei ragni (alla descrizione dei quali, nel racconto, è riservato uno spazio molto contenuto) ma le conseguenze di questa interazione sui ricercatori stessi. Questi presentano tutti quelli che vengono identificati come acufeni, dei suoni fantasma prodotti dal cervello in risposta alla perdita dell’udito. Emerge poi, a seguito di uno studio comparativo fra ricercatori e pazienti affetti da queste sensazioni acustiche, che gli aracnologi stanno manifestando qualcosa di diverso. In primo luogo, al contrario dei facenti parte del gruppo di controllo, non provano dolore, non presentano danni all’udito e, in terzo luogo “l’intero gruppo di aracnologi ha dichiarato che in senso stretto non si tratta veramente di suoni, ma di vibrazioni, che si traducono in pensieri. Affermano anche di non essere mai stati a conoscenza di questa atipica capacità sinestetica […] e le regioni attivate durante la sensazione di vibrazioni, come si vede chiaramente dalla Tac, sono le stesse che di solito si illuminano quando un soggetto si trova nel corso di una conversazione” (Despret 2022, p. 28). I suoni (o meglio, le vibrazioni) percepite dai ricercatori non sono, insomma, acufeni ma le grida dei ragni: i timpani dei ricercatori vengono usati come
“camere d’eco” (ivi: 30). Un quadro che, ovviamente, vede la percezione come estremamente pertinente.
Una prima osservazione doverosa riguarda l’ambiguità fra soggettività e oggettività che per il soggetto percipiente, almeno in un primo momento, non sono molto ben delineate: non solo si parla di acufeni, sensazione di origine endogena, ma i messaggi che li accompagnano (prodotti dai ragni) sono definiti di “natura allucinatoria” (ivi: 24). Il punto di vista è, insomma, falsato: è chiaro chi percepisce ma non è chiaro cosa sia percepito. Una seconda osservazione riguarda l’attenzione che viene data al livello plastico: viene specificato più volte che, quella esperita dagli aracnologi, non è un’esperienza di matrice uditiva ma vibratoria, tattile, che si accompagna a un suono e che viene identificato dagli individui come un pensiero non loro, come il fischio di un acufene. Accanto al plastico – uno strano “vibrurlo” (ivi: 30) –, vi è il figurativo: i ricercatori riconoscono delle frasi. L’ambiguità sta nel fatto che la causa di queste ultime è fraintesa: al vibrurlo, essendo un suono mai sentito prima, è difficile attribuire una causa al momento della percezione.
Spazio del corpo
Per quanto concerne il rapporto fra corpo e spazio, è nel terzo racconto che troviamo il più eminente dei casi per parlare di questo aspetto. Viene, infatti, articolato il discorso intorno ai polpi, sia come contenuti, che come contenitori.
Il corpo del polpo all’interno dello spazio tocca l’aspetto della mimesi. L’autrice illustra come questi animali siano soliti, grazie alla loro capacità di mutare forma, testura e colore, di scomparire fra i fondali marini. È, ovviamente, una competenza che può rivelarsi un’abile tattica da giocare in una struttura polemica che contrappone un Soggetto (preda) a un Anti-Soggetto (predatore). Ma, dice Despret, più che un reale tentativo di sparizione, quello a cui siamo di fronte è piuttosto un caso cattura delle caratteristiche degli ambienti circostanti come collegata a una pulsione creatrice: “Non smettono mai di cambiare forma e colore, e il loro uso dei luoghi non sfugge a questa regola: l’unica abitudine che possiamo riconoscere nei polpi, dicono i pescatori, è la loro costante volontà di infrangere
qualsiasi abitudine” (Despret 2022, p. 64); e, ancora, “In questo caso, non si tratta però di un’imitazione, ma di una vera e propria operazione di cattura con cui il polpo ‘fa mondo con le linee di una roccia, della sabbia e delle piante per diventare impercettibile’” (ivi: 68). Siamo, allora, di fronte a qualcosa di diverso: “l’arte di nascondersi, cioè di coprirsi ‘bricolando’ dall’ambiente diversi oggetti” (Fabbri 2011, p. 3). La capacità di mutare viene poi convertita, seguendo un’ipotesi “exaptativa del divenire” (Despret 2022, p. 69), in un atto espressivo grazie al quale il polpo non mima più l’esterno, scomparendo, ma mostra, invece, i suoi stati emotivi. Si delinea un quadro in cui, la continuità con lo spazio esterno – e dunque un apparire o un non apparire – diviene un modo per mentire (Eco 1975) e la discontinuità (o meglio, una continuità con la propria dimensione patemica) una forma espressiva.
Il corpo del polpo è, però, anche inquadrato come contenitore: “la morte fa tornare in vita il polpo, per ‘per la stessa via’, cioè in una forma di vita del polpo. In altre parole: i polpi credono nella metempsicosi. E avrebbero ragione. I sim più anziani, mi dice Ulisse, lo avevano già intuito. Alcuni pensano che quando un polpo muore, ritorna nel corpo di un altro polpo. E conserva la memoria delle vite precedenti ” (Despret 2022, pp. 101-102). Il corpo è quindi un contenitore “accogliente” (ivi: 98) che ospita quelle che l’autrice definisce anime dei polpi. Si presenta, così, una continuità dell’anima che coesiste con una discontinuità del corpo producendo una morte, una fine, solo apparente. In altre parole, un camouflage. “Per i polpi l’uso del termine ‘apparenza’ è un modo di riferirsi alla vita in contrapposizione alla morte. La vita è fatta di apparenze” (ivi: 101).
Corpo e passioni
Despret, in merito alla capacità mimetica del polpo, riporta un affascinante caso reale: l’osservazione di Heidi, un giovane esemplare di femmina, filmata mentre dorme e che, sognando, cambia colore: “Nel suo sogno sembrerebbe vedere un granchio, e i suoi colori, da bianchi, diventano giallo pallido […]. Ancora immobile, ma questa volta vestita di un verde simile alle piante che formano il suo paesaggio onirico, va infine a sedersi da qualche parte dove, senza essere vista, potrà gustarlo” (ivi: 69-70).
Nel racconto viene descritta una simbambina ormai anziana, e vissuta a stretto contatto con i polpi e che, similmente ad Heidi, è a sua volta in grado di cambiare colore a seconda delle emozioni provate (o meglio, subisce questo “tradimento” da parte del suo corpo): “era la sua pelle che ci impressionava più di tutto, perché cambiava colore, e si poteva conoscere e sentire, con un semplice sguardo, ogni sua emozione.” (ivi: 92). A ben vedere, il corpo di questa donna non fa niente di diverso da ciò che quello di qualunque umano già faccia: è preso dalle passioni. Normalmente, nel percorso passionale canonico, il soggetto percorre tre fasi – costituzione, sensibilizzazione (ulteriormente scandita in disposizione, patemizzazione ed emozione) e moralizzazione – ed è durante quella dell’emozione che l’individuo “torna” al proprio corpo (Greimas, Fontanille 1991; Fontanille 1993); più precisamente, il corpo è preso dalle passioni: si hanno delle manifestazioni somatiche che variano, ovviamente, a seconda della passione in esame provocando, nel soggetto che le prova, ora pianti e balbettii, ora tremori e urla. Nel caso della simbambina , ciò che accade è che l’individuo viene modalizzato per una manifestazione aggiuntiva con cui il corpo viene preso, con cui la passione diviene evidente e verrà poi moralizzata. A livello patemico, però, il soggetto non cambia, non cambia la valenza euforica o disforica che l’individuo attribuisce alle cose del mondo, non cambiano le passioni che può provare. Questa è un’ulteriore dimostrazione che, quello descritto, non è un cambiamento che conduce l’uomo ad essere animale e l’animale ad essere umano. Non ci troviamo, insomma, di fronte a una metamorfosi kafkiana come nel caso analizzato da Pezzini (1998), in cui quella presa in esame è un’evidente trasformazione da uomo ad animale che investe ogni aspetto dell’individuo: non solo corporeo (che, in realtà, non vediamo avvenire, dato che il racconto inizia a metamorfosi già avviata) ma anche, e soprattutto, patemico. Gregor Samsa, accanto alle facoltà di percepire il mondo come ha sempre fatto, perde sempre di più la capacità di provare passioni umane: all’inizio della metamorfosi, vive un ambiguo stadio intermedio in cui i suoi nuovi orizzonti timici sono ormai bestiali ma la moralizzazione è ancora completamente umana. Nel corso del racconto, la metamorfosi diverrà definitiva. Il caso di trasfigurazione costruito da
Despret e quello descritto da Kafka (1915), insomma, denotano una visione ontologica ben diversa (Descola 2005).
Ibridi in Borges
Il tema della trasformazione, nel Libro degli esseri immaginari, è illustrato in maniera molto differente rispetto ad Autobiografia di un polpo al punto che, si potrebbe affermare, non sia propriamente presente. O meglio, in un’opera che raccoglie e illustra in maniera affascinante ogni sorta di creatura mostruosa, onirica, frutto dell’intelletto umano, non possono mancare gli ibridi, inclusi quelli prodotti dall’incontro di caratteristiche umane e animali (tal volta di più animali, o di umani e piante). È, tuttavia, il tema della trasformazione, della metamorfosi, del divenire ad essere completamente assente nel Libro – a parziale eccezione del caso della Volpe cinese (Borges 2006, pp. 218-219), in grado di mutare le proprie sembianze in umane. Questa assenza viene annunciata già nel prologo al Manuale da Borges e Guerrero: “Deliberatamente escludiamo da questo manuale le leggende su metamorfosi dell’essere umano: il lobisòn, il werewolf, ecc.” (Borges 2006, p. 225).
Gli ibridi non sono, dunque, creature in divenire ma esseri che sono conformati fondendo caratteristiche umane e non umane. La natura degli ibridi raccolti nel Libro è perfettamente illustrata nella voce del centauro: “Il centauro è la creatura più armoniosa della zoologia fantastica. ‘Biforme’ lo chiamano le Metamorfosi di Ovidio; ma nulla costa dimenticarne l’indole eterogenea, e pensare che nel mondo platonico delle forme ci sia un archetipo del centauro, come del cavallo o dell’uomo” (ivi: 25).
Animali e umani (ma anche animali e animali) sono ben scissi e destinati a restare tali. Non si parla veramente di una relazione, sicuramente mai di un aggiustamento, tal volta di una struttura polemica, qualche altra di una coabitazione felice con strani pet7; non si produce, però, mai un mutamento in una parte o nell’altra.
Nel prologo del Manuale, Borges e Guerrero descrivono una scena ben precisa: “Un bambino, lo portano per la prima volta al giardino
7 Un incrocio (Borges 2006, pp. 122-124).
zoologico. Questo bambino sarà chiunque di noi o, inversamente, noi siamo stati questo bambino e ce ne siamo dimenticati […]. Il bambino vede animali viventi che mai aveva visto: vede giaguari, avvoltoi, bisonti, e più strano ancora, giraffe. Vede per la prima volta la sfrenata varietà del regno animale” (ivi: 225). Berger (1980) vede nello zoo l’emblema dell’impossibilità di una relazione uomo animale, il fallimento dell’incontro: quello di Borges e Guerrero non fa eccezione (Yelin 2008).
La scelta degli autori di escludere dal loro bestiario le metamorfosi viene aspramente criticata da Deleuze e Guattari in Mille piani (1980) nel capitolo-piano 1730. Divenir-intenso, divenir-animale, divenir-impercettibile… in cui i due affermano che Borges tralascerebbe completamente i problemi della muta e del divenir-animale. Il concetto di divenir-animale di Deleuze e Guattari è esattamente un’operazione di trasformazione che mette il punto di partenza e di arrivo in secondo piano: “Il divenire può e deve essere qualificato come divenire-animale senza avere un termine che sarebbe l’animale divenuto. Il divenire-animale dell’uomo è reale, benché non sia reale l’animale che egli diviene; e, simultaneamente, il divenire-altro dell’animale è reale benché tale altro non lo sia” (Deleuze, Guattari 2021, p. 338). È una nozione strettamente legata a un’altra cara agli autori: quella di molteplicità. In primo luogo, ogni animale è una muta (ed è, quindi, una molteplicità); in secondo luogo, ogni divenire è una molteplicità: il divenire è una linea che passa attraverso gli elementi che investe – e di cui è, gerarchicamente, più importante – formando un blocco all’interno del quale le entità sono difficilmente distinguibili.
Emblematica per illustrare la differenza fra le creature di Borges e la trasformazione che incorre nell’interazione uomo-animale illustrata da Despret, è la differenza fra epidemia e filiazione. Agli ibridi viene data una storia delle origini che si risolve in un atto di filiazione: così, i centauri avrebbero origine perché “Issione, re di Tessaglia, e una nuvola cui Zeus dette la forma di Era, generarono i centauri” (Borges 2006, p. 59) e il minotauro “mezzo toro e mezzo uomo, nacque dagli amori di Pasifae, regina di Creta, con un toro bianco che Poseidone fece uscire dal mare. Dedalo, autore dell’artificio che permise a quegli amori di realizzarsi, costruì il labirinto per rinchiudervi e occultarvi il figlio mostruoso.” (ivi: 147).
Dall’altra parte, il rapporto fra individui nella sfera umanimale è per sua natura orizzontale: avviene per un contagio reciproco che porta entrambe le parti a diventare qualcosa di altro da loro stessi. È doveroso, infine, citare uno degli esempi più celebri di divenire proposto dagli autori: quello dell’orchidea e della vespa, in cui l’orchidea prende le sembianze della vespa, la vespa diventa un pezzo dell’apparato riproduttivo dell’orchidea8. Quello che avviene è una “cattura di codice, plusvalore di codice, aumento di valenza, vero divenire, divenire-vespa dell’orchidea, divenire-orchidea della vespa, dove ciascuno di questi due divenire assicura la deterritorializzazione di uno dei termini e la riterritorializzazione dell’altro, e i due divenire si concatenano e si danno il cambio” (Deleuze, Guattari 2021, p. 45). Questo stesso esempio viene ripreso da Despret (che parla, però, di un’ape e un’orchidea) in Autobiografia di un polpo come metafora del rapporto fra uomini e polpi: “È un’orchidea, ha detto, Ophrys apifera, il cui fiore assomiglia alle femmine delle api. Anticamente, ha continuato, i maschi di queste api cercavano di accoppiarsi col fiore e ripartivano con il polline che depositavano altrove, su un altro fiore […]. Non rimane nulla dell’ape, ma sappiamo che è esistita grazie alla forma e ai colori del fiore” (Despret 2022, pp. 94-95). È qui che si coglie l’importanza della relazione e il rilievo di essa sopra le singole unità: al mancare di una delle parti, all’altra non resta che provare a colmare l’assenza: “Questa orchidea produce ancora fiori. Ma nessuna delle api che ne portavano l’immagine viene più a visitarla, perché queste api si sono estinte […]. Senza i loro partner, le orchidee hanno dovuto ricorrere all’autofecondazione –‘una strategia genetica di ultima istanza che ritarda solo l’inevitabile’” (ivi: 95). Con l’assenza del contagio, si deve ricorrere alla filiazione che porterà, però, a un’inevitabile morte.
Orizzonti ontologici
Il Libro, non solo tralascia completamente la documentazione delle metamorfosi, ma non si sofferma poi troppo neanche su possibili effetti della relazione uomo e animale. Anzi, la presenza di ibridi all’interno del libro
8 Immagine già presente nella Rechcerche proustiana (Proust 1921).
non fa altro che rafforzare la separazione uomo – animale (Yelin 2008). È, a questo punto, indispensabile soffermarsi sull’orizzonte ontologico che emerge nelle due opere.
Descola (2005) costruisce le sue celebri ontologie incrociando due parametri: ponendo uomo e animale come soggetti della comparazione, osserva se fra la dimensione fisica e quella cognitiva vi sia continuità o discontinuità. Da qui, è possibile ottenere quattro ontologie: il totemismo (continuità fisica, continuità cognitiva) è opposto all’analogismo (discontinuità fisica, discontinuità cognitiva); le posizioni intermedie sono invece occupate dal naturalismo (continuità fisica, discontinuità cognitiva) e dall’animismo (discontinuità fisica, continuità cognitiva). In un’ottica semiotica, le ontologie di Descola altro non sono che effetti di senso derivanti da determinati dispositivi discorsivi (Marrone 2017).
Nell’opera di Borges, data la natura estremamente variegata di voci che compongono questa curiosa enciclopedia (e che, a ben vedere, non sempre sono propriamente animali ma, molto più spesso, sono di esseri variamente provvisti di tratti umani) è complicato dare una lettura univoca all’orizzonte ontologico predominante all’interno del Libro. In questa sede, dunque, sarà nuovamente su tre ibridi che si concentrerà questa breve riflessione: il centauro, il minotauro, la sirena.
Il centauro è descritto, com’è ben noto, come un umano con le gambe da cavallo:
La più popolare delle favole in cui figurano i centauri è quella del loro combattimento con i lapiti, che li avevano invitati a certe nozze. Per gli ospiti, il vino era cosa nuova: a metà del festino un centauro ubriaco oltraggia la sposa […]. La rustica barbarie e l’ira sono simboleggiate nel centauro, ma ‘il più giusto dei centauri, Chirone’ (Iliade, XI, 832), fu maestro di Achille e di Esculapio, che istruì nelle arti della musica, della cinegetica, della guerra, e perfino della medicina e della chirurgia (Borges 2006, p. 60).
Proprio in virtù del suo venir descritto come dotato della cognizione di un essere umano, nei vizi e nelle virtù, sono proprio quelle zampe equine a costituire l’unica differenza sostanziale con un uomo. È quindi
possibile dire che il centauro è inquadrato, vista la continuità cognitiva e la discontinuità fisica, nell’ontologia animista. Lo stesso vale per la sirena: “Un’altra, nel 1403, passò per la breccia di una diga, e abitò in Haarlem fino al giorno della sua morte. Nessuno la capiva, ma le insegnarono a filare, e venerava per istinto la croce. Un cronista del secolo XVI ragionò che non era pesce, perché sapeva filare, e non era donna, perché poteva vivere nell’acqua” (ivi: 194). Sarebbe però, forse, più puntuale dire che Borges (e le fonti che riporta) ritraggono i centauri esattamente come umani con le zampe da cavallo e le sirene come delle donne con le code di pesce: degli ibridi appunto. La cognizione del centauro non somiglia a quella umana, è esattamente la stessa: è nel corpo, formato da una parte animale e una umana che si rafforza la scissione uomo-animale, una discontinuità fisica. Caso molto diverso, doveroso farne menzione, è quello del minotauro: “L’idea d’una casa fatta perché la gente si perda, è forse più singolare di quella d’un uomo con testa di toro […] Ci sta bene, nel centro d’una casa mostruosa, un abitante pure mostruoso” (ivi: 147). Il minotauro è “mostruoso” proprio in virtù dell’essere “un uomo con la testa di toro”, vi è dunque una discontinuità fisica a cui questa volta, però, si accompagna anche una discontinuità cognitiva. Infatti, sebbene Borges non riporti particolari testimonianze che si soffermano su questo aspetto della creatura, questa è pur sempre descritta come mostruosa, appunto, e cannibale: decisamente disumana. L’ontologia in cui è inquadrata è, quindi, quella analogista. Si potrebbe osservare che centauri o sirene e il minotauro presentano una differenza piuttosto evidente: mentre i primi hanno la parte superiore del corpo (e, dunque, anche la testa) umana, il secondo ha la testa di bestia. È piuttosto chiaro che, in una visione dualista che oppone il corpo alla mente, un capo umano sia la figurativizzazione di un intelletto umano; allo stesso modo, una testa di bestia non può che richiamare una mancanza di umanità: un mostro, appunto.
In Autobiografia di un polpo, d’altra parte, l’ontologia dominante è sicuramente quella animista. L’autrice costruisce un discorso che inquadra gli animali come, non solo capaci di comunicare, ma anche dotati di una pulsione creatrice: sarebbero cognitivamente simili all’uomo. Lo sono, però con le loro modalità, con i loro corpi che sono diversi dai nostri, con
competenze particolari. Qualcosa cambia nell’ultimo racconto: i simbambini, pur avendo dei corpi diversi da quelli dei polpi, sono tuttavia più simili a loro rispetto che ai non-sim. Ciò che è interessante, però, è il punto di vista con cui questa somiglianza è inquadrata: non sono i polpi a diventare, col tempo, più simili agli umani ma sono, bensì, questi ultimi a coltivare, pur mantenendo una differenza biologica che non si desidera neutralizzare, l’apprendimento delle caratteristiche fisiche e comportamentali dei molluschi (fino ad arrivare, come è stato descritto, ad introiettare la capacità di cambiare colore). Un vero divenire animale.
Conclusioni
La scelta di comparare Autobiografia di un polpo e Il libro degli esseri immaginari è derivata dalla natura delle due opere e dalla loro, apparente, similitudine: sono libri dei sogni (Scarano 2014). A ben vedere, però, le differenze che sono emerse nelle aree indagate dimostrano una distanza più profonda di quanto non sembri. La prima differenza sostanziale è nella natura degli animali descritti: quelli di Borges sono animali immaginari, quelli nei racconti di Despret sono plausibili, immaginati. Despret, all’interno del libro, si concentra molto sulle trasformazioni che investono uomini e animali: questo aspetto è stato analizzato focalizzandosi sulla corporeità in rapporto alla percezione, allo spazio e alle passioni. Il bestiario di Borges differisce profondamente sotto questo punto di vista. Il Libro non parla di trasformazione ma dedica largo spazio agli ibridi: sono stati comparati i concetti di divenir-animale e di ibridi in riferimento al pensiero di Deleuze e Guattari (1980). Infine, è stato ricostruito l’orizzonte ontologico che caratterizza le opere degli autori facendo riferimento alla teoria di Descola (2005).
Alla luce di queste osservazioni, è difficile incasellare il libro scritto da Despret come fantastico o fantascientifico. Autobiografia di un polpo è, piuttosto, una visione, un augurio per il futuro: la descrizione di un’attitudine alla ricerca che ponga sempre più sullo stesso piano ricercatore e oggetto di studio fino a rendere questa distinzione talmente labile da scomparire. Questi percorsi di metamorfosi sono già usati, in una certa misura, come strategie di abitudinarietà: un esempio è costituito dal lavoro di Barbara Smuts (Bertrand 2018; Despret 2012), primatologa che, ritrovatasi
a osservare sul campo il proprio oggetto di studio (un gruppo di babbuini), ha optato per una tattica specifica, ovvero provare – invano – a narcotizzare la propria presenza: “L’unica creatura per cui la scienziata, sedicente neutra, risultava invisibile era se stessa. Ignorare gli indizi sociali è tutto fuorché essere neutrali” (Despret 2012, p. 25). Solamente nell’interazione, mettendosi allo stesso piano di chi stava osservando, Smuts è riuscita a integrarsi con i babbuini, ottenere una chiave di lettura dei loro comportamenti e condurre fruttuosamente le proprie ricerche: “Da un punto di vista semiotico il percorso veridittivo, con le sue implicazioni attanziali, con le sue modulazioni sensibili e passionali, con le inversioni tra la fonte e il bersaglio che modificano posizioni e relazioni, mette in evidenza modelli trasversali e rende possibile una lettura dell’interspecificità” (Bertrand 2018, p. 216). Autobiografia di un polpo, portando agli estremi “la soluzione di continuità tra gli universi dell’espressione linguistica umana e quelli dell’espressione non umana” (ivi: 218) si posiziona nel panorama attuale della letteratura che alimenta la zoosemiotica come un’opera avveniristica: la concretizzazione della sfera umanimale.
Riferimenti
Berger, J. (1980). About looking. Pantheon. Bertrand, D. (2018). Postface. Animal, humain: quelles opérations trans-langagières, à quelles fins? In D. Bertrand, M. Costantini, R, Horrein (a cura di), La parole aux animaux. Conditions d’extension de l’énonciation. Fabula.
Borges, J. L. e Guerrero, M. (1957). Manual de zoología fantástica. Fondo de Cultura Económica.
Borges, J. L. (1967). El libro de los seres imaginarios. Kier, S. A. Buchanan, B., Chrulew, M. e Bussolini, J. (2015). Vinciane Despret. Angelaki, 20(2), 1-3. Buchanan, B. (2015). The metamorphoses of Vinciane Despret. Angelaki, 20(2), 17-32.
Descola, Ph. (2005). Par-delà nature et culture. Gallimard.
Despret, V. (2002). Quand le loup habitera avec l’agneau. Les Empêcheurs de penser en rond.
Despret, V. (2012). Que diraient les animaux, si… on leur posait les bonnes questions? Les Empêcheurs de penser en rond.
Despret, V. (2021). Autobiographie d’un poulpe: et autres récitsd’anticipation. Éditions Actes Sud.
Deleuze, G. e Guattari, F. (1980). Mille plateaux. Minuit. Eco, U. (1975). Trattato di semiotica generale. Bompiani.
Quello che i polpi non dicono
Fabbri, P. (2011). Semiotica e camouflage. In L. Scalabroni (a cura di), Falso e falsi. Prospettive teoriche e proposte di analisi (pp. 11-25). ets
Fontanille, J. (1993). Le schéma des passions. Protée, 21(1), 33-41.
Greimas, A. J. (1987). De l’imperfection. Pierre Fanlac.
Greimas, A. J. e Fontanille, J. (1991). Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d’âme. Éditions du Seuil.
Kafka, F. (1915). Die Verwandlung. Kurt Wolff.
Lacan, J. (1974). Lo stadio dello specchio come formatore della funzione dell’io. In Scritti (pp. 85-94). Einaudi.
Landowski, E. (2008). Les interactions risquées pulim
Le Guin, U. K. (1974). The author of the acacia seeds’ and other extracts from the journal of the association of therolinguistics. In T. Carr (a cura di), Fellowship of the stars. Nine science fiction stories. Simon and Schuster.
Marrone, G. (2005). La cura Ludovico. Einaudi.
Marrone, G. (2017). Bestialità: culture animali. In G. Marrone (a cura di), Zoosemiotica 2.0. Forme e politiche dell’animalità (pp. 23-37). Edizioni Museo Pasqualino.
Marrone, G. (2019). Il discorso animale. In D. Bertrand, G. Marrone (a cura di), La sfera umanimale. Valori, racconti, rivendicazioni (pp. 7-26). Meltemi.
Marrone, G. (2022). Vinciane Despret e la terolinguistica. Prometeo, 160, 160-162.
Pezzini, I. (1998). Le passioni del lettore. Bompiani.
Proust, M. (1921). Sodome et Gomorrhe. Gallimard.
Scarano, T. (2014). Un singolare inventario d’irrealtà. In J. L. Borges, Il libro degli esseri immaginari. Adelphi.
Spinicci, P. (2021). Notes for an imaginary zoology. Studi di estetica, 21. Yelin, J. (2008). El Bestiario inhumano. Sobre el manual de zoología fantástica de Jorge Luís Borges y Margarita Guerrero. In Ensayos sobre ciencia ficción y literatura fantástica: 1er Congreso Internacional de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción (pp. 745-751).
L’equivoca transcodifica tra Bíos ed Ethnos. Proposte ecosofiche per una biosemiotica in prospettiva strutturale
Abstract
Gianluca De Fazio
Il saggio ha come obiettivo di determinare un incontro possibile tra la biosemiotica e l’etnosemiotica, al fine di delineare una metodologia semiotica per la prospettiva dell’ecosofia contemporanea tramite un incontro possibile tra i concetti di Bíos e di Ethnos. Il capitolo analizza la Dwelling Perspective dell’antropologo Tim Ingold e l’incontro tra Uexküll e Saussure proposto, negli anni Cinquanta del secolo scorso, da M. Merleau-Ponty. L’idea è quella di sviluppare i presupposti filosofici per una possibile biosemiotica strutturale mediante una ecologia dell’animale umano basata sullo studio delle pragmatiche abitative nella loro determinazione fenomenologiche.
Nota preliminare sull’ecologia filosofica
La questione ecologica è oggi di grande attualità nei dibattiti accademici, politici e mediatici. Molti sono i temi che la attraversano: i complessi rapporti tra Natura e Cultura, i battaglieri incontri tra Hard Sciences e Humanities, gli equilibri metastabili tra le denotazioni naturalistiche dell’ambiente e le connotazioni valoriali del paesaggio, sono solo alcuni temi dei quali chiunque oggi si muova nel campo degli Environmental Studies ha sentito parlare.
Tuttavia, a fronte di questa diffusione capillare, il pensiero ecologico sembra ancora oscillare (O’Riordan 1981; Alexander 1999) tra una posizione culturalista, che fa sua l’idea che solo l’innovazione tecnologica possa porre rimedio alla crisi ambientale (Salman e Nagy 2019), e una posizione naturalistica, che si richiama a vario titolo a uno stile di vita più in linea con la Natura (Naess 2016). Inutile aggiungere, infine, che gli
ibridi di queste due posizioni possono assumere svariate configurazioni1. Non discuteremo qui queste posizioni2 , limitandoci a rilevare che il dualismo in cui incorre il pensiero ecologico richiede una vera e propria critica filosofica per evitare di incorrere in circoli viziosi teorici come quelli insiti nell’idea che l’attività dell’umano, che oggi sappiamo essere uno dei principali agenti ad alto impatto ecosistemico (Cook et al. 2013), possa essere al contempo tanto causa quanto soluzione della questione ecologica. Al contrario, sosteniamo che, proprio perché ormai altamente impattante sull’ecosistema Terra, sia la prassi umana stessa a dover essere al centro di uno studio ecologico.
Si può parlare, allora, a questo proposito di ecologia filosofica, o ecosofia (De Fazio 2021a; De Fazio et al. 2019), come articolazione contemporanea della filosofia critica, quella branca della filosofia che si pone il compito di descrivere concettualmente le condizioni trascendentali dell’attività umana e di seguirne la genesi fenomenologica3. Così posta la questione, culturalismo e naturalismo convergono nel non intaccare il nodo cruciale della questione ecologica. Se infatti intendiamo con il termine ecologia quella branca della biologia che studia le relazioni ecosistemiche tra gli organismi viventi e gli ambienti, ecco diventare necessario rendere il pensiero ecologico una metodologia d’analisi delle relazioni complesse tra l’essere umano e il suo ambiente: alla lettera, una ecologia dell’animale umano (Barthélémy 2022). Da questa prospettiva, non si tratta più di opporre una generica attività antropica a una natura edenica, ma di cogliere le pragmatiche umane nell’atto stesso del loro generarsi ecosistemico (Richerson 1976) al fine di produrre un modello filosofico per tematizzare la genesi delle relazioni tra l’umano, inteso come agente-organismo, e il suo mondo-ambiente. Ciò significa mettere in discussione la partizione cartesiana tra una materia partes extra partes e una condizione umana
1 Cfr. Cobley (2016); Richerson e Boyd (2005).
2 In parte lo abbiamo fatto in De Fazio e Lévano (2021).
3 Per i presupposti del nostro discorso rimandiamo a: Iofrida (2019); Villani e Fadini (2021); Bonato e Kirchmayr (2023); Brown and Toadvine (2003); Amoroso (2019); Missiroli (2022).
L’equivoca transcodifica tra Bíos ed Ethnos
spirituale4. A differenza di un semplice pezzo di materia fisica, l’organismo ha la capacità di instaurare relazioni sensate col mondo e mediante comportamenti orientati presenta sacche di finalità contingenti5, non è un meccanismo in esecuzione (Longo 2021). Non è, tuttavia, solo la nozione di oggetto che l’idea di organismo mette in questione, ma anche quella di soggetto cartesiano in quanto l’organismo instaura
una relazione dinamica di scambio fra due entità che sono sì distinte, ma inseparabili. Ne consegue che l’organismo non rappresenta un soggetto che avrebbe il mondo come suo oggetto, ma che esso è l’altra faccia del mondo (Iofrida 2012, p. 56).
La relazione dell’organismo col suo ambiente, a differenza di quella soggetto-oggetto, presenta molteplici strati di senso6: l’organismo e il suo ambiente fanno sistema. Se la tradizione moderna ha fatto del soggetto la forma pura della sintesi e polo univoco dell’attività, pensarlo come fenomeno vivente significa dismetterlo da perno metafisico attraverso il quale si regge ogni agentività e riconoscere, nel cuore stesso dell’attività umana, strati di non-umano che non sono riducibili a una ‘incrostazione della natura’ (l’immagine è di matrice hegeliana) bensì la condizione di possibilità di ogni attività umana.
In questo senso, è stato proposto di fondare l’ecologia filosofica su un paradigma del corpo (Iofrida 2019) che colga l’intreccio tra umano e non umano aprendo verso una prospettiva more-than-human7 e considerare l’umano non come qualcosa da superare (di cui si attesterebbe una condizione postuma), bensì da integrare in un paradigma di pensiero più vasto e ampio, trovando così un’agentività anche nell’elemento ambientale, in quell’altra faccia dell’organismo umano, che non è l’appendice inerte
4 Cfr. Hoffmeyer (2008, p. 318-322).
5 Cfr. Hoffmeyer (2008, p. 62-65).
6 Non solo l’organismo umano, si pensi al tema dell’animalità espressiva o alla Vegetal Turn, cfr. Sebeok (2011); Hedigher (2011), Hiernaux (2018), Marder (2013), Fogliato (2023), Zengiaro (2022).
7 Cfr. Moura Carvalho et al. (2020).
dell’Uomo Trascendentale, ma uno spazio di azione (Spielraum) delle possibilità esistenziali e vitali dell’attore umano.
Tra Bíos ed Ethnos
Occorre però sgombrare il campo da un possibile fraintendimento. Niente è più estranea a questa prospettiva quanto l’idea di fondare l’etica sul biologico. Non stiamo sostenendo una naturalizzazione dell’eticità. Un paradigma del corpo, piuttosto, ha come contropartita teorica quella di emancipare il corpo vivente (Leib) per ripensarne il portato soggettivo.
Un corpo è un precipitato di molteplici piani semiotici, è tanto forgiato culturalmente quanto determinato naturalisticamente, e perciò irriducibile tanto al primo quanto al secondo: la natura e la cultura non sono un fondamento, ma la determinazione del possibile di un organismo. L’idea di un corpo agente comporta anche l’impossibilità di sostenere, quando si tenta di ricostruire una struttura narrativa della crisi ecologica, l’idea di una unica specie, Homo Sapiens, che impatterebbe in maniera univoca sul sistema-Terra (Bonneuil, Fressoz 2016, p. 358). Col tema della soggettività-corpo (Subjektleib) si pone contestualmente il rapporto pratico con l’ambiente. Diventa fondamentale prestare attenzione alle differenze etnologiche dell’impatto antropico rendendo necessario l’incontro tra l’antropologia culturale e la semiotica. L’etnosemiotica permette all’ecosofia di “contestare l’euro-centrismo e oltrepassarlo sviluppando una problematica dell’universalità degli oggetti culturali e delle forme semiotiche” (Greimas, Courtés 2007, p. 116) tramite la sua capacità “di rendere conto della significazione in atto” (Marsciani 2017, p. 24) e dei processi di transcodifica dei sistemi semiotici culturali di riferimento, permettendo alla filosofia di pensare il Subjektleib come istanza di senso colta in un processo di significazione in actu attraverso “una ragnatela appena visibile, fatta di migliaia di scarti differenziali intrecciati” (Greimas 1974, p. 9). La prospettiva etnologica sul Senso ha il merito di frammentare e moltiplicare prospetticamente la cultura umana fino a farne un sistema variamente articolato di pratiche di senso8 o, correlati-
8 Cfr. Viveiros de Castro (2018, pp. 107 e ss).
L’equivoca transcodifica tra Bíos ed Ethnos
vamente, di evidenziare “la dimensione etnosemiotica delle pratiche” di vita (Fontanille 2018, p. 43).
Ciò però implica anche che questa pratica di senso ha, nella prospettiva del Subjektleib, una portata ecosistemica. La cultura è, ecosoficamente, una strategia messa in atto da una attanzialità ecologicamente determinata. È importante rilevare che qui sosteniamo una determinazione ecologica e non un determinismo biologico. Ritenere infatti la significazione culturale fondata su quest’ultimo, significherebbe fondare l’etico su una sostanza. Si tratta, invece, di tenere presente la centralità della relazione: un determinismo relazionale che presenta dei margini di gioco (Spielraum) nella relazione tra l’organismo e l’ambiente (De Fazio 2021b; Amoroso 2019).
D’altro canto, è opportuno evitare la tendenza opposta e complementare alla naturalizzazione, ossia un culturalismo realtivista, che di fatto eliminerebbe anch’esso la centralità della relazione, mantenendo un relativismo superficiale (Latour 2009, pp., 121-170) dove ad avere priorità sono i sistemi significanti già determinati e non i processi di significazione che si danno nella relazione: il relativismo privilegia i poli alla relazione stessa. Si tratta di inserire quella ragnatela fatta di migliaia di scarti differenziali all’interno di ulteriori relazioni, ricercando nel rapporto ecosistemico del corpo la genesi della sua attanzialità. Ritrovare, al di sotto della narratività manifesta, non una sostanza ultima, bensì le impalcature semiotiche che determinano le potenzialità del Subjektleib. Si tratta di pensare la capacità del corpo di produrre scarti differenziali, cioè fare segni. Così, se l’etnosemiotica rappresenta l’ascissa dell’etica ecosofica, per determinarne l’ordinata è necessario orientarsi verso una prospettiva che potremmo chiamare biosemiotica, se con questa intendiamo quella disciplina che studia i fenomeni semiotici negli esseri viventi.
La biosemiotica propriamente detta ha senz’altro una genealogia di tutt’altro genere rispetto alla semiotica greimassiana richiamata, e per suo stesso atto di nascita si ispira alla semiotica interpretativa. Ma è forse possibile ipotizzare una biosemiotica da un punto di vista strutturale. Se è vero che la biosemiotica postula che “all living creatures are semiotic systems and that semiosis is not a side-effect but a fundamental process in life” (Barbieri 2007, p. 180), è anche vero che in alcune delle sue direttive
essa postula la possibilità di una separazione della semiosi dall’ipotesi interpretativa proprio in virtù del fatto che un sistema semiotico vivente è piuttosto un code-maker che non un interpretante. La sfida della biosemiotica necessita di separare la “semiosis from interpretation and to study them as two different processes” (Barbieri 2007, p. 202).
Non ci interessa qui discutere, cosa che non rientra nel nostro expertise, dei rapporti complessi tra semiotica generativa (Marsciani e Zinna 2022) e semiotica interpretativa (Paolucci 2010), ma di evidenziare quali questioni filosofiche si pongono con l’idea di una nuova genesi del processo semiogenico. L’idea è che etnosemiotica e biosemiotica offrano, ciascuna secondo la propria prospettiva, due aspetti fondamentali per un pensiero ecologico filosoficamente avvertito, permettendo di studiare i modi in cui i sistemi viventi umani interagiscono in maniera significante con l’ambiente e di pensare a questa agentività come una semiosi corporea, ossia indipendente dalle pure significazioni linguistiche. Quella dell’organismo con l’ambiente è una relazione sensata, perciò, non solo per l’etnologo o per l’ecologo che la studia, ma anche dal punto di vista soggettivo del vivente umano (in quanto Subjektleib) che si trova catturato attivamente in operazioni di transcodifica continua dal piano dei codici biologici a quello dei codici culturali. Così, l’idea di un’etica ecosofica si situa, come detto, sul crinale tra le denotazioni naturalistiche e le connotazioni valoriali, presentandosi come quella disciplina atta a proporre una ‘antropologia dal punto di vista pragmatico’ fondata sulla potenzialità semiotica, semiosica e transcodificante a un tempo, dell’animale umano nelle relazioni ecosistemiche. La partizione tra animale umano e soggetto trascendentale diventa più complessa: né completamente persona né completamente organismo, si tratta di far emergere un piano di consistenza diverso da quello che la tradizione filosofica ci ha tramandato.
Se la questione ecologica non è meramente l’oggetto contemplativo della filosofia, ma la sfida contemporanea per il pensiero, è una relazione differente che va instaurata tra l’Ethnos e il Bíos, tra la vita sociale e quella biologica. La ricerca di una nuova sintesi tra questi due piani di articolazione è alla base della ricerca, ormai trentennale, dell’antropologo culturale
L’equivoca transcodifica tra Bíos ed Ethnos
Tim Ingold (2000). Un richiamo alla sua proposta nota come Dwelling Perspective (dp) potrebbe essere un buon punto di partenza, nella misura in cui ci si approccia al tema biologico a partire da un’esigenza interna alle discipline etno-antropologiche stesse.
Prima di commentare, parzialmente e solo ai nostri fini di argomento, la proposta di Ingold, ci sia concesso insistere ancora su questa esigenza dell’antropologia culturale. Ciò è importante anche perché la possibilità di una biosemiotica strutturale si può inserire in un contesto di ragionamento più ampio che investe le discipline ‘etno’. In gioco vi è la possibilità di pensare uno strutturalismo emendato sia dal riduzionismo linguistico che dalle ‘rivoluzioni’ che, negli anni Sessanta, hanno condotto alla destrutturazione post-moderna. Per indicare brevemente in cosa una biosemiotica strutturale può aiutare l’antropologia, si pensi, ad esempio, a questo passaggio di Lévi-Strauss (1972, pp. 39-40):
L’uomo è un essere biologico e contemporaneamente [c.n.] un individuo sociale. Tra le risposte che egli fornisce agli stimoli esterni o interni, alcune dipendono integralmente dalla sua natura, ed altre dalla sua condizione. […] Il fatto è che la cultura non è né semplicemente giustapposta né semplicemente sovrapposta alla vita. Per un verso essa si sostituisce alla vita, per un altro la utilizza e la trasforma per realizzare una sintesi di altro ordine. […] Negare o sottovalutare l’opposizione [tra natura e cultura] significa vietarsi ogni intelligenza dei fenomeni sociali. Se però si concede a questa opposizione la sua piena portata metodologica, si rischia di erigere in mistero insolubile il problema del passaggio tra i due ordini. Dove finisce la natura? Dove comincia la cultura?
Lévi-Strauss sintetizza molto bene la difficoltà di base di conciliare biologia ed etnologia nella determinazione sociale del comportamento e sottolinea un aspetto che riteniamo cruciale: l’idea, cioè, che la cultura sia un certo uso della vita. Ciò filosoficamente significa che la cultura non è una condizione umana opposta a uno stato di natura ferina, ma una strategia che l’animale umano mette in gioco nel suo processo vitale. La cultura, diciamo noi, ha una portata bio-strategica, nel senso peculiare dell’uso
strategico delle proprie caratteristiche biologiche (non, invece, in un senso di riduzionismo biologico delle pratiche culturali).
Questa idea la ritroviamo, pur con le dovute differenze del caso, anche in Descola (2021, p. 7-8), che concepisce l’antropologia culturale come una vera e propria ecologia delle relazioni umane, la quale ha lo scopo di
contribuire insieme ad altre scienze, e secondo metodi propri, a rendere intelligibile il modo in cui degli organismi di un tipo particolare s’inseriscono nel mondo, ne acquisiscono un’interpretazione stabile e contribuiscono a modificarlo tessendo con esso e fra loro, legami costanti o occasionali di una notevole, ma non infinita diversità. [O]ccorre dunque tracciare innanzitutto la cartografia di questi legami […] ed esaminare come essi prendano forma in maniere di essere al mondo immediatamente distintive.
Ecco che, in chiave ecosofica, l’antropologia incontra favorevolmente l’ecologia, ponendo al centro dell’interesse di ricerca gli usi della vita e le strategie ecosistemiche che l’animale umano mette in atto, ossia, per prendere a prestito le parole di Ingold, i modi in cui fa del mondo la propria casa (oikos).
Pensare per relazioni
Al cuore della Dwelling Perspective (dp) si trova il rapporto complesso tra la vita vivente dell’organismo umano e le sue strategie di adattamento all’ambiente e trasformazione ecosistemica. Questa idea posiziona la dp in una genealogia filosofica che ha tentato in vari modi di conciliare le categorie trascendentali e il fenomeno vivente. Questa tradizione, che storicamente nasce quantomeno nella Germania di fine Settecento grazie alla Critica del Giudizio di Kant e al lavoro pionieristico di Goethe, solo per citare i più noti, ha trovato importanti luoghi di elaborazione nel pensiero francese del Novecento: autori come Bergson, Merleau-Ponty, Derrida e Deleuze hanno affrontato questo tema. Ingold è strategicamente utile poiché oltre a offrire una prospettiva antropologica ecologicamente orientata, attraverso un pensiero per relazioni, cerca una sintesi tra biologia e discipline etno-sociali di tipo nuovo
L’equivoca transcodifica tra Bíos ed Ethnos
rispetto tanto a quella del paradigma neo-darwinista del gene egoista, che “ci propone lo strano spettacolo di una biologia dalla quale gli organismi come entità reali sono completamente scomparsi” (Ingold 2001, p. 87), quanto a quelle di matrice puramente culturalista, che mancano nel loro approccio l’incarnazione delle pratiche antropiche o, quella che è stata definita, filogenesi della cultura (Lestel 2011).
Nel saggio An Anthropologist Looks at Biology del 1990 leggiamo che
l’antropologia - inclusi gli orientamenti di antropologia ‘sociale’ o ‘culturale’ - […] rientra pienamente nell’ambito della biologia. Non arriviamo a facili conclusioni però. Non mi sono […] convertito alla sociobiologia. Al contrario, io sostengo che, nella sociobiologia, una biologia impoverita che ha perso il contatto con la realtà degli organismi viventi si sposa a un’altrettanto impoverita scienza sociale, che non lascia spazio alcuno alle persone vere e viventi (Ingold 2001, p. 81).
Al fine di non perdere questo contatto con la realtà, Ingold (2001, p. 81) invita ad “adottare un tipo di ‘pensiero per relazioni’ che riconosce all’organismo e alla persona il ruolo di agenti creativi all’interno di un campo totale di relazioni le cui trasformazioni descrivono un processo di evoluzione”. È all’interno della ricerca “di una nuova sintesi tra la biologia e l’antropologia sociale o culturale” (ibidem) dunque che va inquadrata la dp messa in forma nel suo importante libro The Perception of the Environment del 2000. L’idea è quella di mettere a tema un pensiero capace di restituire la profonda capacità creativa dell’organismo biologico e della persona umana.
La posta in gioco è alta e possiamo sintetizzarla – senza pretese esaustive – nell’idea che non si tratti di trovare l’essenza ultima dell’agentività umana, bensì di tematizzarne la genesi nello scambio continuo tra la natura specifica dell’animale e le sue pratiche culturali:
La mia tesi principale è che diventare una persona non significa, come viene creduto dagli antropologi sociali più tradizionali, che una specifica essenza umana venga innestata su di un substrato organico indifferenziato.
Al contrario, io credo che la persona venga formandosi gradualmente all’interno dell’organismo umano che si sviluppa. È fondamentalmente sbagliato considerare lo sviluppo umano come un processo di socializzazione estrinseca, cioè come l’imposizione di una struttura esteriore di relazioni sociali alla “materia prima” data dagli individui organici preformati (ivi, p. 99-100).
Questo pensiero relazionale aspira a essere ‘generativo’, capace di pensare la genesi della persona nell’atto stesso del suo vivere biologicamente orientato. Biologia e sociologia convergono verso un punto di indiscernibilità, dove non è più possibile dire “questo è un aspetto naturale, questo invece è culturale”, giacché nell’atto stesso del vivente umano, organismo e persona a un tempo, è sempre un ibrido a essere in questione9
Un incontro possibile tra antropologia e biologia può avvenire sul piano di omologia del proprio oggetto di studio: come le culture, anche gli organismi non sono mai pienamente oggettivabili, e le scienze devono sempre venire a patti coi propri oggetti. Il mondo culturale e quello naturale sono in continuo cambiamento, e i modelli scientifici che tentano di descriverne i funzionamenti estrinseci, non possono ignorare una specie di ‘principio di indeterminazione’ intrinseco.
Ma la questione è più profonda, perché l’omologia non è solo epistemologica. Il punto è che la persona umana è sempre più che umana, mentre l’organismo animale non è mai il mero substrato sostanziale sul quale si innestano strutture sociali (c’è dell’umano già nel cuore stesso dell’animalità) e per dirla con Merleau-Ponty (1996, p. 303) – autore caro a Ingold e sul quale torneremo – l’umanità è solo un altro modo di essere corpo. La socialità dell’animale umano ne condiziona la relazione all’ambiente, tanto
9 La nozione di ibrido, che al lettore può far venire alla mente autori come Bruno Latour o Donna Haraway, è un tema che attraversa carsicamente il pensiero filosofico moderno sin dai grandi sistemi razionalistici seicenteschi (si pensi ad esempio alla VI meditazione cartesiana). Con le parole di G. Deleuze (2010, p. 287 ss.), ibrida è la sintesi asimmetrica del sensibile, ossia espressione materiale di indiscernibilità del piano trascendentale e del piano fenomenico (il c.d. empirismo trascendentale deleuziano). Del resto, una delle fonti di Latour, ad es., è M. Serres che a Leibinz ha dedicato un’importante e influente monografia.
L’equivoca transcodifica tra Bíos ed Ethnos
quanto le condizioni ambientali impattano sulle condizioni biologiche10. Il divenire-persona immanente all’organismo umano è inseparabile dalle condizioni ambientali, e queste ultime non sono mai neutre rispetto all’attività umana. È un doppio gioco, potremmo dire, di attività e passività che investe al contempo tanto l’organismo-persona quanto l’ambiente. Al generarsi dell’organismo si genera il suo ambiente, senza il quale l’organismo non sarebbe possibile e si tratta di mappare i processi generativi biologici attraverso i modi di abitare l’ambiente. La “tesi fondante della prospettiva dell’abitare” è l’idea che gli organismi umani “emergono nel flusso delle loro attività, nei contesti specifici di relazione del loro coinvolgimento pratico con ciò che li circonda” (Ingold 2001, p. 135). Si tratta di mettere al centro la pragmatica attraverso la quale gli organismi umani fanno del mondo la propria casa (oikos), ovvero quella capacità attanziale che definisce l’umano né come mero membro della propria specie né come polo di significazione universale, ma come facoltà intrinseca, in quanto organismo, di istituire mondi sensati atti all’esplicazione della vita. L’abitare è una vera e propria pragmatica generativa di Senso ecologico nel e tramite un ambiente in cui vi è un continuo scambio tra dispiegamento (unfolding) e introflessione (enfolding), “un’attività – scrive Ingold (ivi: 135) – espletata da persone reali in un ambiente-mondo reale, e non un intelletto incorporeo”.
Ecologia dal punto di vista pragmatico
La Dwelling Perspective (dp) propone un’antropologia centrata sulle pratiche abitative dell’animale umano, inteso come Subjektleib, offrendo una ecologia dal punto di vista pragmatico, basata cioè sull’idea che il fenomeno umano vada compreso a partire dal suo agire all’interno delle condizioni ambientali. Emerge una relazione al mondo che è ecosistemica e generativa: “my environment is the world as it exists and takes on meaning in relation to me, and in that sense it came into existence and undergoes development with me and around me” (Ingold 2000, p. 20).
10 Non è forse vero che gli attuali fenomeni del cambiamento climatico, in cui l’impatto antropico è centrale, mettono a rischio l’esistenza biologica stessa di Homo Sapiens? Abbiamo certo fatto un salto temporale non da poco, dalla fine del Millennio all’epoca dell’Antropocene, ma appare evidente come le questioni sollevate da Ingold siano ancora (purtroppo) all’ordine del giorno.
La concrescenza dell’organismo e dell’ambiente implica che anche quest’ultimo sia in continuo divenire e soggetto a metamorfosi tramite l’attività dell’organismo. Il vivente e l’ambiente sono continuamente da fare e rifare in un reciproco processo “of growth or development” (Ingold 2000, p. 20). La dp ha per oggetto tale processo di apertura continua di possibilità esistenziali dell’organismo che Ingold legge in una prospettiva fenomenologica, mettendo al centro il portato e la valenza creativa dell’organismo nella sua relazione con l’ambiente.
Questa pragmatica dell’organismo, creativa e vincolata a un tempo, è proprio l’abitare. È nell’attività dell’abitare, infatti, che emerge la dimensione in fieri dell’ambiente, che non preesiste all’attività dell’organismo, ma consiste nello spazio di esplicazione dell’attività del vivente. Abitare è la relazione di senso che l’organismo intrattiene con il suo environment in quanto spazio significativo. Sul piano concettuale, è opportuno seguire la distinzione che Ingold pone tra la dp e quella che invece chiama prospettiva del costruire. Si nota qui la finezza del ragionamento dell’autore: anche quest’ultima postula una centralità della relazione nel rapporto con il mondo esterno, riducendolo, però, a uno spazio geometrico e formale che perde di vista il rapporto concreto che il soggetto intrattiene in questa relazione. Al contrario, la dp pensa lo spazio come un campo semanticamente ricco in cui, rubando le parole a Greimas (1974, p. 13), “il senso è dato, s’impone come un’evidenza […] assolutamente naturale”. L’ambiente, in una prospettiva dell’abitare, è una struttura significante. Abitare e costruire sono due atti differenti a partire dai quali si dipanano due modelli pragmatici alternativi e due relazioni ecologiche molto distanti. L’essenza della prospettiva dell’abitare è che i mondi “are made before they are lived in; […] that acts of dwelling are preceded by acts of worldmaking” (Ingold 2000, p. 179). La prospettiva del costruire suppone non solo una distinzione tra il mondo specificamente umano, costruito a suo uso e consumo ‘sovranamente’, e il mondo esteso, privo di qualsiasi significato per l’umano se non per quel tanto che gli offre il materiale ‘da costruzione’, ma altresì la separazione tra anima e corpo, tra il regno sovrasensibile dell’intelletto umano e il piano sensibile dell’inerte natura. Infatti, la prospettiva del costruire presuppone che vi sia una intelligenza
L’equivoca transcodifica tra Bíos ed Ethnos
capace di allontanarsi dal mondo naturale e progettare un’architettonica artificiale capace di trasformare uno spazio liscio in un ambiente confortevole e idoneo ai bisogni e alle volontà del progettista. È, in sostanza, la prospettiva dell’ingegnere o dell’architetto: “first plan and build the houses, then import the people to occupy them” (ivi: 180).
Non che nella prospettiva ingegneristica sia assente la relazione all’ambiente, è che questa relazione vede nell’umano l’unico attore e l’ambiente come pura scenografia. La relazione c’è, ma, possiamo dire, ancella dell’attività di uno solo dei due poli. La distribuzione tra ciò che è attivo e ciò che è passivo è univoca: l’ambiente è materia bruta da trasformare mediante il lavoro umano e l’abitare diviene un’occupazione derivata da una attività di pianificazione, geometrizzazione e costruzione dello spazio. La vita umana è vincolata tanto alla sua attività trascendentale di progettare per superare l’istantaneità animale quanto a uno spazio che è sottoposto alla continua alternativa tra l’essere uno spazio materiale a disposizione o un ambiente sensato. Senza l’attività progettante dell’umano, non v’è alcun Senso nello spazio e la significazione culturale diventa sinonimo di “ingegneria ambientale”11. Lo spazio è sensato solo nella misura in cui l’attività antropica lo rende tale. La prospettiva del costruire marcherebbe così una eccezionalità umana nella genesi del Senso, e una eccezionalità antropologica rispetto all’organismo. Al contrario degli altri esseri viventi, l’Uomo (qui inteso come Soggetto trascendentale) non sarebbe dotato naturalmente di un ambiente, ma troverebbe la sua destinazione nella fabbricazione artificiale.
A questa idea di uno spazio-mondo estensionale (uno stato di natura) che precede un mondo-ambiente forgiato dall’attività progettuale dell’uomo (la condizione culturale), Ingold (ivi: 179-180) contrappone la dp, con l’obiettivo di criticare “the assumptions entailed in making the distinction between an ‘architecturally modified environment’ and what is simply called ‘nature’”. Si tratta di mettere in atto un vero e proprio rovesciamento della prospettiva costruttivista antropocentrica: è perché si è già in un campo vitale significante che è possibile progettare e costruire spazi
11 Un dibattito che attraversa l’attuale pensiero ecologico, per una panoramica cfr. Hamilton 2013; Neyrat 2019.
geometrici. La geometrizzazione è un modo d’abitare lo spazio, e non ciò che fonda l’abitabilità. Ingold (ivi: 186) cita Heidegger (1991, p. 107): “solo se abbiamo la capacità di abitare, possiamo costruire”.
Se un ambiente ha un senso umano è perché l’umano, in quanto vivente, abita già in un ambiente sensato indipendentemente dalla sua attività trascendentale. È qui la tesi della dp: questo “senso naturale” non è lo “stato di natura” che precede le nostre significazioni, ma una struttura di Senso che sostiene ogni pratica culturale. Ciò che si abita non è uno spazio artificiale sovrapposto a uno naturale: abitare, piuttosto, è coestensivo al vivere un ambiente nella sua totalità. Nella dp emerge una rete di senso che eccede l’umano, presentandosi piuttosto come una composizione stratificata del Senso. L’ambiente del vivente ha una agentività sua propria e l’insieme dei feedback tra queste due agentività determina la relazione abitativa dell’organismo, che non è mai l’unico attore in gioco. Per un verso, le forme viventi “rise within the current of their involved activity, in the specific relational contexts of their practical engagement with their surroundings”, per l’altro, “are the emergent outcomes of environmentally situated development processes” (Ingold 2000, p. 186).
Così, se nella prospettiva del costruire l’agentività è esclusiva pertinenza degli attori umani, la dp tenta “to dissolve the orthodox dichotomies […] between biology and culture” (ivi, p. 187), lasciando emergere una rete attanziale naturale che include e raccoglie al suo interno anche l’umano. Le pratiche con cui questi fa il suo mondo-ambiente entrano a far parte del processo generale della co-evoluzione ecosistemica:
For if, by evolution, we mean differentiation over time in the forms and capacities of organisms, then we would have to admit that changes in the bodily orientations and skills of human beings, insofar as they are historically conditioned by […] the enduring products of [their] work, such as buildings […], must themselves be evolutionary. And if, by cultural variation, we mean those differences of embodied knowledge that stem from the diversity of local developmental contexts, then far from being superimposed upon a substrate of evolved human universals, such variation must be part
L’equivoca transcodifica tra Bíos ed Ethnos
and parcel of the variation of all living things, which has its source in their enmeshment within an all-encompassing field of relations (ibidem).
La dp evidenzia l’importanza della relazione e richiede – qui la necessità filosofica – un pensiero capace di cogliere l’intreccio tra evoluzione naturale e processo culturale, tra la facoltà biologica della specie e le potenzialità performative della cultura. Serve, come detto, un pensiero delle relazioni in grado di tematizzare le capacità generative del Senso ecologicamente determinate. È questa la sfida filosofica della dp
Verso una biosemiotica strutturalista:
Merleau-Ponty lettore di Saussure e Uexküll
Può sembrare che ci siamo allontanati dalle questioni biosemiotiche in senso stretto, tuttavia riteniamo di poter rintracciare nelle intuizioni di Ingold una nuova relazione tra Bíos ed Ethnos che possa indirizzare il pensiero ecologico verso la biosemiotica, e che guarda anche alle questioni più attuali di ecosemiotica (Maran 2020). La scommessa filosofica della dp è di permettere una possibile pista per pensare una semiosi che si attua nella relazione abitativa dell’organismo con il suo ambiente. La dp ambisce, infatti, a studiare i modi in cui gli organismi umani percepiscono il loro ambiente. L’idea, ispirata anche dal lavoro di J. Gibson (2014), è che la percezione ecologica non sia che l’altra faccia dell’attività dell’abitare, che la percezione dell’ambiente sia intrinseca all’abitare (Ingold 2015, p. 24).
Il riferimento di Ingold è alla fenomenologia di Merleau-Ponty (2009), la quale, nelle sue elaborazioni più mature, ha, in tempi non sospetti, tentato l’unione della linguistica suassuriana e la biologia di von Uexküll 12 . L’ipotesi del filosofo è che la percezione non sia semplicemente la ricezione passiva di stimoli dall’esterno, ma il fenomeno cerniera tra lo schema corporeo e il mondo. Percepire non è cioè semplicemente osservare un panorama, ma al contrario presenta un “coefficiente di soggettività” (Merleau-Ponty 2010, p. 204), è un abbozzo di struttura
12 Sulle radici fenomenologiche della biosemiotica, in special modo di ispirazione merleau-pontyana, cfr. Lanfredini (2021).
comportamentale perché l’organismo percipiente ha una sua situazione, un ambiente nel quale può agire, e agisce già semplicemente sentendo questo mondo. Come è stato rilevato, “la peculiarità della struttura di un comportamento è precisamente quella di essere una forma che appare in quanto è radicata in un corpo che agisce, si muove, percepisce, vive” (Vanzago 2012, p. 15). La percezione non è il contrario dell’azione, ma una sua modalità “passiva” (Ménasé 2003). Percepire significa “frequentare il mondo” (Ingold 2015, p. 25), tessere una relazione espressiva tra il vivente e i suoi dintorni. Percependo il proprio ambiente, l’organismo lo esprime, intrattenendo “una relazione di senso col mondo” (Amoroso 2019, p. 152), il quale, “rivelandosi, mi circonda, dunque sempre mi eccede” (Dalmasso 2021, p. 26).
Il comportamento percettivo marca la reciprocità tra organismo e ambiente, un movimento che è sempre a doppio senso, quello che, mutuando l’espressione da K. Goldstein (2010), Merleau-Ponty chiama un venire a patti tra l’organismo e il mondo: da una parte, “l’organismo riorganizza continuamente se stesso e il proprio mondo in funzione delle proprie possibilità e necessità” (Amoroso 2019, p. 133), dall’altra questa “libertà d’azione” è strutturale. Da una parte la capacità del vivente, dall’altra le condizioni dell’ambiente: non un ultimatum di quest’ultimo, ma un “rapporto prassico al senso, senso che è praticato […] in virtù del rapporto espressivo che il corpo intesse con il mondo sensibile” (Dalmasso 2021, p. 25).
Tramite il tema dell’espressione Merleau-Ponty delinea l’idea di una percezione diacritica. Il filosofo definisce l’espressione come “la proprietà che ha un fenomeno, per la sua organizzazione interna, di farne conoscere un altro” (Merleau-Ponty 2021, p. 62). Vi è una performatività dell’atto percettivo che non si limita a denotare uno stato di cose, ma contribuisce a manifestare e realizzare quel che si percepisce: “la percezione è espressione, espressione del mondo” (ivi, p. 63) tramite “un rapporto espressivo tra il corpo e il paesaggio, o tra il paesaggio e me come suo ‘abitante’” (ivi, p. 76). Il filosofo sottolinea che l’espressione è tale in virtù della sua “organizzazione interna”, cioè un “rapporto di segno a segno” (ivi, p. 90). La percezione è espressiva in quanto ‘strutturazione’ di un campo sensibile/comportamentale.
L’equivoca transcodifica tra Bíos ed Ethnos
Questa affermazione è comprensibile se si tiene conto di due aspetti. La percezione non ci offre lo spettacolo di uno spazio geometrico, ma inerisce a un ambiente nel quale contribuisce a “rilevare uno scarto” (ivi: 65) tra i vari elementi del campo percettivo. Qui, scarto indica l’idea che le parti del mondo sensibile non si danno, come nello spazio cartesiano, partes extra partes, ma si manifestano mediante differenze cromatiche, uditive, tattili: un piano sensibile della diacriticità. Rilevare uno scarto non è altro che “la costituzione di un segno” (ivi: 247), un segno sensibile che comporta una “convergenza [con] la teoria linguistica del segno” (ivi: 69). Il riferimento è esplicitamente a Saussure e alla sua idea di diacriticità, l’idea cioè che sia segno tutto ciò che esiste per differenza e che questo abbia senso “non par possession d’une signification, mais par sa différence et sa coexistence avec les autres significations” (Andén 2020, p. 10). Il tema è esplicitato nel saggio
Sulla fenomenologia del linguaggio:
Saussure ci ha insegnato che, presi isolatamente, i segni non significano niente: più che esprimere un senso, ognuno di essi indica uno scarto di senso fra sé e gli altri. […] Proprio perché esclude che i segni possano avere un senso che non sia ‘diacritico’, [Saussure] non può fondare la lingua su un sistema di idee positive. L’unità di cui parla Saussure è unità di coesistenza (Merleau-Ponty 2003, p. 63).
Scoperta da Saussure nel sistema linguistico, Merleau-Ponty trasla la diacriticità sul sensibile13: come i segni linguistici non significano altro che la loro differenza, allo stesso modo “possiamo percepire delle differenze senza termini, degli scarti” (Merleau-Ponty 2021, p. 264) senza una sostanza sensibile. La convergenza chiama in causa l’analogia tra percepire e parlare: un fonema non investe solo l’apparato mentale dei soggetti linguistici, ma chiama in causa la sensibilità e il corpo14 . Una
13 Cfr. Merleau-Ponty (2020); Chiletti (2007).
14 Come rileva Ponzio (2015, p. 77), per Saussure il segno linguistico unisce non stati di cose e nomi, ma un concetto e un’immagine acustica. Sul rapporto tra corpo e differenza in prospettiva merleau-pontyana cfr. Iofrida (2019, 33-44).
parola tanto la si comprende sul piano mentale, quanto la si proferisce, la si sente, la si scrive, la si legge attraverso un’attività corporea complessiva. Attraverso l’idea di una percezione diacritica si manifesta un ambito della produzione di Senso che pertiene allo schema corporeo ed è autonomo da quello linguistico, una vera e propria semiosi naturale, una semiosi espressiva: “Les créations linguistiques créent non seulement de nouvelles significations linguistiques, mais aussi de nouvelles significations perceptives” (Andén 2020, p. 27).
La percezione ambientale, così, può essere letta come la genesi di uno spazio sensato mediante un comportamento semiosico. Percepire significa manifestare una unità di coesistenza strutturale, attraverso una semiosi differenziale ecologicamente orientata. Un corpo “è espressivo in quanto reca in ciascuno dei suoi gesti Umweltintentionalität, esso delinea e dispiega una Umwelt” (Merleau-Ponty 2021, p. 76). La diacriticità della percezione è espressione di Umwelt: ecco che Saussure incontra von Uexküll. Quest’ultimo offre i concetti per pensare la relazione espressiva dell’organismo con il suo ambiente e tematizzarne l’agentività15 .
La nozione di Umwelt è da leggere in chiave strategico-argomentativa al fine di ripensare la relazione ecosistemica in una prospettiva espressiva. La Umwelt non è né spazio estesiologico né ambiente in senso generale, ma sempre “un mondo di tale o talaltro essere vivente” (Merleau-Ponty 1996, p. 245), un “ambiente di comportamento” (ivi: 245) coestensivo all’organismo stesso, uno Spielraum espressivo: vi è Umwelt non “appena si hanno degli stimoli che agiscono […] in quanto un organismo è disposto a riceverli e a considerarli come segnali” (ivi: 246). La Umwelt esprime la capacità del vivente di dare senso a quanto lo circonda, e allo stesso tempo è l’ambito di possibilità in cui il fenomeno vivente può svilupparsi. Emerge una significazione biologicamente orientata, e l’unità del vivente è, dice Merleau-Ponty sulla scia di Uexküll, una ‘unità
15 Occorre precisare che si tratta di riconoscere, all’interno dei processi evolutivi, spazi di agentività dell’organismo nei suoi feed-back con l’ambiente. Lungi dal difendere teoricamente una ‘ereditarietà’ dei caratteri acquisiti, la sfida è ricomprendere la selezione nei termini di un coming to terms, continuo tra l’organismo e l’ambiente. Problema quest’ultimo quanto mai attuale, oggi, nella governance della crisi ecologica che stiamo attraversando.
L’equivoca transcodifica tra Bíos ed Ethnos
d’azione’16, mentre il processo di individuazione biologico è la coesistenza di focolai di azioni possibili all’interno di quello Spielraum che è la Umwelt determinata.
L’individuazione biologica nella filosofia di Merleau-Ponty è da intendersi nei termini di un “power of manifestation” (Meacham 2014, p. 144). La scommessa è di pensare lo spazio del vivente in termini espressivi, e la Umwelt nomina questa potenza dello spazio di manifestare l’apertura di un campo di azioni possibili, uno spazio ontologicamente imperfetto che fa appello al vivente in quanto “precessus creatif” (Robert 2014, p. 168) e alla sua capacità di attualizzare le virtualità che lo determinano (Lanfredini 2014). La Umwelt è uno spazio
posseduto dall’animale. Il mondo esterno viene ‘distillato’ dall’animale che, differenziando i dati sensoriali, può rispondere loro con azioni [più o meno] sofisticate e queste reazioni differenziate sono possibili solo perché il sistema nervoso si organizza come una riproduzione del mondo esterno (Gegenwelt) (Merleau-Ponty 1996, p. 251).
La Umwelt è stratificata e mediata dalle strategie dell’organismo per rispondere agli stimoli. C’è una diacriticità della relazione ambientale, laddove il mondo-ambiente è ‘distillato’, discrezionato dall’organismo tramite la capacità di riorganizzare il proprio campo d’esperienza, di attualizzare strutture sensate che permettono un migliore adattamento alle condizioni esterne, una persistenza e resistenza del vivente rispetto alle variazioni della Umwelt. Vi è una ‘riproduzione’ dell’ambiente da parte dell’organismo (la Gegenwelt) che è al contempo una strutturazione sensibile delle diacriticità del proprio campo esistenziale.
L’ambiente esterno non è l’innesco meccanico delle reazioni dell’organismo, bensì ha “il ruolo di segno piuttosto che di causa” (ibidem). Tuttavia non si deve pensare a un nuovo dualismo tra Umwelt e Gegenwelt, facendo della Umwelt un mondo di pura sensibilità e la Gegenwelt il mondo delle rappresentazioni. La “riproduzione” qui non
16 “L’unità dell’organismo […] bisogna farla poggiare su un’attività” (Merleau-Ponty 1996, p. 250).
è rappresentazione intellettuale, ma stratificazione del Senso vissuto dall’organismo. Si tratta di seguirne la genesi fenomenologica. Se la Umwelt è lo Spielraum dell’organismo e la Gegenwelt la risposta sensata alle situazioni che si trova a vivere, il trait d’union è ancora una volta lo schema corporeo, occorre riprendere le nozioni di percezione e comportamento. Tra la Umwelt la Gegenwelt si inseriscono altri due mondi intermedi (Iacono, Gargani 2005): la Merkwelt, “una griglia interposta tra l’animale e il mondo”, e la Wirkwelt, “ossia le reazioni dell’animale nell’ambiente” (Merleau-Ponty 1996, p. 253). Tra la Umwelt e la Gegenwelt si aprono quindi altri spazi ognuno dei quali è “fatto di scarti” (ibidem), cioè di segni, e implica le potenze corporee di semiosi. Ci si potrebbe chiedere se questa attività dell’organismo non rischi di far ricadere l’intenzionalità biologica in una forma camuffata di intenzionalità spirituale, riproponendo sotto mentite spoglie un primato del Cogito e della significazione linguistica sulla semiosi sensibile. Tuttavia, l’attività del vivente non è mai arbitraria, in quanto si costruisce in un ambiente che l’organismo già abita. È il problema della Umweltintentionalität, una dimensione ambientale dell’intenzionalità che l’organismo ha in quanto “prodotto dalla produzione di un ambiente” (ivi: 254). Riteniamo si possa parlare a buon diritto di una reciprocità semiotica tra vivente e ambiente: l’espressione biologica è una semiosi situata, composizione (eco)sistemica di differenze, scarti percettivi e margini di azione.
The explanation for how an organism can stay developmentally oriented toward a species-typical form despite varying environmental obstacles and constraints does not have to do with an entelechy within the germ plasm or genome or other appeals to various forms of finalism, but rather is a case of an indeterminate yet oriented path of developement that is latently present (Meacham 2014, p. 146).
La Umweltintentionalität non è una rinnovata forma di entelechia né un aut-aut imposto dall’esterno. Siamo al di là di un dualismo tra libertà e determinismo: è la relazione significante a determinare la Umweltintentionalität, che “ha il compito di collegare quello che abitualmente viene
L’equivoca transcodifica tra Bíos ed Ethnos
separato” (ibidem) risemantizzando in prospettiva strutturale il concetto stesso di ecosistema17: un sistema di differenze in cui ogni elemento non è che scarto sistemico. Ogni elemento dell’ecosistema è e fa segno contribuendo al “dispiegamento della Umwelt” (ibidem) di ogni singolo organismo che ne fa parte.
La relazione semiotica tra l’organismo e l’ambiente apre a una concezione ecologica del Senso, il quale “non può essere fissato una volta per tutte, al di fuori del rapporto tra un segno e l’altro, poiché esso si dà in questo specifico rapporto” (Amoroso 2016, p. 16). La struttura semiotica biologica, intesa in quanto composizione differenziale, è dinamica, diventa una struttura storica, non nel senso che esso dipenda dalle condizioni storiche, bensì nel senso che essa ha una storia naturale immanente (Toadvine 2014), espressione e generazione nella quale l’organismo è attivamente catturato nel divenire sensato di quell’ inframondo che intreccia la Merkwelt e la Wirkwelt, le quali “costituiscono due linguaggi con l’aiuto dei quali l’animale interpreta [c.n.] la situazione” (Merleau-Ponty 1996, p. 256) e può farlo proprio perché l’organismo è segno esso stesso all’interno di una struttura significante (De Fazio 2021b, p. 27-29).
Abitare un ambiente ha un significato al contempo biosemiotico e strutturale. Mediante una semiosi vitale, l’organismo è momento attivo dell’ecosistema, complementare a una situazione ambientale imprescindibile. L’organismo è un sistema semiotico nella misura in cui è in una relazione sensata col mondo, cioè nella misura in cui abita un’articolazione di Senso ed è parte attiva delle sue metamorfosi.
Ogni azione dell’ambiente è condizionata dall’azione dell’animale, la condotta dell’animale suscita delle risposte da parte dell’ambiente. C’è una retroazione di ciò che l’animale ha fatto, la quale rilancia il comportamento animale. [C’è] un rapporto di senso che traduce l’espressione: Umwelt. La Umwelt è il mondo implicato dai movimenti dell’animale, […] ne regola i movimenti mediante la sua propria struttura (Merleau-Ponty 1996, p. 256).
17 Quello di Ecosistema è concetto complesso, che necessiterebbe d’essere discusso separatamente. Ci limitiamo qui a rimandare per una ricostruzione filosofica in prospettiva ecosofica a Bernava (2021, 2023).
Avviandoci a concludere, grazie a Ingold e Merleau-Ponty, possiamo sostenere che abitare un ambiente è una pragmatica di vita che non è la traduzione univoca da un piano Naturale a una molteplicità di codici culturali, ma una transcodifica ecosistemica costante, da una organizzazione di senso a un’altra. Cambia anche il posto dell’umano nel mondo: esso è un agente ecosistemico in quanto organismo vivente con un ambiente di esercizio che risponde continuamente alle sue attività. La transcofidica del vivente è multivoca nella misura in cui esprime, tramite relazioni ecosistemiche, una molteplicità variegata di focolai virtuali di possibilità. Queste relazioni chiamano in causa l’umano nel suo comportamento, nella sua capacità di comprendere i segni che lo circondano e di fare esso stesso segno. Una semiosi vivente incastonata in un ecosistema totale. Certamente la legittimità di indirizzarsi verso una biosemiotica di stampo strutturale è ancora lungi dal poter essere definita in maniera chiara e distinta. Ma senza dubbio, la prospettiva strutturale che anima l’ecologia filosofica può prendere molto dalla riflessione biosemiotica, il cui contributo più profondo è, parafrasando Sebeok (2003, p. 81), descrivere il ruolo dello schema corporeo umano “nella creazione del mondo […] a partire da un vasto e diversificato flusso di impressioni sensoriali”.
Riferimenti
Alexander, D. E. (n.d.). Biocentrism, anthropocentrism, technocentrism. In D. E. Alexander, e R. W. Fairbridge, Encyclopedia of environmental science (pp. 44-45). Springer.
Amoroso, P. (2016). L’esperienza della parola. Il problema del linguaggio in Merleau-Ponty. In AA.VV., Corpo, linguaggio e senso tra semiotica e filosofia. Esculapio.
Amoroso, P. (2019). Pensiero terrestre e spazio di gioco: L’orizzonte ecologico dell’esperienza a partire da Merleau-Ponty. Mimesis. Andén, L. (2020). Pour une phénoménologie du langage: le primat ontologique de la parole. In M. Merleau-Ponty, Le problème de la parole. Cours au Collège de France, Notes, 1953-1954 (pp. 9-32). MetisPress.
Barbieri, M. (2007). Is cell a semiotic system? In M. Barbieri (a cura di), Introduction to biosemiotics: The new biological synthesis (pp. 179-207). Springer.
Barthélémy, J. H. (2022). Manifeste pour l’écologie humaine. Actes Sud.
L’equivoca transcodifica tra Bíos ed Ethnos
Bernava, C. (2021). L’ecosistema tra natura e cultura. Aeroplani, sistemi e mappe. Philosophy Kitchen, 15, 93-104.
Bernava, C. (2023). Ecosistema. In A. Pastorello (a cura di), Selvario. Guida alle parole della selva. Mimesis.
Bonato, B. e Kirchmayr, R. (2023). La filosofia e la crisi ecologica. Mimesis.
Bonneuil C. e Fressoz, J. B. (2016). La terra, la storia e noi. L’evento antropocene. Treccani.
Brown, S. e Toadvine, T. (2003). Eco-phenomenology. Back to the earth itself. suny.
Chiletti, S. (2007). Ai limiti di fenomenologia e strutturalismo: Il concetto di struttura nella filosofia di Merleau-Ponty. Segni e Comprensioni, 21(62), 102-118.
Cobley, P. (2016). Cultural implications of biosemiotics. Springer. Cook, J. et al. (2013). Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature. Environmental Research Letters, 2(8).
Dalmasso, C. (2021). Cinetica dell’espressione. In M. Merleau-Ponty, Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione. Mimesis.
De Fazio, G. (2021a). Ecologia del possibile: Razionalità, esistenza, amicizia. Ombre Corte.
De Fazio, G. (2021b). Avversità e margini di gioco: Studio sulla soggettività in Merleau-Ponty. Ets.
De Fazio, G. et al. (2019). Prontuario di ecosofia: Bibliografie metastabili. Ventura.
De Fazio, G. e Lévano, P. F. (2021). Rendere visibile le alternative. Una critica ecosofica al dualismo “sostenibile”. Philosophy Kitchen, 15, 105-117.
Deleuze, G. (2010). Differenza e ripetizione. Cortina.
Descola, P. (2021). Oltre natura e cultura. Cortina.
Fogliato, S. (2023). La ragione delle piane. DeriveApprodi.
Fontanille, J. (2017). Intervista a Jacques Fontanille. In P. Donatiello, G. Mazzarino (a cura di), Tra “etno” e “semiotica” (vol. i, pp. 41-56). Esculapio.
Gibson, J. (2014). L’approccio ecologico alla percezione visiva. Mimesis.
Greimas, A. J. (1974). Del senso. Bompiani.
Greimas, A. J. e Courtés, J. (2007). Semiotica: Dizionario ragionato della teoria del linguaggio. Mondadori.
Hamilton, C. (2013). Earthmasters: The dawn of the age of climate engineering. Yale University Press.
Hediger, H. (2011). The animal’s expressions. In T. Maran et al. (a cura di), Readings in zoosemiotics (pp. 123-140). de Gruyter.
Heidegger, M. (1991). Costruire, abitare, pensare. In Saggi e discorsi (pp. 96-108). Mursia.
Hierneaux, Q. (2018). Philosophie du végétal: botanique, épistémologie, ontologie. Vrin.
Hoffmeyer, J. (2008). Biosemiotics. An examination into the signs of lift and the lift of signs usp
Iacono, A. M. e Gargani, A. G. (2005). Mondi intermedi e complessità. ets.
Ingold, T. (2000). The perception of environment: Essays on livelihood, dwelling and skill. Routledge.
Ingold, T. (2001). Persone e organismi: Un antropologo guarda alla biologia. In T. Ingold, Ecologia della cultura (pp. 81-109). Meltemi.
Ingold, T. (2015). Qualche domanda a Tim Ingold. In M. Iofrida (a cura di), Ecologia, esistenza, lavoro (pp. 23-29). Mucchi.
Iofrida, M. (2012). Vita, natura, soggetto. In M. Iofrida (a cura di), Crisi. Condizione e progetto (pp. 49-65). Mucchi.
Iofrida, M. (2019). Per un paradigma del corpo: una rifondazione filosofica dell’ecologia. Quodlibet.
Lanfredini, R. (2014). Essenza e natura: Husserl e Merleau-Ponty sulla fondazione dell’essere vivente. Discipline Filosofiche, 24(2), 45-66.
Lanfredini, R. (2021). Physical intentionality: The phenomenological roots of biosemiotics. In E. Pagni, R. Theisen Simanke (a cura di), Biosemiotics and evolution (pp. 221-236). Springer.
Latour, B. (2009). Non siamo mai stati moderni. Elèuthera.
Lestel, D. (2011). The biosemiotics and phylogenesis of culture. In T. Maran et al. (a cura di), Readings in zoosemiotics (pp. 377-410). de Gruyter.
Lévi-Strauss, C. (1972). Le strutture elementari della parentela. Feltrinelli.
Longo, G. (2021). Matematica e senso. Per non divenire macchine. Mimesis.
Maran, T. (2020). Ecosemiotics. The study of signs in changing ecologies cup
Marder, M. (2013). Plant-thinking a philosophy of vegetal life. cup.
Marsciani, F. (2017). Intervista a Francesco Marsciani. In P. Donatiello, G. Mazzarino (a cura di), Tra “etno” e “semiotica”. Affinità e divergenze ai margini di due discipline (vol. i, pp. 23-40). Esculapio.
Marsciani, F. e Zinna, A. (2022). Elementi di semiotica generative: Processi e sistemi della significazione (2a ed.). Esculapio.
Meacham, D. (2014). Sense and life: Merleau-Ponty’s philosophy of nature and evolutionary biology. Discipline Filosofiche, 24(2), 137-164.
Ménasé, S. (2003). Passivité et création puf
Merleau-Ponty, M. (1996). La natura. Cortina.
Merleau-Ponty, M. (2003). Segni net
Merleau-Ponty, M. (2009). Fenomenologia della percezione. Bompiani.
Merleau-Ponty, M. (2010). La struttura del comportamento. Mimesis.
Merleau-Ponty, M. (2020). Le problème de la parole. Cours au Collège de France Notes, 1953-1954. Metis.
Merleau-Ponty, M. (2021). Il mondo sensibile e il mondo dell’espressione. Mimesis.
L’equivoca transcodifica tra Bíos ed Ethnos
Missiroli, P. (2022). Teoria critica dell’antropocene. Mimesis.
Moura Carvalho, I. C. de et al. (2020). Learning from a more-than-human perspective. Plants as teachers. The Journal of Environmental Education, 51.
Næss, A. (2016). Introduzione all’ecologia ets
Neyrat, F. (2019). The unconstructable earth. An ecology of separation. Fordham University Press.
O’Riordan, T. (1981). Environmentalism (2nd ed.). Pion.
Paolucci, C. (2010). Strutturalismo e interpretazione. Bompiani.
Ponzio, A. (2015). Il linguaggio e le lingue. Mimesis.
Richerson, P. J. (1976). Human ecology: An environmental approach. Duxbury Press.
Richerson, P. J. e Boyd, R. (2005). Not by genes alone: How culture transformed human evolution. cup.
Salman, D. M. e Nagy, M. (2019). Favoring technocentrism over ecocentrism evidence from Finland and Bhutan. Bussecon Review of Social Sciences, 1, 12-23.
Sebeok, T. A. (2011). Zoosemiotics: At the intersection of nature and culture. In T. Maran et al. (a cura di), Readings in zoosemiotics (pp. 77-86). de Gruyter.
Sebeok, T. A. (2003). Segni: Una introduzione alla semiotica. Carocci.
Toadvine, T. (2014). Tempo naturale e natura immemoriale. Discipline Filosofiche, 24(2), 9-22.
Vanzago, L. (2012). Merleau-Ponty. Carocci.
Villani, T. e Fadini, U. (2021). Eco/logiche. Politiche, saperi e corpi nel tempo della crisi ambientale. Manifestolibri.
Viveiros de Castro, E. (2018). Il nativo relativo. In R. Brigati, V. Gamberi (a cura di), Metamorfosi: La svolta ontologica in antropologia (pp. 107-144). Quodlibet.
Zengiaro, N. (2022). From biosemiotics to physiosemiotics: Towards a speculative semiotics of the inorganic world. Linguistic Frontiers, 5(3), 37-48.
Autori
Baal Delupi
Dottore di Ricerca in Semiotica presso la Universidad Nacional de Córdoba (unc), egresado del Programa de Actualización en Prácticas Artísticas y Política en América Latina della Universidad de Buenos Aires (uba) e laureato in Comunicación Social. È stato ricercatore post-dottorale presso la Università di Torino, Italia (Progetto facets erc) e visiting scholar presso il Centre of Discourse Studies di Barcellona, diretto da Teun A. van Dijk. È professore presso la Universidad Provincial de Córdoba (upc), il Colegio
Universitario Politécnico (cup) e la Universidad Blas Pascal (ubp). Attualmente lavora come borsista post-dottorale del conicet-iecet.
Beatrice Vanacore
Dottoranda in Semiotica presso l ’Università degli Studi di Palermo. Il suo progetto di ricerca, collocato nell ’ambito della zoosemiotica di seconda generazione, si propone di indagare le strutture narrative e discorsive attraverso cui si costituiscono le relazioni tra soggetti umani e non-umani. Ispirandosi al pensiero antiessenzialista di Vinciane Despret, la ricerca parte dalla decostruzione della dicotomia ontologica tra Natura e Cultura, esplorando forme emergenti di animalità. L’analisi si sviluppa su un ampio spettro testuale, comprendente pratiche comunicative e culturali contemporanee, quali la pubblicità per animali domestici e il dibattito etico e semiotico sulla carne coltivata.
Elizabeth Davila Dezeo
Professoressa presso la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Facoltà di Arte, Scuola di Musica e Arti Visive e Design Grafico. Musicista. Laurea in Lettere e Magister Scientiae in Letteratura Iberoamericana, menzione in Lingua e Letteratura Latinoamericana e Venezuelana. Dottoranda
Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità
in Letteratura (ula). Membro del Laboratorio de semiotica y socioantropologia de las Artes.
Emiliano Vargas
Dottorando in Scienze Umanistiche presso l ’Università degli Studi di Urbino “Carlo bo”, musicista e compositore di musica popolare. È stato borsista presso l ’Università di Torino e l ’Università di Buenos Aires. È stato inoltre docente presso l ’Istituto per il recupero e la rivalutazione del patrimonio culturale dell ’Università Nazionale di Tucumán”. Attualmente è visiting research student presso la Kaunas University of Technology (Lituania). Il suo interesse di ricerca si concentra sulla coevoluzione culturale mediatica di diverse forme di vita nelle espressioni, pratiche artistiche e nella creatività.
Eric Hirschfeld
Professore e laureato in Lettere. Dottorando in Semiotica (Universidad Nacional de Córdoba) e laureando magistrale in Metodologie della Ricerca (Universidad Nacional de Entre Ríos). Conduce ricerche sull ’ istituzionalizzazione degli studi semiotici con il sostegno di una borsa di dottorato del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet). È membro del Gruppo di Studio su Biosemiotica, Arte e Tecnologia (gebat) e del Centro de Investigaciones Teórico-Literarias (cedintel). Insegna in diverse università argentine, tra cui l ’ Università
Autonoma di Entre Ríos e Università Nazionale del Litoral. Fa inoltre parte del progetto trans.arch (msca-rise Scheme, Grant Agreement n. 872299). I suoi scritti e traduzioni sono apparsi su riviste come Revista Ñ, Periódico Pausa e Cuarta Prosa
Gianluca De Fazio
Ha un dottorato in Filosofia Morale e Politica presso l ’Università di Pisa. Ha conseguito l ’Abilitazione Scientifica in Filosofia Morale e Filosofia teoretica. È Cultore della materia in Storia della Filosofia presso l ’ Università di Bologna e collabora con diversi centri di ricerca europei e sudamericani. I suoi interessi di ricerca vertono sul pensiero francese, i
fondamenti dell ’ecologia filosofica e i rapporti tra semiotica strutturale e filosofia. Tra le sue pubblicazioni più recenti : Avversità e margini di gioco (2021), Fini senza scopi (2024, con V. Cavedagna) e Soglie della visibilità (2024, con C. Bernava).
Lucía Stubrin
Ricercatrice, curatrice e docente universitaria. È Dottoressa in Teoria e Storia delle Arti (Universidad de Buenos Aires) e Laureata in Comunicazione Sociale (Universidad Nacional de Entre Ríos). È docente-ricercatrice presso l ’uner e insegna all ’Universidad Nacional del Litoral. Dirige il Grupo de Estudio Biosemiótica, Arte y Técnica (gebat), concentrando la sua ricerca su arte, scienza, tecnologia e bioarte. Autrice di Bioarte. Poéticas de lo viviente (eudeba | Ediciones unl, 2021), ha ricevuto borse di studio nazionali e internazionali, premi di ricerca e curatela, e svolge attività di giurata e consulente per musei e archivi d ’arte.
Luigi Lobaccaro
Ricercatore (rtd-a) presso il Dipartimento di Filosofia dell ’Università di Bologna. Le sue aree di ricerca sono la semiotica interpretativa, la semiotica cognitiva, le scienze cognitive 4E e la psicopatologia. In particolare, il suo lavoro si concentra sull ’analisi interdisciplinare dei processi di significazione nella schizofrenia tema a cui ha dedicato la monografia “Ai confini del senso: la schizofrenia tra semiotica, psicopatologia e scienze cognitive” per l ’editore Quodlibet, disponibile in Gold oa. Attualmente è pi del progetto Young researcher “mica – Mental Illness, Creativity and Art: An Interdisciplinary Perspective on Psychopathological Artistic Creation” Collabora inoltre con il Centro Internazionale di Studi Umanistici “Umberto Eco”, con il Center for Knowledge and Cognition e con il Centre for Enactivism and Cognitive Semiotics.
Monica Torres
Professoressa presso la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Facoltà di lettere e facoltà di scienze umane. Laurea in Scienze
Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità
dell ’Educazione, specializzazione in Lingua, Cultura e Lingue (ula). Membro della Rete Internazionale di Ricerca in Letteratura Comparata e del Gruppo di Ricerca sul Patrimonio (gip) della Universidad de Los Andes.
Dottoranda in Letteratura (ula), membro del Laboratorio de semiotica y socioantropologia de las Artes, ula.
Nicola Zengiaro
Ha conseguito il dottorato in Semiotica presso l’Università di Bologna, con una tesi dedicata alla soglia che separa vita e non-vita nel contesto della biosemiotica e dell’ecosemiotica. La sua ricerca, svolta anche presso l’Università di Tartu (Estonia), si concentra sull’interazione tra segni, materia e ambienti, con particolare attenzione alla costruzione semiotica del paesaggio e alla dimensione ecologica del significato. Ricercatore e saggista, editore delle riviste Biosemiotics e Animal Studies, attualmente è borsista dell ’Università di Torino con un progetto su Intelligenza Artificiale e comunicazione animale, ed è docente del corso “Design della mente” alla Scuola Holden di Torino.
Rocco Mangieri
Architetto, musicista e semiologo. Ha studiato semiotica e filosofia del linguaggio al dams dell ’Università di Bologna e all ’Università di Urbino. Insegna semiotica delle arti alla Universidad de Los Andes e collabora regolarmente con diverse università e centri di ricerca nazionali e internazionali. Coordina il Laboratorio de semiotica y socioantropologia de las Artes della Universidad de Los Andes.
Semiotica, vita, ecologia e sostenibilità: Critici biosemiotici was typeset with Minion Pro typeface. Printed in Cali, Colombia, in October 2025.


