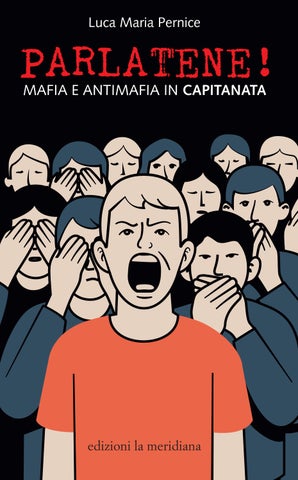Luca Maria Pernice
PARLATENE!
MAFIA E ANTIMAFIA IN CAPITANATA
ed izio ni la mer idiana
Luca Maria Pernice
PARLATENE!
Mafia e antimafia in Capitanata
Prefazione di Daniela Marcone
di Daniela Marcone*
“Parlate di mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però, parlatene”
Ho pensato di partire da un vero e proprio appello di Paolo Borsellino, diventato negli anni una citazione molto utilizzata, per incoraggiare coloro che leggeranno il testo di Luca Pernice a porsi un interrogativo: oggi si parla a sufficienza di mafia, o meglio di mafie, e se ne parla nel modo più corretto ed efficace per costruire una coscienza individuale e collettiva che muova ogni persona a fare la propria parte?
Ho consultato, di recente, la relazione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) del 1995, l’anno in cui è stato ucciso mio padre; partendo dall’indice mi sono resa conto che relativamente alla Puglia si evidenziava la sola presenza della Sacra Corona Unita (SCU), quasi come unico fenomeno criminale di stampo mafioso nell’intera regione. Effettivamente, ricordo che la stessa percezione nazionale era attestata sulla cosiddetta Sacra Corona Unita come fenomeno mafioso pugliese. Bisogna arrivare al 1997 per percepire, nella relazione DIA di quell’anno, una presa d’atto della pluralità delle organizzazioni criminali pugliesi, legata senza dubbio alle operazioni investigative che via via portavano a un chiarimento della situazione di fatto.
* Daniela Marcone lavora presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dopo l’uccisione di suo padre Francesco nel 1995, diventa, nel 1996, attivista nella rete associativa “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, nell’ambito della quale ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente nazionale per due mandati. Ora è referente nazionale memoria all’interno della Direzione della stessa rete associativa. Cura il sito della Memoria “Vivi” e si occupa di ricerca e studio della storia delle vittime innocenti delle mafie e dei fenomeni mafiosi e corruttivi ad esse legati.
Nell’opinione pubblica però, comprensiva di una parte della stampa nazionale, la Puglia resta di dominio della SCU per molti anni e poco è valso l’impegno “narrativo” di persone, me compresa, che in ogni luogo d’Italia in cui fossimo chiamate a raccontare la situazione pugliese, hanno provato a fare chiarezza. Come evidenzia bene Luca Pernice, occorrerà giungere al 9 agosto del 2017, giorno dell’efferata strage di San Marco in Lamis, perché ci si risvegli, nel modo più tragico, da una sorta di confusione collettiva e piombi su Foggia l’attenzione nazionale, da parte del livello centrale istituzionale e mediatico.
Ricordo la prima telefonata che ricevetti, nel primo pomeriggio del 9 agosto stesso, da un giornalista di un quotidiano a diffusione nazionale, che mi chiese di raccontargli di questa nuova mafia che in quel torrido giorno aveva ucciso quattro persone, di cui due innocenti. Ebbi una sensazione di scoramento profondo e puntellandomi sui tanti anni di impegno, di attenzione e cura per la mia terra, raccolsi le forze e ripresi a raccontare degli anni Novanta e oltre a Foggia, degli affari in cui le mafie foggiane avevano prosperato, della solitudine sociale vissuta in quegli anni anche a causa dell’indifferenza istituzionale di livello nazionale e della pochissima attenzione mediatica. C’era da colmare un vuoto narrativo molto grave, relativo ad almeno quarant’anni di attività delle organizzazioni criminali mafiose operanti nella provincia di Foggia e nello stesso capoluogo. Una lacuna che presenta ancora oggi delle vaste zone sconosciute alla collettività, probabilmente anche all’interno della Puglia stessa e che non riguarda solo una questione terminologica (Sacra Corona Unita o mafie foggiane), bensì fortemente sostanziale, in quanto le numerose analisi effettuate sugli altri fenomeni mafiosi più conosciuti (Cosa Nostra, Camorra e ’Ndrangheta) hanno dimostrato che per ognuno di essi è importante studiare e, quindi, applicare metodologie investigative sempre più efficaci, adatte alle peculiarità degli stessi. Non è un caso se, da quando si
sono accesi i riflettori sulle mafie foggiane, sono aumentati gli investimenti e gli interventi specifici, che hanno fatto da supporto alle molteplici operazioni investigative e ai relativi provvedimenti giudiziari, determinando risultati importanti. Questo è il tempo giusto per costruire una narrazione completa e attenta delle mafie e della cosiddetta antimafia della terra di Capitanata. Quest’ultima merita una riflessione accurata, in quanto per leggere un fenomeno con tante sfaccettature di natura sociale e culturale, occorre molta cura, per evitare inesattezze che, come ho provato a dimostrare, non possiamo più permetterci. Il nostro tempo è davvero quello giusto per raccontare delle persone che “a mani nude”, prive perfino di strumenti conoscitivi completi, hanno provato a fare la loro parte, denunciando episodi criminali che vivevano sulla propria pelle o nell’ambito del proprio impegno lavorativo e per questo sono state considerate ostacoli da spazzare via e sono state uccise. Le vittime delle mafie foggiane sono rimaste troppo tempo immerse in un silenzio mortifero, proprio perché vittime di un fenomeno criminale, come già evidenziato, misconosciuto.
Ritengo di poter affermare che sia stata proprio la caparbietà di un piccolo gruppo di cittadine e cittadini appartenenti alla comunità foggiana, che ha deciso scientemente di fare rumore intorno alle uccisioni di persone innocenti negli anni Novanta, a determinare un primo nucleo vitale da cui la memoria collettiva ha iniziato il suo processo formativo, una memoria che ha portato fino ai giorni nostri le storie individuali delle vittime, ma anche le informazioni necessarie che ci hanno permesso di recuperare la contestualizzazione sociale e culturale che ci aiuta a definire quanto accade nel nostro tempo. Questo patrimonio memoriale, di cui anche il presente testo è prezioso veicolo di trasmissione, può essere un forte strumento antimafia, che incoraggi sempre più persone a sentirsi coinvolte, prima sul piano della co-
11
noscenza e della comprensione e poi sul piano dell’azione, ciascuna per ciò che può, ma nessuna esclusa.
Concludo prendendo in prestito altre parole, quelle che costituiscono il titolo di un noto romanzo di Primo Levi, che mi paiono già da qualche anno un invito anche a me stessa: “Se non ora, quando?”.
La provincia di Foggia, nel cuore della Puglia, ha vissuto per decenni all’ombra di una realtà difficile e soffocante: quella dell’oppressione delle organizzazioni mafiose, del silenzio assordante dell’omertà e della sfiducia nelle istituzioni. Per lungo tempo, il fenomeno mafioso è stato sottovalutato – tanto dal Governo centrale quanto dalla società civile – e questo ha permesso alle mafie di radicarsi profondamente nel territorio. Un radicamento che ha contagiato non solo le strutture economiche e politiche, ma anche la stessa coscienza collettiva della comunità. La paura di opporsi, il disincanto verso le istituzioni e la convinzione che nulla potesse cambiare, sono stati per anni gli alleati delle organizzazioni criminali.
Eppure, nonostante queste difficoltà, il seme del cambiamento ha cominciato a germogliare. Negli ultimi anni – a cominciare dalla strage di San Marco in Lamis del 9 agosto del 2017, quando in un agguato mafioso furono uccisi anche due innocenti, i fratelli Luigi e Aurelio Luciani – la risposta delle istituzioni, soprattutto quelle centrali, attraverso la cosiddetta “Squadra Stato”, ha cominciato a produrre risultati significativi. Operazioni mirate, indagini incisive e la collaborazione sempre più stretta tra le forze dell’ordine, le istituzioni e i cittadini hanno portato a smantellare importanti realtà mafiose e a colpire duramente tutte le forme di illegalità che imperversavano sul territorio. I successi ottenuti sono stati fondamentali non solo nel colpire i gruppi criminali, ma anche nel restituire fiducia ai cittadi-
ni che hanno ricominciato a credere nella possibilità di un cambiamento.
Ma in questo processo di riscatto c’è un aspetto che non può essere ignorato: l’importanza fondamentale dell’antimafia. Non solo quella delle associazioni che da sempre hanno avuto nel loro DNA la missione di contrastare le mafie, ma anche e soprattutto quella di ogni singolo cittadino. La lotta alla criminalità organizzata non può essere delegata esclusivamente alle istituzioni o alle forze dell’ordine. È necessario che ciascun individuo, nella propria quotidianità, dia il proprio contributo. Non voltandosi dall’altra parte quando la legalità viene violata, ma facendo sentire la propria voce, prendendo posizione e rifiutando di accettare l’illegalità come una condizione ineluttabile. In questo contesto, l’antimafia non è solo una lotta contro la criminalità, ma una vera e propria battaglia per la dignità, la giustizia e il futuro di un intero territorio. In questo libro, anche attraverso le parole dei protagonisti di questo nuovo volto del territorio, ho voluto raccontare il cammino difficile ma significativo dell’antimafia in provincia di Foggia, un cammino che ha visto l’impegno di magistrati, appartenenti alle forze dell’ordine, associazioni e cittadini, ma anche l’importanza di un cambiamento culturale che ha coinvolto ogni angolo della società. La lotta contro le mafie non è mai finita, ma oggi possiamo dire che, grazie alla determinazione e al coraggio di chi ha scelto di non restare in silenzio, il futuro della provincia di Foggia può essere guardato con maggiore speranza.
PARTE PRIMA
LA SOCIETÀ
FOGGIANA
FOGGIA SI RIBELLA ALLA MAFIA
A maggio del 2017, Libera sceglie di tornare in Puglia per celebrare la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Dopo dieci anni da quando la giornata fu celebrata a Bari, per il 21 marzo 2018 fu scelta la città di Foggia. Una terra, quella di Capitanata, colpita da gravissimi fatti di sangue. Ad agosto del 2017, nei pressi della vecchia stazione ferroviaria di San Marco in Lamis, in un agguato mafioso furono uccisi Mario Luciano Romito, considerato elemento apicale dell’omonimo clan di Manfredonia, Matteo De Palma, suo cognato che gli faceva da autista e i fratelli Luigi e Aurelio Luciani, due agricoltori che, quel giorno, come sempre stavano controllando i loro terreni. Assassinati perché non ci fossero testimoni. Una strage che colpì tutta Italia e fece capire a livello nazionale, forse per la prima volta, che in provincia di Foggia vi era una mafia feroce e pericolosa quanto se non più delle altre. Aver scelto quel territorio, dunque, non era una decisione casuale. Libera, infatti, scelse di andare a Foggia e di fare della città capoluogo la piazza nazionale della XXIII edizione perché quella terra aveva bisogno di essere raccontata. I volontari, dal palco, furono chiarissimi:
Perché le mafie del foggiano sono organizzazioni criminali molto pericolose che facciamo una tragica fatica a leggere. Perché, malgrado l’evidenza, la percezione della cittadinanza è ancora bassa. Una mafia, quella foggiana, così invasiva
da spaventare. Le mafie foggiane sparano mentre le altre mafie non sparano più. Le mafie foggiane, tutte le mafie foggiane, mantengono la loro evidenza violenta laddove le altre mafie impongono il silenzio. Foggia è una città sotto attacco. La Capitanata è una provincia sotto attacco.
E infatti, solo nei primi nove mesi del 2017 erano già diciassette le persone morte ammazzate in provincia di Foggia, a cui si aggiungevano due casi di “lupara bianca”, ossia la scomparsa di due persone, su una popolazione di 620mila abitanti. Un dato, tanto impressionante all’epoca, ma per molti ignoto. Le mafie del foggiano hanno una loro peculiarità che le differenzia tra loro anche nella stessa provincia. E così, la manifestazione di quel 21 marzo 2018 voleva innanzitutto provare a generare consapevolezza e colmare un ritardo storico, figlio soprattutto della sottovalutazione da parte delle istituzioni nazionali.
Le giornate del 21 marzo di Libera erano nate dopo che don Luigi Ciotti aveva raccolto il dolore di una madre che aveva perso il figlio nella strage di Capaci ma che, in tutte le ricorrenze, non aveva mai sentito il nome del suo ragazzo. E così dal 1996 ogni anno, in una città diversa, vengono letti i nomi e i cognomi delle vittime innocenti di mafia: un elenco che anno dopo anno diventa sempre più lungo e che serve per mantenere vivi nella memoria collettiva quegli uomini, quelle donne e quei ragazzi uccisi dalla barbarie mafiosa.
Il 21 marzo del 2018 le strade di Foggia furono invase da ragazzi, associazioni, sindaci provenienti da tutta la Regione e sindacati. C’erano gli scout e, in prima fila, come accade ogni anno, c’erano i familiari delle vittime uccise dalle mafie. Oltre 40mila le persone che, quella mattina, ascoltarono in silenzio quei nomi e cognomi. Dal palco tuonò don Luigi Ciotti:
Non dimentichiamoci che la prima corruzione è quella delle coscienze. Il problema siamo noi, non le mafie. Possibile che milioni di italiani onesti non riescano a voltare pagina? Il cambiamento che noi desideriamo ha bisogno di ciascuno di
noi. Noi dobbiamo essere questo cambiamento. Noi dobbiamo essere questa speranza.
Poi il sacerdote si rivolse direttamente ai mafiosi foggiani:
Alle persone che sono dentro le organizzazioni criminali, da questo palco, da Foggia, dopo aver sentito questo interminabile elenco di persone assassinate, una parola a voi: non è vita quella che fate, vi aspetta o il carcere o la morte. Vi aspetta il dovervi nascondere, perché sarà il bene a vincere sul male. Perché noi, unendo le nostre forze, diventiamo più forti di voi. Non bastano le vostre bombe, le auto incendiate. Non ce la farete. Vi prego, cambiate vita, trovate questo coraggio.
Quelle 40mila persone che sfidarono la pioggia e che sfidarono anche l’omertà e la paura che per decenni avevano caratterizzano quel territorio, furono testimoni che qualcosa davvero stava cambiando. La manifestazione di Libera del 21 marzo del 2018 non disse che tutta la provincia di Foggia era mafiosa. Ma spiegò, a tutti, che quelle foggiane erano mafie violente, che avevano le mani ben piantate negli affari e che erano il freno allo sviluppo economico e civile.
Sasà Spinelli, all’epoca referente provinciale di Libera, ricorda che:
Quel giorno Foggia fu invasa da una marea, un’onda d’urto con i suoi colori, con la sua energia propositiva. Un mare fatto di piccoli fiumi e torrenti che nei mesi precedenti erano stati scavati e alimentati, liberati da dighe fatte di diffidenza, mancanza di dialogo e d’informazione, individualismo o, peggio, di paura e rassegnazione. Non sarà certo una manifestazione a risolvere i problemi atavici della Capitanata, ma era importante dare una risposta collettiva per supportare chi, quotidianamente e nel suo piccolo, prova a dare un contributo al bene collettivo.
E di rete parla Aldo Ligustro, presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, che diede un impulso importante per quel 21 marzo.
19
Una rete che rappresenta la parte migliore e, ne siamo convinti, anche maggioritaria della società, determinata e impegnata a spezzare le odiose e opprimenti catene imposte dalle mafie e dalla criminalità organizzata. Per contrastare efficacemente la mafia non è sufficiente l’impegno di forze dell’ordine e magistrati, ma è necessario diffondere nelle coscienze di tutti la consapevolezza della sua pericolosità, contrapponendovi la cultura e la pratica della legalità.
Tra le associazioni presenti quel giorno anche il CSV Foggia, Centro di Servizio al Volontariato, ente che opera in tutta la Capitanata e in alcuni comuni della BAT. Tra i suoi obiettivi ha anche quello della promozione di un sistema di relazioni territoriali tra le diverse associazioni e le istituzioni locali, per costruire una progettualità comune e promuovere in maniera efficace il volontariato e i principi della solidarietà. Il CSV Foggia ha da subito sostenuto e affiancato Libera per organizzare la giornata e costruire una rete che abbracciasse tutte le varie anime del terzo settore della Provincia.
Oggi, Roberto Lavanna, sociologo e direttore del CSV Foggia, ricorda:
Da sempre abbiamo lavorato con le forze antimafia di Foggia e, in particolare, con Libera e ci è sembrato normale dare tutto l’appoggio possibile alla manifestazione. È stato un evento storico per la città di Foggia. Ne aveva bisogno anche per quello che è accaduto dopo con lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose. Quella del 2018 non è stata la solita manifestazione, ma è stata una manifestazione corale, fatta da tanti cittadini e associazioni che hanno voluto far sentire la propria voce. Quel giorno c’è stato un grido di dolore ma anche una riscossa della città.
Lavanna sostiene anche che per tanto tempo nel territorio foggiano “era impossibile parlare di mafia”.
Invece, dopo quella manifestazione, tutto è cambiato. L’indifferenza e il silenzio alimentano le mafie. Per questo bisogna romperle. E quel giorno c’è stata una forza dirompente che è servita anche per il dopo. Parlare oggi di mafia e di
sottocultura mafiosa significa parlare di noi stessi, di una cultura che disprezza i diritti civili e sociali delle persone, impone la legge del più forte, nega cittadinanza alle differenze.
Dopo quel 21 marzo è davvero cambiato qualcosa. Lo Stato ha compreso la pericolosità della cosiddetta Quarta Mafia, la criminalità organizzata della provincia di Foggia. Due anni dopo quel 21 marzo l’allora procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho spiegò che la Quarta Mafia è una
[...] mafia feroce, aggressiva e violenta, che usa le armi non solo per piegare le vittime di estorsione per pagare il pizzo, ma anche per contrastare gli altri clan sul territorio, [che a differenza delle altre] non utilizza la strategia dell’inabissamento, ma la violenza feroce: la vittima deve non solo essere uccisa, ma scomparire dal ricordo della gente, e questo spiega come, nei casi di omicidio, si riscontrino vari colpi inferti al volto.
E lo Stato fece la sua parte. Il 15 maggio del 2018 a San Severo fu istituito il Reparto Prevenzione Crimine Puglia Settentrionale della polizia. Qualche mese più tardi, il 21 settembre, nacque lo Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori di Puglia” e nel febbraio del 2020 fu istituita anche una sezione della DIA. Nell’aprile del 2017 a Foggia era stato già inaugurato il Ros, il Raggruppamento Operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri. Ma la manifestazione del 21 marzo del 2018 fu importante perché dimostrò che la gente, quella onesta, era al fianco di chi non si rassegna alla violenza mafiosa, alla corruzione e agli abusi di potere. Una manifestazione importante anche perché ha valorizzato l’opera di tante realtà, laiche e cattoliche, istituzionali e associative, impegnate in una terra difficile, ma generosa, per il bene comune, per la dignità e la libertà delle persone. Da quel giorno è cambiata soprattutto la percezione della Quarta Mafia nel panorama nazionale. Grazie anche a quel 21 marzo ci sono state le prime denun-
21
ce e gli imprenditori e i commercianti vittime delle estorsioni hanno compreso che non sono soli.
NICOLA CIUFFREDA:
UN DELITTO SENZA COLPEVOLE
Nicola Ciuffreda nacque a Mattinata il 14 luglio del 1937. Primo di cinque figli, quando il padre fu chiamato per combattere la Seconda Guerra Mondiale, nonostante la sua giovane età si fece carico non solo della cura della sua famiglia, ma anche del suo sostentamento economico. All’età di 13 anni decise di trasferirsi a Manfredonia dove trovò un lavoro come operaio, senza però tralasciare il piccolo terreno di famiglia a Mattinata. Iniziò a produrre olio e dopo qualche anno di duro lavoro e sacrificio, comprò la sua prima azienda agricola. Proprio in quegli anni scoprì la sua passione per l’edilizia reinvestendo il ricavato dell’azienda agricola in quel settore. Nel 1972 a Lucera realizzò il primo palazzo, per poi passare a Manfredonia e Foggia. In poco tempo divenne uno dei più importanti imprenditori edili della provincia. E questo lo scoprì anche la mafia foggiana che, tra novembre e dicembre del 1989, gli fece la prima telefonata estorsiva. Se avesse voluto continuare a lavorare “tranquillamente” avrebbe dovuto pagare una estorsione alla mafia locale. Due miliardi di lire. Subito dopo aver riattaccato la cornetta, Ciuffreda decise che non avrebbe pagato, anzi, il giorno dopo denunciò tutto ai carabinieri che misero sotto controllo i telefoni della sua abitazione e predisposero il monitoraggio dei suoi spostamenti. Incredulo per quello che gli era accaduto, chiese a qualche suo collega se avesse ricevuto simili richieste. Tutti i colleghi negarono.
La mafia continuò a minacciarlo con telefonate in ufficio e facendogli recapitare buste contenenti proiettili di pistola. La pretesa economica scese a 500 milioni di lire. Nicola Ciuffreda, però, decise di andare avanti e di non piegarsi al ricatto della criminalità organizzata. Neanche quando minacciarono di ammazzargli un figlio.
Qualche mese dopo aprì un nuovo cantiere in via Eugenio Masi. Per la mafia rappresentò un vero affronto. Un affronto che non poteva passare. E così la Società decise che era necessaria una risposta esemplare. Il 14 settembre del 1990 l’imprenditore, come sempre, arrivò sul cantiere prima di tutti. Subito dopo il figlio Giuseppe e gli operai. Erano tutti ancora fermi davanti alla cancellata del cantiere quando giunse una motocicletta con a bordo due persone. Una estrasse una pistola sparando otto colpi che raggiunsero Ciuffreda alla testa, al collo, al torace, all’addome e alle gambe. Fu immediatamente soccorso dagli operai e dal figlio. Una corsa inutile verso l’ospedale dove morì poco dopo il suo arrivo. Nicola Ciuffreda fu ucciso perché si era ribellato alla mafia, non si era piegato al racket delle estorsioni. Un affronto grave che doveva essere punito anche per dare un segnale agli altri – imprenditori e commercianti –vittime di quel sistema mafioso. Una vera e propria esecuzione ancora oggi senza mandanti né colpevoli certi, anche perché, all’epoca, magistratura e inquirenti non avevano tecniche e competenze raffinate e, duole dirlo, spesso sottovalutavano la complessità e gravità del fenomeno mafioso a Foggia, arrivando spesso a negarlo. Il nome di Ciuffreda sarà poi inserito nel processo per l’omicidio di Giovanni Panunzio, l’imprenditore foggiano ucciso alcuni anni dopo.
Ricorda oggi Roberto Ciuffreda, imprenditore agricolo e figlio di Nicola:
Dopo l’omicidio di mio padre siamo stati lasciati soli. Anche la città di Foggia ci ha abbandonato.
Per il troppo dolore ci siamo chiusi a riccio e le istituzioni, i colleghi di mio padre, ci hanno dimenticato. L’omicidio di mio padre è stata un’esecuzione. È stato ucciso perché ha osato ribellarsi e bisognava dare un segnale agli altri imprenditori: se non pagate fate la stessa fine. Dopo la sua esecuzione è iniziato il declino della città. Il delitto è avvenuto negli anni Novanta quando gli investigatori non avevano gli strumenti di oggi. Ed era molto più difficile fare le indagini. Anche perché le mafie foggiane erano sottovalutate. La nostra famiglia si è chiusa a riccio per il troppo dolore. Un dolore che è vivo ancora oggi. Ma nessuno ci ha aiutato. La città non ha reagito. Forse per paura. Era la prima volta che accadeva una cosa così drammatica. Siamo stati dimenticati e lasciati soli. Per molti anni la città è stata soggiogata dalla criminalità. Era una città omertosa.
Ma con il passare degli anni qualcosa è cambiato anche a Foggia e il figlio dell’imprenditore ucciso prosegue:
Ho realizzato che qualcosa è cambiato dopo le due manifestazioni di Libera, del 21 marzo del 2018 e del10 gennaio del 2020. Sono stati segnali importanti di reazione da parte della società civile. Ma non possiamo dimenticare gli arresti importanti delle forze dell’ordine e della Magistratura negli ultimi anni. Non sono arrabbiato con la città. Perché la capisco, in qualche modo. Foggia aveva troppa paura. Ma oggi chiedo che nessuna vittima sia lasciata sola. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. Perché non uccidono solo le armi. Anche la solitudine ammazza.
“Parlate di mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene.”
Paolo Borsellino, commemorando il collega e amico Giovanni Falcone, non poteva sapere che poche settimane dopo la ma a avrebbe ucciso anche lui. Una cosa, però, era chiarissima al magistrato palermitano: della ma a bisognava parlare. Quell’appello, a decenni di distanza, risuona ancora con la stessa forza e urgenza ogni volta che con le ma e si è chiamati a confrontarsi. Il silenzio durato troppo a lungo sulla cosiddetta “Quarta Ma a”, radicata, feroce, capace di rigenerarsi e stringere nuove alleanze in un territorio, la Capitanata, che per decenni ha vissuto nell’ombra, tra omertà e sottovalutazione da parte delle istituzioni, ha lasciato che la Società Foggiana venisse confusa con la microdelinquenza. Ma qualcosa è cambiato a partire dalla strage di San Marco in Lamis del 2017. Il volume racconta questo cambiamento e il dif cile, ma necessario, cammino dell’antima a sociale: un fronte fatto non solo di magistrati e forze dell’ordine, ma anche di cittadini e associazioni che hanno deciso di non voltarsi più dall’altra parte.
Le pagine scritte da Luca Maria Pernice sono molto più di una ricostruzione storica: sono il racconto documentato e profondo di un territorio segnato da violenza e silenzi, ma anche da coraggio e riscatto.
Un invito forte e necessario a non restare indifferenti. Perché la lotta alla ma a non è solo una questione giudiziaria, ma un dovere collettivo.
Euro 18,00 (I.i.)
ISBN 979-12-5626-063-8
9791256260638