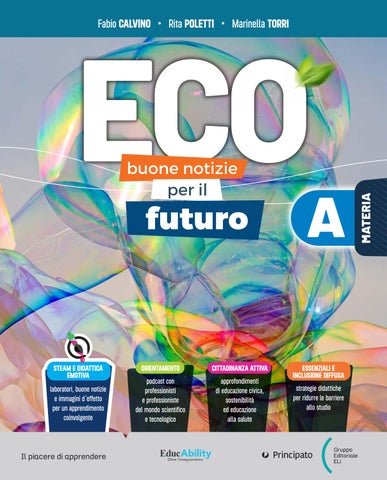A MATERIA ECO buone notizie per il futuro

STEAM E DIDATTICA EMOTIVA
laboratori, buone notizie e immagini d’effetto per un apprendimento coinvolgente
ORIENTAMENTO
podcast con professionisti e professioniste del mondo scientifico e tecnologico
CITTADINANZA ATTIVA
approfondimenti di educazione civica, sostenibilità ed educazione alla salute
ESSENZIALI E INCLUSIONE DIFFUSA
strategie didattiche per ridurre le barriere allo studio
Coordinamento redazionale: Marco Mauri
Responsabile di progetto: Martina Mirabella
Redazione e revisione scientifica: Martina Mirabella, G.E.M.
Art director: Enrica Bologni
Revisione linguistica: Lisa Suett
Progetto grafico e impaginazione: G.E.M.
Copertina: G.E.M.
Ricerca iconografica: Martina Mirabella
Disegni: Daniele Gianni
Immagini di copertina: Shutterstock
La rubrica Lezioni in anteprima e la stesura degli storyboard di alcuni video sono a cura della professoressa Chiara Amati.
La gamification Mission 2030 è realizzata da Eicon, Torino.
Referenze iconografiche:
Shutterstock, NASA (p.45; p.93; p.282)
Tutte le altre immagini provengono dall’Archivio Principato.
Per le riproduzioni di testi e immagini appartenenti a terzi, inserite in quest’opera, l’editore è a disposizione degli aventi diritto non potuti reperire, nonché per eventuali non volute omissioni e/o errori di attribuzione nei riferimenti.
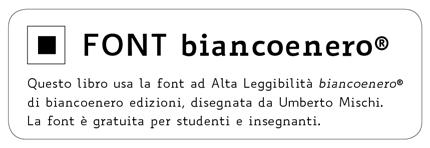
Contenuti digitali
Progettazione: Giovanna Moraglia
Realizzazione: Alberto Vailati Canta, Giovanna Moraglia, Chiara Amati, Marta Bencich, bSmart labs
Prima edizione: gennaio 2024
Printed in Italy
RINGRAZIAMENTI
Per la collaborazione alla realizzazione della rubrica Le professioni del tuo futuro si ringraziano: Luca Antonelli, Pietro Carrara, Maria Luisa Chiaramonte, Giulia Ciconali, Andrea Cioffi, Stefano Giovanzana, Marta Mauri, Paolo Moggio, Marco Piacentini, Simone Salgarollo, Giuseppe Scalia, Stefania Tosto.
© 2024 - Proprietà letteraria riservata. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi (Centro licenze e autorizzazioni per le riproduzioni editoriali), corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org. L’editore fornisce – per il tramite dei testi scolastici da esso pubblicati e attraverso i relativi supporti nel sito www.gruppoeli.it materiali e link a siti di terze parti esclusivamente per fini didattici o perché indicati e consigliati da altri siti istituzionali. Pertanto l’editore non è responsabile, neppure indirettamente, del contenuto e delle immagini riprodotte su tali siti in data successiva a quella della pubblicazione, dopo aver controllato la correttezza degli indirizzi web ai quali si rimanda.
Casa Editrice G. Principato www.gruppoeli.it Via G.B. Fauché 10 - 20154 Milano e-mail: info@gruppoeli.it
La casa editrice attua procedure idonee ad assicurare la qualità nel processo di progettazione, realizzazione e distribuzione dei prodotti editoriali. La realizzazione di un libro scolastico è infatti un’attività complessa che comporta controlli di varia natura. È pertanto possibile che, dopo la pubblicazione, siano riscontrabili errori e imprecisioni. La casa editrice ringrazia fin da ora chi vorrà segnalarli a: Servizio clienti Principato e-mail: info@gruppoeli.it
Stampa: Tecnostampa - Pigini Group Printing Division - Loreto - Trevi 23.85.272.01 © Casa Editrice G. Principato
BUONE NOTIZIE PER IL FUTURO

Video
Filmati, animazioni e Video AR per iniziare e integrare le lezioni.
Contenuti digitali integrativi
Nelle pagine sono inserite le seguenti icone che indicano la presenza e il tipo di contenuti digitali disponibili sul libro.

Audio
Lezioni in MP3 per ripassare le lezioni e listening in lingua inglese.
Sistema Digitale
Accessibile
Il Sistema Digitale Accessibile soddisfa pienamente le esigenze della didattica inclusiva con queste funzionalità di base:
• carattere specifico ad alta leggibilità e alto contrasto
• sintesi vocale dei contenuti testuali (audiolibro)
• pagine “liquide” con possibilità d’ingrandimento

Realtà Aumentata
L’applicazione librARsi permette di accedere ai contenuti multimediali direttamente da smartphone e tablet in modo semplice e rapido:
• scarica l’App gratuita
• inquadra la pagina del libro in cui sono presenti le icone dei contenuti digitali
• accedi ai contenuti multimediali
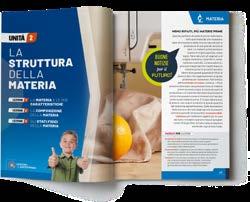

Podcast
Interviste a scienziati e scienziate.

Download
Lezioni in anteprima Presentazioni digitali dei contenuti delle unità.

HTML
Oggetti interattivi per visualizzare e approfondire i contenuti.

Galleria di immagini
Gallery per arricchire di informazioni il testo.
Esercizi
Test di diversa tipologia a correzione immediata.

Raccolta
Insieme di oggetti digitali.

Collegamento web
È il gioco online per scoprire i 17 obiettivi e i traguardi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

I contenuti digitali sono fruibili sul sito www.gruppoeli.it, sull’ e con l’App librARsi


BUONE NOTIZIE PER IL FUTURO
È
ANCORA POSSIBILE CAMBIARE LE SORTI DEL PIANETA!
Infatti sono numerose le soluzioni che la tecnologia e la scienza ci offrono per migliorare le sorti del pianeta e della nostra vita.
Con scoprirai che ci sono tante buone notizie per il futuro della Terra.
COME È FATTO IL TUO LIBRO?
I TEMI
Racchiudono contenuti
scientifici affini e sono introdotti da un breve testo che chiarisce le relazioni che li uniscono.
Il box Parole per capire spiega il significato di alcuni termini, non solo scientifici, che in apertura sono solo anticipati ma che trovano applicazione nelle unità del tema.
L’UNITÀ
Qui si concentra il messaggio positivo di ECO
L’immagine di grande impatto visivo è sempre correlata alla rubrica e può essere usata come avvio di unità.
LA LEZIONE
È il momento dello studio.
Comincia con un VIDEO, un LAB STEM o un LAB TINKERING, poi affronta i fenomeni naturali.
















Il tema dell’orientamento è affrontato in Le professioni del tuo futuro, dove scienziati e scienziate raccontano la loro formazione e la professione che svolgono.
La rubrica Buone notizie per il futuro caratterizza ogni apertura di unità.
Il box Si dice che… sfida le false conoscenze e fornisce la giusta spiegazione ai fenomeni della realtà che ci circonda.
Per aiutarti nella lettura, definizioni e didascalie sono in caratteri ad alta leggibilità.
LE ECOLEZIONI
Gli argomenti di ecologia e le questioni ambientali sono trattati in vere lezioni che richiamano e spiegano gli obiettivi dell’Agenda 2030.







LE VERIFICHE




GLI APPROFONDIMENTI
Approfondisci i temi di educazione ambientale, sostenibilità ed educazione alla salute con la rubrica CITTADINANZA ATTIVA e “osserva” contenuti nuovi con la rubrica VISUAL, anche in versione ECOVISUAL.







Alla fine dell’unità trovi tutto ciò che ti serve per ripassare, fissare le conoscenze e mettere alla prova le competenze in font ad alta leggibilità. Il ripasso è facilitato dalla mappa attiva e dagli esercizi di verifica suddivisi per lezione.









Impara e… divertiti!
Insieme ai volumi del corso trovi SKILL BOOK, una raccolta di schede con tantissime attività: lab stem, lab steam e lab tinkering, letture per approfondire, compiti di realtà, debate, attività coding, percorsi interdisciplinari.
Scegli la tua attività, stacca la scheda e inseriscila nel raccoglitore!









MATERIA



LA SCIENZA E IL SUO METODO











La ricerca di Hasler Grandezze e misure
Misurare lunghezza, superficie
Parla lo scienziato
Leggi le norme di sicurezza in laboratorio
LA STRUTTURA DELLA MATERIA
1
materia e le sue caratteristiche
1. La materia forma tutto quello che ci circonda
2. La materia possiede proprietà fisiche e chimiche
3. La materia si presenta in diverse forme chiamate sostanze


lezione 2
composizione della materia
1. La materia è formata da atomi
2. Dagli atomi alle molecole
3. Le sostanze possono essere semplici o composte
4. I miscugli
3 Gli stati fisici della materia
1. Solidi, liquidi e aeriformi
2. Le proprietà dei solidi
3. Le proprietà dei liquidi e degli aeriformi
4. Lo stato di plasma




Pic-nic nel parco Separare i miscugli Sale d’Italia I miscugli
Gli stati d’aggregazione dell’acqua


Lezioni in MP3
Test interattivi

Listening
3 UNITÀ
LA TEMPERATURA E IL CALORE
lezione 1 La temperatura
1. La temperatura e l’agitazione termica
2. Il calore è una forma di energia
3. Relazioni fra temperatura e calore
4. La misura della temperatura
5. Le scale termometriche
La misura del calore
Il calore specifico
La capacità termica
3 La propagazione del calore
1. Il calore si propaga
2. La propagazione del calore nei solidi
3. La propagazione del calore nei liquidi e negli aeriformi
4. La propagazione del calore nel vuoto
5. La dilatazione termica
lezione 4 I cambiamenti di stato della materia
1. Da uno stato all’altro
2. Il passaggio da solido a liquido
3. Il passaggio da liquido a solido
4. Il passaggio da liquido ad aeriforme



LEZIONI IN ANTEPRIMA Le scale termometriche Come funziona il calorimetro

Come si muovono le correnti convettive in una stanza?

I passaggi di stato
5. Il passaggio da vapore a liquido
6. Il passaggio da gas a liquido 84
7. Il passaggio da solido ad aeriforme e viceversa 84


4 UNITÀ
LA CHIMICA DELLA MATERIA
lezione 1 L’atomo e la sua struttura
1. Le sostanze si possono trasformare
2. La struttura dell’atomo
3. Come si identificano gli atomi
4. Gli isotopi
5. Come si determina il peso di un atomo: la massa atomica
lezione 2 La tavola periodica degli elementi
1. Mettere in ordine gli elementi
2. Come è strutturata la tavola periodica
3. Gli elementi sono suddivisi in categorie
Esploriamo la tavola periodica
lezione 3 I legami chimici
1. La regola dell’ottetto
2. La formula chimica
3. Perché gli atomi si combinano tra loro
4. Il legame ionico
5. Il legame covalente
6. Il legame metallico







teoria atomica Fenomeni chimici e fisici a confronto Il Sistema Periodico degli elementi

legami chimici



ionici
covalenti in
lezione 4 Le reazioni chimiche
1. Le trasformazioni chimiche
2. Le leggi che regolano le reazioni chimiche
3. I tipi di reazioni chimiche
I CONTENUTI ESSENZIALI
5 UNITÀ
I COMPOSTI CHIMICI
lezione 1 Ossidi, anidridi e basi
1. L’ossidazione
2. Gli ossidi basici o ossidi
3. Gli ossidi acidi o anidridi
4. Le basi
lezione 2 Acidi e sali
1. Gli acidi
2. I sali
lezione 3 Soluzioni acide, basiche e neutre
1. Miscugli particolari: le soluzioni
2. La solubilità
3. L’acidità e la basicità delle soluzioni
4. Gli indicatori
4 I composti organici e le biomolecole
I composti del carbonio
Gli idrocarburi
3. Le biomolecole
4. Le classi dei composti organici
mondo dei composti organici
5 ECO La chimica quotidiana
C’è chimica intorno a noi!
2. Il vetro
3. L’alluminio
La carta
5. La plastica








Scopriamo il pH di alcune sostanze Il mondo dei composti organici Dove lo butto?


Lezioni in MP3
Test interattivi

Listening
MATERIA
Corpi in movimento


6 UNITÀ
IL MOTO DEI CORPI
lezione 1 Gli elementi che descrivono il moto
1. La relatività galileiana
2. Stato di quiete, stato di moto e sistema di riferimento
3. Le caratteristiche del moto
4. Applichiamo il metodo scientifico al moto
1. La velocità
2. Il moto rettilineo uniforme
Il moto
3 L’accelerazione e il moto accelerato
L’accelerazione
2. Il moto uniformemente accelerato
3. Il moto dei corpi in caduta libera
7 UNITÀ
LE FORZE
cos’è una forza
Le caratteristiche di una forza
Come si misurano le forze
3. La composizione delle forze
4. Tanti tipi di forze
lezione 2 I principi della dinamica
1. La dinamica
2. Il primo principio della dinamica




Tutto si muove! I sistemi di riferimento inerziali Il moto rettilineo


Lezioni in MP3
Test interattivi

Listening

LEZIONI IN ANTEPRIMA

Cronaca di una partita di calcio


costruzione del poligono funicolare Il principio di inerzia
3. Il secondo principio della dinamica
4. Il terzo principio della dinamica
5. Forze e moti circolari
lezione 3 L’equilibrio dei corpi
1. La statica
2. Il baricentro
3. L’equilibrio di un corpo appoggiato e di un corpo sospeso
lezione 4 Macchine e leve
1. Le macchine semplici
2. La leva
3. I tre generi di leve
lezione 5 La pressione e le forze nei fluidi
1. La pressione
2. Il principio di Pascal
3. La pressione dei fluidi
4. La spinta idrostatica
5. La spinta aerostatica







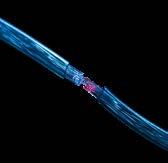


lezione 2 Le trasformazioni dell’energia
1. Altre forme di energia
2. Il principio di conservazione dell’energia
3. Le macchine termiche
4. Potenza e rendimento di una macchina
CITTADINANZA ATTIVA L’energia nucleare
lezione 3 ECO Le fonti di energia
1. Energia, un problema da affrontare
2. Le fonti di energia non rinnovabili
3. Le fonti di energia rinnovabili
CITTADINANZA ATTIVA L’energia in casa
L’ ELETTRICITÀ E IL MAGNETISMO
lezione 1 I fenomeni elettrici
L’elettrizzazione per strofinio
L’elettricità statica
3. Conduttori e isolanti
2 La corrente elettrica
La differenza di potenziale
I generatori di corrente elettrica
I circuiti elettrici
4. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm
visual Attento alla scossa
casa ecosostenibile
Tecnologie per migliorare il Pianeta
2. Come è fatta l’etichetta energetica
3. L’evoluzione della lampadina
Il risparmio energetico
I poli magnetici
Il campo magnetico
1. La corrente elettrica genera un campo magnetico
2. L’elettrocalamita
3. L’induzione elettromagnetica








per contatto



La corrente elettrica Chi consuma di più?

Lezioni


IL SUONO E LA LUCE
lezione 1 Che cos’è il suono
1. Le sorgenti sonore
2. La propagazione del suono
3. Le onde sonore
4. Le caratteristiche di un’onda
2 Le caratteristiche dei suoni
Altezza, intensità e timbro dei suoni
La velocità del suono
3. La riflessione del suono
4. La risonanza
lezione 3 Che cos’è la luce
1. L’energia luminosa
2. La propagazione rettilinea della luce
3. Sorgenti luminose e corpi illuminati
4. Ombra e penombra
lezione 4 Riflessione, diffusione e rifrazione della luce
1. La riflessione della luce
Gli specchi
La diffusione della luce
La rifrazione della luce
Le lenti
5 I colori
La luce bianca
2. La dispersione della luce
3. I colori degli oggetti


Le caratteristiche delle onde

Il campo di udibilità

L’ecolocalizzazione dei pipistrelli

Luce: onda o particelle?

Lo spettro elettromagnetico

Fenomeni ottici

L’esperimento di Newton



I colori complementari
Lezioni in MP3 Test interattivi

Listening
1 MATERIA TEMA Le teorie scientifiche e i fenomeni naturali
Viviamo in un mondo fatto di materia: sono materia tutti gli organismi viventi, l’aria che respiriamo, gli oggetti che usiamo ogni giorno, il nostro stesso corpo. Pertanto, è dalla materia che dobbiamo cominciare le nostre indagini per comprendere come funziona e come è fatta la realtà. Le discipline scientifiche che ci aiutano più di altre in questo compito sono le hard sciences, “scienze dure”, che comprendono la fisica, la chimica, la biologia. Ma perché le hanno chiamate così?
Queste discipline scientifiche hanno in comune l’uso sistematico di un metodo di indagine della realtà, il metodo scientifico, e l’utilizzo del linguaggio della matematica per rielaborare i dati raccolti. L’applicazione del metodo scientifico ha permesso, nel corso degli anni, di raccogliere una grandissima quantità di dati sperimentali, grazie ai quali sono state elaborate le leggi e le teorie scientifiche con le quali spieghiamo i fenomeni naturali.
L’applicazione delle scoperte della fisica e della chimica, in particolare, hanno dato uno straordinario contributo allo sviluppo umano, basti pensare ai livelli raggiunti dalle tecnologie digitali che usiamo ogni giorno, alla produzione di nuovi strumenti e farmaci usati per la cura delle malattie o per la soluzione dei problemi ambientali della Terra.
Parole per capire
Fisica • È la scienza che studia i fenomeni naturali, come il calore, il moto, la luce. Si occupa di grandezze, cioè di quantità che possono essere misurate utilizzando appositi strumenti, come il termometro, il cronometro o la bilancia.
Chimica • È la scienza che studia la composizione, la struttura e le trasformazioni della materia. Indaga sul comportamento sia della materia naturale sia della materia artificiale.
Biologia • È la scienza che studia gli organismi viventi e i fenomeni e le leggi che regolano la vita. La biologia comprende diverse discipline, come per esempio la zoologia, che studia gli animali, e la botanica che studia i vegetali.
Matematica • È la scienza che studia le quantità, i numeri, lo spazio, le strutture e i calcoli. La matematica è alla base di tutte le discipline scientifiche e tecniche.
LE PROFESSIONI del tuo futuro!






ANDREA CIOFFI, data scientist
Ha 26 anni e ha studiato Ingegneria matematica con una specializzazione in Statistica. Da sempre è affascinato da ciò che permette al computer o al cellulare di svolgere le proprie funzioni e ha trovato nello studio della matematica la risposta a tutte le sue curiosità. Oggi lavora come data scientist per una società di consulenza. Si occupa di analizzare grandi quantità di dati e di metterli in relazione per ottenere informazioni che possono essere utili in diversi ambiti, da quello medico a quello economico.
MARIA LUISA CHIARAMONTE, clinical research associate
Si è laureata in Biologia e, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in Biologia Molecolare, ha intrapreso la carriera di clinical research associate. Il suo lavoro consiste nel gestire e supervisionare la conduzione degli studi clinici su nuovi farmaci e terapie all’interno degli ospedali. Questo tipo di attività prevede il suo coinvolgimento sin dalle fasi iniziali del percorso, selezionando i centri partecipanti alla sperimentazione, e prosegue fino al completamento dello studio. I suoi compiti sono controllare che la sperimentazione sia condotta e documentata in modo appropriato, e garantire l’integrità e l’attendibilità dei dati.
GIUSEPPE SCALIA, productionmanager
Dopo l’istituto tecnico con indirizzo in elettronica e telecomunicazioni, si è laureato in Fisica all’Università di Catania con una tesi svolta presso i Laboratori Nazionali del Sud. Ha conseguito un master e ha svolto per due anni attività di ricerca presso l’Università della California di Los Angeles, occupandosi dell’applicazione delle tecniche di microscopia a fluorescenza per lo studio delle strutture inorganiche e organiche. Ha continuato ad approfondire gli studi sulla propagazione e le proprietà della luce conseguendo il dottorato di ricerca in Fisica presso l’Università di Friburgo. Si occupa di quantum key distribution, una nuova tecnologia per la protezione dei dati informatici.
PARLA LO SCIENZIATO
1 UNITÀ LA SCIENZA E IL SUO METODO
1 LEZIONE IL METODO SPERIMENTALE
2 LEZIONE FACCIAMO UN ESPERIMENTO
3 LEZIONE MISURARE LE GRANDEZZE : LUNGHEZZA , SUPERFICIE E VOLUME
4 LEZIONE MISURARE LE GRANDEZZE : MASSA , PESO E TEMPO
5 LEZIONE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI DATI

LEZIONI ANTEPRIMA in


© Casa Editrice G. Principato

UN MODELLO VIRTUALE DELLA TERRA
BUONE NOTIZIE per il futuro!
A partire dal XVII secolo l’ideazione del metodo scientifico per indagare il mondo che ci circonda ha permesso di ottenere grandi risultati in ogni tipo di ricerca scientifica. La complessità della realtà però presenta situazioni in cui il metodo scientifico non è sempre applicabile, per esempio perché il fenomeno non è “ancora” avvenuto e si vuole conoscere la sua evoluzione nel tempo: ciò è tipico della meteorologia, dell’astronomia, di una epidemia da virus. In queste situazioni una grande quantità di dati e di variabili concorrono a determinare un risultato piuttosto che un altro. L’invenzione dei computer ha permesso di studiare questi fenomeni e di gestire un’enorme quantità di dati con i quali è possibile costruire modelli scientifici virtuali di moltissimi fenomeni naturali. È il caso del “gemello digitale” della Terra, un modello virtuale e fedelissimo del nostro pianeta, grazie al quale gli scienziati possono studiare gli effetti del cambiamento climatico, lo stato degli oceani, la biodiversità ecc. Ma non è tutto: il modello virtuale della Terra offre agli scienziati la possibilità di eseguire veri e propri esperimenti a livello globale, simulando i fenomeni naturali e le attività umane che altrimenti sarebbero impossibili da controllare.
Computer • Dispositivo elettronico programmabile, in grado di eseguire in tempi rapidissimi complessi calcoli matematici e di elaborare, memorizzare e recuperare informazioni sotto forma di dati digitali.
Modelli scientifici • Sono rappresentazioni fisiche di fenomeni naturali difficili da osservare o descrivere, oppure rappresentazioni di concetti o rappresentazioni matematiche. I modelli scientifici devono essere coerenti con osservazioni, deduzioni e spiegazioni concrete.
Parole per capire
© Casa Editrice G. Principato
1 LEZIONE IL METODO SPERIMENTALE
FLIPPED CLASSROOM
Guarda il video e scrivi le risposte sul quaderno.

Galilei e il metodo sperimentale
1. Dove e quando Galilei approfondisce la conoscenza della matematica e della fisica?
2. Quali sono i più importanti strumenti costruiti o perfezionati da Galilei?
3. Che cosa ha scoperto con il telescopio?
4. Come è strutturato il metodo scientifico sperimentale?
ORA FERMA L’IMMAGINE!
Metti in pausa il video nei seguenti punti.


5. Che cosa significa per Galilei “sensata esperienza”?
6. Che cosa sostiene nelle pagine del Saggiatore a proposito del linguaggio della natura?
1 DALLA MAGIA ALLA SCIENZA
«Perché il Sole sorge e tramonta? Perché cadono i fulmini? Perché si forma l’arcobaleno?»
Queste sono alcune delle domande che bambini e bambine rivolgono agli adulti e in questo modo manifestano il bisogno di capire il mondo che li circonda. Probabilmente anche i nostri antenati si ponevano domande simili quando cercavano una spiegazione dei fenomeni naturali che avvenivano davanti ai loro occhi.
SI DICE CHE…
L’arcobaleno si può vedere in qualsiasi ora della giornata dopo un temporale
Un tempo si riteneva che l’arcobaleno fosse un fenomeno magico, un ponte che metteva in comunicazione la terra e il cielo. Oggi sappiamo che è un fenomeno ottico prodotto dalla dispersione della luce solare ad opera delle goccioline di pioggia sospese nell’aria dopo un temporale. Perché possiamo osservare il fenomeno, tuttavia, è necessario che il Sole sia a un’altezza inferiore ai 42 gradi sull’orizzonte, condizione che si verifica solo al mattino o nel tardo pomeriggio.

I nostri antenati avevano trovato risposte magiche e mitologiche a queste domande: ad esempio il Sole è un carro infuocato che attraversa il cielo, i fulmini sono lanciati da un dio adirato che vive sulle nuvole.
Le risposte magiche non richiedevano nessuna prova e alimentavano la superstizione e il senso di paura nei confronti della natura.
I filosofi dell’antica Grecia sono stati i primi a spiegare i fenomeni naturali attraverso l’osservazione e il ragionamento. Il loro metodo non dava spiegazioni magiche, ma le risposte non prevedevano la realizzazione di esperimenti in grado di provarle. Il metodo dei filosofi greci fu utilizzato fino al Cinquecento, quando uno scienziato e artista italiano, Leonardo da Vinci, iniziò a metterlo in dubbio.
2 GALILEO GALILEI E IL METODO SPERIMENTALE
Nei primi anni del XVII secolo comincia a diffondersi l’idea che lo studio di un fenomeno naturale deve essere effettuato seguendo un determinato “metodo di lavoro”. Lo scienziato pisano Galileo Galilei (1564-1642) è stato il primo a comprendere che, per spiegare i fenomeni naturali, è necessario compiere delle osservazioni, elaborare ipotesi ed effettuare prove per verificarle 1 . Queste prove sono gli esperimenti e rappresentano la parte innovativa del “metodo di lavoro” di Galilei. Molto spesso Galilei eseguiva i suoi esperimenti in laboratorio così da seguirli passo passo; ha anche ideato e perfezionato vari strumenti per fare delle osservazioni approfondite e delle misurazioni più accurate. Analizzando i risultati dei suoi esperimenti, Galilei ricavava delle teorie che fornivano una spiegazione dei fenomeni osservati.
Il lavoro di indagine e sperimentazione ideato da Galilei è detto metodo sperimentale, o metodo scientifico.
I criteri del metodo sperimentale enunciati da Galilei sono tuttora validi e sono applicati in diversi ambiti della scienza moderna.
3 LE FASI DEL METODO SPERIMENTALE
Quando compiamo una ricerca su un fenomeno naturale seguendo il metodo sperimentale, dobbiamo procedere come farebbe uno scienziato.
1. Partiamo dall’osservazione del fenomeno naturale che attira la nostra attenzione: ad esempio l’arcobaleno che si forma, a volte, dopo un temporale, un’ape che vola da un fiore all’altro, il salmone che risale il fiume, un pezzo di ghiaccio che si scioglie. Compiute le osservazioni, ci poniamo una domanda sull’aspetto che vogliamo indagare.
2. Il nostro interesse ci porta alla formulazione di un’ipotesi che possa spiegare in modo razionale il fenomeno osservato. Per esempio, un cubetto di ghiaccio si scioglie perché la temperatura dell’ambiente è maggiore di quella del freezer. La prima spiegazione, che può essere soggettiva, quando diventa un’ipotesi ci spinge a considerare quegli aspetti della nostra osservazione che sono più utili allo scopo prefissato e che ci portano a fare una previsione sulle possibili conseguenze. Per esempio, se metto l’acqua al freddo si ghiaccia?
3. Per rispondere alla domanda, cioè per verificare le conseguenze dell’ipotesi, possiamo realizzare un esperimento. Mi procuro il materiale necessario: in questo caso alcuni contenitori, dell’acqua e un apparecchio come il frigorifero di casa che mi permette di avere un ambiente a temperatura inferiore a quella della stanza.
1 Nel ritratto Galileo Galilei tiene in mano un telescopio, lo strumento con il quale ha compiuto importanti osservazioni astronomiche.

1
2 Le fasi del metodo sperimentale.
Osservazione di un fenomeno.

in autunno le foglie di molte piante ingialliscono e cadono.
4. La fase successiva rende necessario raccogliere i dati e registrare le misurazioni. Per effettuare le misurazioni che ci servono dobbiamo utilizzare degli strumenti opportuni, nel nostro caso il termometro, che ci permette di rilevare la temperatura all’interno del frigorifero e del freezer.
Osserviamo il risultato dell’esperimento: l’acqua del contenitore riposta nel frigorifero, dove abbiamo rilevato una temperatura bassa, ma superiore a 0 °C, non si è ghiacciata, mentre quella nel freezer sì.
2
Formulazione di una domanda sull’aspetto che si vuole studiare e di un’ipotesi che lo possa spiegare in modo razionale.

queste piante smettono di fabbricare il colore verde e cominciano a produrre i colori giallo e arancio, oppure questi sono giˆà presenti nella pianta?
estraggo i colori dalle foglie verdi di una pianta e li separo: con il verde ci sono il giallo e lÕarancio.

Realizzazione di un esperimento per verificare le conseguenze dell’ipotesi.
5. Dall’analisi dei risultati traiamo le conclusioni: l’ipotesi che possiamo confermare è che l’acqua si ghiaccia nel freezer, quella che dobbiamo abbandonare è che l’acqua si ghiaccia nel frigorifero 2 . La caratteristica che devono avere gli esperimenti è la loro completa riproducibilità, cioè la possibilità di ripeterli e verificarne i risultati, grazie a una descrizione corretta e precisa del procedimento. Per questo è importante comunicare i risultati ottenuti e condividerli con il resto della comunità scientifica.
Dobbiamo ripetere più volte l’esperimento, per essere certi che il risultato ottenuto non sia frutto del caso; variamo anche la temperatura, per determinare esattamente quella di congelamento.
Quando i dati sperimentali presentano delle regolarità, ad esempio l’acqua si congela sempre alla stessa temperatura, possiamo confermare la nostra ipotesi e trasformarla in una legge scientifica . Una legge scientifica spiega come quel fenomeno naturale funziona e permette di prevedere come avverrà un fenomeno simile a quello osservato.
Le leggi e le teorie scientifiche non sono verità assolute e sono valide solo temporaneamente: possono essere riviste in qualunque momen-
raccolgo i dati in modo che anche altri possano ripetere lÕesperimento.

4
Raccolta dei dati e registrazione delle misurazioni.
lÕipotesi Òi colori giallo e arancio sono giˆà presenti nelle foglie verdiÓ è provata.

5
Conferma o abbandono dell’ipotesi iniziale sulla base dei risultati degli esperimenti.
to, quando i risultati di un nuovo esperimento forniscono elementi che mettono in discussione il contenuto della teoria stessa. È proprio per questa ragione che la scienza è sempre in evoluzione.
L’incredibile evoluzione delle scienze, in particolare negli ultimi decenni, è dovuta anche alle nuove scoperte della tecnologia, che hanno messo a nostra disposizione strumenti sofisticatissimi su oggetti diventati di uso comune. Hai mai preso in considerazione l’incredibile dotazione del tuo smartphone?
Spesso chi è assorbito da un lavoro di ricerca arriva al punto di modificare o addirittura costruirsi gli strumenti più adatti al tipo di indagine che sta conducendo. Sono proprio il metodo scientifico e questa capacità “imprenditoriale” che, applicati in qualunque ambito, permettono un costante progresso.
FISSA I CONTENUTI ESSENZIALI
Segna con una crocetta se vero (V) o falso (F).
1. Il metodo scientifico è il metodo di lavoro di chi studia i fenomeni.
2. Il primo a utilizzare il metodo sperimentale fu Leonardo da Vinci.
3. Una legge scientifica è una verità assoluta.
4. La fase iniziale del metodo scientifico è la realizzazione di un esperimento.
VERSO LE COMPETENZE
Abbina ogni azione con la corrispondente fase del metodo sperimentale. Stai pedalando e ti sembra che ci sia qualcosa che non va. Esamina la situazione come se fossi uno scienziato.
a La pedalata è faticosa anche con le gomme ben gonfie. Devi scartare la prima ipotesi.
PROVE DI COMPETENZA
MISURARE
DALL’ANTICHITÀ A OGGI
SKILL BOOK
1 Osservazione di un fenomeno
2 Formulazione di un’ipotesi
3 Previsione di conseguenze dell’ipotesi
4 Realizzazione di un esperimento
5 Conferma o smentita dell’ipotesi
6 Formulazione di un’altra ipotesi
7 Realizzazione di un altro esperimento
8 Conferma o smentita della seconda ipotesi
b Gonfi le gomme della bicicletta e riparti.
c Pensi che le gomme sgonfie rendono la pedalata più faticosa.
d Osservi che le gomme della bicicletta sono un poco sgonfie.
e Se le gomme sono gonfie, allora pedali più velocemente.
f Aggiungi qualche goccia di olio alla catena.
g Pensi a un’altra ipotesi: ad esempio la catena non è ben oliata.
h La catena gira fluida e la tua ipotesi è confermata.
1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:

2 LEZIONE FACCIAMO UN ESPERIMENTO
FLIPPED CLASSROOM
Guarda il video e scrivi le risposte sul quaderno.

La ricerca di Hasler
Raggi di Sole che filtrano dalle nuvole.
1. Qual era lo scopo dell’esperimento di Hasler?
2. Quale ipotesi ha formulato lo scienziato relativamente alla capacità di orientarsi dei salmoni?
3. Come è stato organizzato l’esperimento?
4. Quali conclusioni ha tratto Hasler dall’esame dei dati raccolti?
5. Perché è importante che i risultati di un esperimento siano pubblicati e fatti conoscere alla comunità scientifica?
FERMA L’IMMAGINE!
Metti in pausa il video nei seguenti punti.


6. Dai un titolo alle immagini e scrivi sul quaderno una didascalia per ciascuna foto (max due righe).
1 APPLICHIAMO IL METODO SPERIMENTALE
Tutti coloro che indagano sui fenomeni naturali applicano il metodo sperimentale. Se anche tu vuoi agire in modo scientifico è importante che impari a seguire le tappe che caratterizzano questo metodo di indagine della realtà che ti circonda. Applichiamo il metodo allo studio di un fenomeno che sicuramente ti sarà capitato di osservare: la propagazione della luce. La domanda è: “I raggi luminosi hanno un andamento rettilineo?”

■ Fase 1 OSSERVAZIONE DI
UN FENOMENO
Le osservazioni devono essere accurate e sistematiche e, se necessario, effettuate mediante appositi strumenti. Nella vita quotidiana è facile osservare i raggi del Sole che filtrano dalle nuvole o la traccia lasciata da un laser: in entrambi i casi i raggi luminosi sembrano mantenere una traiettoria rettilinea 1 .
ORA
■ Fase
2 FORMULAZIONE DI UNA DOMANDA SULL’ASPETTO CHE SI VUOLE STUDIARE E DI UNA IPOTESI CHE LO SPIEGHI IN MODO RAZIONALE
Questa è la parte più creativa del metodo sperimentale, servono un po’ di intuizione, immaginazione e… un pizzico di fortuna. Naturalmente non è possibile limitarsi a formulare un’ipotesi, ma occorre anche cercare di prevedere che cosa potrebbe accadere se l’ipotesi fosse confermata. La cosa migliore è fare più di una previsione, cercando di immaginare gli effetti delle possibili variazioni degli elementi in gioco.
Dalle osservazioni eseguite si può formulare l’ipotesi che la luce si propaghi in modo rettilineo indipendentemente dalla sorgente che la produce.
■ Fase
3 REALIZZAZIONE DI UN ESPERIMENTO PER VERIFICARE LE CONSEGUENZE DELL’IPOTESI
Occorre progettare l’esperimento con cura, ma non è indispensabile avere a disposizione un laboratorio. Chi studia la foresta amazzonica, per esempio, deve ingegnarsi con quello che trova!
Procurati 4 cartoncini, pratica un foro in ognuno di essi dopo averli disposti su un piano in modo che i fori siano allineati. Per tenerli ben fermi puoi usare delle mollette da bucato fissate ai lati di ogni cartoncino o realizzare una base di plastilina per tenerli allineati. Utilizza un cartoncino nero per costruire uno schermo. Da un lato disponi una candela, dall’altro dei cartoncini forati. Sullo schermo vedrai formarsi l’immagine del punto del raggio di luce che passa attraverso i fori.
Sposta uno dei cartoncini in modo che i fori non siano più allineati: il punto luce sullo schermo non sarà più visibile.
■ Fase 4 LA RACCOLTA DEI DATI
Normalmente i dati di tipo numerico o visuale (per esempio immagini di fototrappole) sono riportati in tabelle, rielaborati e presentati sotto forma di grafico. Documenta mediante fotografie i risultati del tuo esperimento dopo aver utilizzato altre fonti di luce, per esempio una torcia o una lampadina.
■ Fase 5 CONFERMA O ABBANDONO DELL’IPOTESI
In questa fase possiamo commentare i risultati ottenuti e confrontarli con quelli di esperimenti analoghi di altri scienziati; possiamo anche segnalare eventuali difficoltà che abbiamo incontrato.
Anche cambiando la sorgente di luce, il punto luminoso appare sullo schermo solo quando i fori dei cartoncini sono allineati. Questi risultati ti conducono a confermare l’ipotesi della propagazione rettilinea della luce.
2 MISURE ED ERRORI
Per effettuare un esperimento è quasi sempre necessario utilizzare degli strumenti di misura. Tuttavia, ogni volta che si misura una grandezza, cioè la si confronta con una opportuna unità di misura, sorgono dei problemi. Il primo è quello di avere sempre a disposizione dei dati comprensibili da tutti, ed è questo il motivo che ha portato la maggior parte dei paesi del mondo ad adottare il Sistema Internazionale. Il secondo problema riguarda lo strumento di misura scelto: la misura di un banco, rilevata con la riga, si ottiene con uno o al massimo due appoggi, mentre con il righello è necessario un numero maggiore di rilevazioni.

Leggi le norme di sicurezza in laboratorio
Altri problemi dipendono dalla persona che effettua la misura oppure da un’errata lettura della scala o a imprecisioni nel procedimento.
Ogni misurazione, quindi, è inevitabilmente accompagnata da errori
Come si fa, allora, a determinare il valore esatto di una grandezza?
Prima di tutto, quando affronti una misurazione, devi valutare preventivamente quale tipo di strumento ti permette la corretta rilevazione. Per esempio, la lunghezza della tua aula potrà essere circa 4-5 metri, e quindi per misurarla sarà meglio utilizzare un metro piuttosto che un righello. Inoltre, è bene ripetere più volte la misurazione e calcolare la media aritmetica (M) dei valori ottenuti. Il calcolo viene eseguito sommando i valori delle misurazioni e dividendo il risultato per il numero delle misurazioni stesse:
media aritmetica = somma dei valori numero delle misurazioni
In questo modo si cerca di limitare il più possibile il numero di errori, ma quello che ottieni è un valore approssimativo della misura cercata.
3 LA RELAZIONE DI LABORATORIO
Un esperimento non è ben realizzato se, una volta concluso, non contiene tutte le indicazioni necessarie affinché altri scienziati lo possano ripetere allo stesso modo. La relazione di laboratorio è lo strumento che ti permette la condivisione dei risultati. In questo corso, la sigla LAB STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) indica che l’attività sperimentale proposta deve essere eseguita seguendo le fasi del metodo sperimentale e prevede una relazione di laboratorio finale. L’esempio che segue riguarda un esperimento sulla combustione effettuato applicando il metodo sperimentale. Ricorda! Prima di lavorare in laboratorio devi conoscere le norme di sicurezza e il comportamento da tenere perché non avvengano incidenti, non si provochino danni e l’ambiente non venga inquinato dalle sostanze che usi.
• il nome di chi esegue l’esperimento; la data di esecuzione permette di verificare a distanza di tempo se i risultati rimangono invariati oppure no;
• il titolo indica quale esperimento si esegue;
• l’osservazione del fenomeno e l’ipotesi che si vuole verificare;
La relazione di laboratorio
nome cognome
■ Titolo
Esperimento sulla combustione
■ Osservazione del fenomeno
data / /
Un falò, la fiamma del gas, una candela accesa sono esempi di combustione, il fenomeno grazie al quale una sostanza brucia. Quali sono le condizioni necessarie perché possa avvenire una combustione? Devono esserci un materiale in grado di bruciare (il combustibile) e qualcosa che permette la combustione (il comburente), cioè l’ossigeno.
Ho ipotizzato che la combustione possa avvenire solo in presenza di ossigeno, quindi posso prevedere che in mancanza di esso la combustione non è possibile.