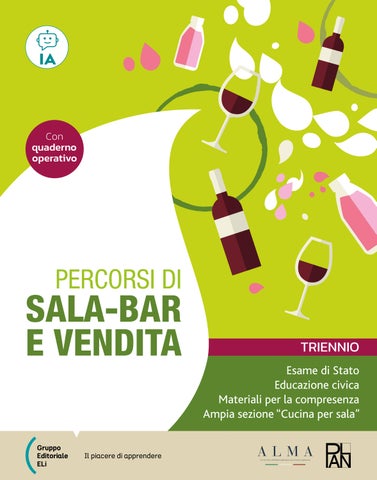Con quaderno operativo
PERCORSI DI SALA-BAR E VENDITA
Gruppo
Editoriale
ELi
Il piacere di apprendere
Esame di Stato
Educazione civica
Materiali per la compresenza
Ampia sezione “Cucina per sala” TRIENNIO
PERCORSI DI SALA-BAR E VENDITA
TRIENNIO
Gruppo Editoriale
ELi
Il piacere di apprendere
UDA 1
IL MONDO DELLA RISTORAZIONE
UDA 2
LA SICUREZZA NELLA RISTORAZIONE
UDA 3
L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE
PERCORSO 1
L’organizzazione e la gestione
1 Le risorse umane nelle imprese di servizi 80 COMPETENZE PROFESSIONALI - Formare il personale 81
2 Lo staff management 82
COMPETENZE PROFESSIONALI - L’organigramma aziendale 82
3 La politica del personale ........................................... 84
CONSIGLI PRATICI - Il recruiting: la selezione del personale ... 85
4 Il rapporto di lavoro 85
EDUCAZIONE CIVICA - La crisi dell’occupazione nel settore ristorativo 85
5 L’approvvigionamento 86
6 L’organizzazione dell’approvvigionamento 87
EDUCAZIONE CIVICA - Evitare gli sprechi nella gestione delle scorte 87
CONSIGLI PRATICI - L’acquisto della dotazione di sala 88
7 L’organizzazione del magazzino 90 COMPRESENZA - Laboratorio di Cucina: le celle frigorifere 93
8 La gestione delle
- Il controllo del food cost 99
12 Il beverage cost 100
13 La formulazione dei prezzi: le strategie di pricing 103
CONSIGLI PRATICI - Evitare errori nella formulazione dei prezzi 103
CONSIGLI PRATICI
UDA 5 LA SALA
PERCORSO 1 Il servizio di sala
1
3
LABORATORIO
1
5
- Proporre una degustazione di formaggi 207
13 I dolci 212
14 La frutta 214 CONSIGLI PRATICI - Come preparare e servire la macedonia di frutta 214
15 La cucina di sala 218
L’organizzazione della sala
PRATICI - Gestire gli
preliminare
UDA 6
ENOLOGIA E SOMMELLERIE
PERCORSO 1
Produzione e caratteristiche del vino
1 La pianta della vite
2 Il mosto
3 La fermentazione
4 Le tecniche di vinificazione .....................................
5 L’evoluzione del vino ..............................................
6 I trattamenti e le correzioni del vino
7 L’imbottigliamento e la tappatura
8 Le regole dell’enologia europea
9 L’etichettatura
LEZIONE SPECIALE
1 I vini passiti e i vini speciali
2 I vini spumanti e lo champagne
concettuale Il vino
PERCORSO 2 La degustazione e l’abbinamento
1 La decantazione
2 La composizione chimica del vino
3 Gli aspetti teorici della degustazione
PRATICI - Come mantenere i vini alla giusta temperatura
4 L’esame visivo .........................................................
5 L’esame olfattivo
6 L’esame gusto-olfattivo
UDA 7
IL SERVIZIO BAR

PERCORSO 2
Le bevande miscelate
1 L’evoluzione del bartending nel tempo 368
2 Bevande miscelate e tecniche di miscelazione 370
COMPETENZE PROFESSIONALI - La scelta delle materie prime 371
3 La classificazione delle bevande miscelate 372
4 Le attrezzature per la miscelazione 374
5 La scelta del bicchiere 378
6 La postazione di lavoro 380
7 Gli accorgimenti operativi ....................................... 381
COMPETENZE PROFESSIONALI - La scelta del cocktail 381
LABORATORIO
1 Le unità di misura e le tecniche di mescita ............... 382
2 Le tecniche di miscelazione 385
3 La guarnizione 391
NUOVE FRONTIERE DEL BEVERAGE - Guarnizioni originali e innovative 393
LEZIONE SPECIALE
1 L’assunzione di alcol etilico ..................................... 394 EDUCAZIONE CIVICA - L’alcolismo 395
2 Aperitivi e cicchetti nella storia del bere in Italia 396
3 I cocktail home made 398
Mappa concettuale Le bevande miscelate (o cocktail) 400 Sintesi 401
DOSSIER
PERCORSO 3
I distillati e i liquori
1 Il processo produttivo dei distillati 404
2 L’alambicco e i metodi di distillazione 406
3 I distillati: classificazione e servizio .......................... 408
4 I liquori .................................................................. 413
5 I liquori: classificazione e servizio 414
LEZIONE SPECIALE
1 I bitter ................................................................... 416
Mappa concettuale I distillati e i liquori 418
Sintesi 419
CUCINA PER SALA
VERIFICA DELLE COMPETENZE
La mixology contemporanea: tra sostenibilità, tecnologia e benessere 422
Assicurare salute e benessere per tutti .......................... 423
ESAME DI STATO 424
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
1 Il ruolo dei chatbot
Didattica Digitale Integrata
Approfondimenti ed esercizi interattivi
Videoricette, videolezioni e videosintesi
SOSTENIBILITÀ
Tutti gli argomenti riferiti alla sostenibilità sono segnalati dall’apposita icona.
Il Gruppo Editoriale ELi promuove una cultura delle pari opportunità rispettosa delle differenze di genere, della multiculturalità e dell’inclusione. Nel presente testo viene usata la forma maschile esclusivamente per semplificare la lettura, senza alcun intento discriminatorio.
UDA 1 IL MONDO DELLA RISTORAZIONE

PERCORSI
1 Il menu e le carte
2
La relazione
con il cliente
p. 4
p. 32
Competenze
Competenza n. 1
Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione
Competenza n. 6
Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di comunicazione più idonee
Abilità
• Monitorare il grado di soddisfazione della clientela
• Utilizzare i software applicativi di settore
• Applicare procedure e tecniche di comunicazione nei confronti del cliente
• Gestire la fidelizzazione del cliente mediante tecniche di customer care
Conoscenze
• L’evoluzione della ristorazione
• Il servizio ristorativo
• La classificazione delle aziende ristorative
• L’esperienza di acquisto del cliente
• La customer satisfaction
• Le tecniche di vendita e di comunicazione con il cliente
• La redazione di menu e carte
COMPITO DI REALTÀ
Carta dei vini, p. 49


Diritto e tecniche amministrative
Le normative che regolano le informazioni obbligatorie nei menu
Il mondo della ristorazione
Scienza e cultura dell’alimentazione
I valori nutrizionali nei menu
CLASSE CAPOVOLTA EDUCAZIONE CIVICA
Il menu: territorialità e stagionalità
Nucleo concettuale Costituzione
Competenza n. 3 Rispettare le regole e le norme che governano lo stato di diritto
Nucleo concettuale Sviluppo economico e sostenibilità
Competenza n. 5 Comprendere l’importanza della crescita economica
Il menu è lo strumento principale che mette in comunicazione l’impresa ristorativa e il cliente.
Un menu ben riuscito si basa sulla trasparenza delle informazioni e valorizza il legame con il territorio.

Guarda la videolezione e rispondi sul quaderno.
• Cosa vuol dire valorizzare i prodotti del territorio nel menu di un ristorante?
• Quali sono i vantaggi di un menu che privilegia la stagionalità?
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
1 Predisposizione di prodotti e/o servizi che abbiano come riferimento i bisogni, le attese e i profili dietetici e/o culturali del cliente
8 Ospitalità, intesa come spazio comunicativo del “customer care”
OBIETTIVO 8
Lavoro dignitoso e crescita economica, p. 49
Italiano Scrivere una ricetta
Storia
La ristorazione nel tempo
1

LA RELAZIONE CON IL CLIENTE
1 L’evoluzione della ristorazione
I ristoranti così come li intendiamo oggi sono nati in seguito a cambiamenti socio-economici abbastanza recenti. Le loro origini, però, sono assai remote: già nell’antica Grecia, ad esempio, sorgevano locande, soprattutto vicino ai templi e ai porti.

A Roma, i ceti meno abbienti consumavano i pasti per strada, dato che molto spesso era vietato cucinare in casa per il pericolo di incendi. Come accade oggi nei moderni fast food, i venditori ambulanti provvedevano alla ristorazione veloce, offrendo un po’ di tutto: olive, pesci in salamoia, pezzetti di carne arrosto, frutta, formaggio, bibite, salsicce, acciughe, pizzette e dolci. I clienti consumavano dunque pasti molto semplici e mangiavano quasi sempre cibi freddi. In alternativa, potevano consumare degli spiedini caldi di carne e pesce alla griglia nelle taverne, assieme alla polta (o puls), una specie di polenta che venne abbandonata con la diffusione del pane (dal II secolo a.C.).

distrutto dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., sono state identificate locande e osterie, frequentate dai clienti per la consumazione di vino e pasti veloci, oltre che antichi forni
A Pompei alcune imprese artigiane si dedicavano alla produzione del garum, una salsa ottenuta dalla macerazione sotto sale delle interiora di pesce, condite con olio, vino, aceto e pepe.
GUIDA ALLO STUDIO
1 Nell’antica Grecia era vietato aprire locande vicino ai templi
2 Nell’antica Roma era proibito mangiare per strada
3 Nelle taverne romane venivano proposti cibi caldi
4 A Pompei sorgevano locande, osterie e forni


Nel Medioevo, con la crescita degli scambi commerciali e dei pellegrinaggi, comparvero le prime forme di ristorazione pubblica: nelle città si moltiplicarono le taverne e le locande. A partire dall’VIII-IX secolo, l’alimentazione si diversificò sempre di più a seconda delle classi sociali: i clienti più abbienti prediligevano carne e selvaggina, mentre i contadini restarono legati ai prodotti della terra, come cereali, legumi e ortaggi.
Nel Rinascimento la cucina si caratterizzò per il diffondersi di sontuosi banchetti presso le corti delle famiglie nobili, con presentazioni altamente scenografiche. Per gli allestimenti dei banchetti ci si avvaleva della collaborazione di artisti e artigiani tra i più noti dell’epoca, che trasformavano il pasto in una vera e propria messinscena teatrale. I cuochi più rinomati prestavano servizio presso le famiglie benestanti

Nel Seicento divenne chiara l’influenza della cucina francese, che nel Settecento si elevò a punto di riferimento per i cuochi di tutta Europa. Il modello della cucina delle corti italiane entrò in crisi e furono i cuochi francesi a imporre le nuove mode. Risale circa alla metà del Settecento il successo del ristorante di monsieur Boulanger, che iniziò a offrire nel suo locale di Parigi cibi cotti e brodi caldi. L’esercizio commerciale di Boulanger è considerato il primo ristorante della storia, caratterizzato da un ambiente ben arredato e accogliente, una maggiore ricercatezza dei piatti proposti, tavoli apparecchiati e più intimi che andarono a sostituire la tavolata unica tipica della taverna.

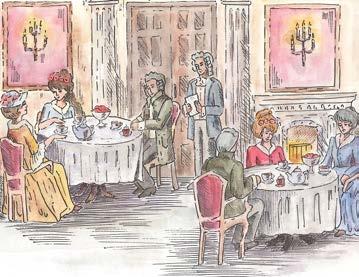
CLASSE CAPOVOLTA – Costruire una linea del tempo
Nell’Ottocento, i ristoranti iniziarono a essere diretti dai cuochi e aperti a clienti paganti senza distinzioni di ceto. A differenza dei lunghi e sontuosi pranzi nobiliari del Rinascimento, nei quali veniva servito ogni tipo di pietanza, nei ristoranti iniziò a essere esposta la carta dei piatti, il menu, dove i clienti potevano scegliere cosa ordinare.
COMPETENZA DIGITALE
A casa: schematizza in una linea del tempo i principali avvenimenti che hanno contrassegnato la storia della ristorazione. La linea del tempo è uno strumento utile a collocare gli eventi in ordine cronologico ed è costituita da una freccia che indica la direzione del tempo.
• Per prima cosa raccogli le informazioni che intendi schematizzare.
• Scegli come impostare la linea del tempo: se prediligi una linea orizzontale, ricorda che i fatti storici più antichi sono collocati a sinistra, mentre quelli più recenti si trovano a destra; se invece decidi di optare per una linea verticale, il primo evento va inserito nella parte superiore e l’ultimo nella parte inferiore.
• Disegna sul quaderno la linea del tempo, o usa un software che permette di costruire linee del tempo.
• Inserisci le epoche storiche, le descrizioni degli eventi e arricchiscile con immagini pertinenti.
• Inserisci le tue riflessioni sull’evoluzione del rapporto cliente-ristorazione nel corso del tempo. A scuola: presenta il lavoro all’insegnante ed esponi alla classe gli avvenimenti in ordine cronologico.

Auguste Escoffier
Cuoco francese vissuto dal 1846 al 1935, è considerato uno degli chef più influenti nella storia. IL PROTAGONISTA
2 La cucina classica e la cucina moderna
Alla fine dell’Ottocento la ristorazione conobbe un significativo sviluppo grazie all’incontro tra il cuoco Auguste Escoffier, genio della cucina francese, e l’imprenditore svizzero Cesar Ritz Ritz aprì alberghi di lusso in tutta Europa, da Londra a Parigi, ed Escoffier si incaricò di gestirne la ristorazione. Fu Escoffier a codificare per primo la cucina classica, raccogliendo le ricette dei cuochi e le esperienze culinarie del passato, che affondavano le radici nella cucina delle corti europee del Cinquecento, caratterizzata dai sontuosi banchetti che avvenivano presso le famiglie nobili. Escoffier rivoluzionò il mondo della cucina e della ristorazione creando moderni modelli di organizzazione e introducendo il concetto di brigata. Stabilì una chiara terminologia, una precisa divisione e suddivisione delle pietanze e costruì ricette e menu articolati. L’apporto di Escoffier (e dei grandi cuochi che insieme a lui hanno definito la cucina classica) è stato fondamentale perché alcune preparazioni di base sono rimaste anche nella cucina moderna, come ad esempio l’uso dei fondi e l’abbinamento delle salse con le pietanze.
La cucina moderna
Ristoranti gourmet
Sono ristoranti che servono piatti sofisticati di alta qualità, con grande attenzione alla presentazione e al rispetto delle materie prime. La cucina raffinata è identificata anche con l’espressione inglese fine dining.
Il Novecento ha visto un forte sviluppo dell’industria alimentare e della grande distribuzione, che ha reso possibile l’importazione di nuovi alimenti provenienti da Paesi lontani. La maggiore disponibilità di cibo nei Paesi occidentali industrializzati è dovuta alla meccanizzazione di agricoltura e allevamento, oltre che alle nuove tecniche di conservazione. Nel Novecento i ristoranti sono diventati molto popolari e accessibili, diversificando al massimo l’offerta: basti pensare da un lato alla diffusione dei fast food, che offrono piatti semplici, economici e da consumare velocemente, e dall’altro alla crescente attrazione esercitata dai ristoranti gourmet, che offrono invece esperienze di alta cucina. Negli ultimi decenni, è proprio nei ristoranti gourmet che si è sviluppata la cucina moderna, caratterizzata da diversi filoni. La cucina moderna si distingue per la voglia di sperimentare e creare abbinamenti inusuali di consistenze, ingredienti e sapori. Tra gli aspetti principali della cucina moderna ricordiamo:
• tecniche di preparazione non convenzionali, innovative e sperimentali;
• cotture brevi volte a salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e organolettiche degli ingredienti;
• accostamento di diverse consistenze;
• accostamento di diverse temperature (ad esempio preparazioni calde e fredde);
• servizio al piatto con attenzione alla presentazione e alla guarnizione, con strutture e composizioni prevalentemente verticali;
• rispetto degli ingredienti e scelta di materie prime di alta qualità, con predilezione per i prodotti del territorio.
EDUCAZIONE CIVICA
cucina di rivisitazione
SOSTENIBILITÀ Negli ultimi anni si è sviluppata la cucina di rivisitazione, che reinterpreta ricette tradizionali innovandole grazie alla creatività degli chef e alle più avanzate tecniche di preparazione e cottura. La cucina di rivisitazione da un lato ha l’obiettivo di rispettare l’autenticità di piatti tradizionali, dall’altro lato li arricchisce con elementi nuovi, privilegiando ingredienti genuini e prodotti stagionali a chilometro zero. Per una moderna
cucina di rivisitazione, attenta alla sostenibilità e al rispetto della materia prima, occorre favorire l’utilizzo di prodotti di origine vegetale, privilegiare cotture brevi e/o cotture separate degli ingredienti al fine di esaltarne i sapori e i colori, oltre che predisporre la presentazione del piatto in maniera accattivante. La cucina di rivisitazione si configura dunque come una cucina che guarda al futuro, ma con solide radici e un’attenzione particolare alla sostenibilità.
3 Gli stili di cucina attuali
Come abbiamo accennato, in periodi recenti le aziende ristorative hanno diversificato la propria offerta gastronomica, al fine di soddisfare le richieste di una clientela che ha esigenze e preferenze alimentari sempre più specifiche:
• la riscoperta di tradizioni regionali, ricette e prodotti del territorio, promossi dai ristoranti tipici e dalle trattorie;
• l’esigenza di pasti economici da consumare rapidamente, ad esempio in pausa pranzo, ispirati alle cucine internazionali;
• l’attenzione verso modelli di cucina sana e attenti alla dietetica, che utilizzino ingredienti di qualità e sistemi di cottura salutari e innovativi, come la cottura al vapore o sottovuoto;
• l’interesse verso le cucine etniche e la commistione di diversi elementi. Attualmente la clientela può dunque scegliere fra innumerevoli stili di cucina.

Cucina nazionale
La cucina nazionale presenta piatti che fanno parte della cultura gastronomica italiana, come pizza e pasta, che oggi sono noti e apprezzati in tutto il mondo. Questo stile di cucina comprende tradizioni fortemente radicate e comuni a tutto il Paese e rappresenta un classico esempio di dieta mediterranea
Cucina regionale
La cucina regionale è legata alle ricette e agli ingredienti delle tradizioni locali e delle cucine popolari. Viene servita da locali informali, come trattorie, ristoranti tipici e osterie, che propongono piatti semplici in porzioni abbondanti.
Cucina internazionale
Comprende i piatti più rappresentativi delle cucine di tutto il mondo e viene servita soprattutto in ristoranti in franchising, fast food e business hotel. In Italia si stanno diffondendo sempre più ristoranti che offrono i piatti tipici delle cucine europee, come ad esempio i ristoranti legati alla tradizione greca o a quella spagnola (così come all’estero sono assai numerosi i ristoranti italiani, spesso gestiti da connazionali).
Cucina etnica
Propone le cucine provenienti da aree del mondo diverse dalla nostra. In Italia fanno parte della cucina etnica soprattutto ristoranti cinesi, giapponesi, tex-mex, thailandesi, indiani e brasiliani. Non sempre i piatti proposti sono fedeli agli originali, in quanto spesso subiscono adattamenti per renderli appetibili ai palati italiani.
Cucina biologica
Utilizza alimenti e ingredienti biologici (cioè trattati senza l’uso di pesticidi e prodotti chimici) e segue la stagionalità dei prodotti che la natura offre.
Cucina equosolidale
Utilizza prodotti e ingredienti provenienti dal commercio equo e solidale. Si tratta di una modalità di distribuzione che permette ai consumatori di Paesi sviluppati di acquistare prodotti che provengono da Paesi in via di sviluppo, allo scopo di favorire le economie dei Paesi produttori.
Cucina vegetariana
Prevede l’eliminazione di carni e prodotti ittici, per motivi di carattere etico, religioso, ambientale e/o salutistico. All’interno della cucina vegetariana si possono identificare diversi filoni: la cucina latto-ovo-vegetariana comprende uova, latte e derivati; quella ovo-vegetariana comprende uova, ma non latte e derivati; quella latto-vegetariana comprende latte e derivati, ma non uova. La cucina vegana, infine, è basata sul consumo esclusivo di alimenti di origine vegetale.
Cucina macrobiotica
La cucina macrobiotica si basa sui princìpi filosofici del Taoismo, cioè l’insieme delle dottrine formulate nei secoli IV e III a.C. da pensatori cinesi. Gli alimenti ammessi sono cereali, frutta, verdura, legumi, soia e alimenti della tradizione orientale, oltre che piccole quantità di alimenti di origine animale, preferendo i prodotti ittici ed escludendo latte, uova e loro derivati.
Cucina fusion
Combina tratti di tradizioni culinarie diverse per produrre piatti complessi non riconducibili a una precisa tradizione Ne è un esempio la fusione tra un piatto tipico giapponese, il sushi, e le tradizioni brasiliane, come nel caso del sushi brasiliano, caratterizzato soprattutto dal temaki (un cono d’alga con all’interno riso e pesce crudo).
Cucina destrutturata
Fondata dallo chef spagnolo Ferran Adrià, la cucina destrutturata si propone di reinventare piatti già noti, rielaborando in modo creativo i singoli ingredienti, modificando la temperatura di servizio e la presentazione. I piatti vengono scomposti presentando i singoli ingredienti sul piatto separatamente.
Cucina molecolare
La cucina molecolare si basa sullo studio delle reazioni chimiche che avvengono tra le molecole che costituiscono gli alimenti, al fine di modificare la struttura molecolare degli alimenti stessi. Le tecniche della cucina molecolare possono essere applicate per ottenere piatti d’effetto, di consistenze differenti, che garantiscono un’esperienza inaspettata.
L’obiettivo è creare stupore nella clientela attraverso effetti scenografici durante l’impiattamento, che avviene al cospetto del cliente.
VIDEOLEZIONE
4 La neoristorazione
I diversi stili di cucina analizzati finora danno origine alle innumerevoli forme di ristorazione che caratterizzano il mercato di oggi, come:
• i ristoranti gourmet, che offrono un servizio e una proposta enogastronomica molto accurati;
• i ristoranti d’affari, con un’offerta attenta ai consumatori internazionali;
• i ristoranti etnici, che propongono esperienze gastronomiche legate all’atmosfera dell’Oriente e dell’esotico;
• i ristoranti alternativi, basati su forme di cucina particolari, come quella salutistica o macrobiotica;
• i ristoranti appartenenti a catene in franchising, che offrono un servizio standardizzato, con gli stessi piatti in ogni Paese del mondo;
• i bistrot e le brasserie, ristoranti in stile francese (simili alle trattorie italiane) che servono un menu limitato tutto il giorno;
• i gastropub, ristoranti nei pub diffusi soprattutto nel Regno Unito;
• i caffè e le caffetterie, ristoranti aperti solo di giorno, che servono snack e bevande, torte e pasticcini;
• i take-away, che preparano cibo che può essere mangiato fuori dal locale oppure consegnato a domicilio;
• i ristoranti virtuali (o dark kitchen) che servono esclusivamente cibo a domicilio;
• i ristoranti pop-up, cioè ristoranti temporanei che, proprio come i pop-up che compaiono mentre stiamo navigando in Internet, nascono all’improvviso, sfruttando location particolari per brevi periodi di tempo;
• i ristoranti all-you-can-eat, che, a un prezzo prestabilito, permettono al cliente di mangiare tutto quello che vuole senza un limite di quantità;
• i ristoranti esperienziali, che forniscono diverse esperienze di intrattenimento, ad esempio mangiare al buio o sospesi in aria su apposite strutture, il tutto per stupire i clienti al punto che il cibo può passare in secondo piano rispetto all’esperienza memorabile proposta.
NUOVE FRONTIERE DEL FOOD
Le dark kitchen

La pandemia Covid-19 ha decretato la diffusione delle dark kitchen (o “cucine nascoste”). Con questa espressione si intendono le cucine di ristoranti privi di locale per la somministrazione ai clienti, dove non ci sono né tavoli, né personale di sala. L’ordinazione da parte dei clienti avviene online attraverso il sito web, o apposite app, e il cibo viene consegnato a domicilio. Nelle dark kitchen, quindi, accanto agli chef operano i picker che preparano i piatti per il trasporto e i rider che li consegnano. Si tratta di un servizio sempre più apprezzato perché
in grado di offrire diverse tipologie di piatti, passando dalle pietanze tradizionali a quelle internazionali, e di offrire esperienze personalizzate, velocità di consegna e semplicità nel metodo di pagamento. Vi sono diverse tipologie di dark kitchen: la ghost kitchen è una cucina nascosta multi-brand, dove diversi marchi condividono una sola cucina (pur mantenendo ciascuno la propria proposta gastronomica), mentre la cloud kitchen è una sorta di spazio di lavoro condiviso, in cui ogni brand ha la propria cucina e la propria postazione.

5 Le caratteristiche del servizio ristorativo
Tutte le aziende ristorative rientrano tra le imprese di servizi. Queste imprese hanno l’obiettivo di soddisfare i bisogni e le aspettative dei clienti attraverso l’erogazione di servizi, concepiti sulla base delle richieste. L’attività dell’impresa va impostata quindi sulla relazione con il cliente, con lo scopo di soddisfarlo e fidelizzarlo
È intangibile perché non si basa su elementi materiali
Non è immagazzinabile e, quindi, non può essere commercializzato in un momento successivo
IL SERVIZIO
È valutabile solo da chi ne usufruisce in base al grado di soddisfazione che ne ha tratto
È insostituibile perché, una volta erogato, il servizio non può essere sostituito o ripetuto
IN SINTESI
Può essere offerto ed erogato solo in presenza del fruitore
I diversi stili comunicativi del cliente
È sempre diverso, perché cambiano i clienti che ne fruiscono, gli operatori che lo erogano ecc.
Alla fine dell’Ottocento, la ristorazione conobbe un significativo sviluppo grazie al cuoco
genio della cucina francese, che codificò per la prima volta la cucina ……………..………. . Negli ultimi decenni, nei ristoranti gourmet si è sviluppata la cucina ……………..………., che si distingue per la voglia di sperimentare e creare abbinamenti inusuali. In periodi recenti le aziende ristorative hanno diversificato la propria offerta gastronomica, proponendo diversi di cucina. Tutte le aziende ristorative, a prescindere dalla tipologia, rientrano tra le imprese di . Il servizio ristorativo:
• è ……………..………. perché non si basa su elementi materiali;
• non è e, quindi, non può essere commercializzato in un momento successivo;
• può essere offerto ed erogato solo in presenza del ;
• è solo da chi ne usufruisce;
• è perché, una volta erogato, non può essere sostituito o ripetuto;
• è sempre , perché cambiano i clienti che ne fruiscono, gli operatori che lo erogano ecc.
Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti, bevande (comprese quelle con titolo alcolometrico volumico superiore al 21%) e latte
Esempi: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari
6 La classificazione delle aziende ristorative
In linea generale, le aziende ristorative possono essere classificate secondo diversi criteri, come la modalità di servizio, la tipologia di cucina e la categoria di prezzo applicata alle prestazioni. Dal punto di vista legislativo, le aziende ristorative sono pubblici esercizi, cioè locali aperti al pubblico che erogano servizi. La loro classificazione è stabilità dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287
Tipologia A

I PUBBLICI ESERCIZI: CLASSIFICAZIONE
Tipologia B

Esercizi appartenenti alle tipologie A e B nei quali la somministrazione di alimenti e bevande avviene congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago
Esempi: sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari
Tipologia C
(legge n. 287/1991)

EDUCAZIONE CIVICA
Esercizi per la somministrazione di bevande (comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione), latte, dolciumi (compresi i prodotti di gelateria e pasticceria) e prodotti di gastronomia
Esempi: bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari
Tipologia D

Esercizi riconducibili alla tipologia B nei quali è però vietata la somministrazione di bevande alcoliche
Le informazioni da esporre obbligatoriamente nelle aziende ristorative
Ai sensi delle normative vigenti, negli esercizi pubblici vanno esposti molteplici cartelli, autorizzazioni, tabelle e documenti di varia natura. Qui forniamo un elenco delle principali informazioni da esporre al pubblico:
• SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è l’autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune;
• autorizzazione sanitaria rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale, necessaria per tutte le attività che comportino la manipolazione di alimenti;
• orari di apertura e chiusura;
• listino dei prezzi;
• cartello con divieto di fumo;
• licenza per la vendita di liquori o di prodotti contenenti alcool;
• tabelle alcolemiche che informano sugli effetti del consumo di alcool;
• cartelli indicanti ingredienti e possibili allergeni;
• cartello con divieto di somministrazione e vendita alcool ai minori di 18 anni;
• cartello indicante il numero di emergenza (112 o 118) e, in alcuni casi, il piano di emergenza o la segnaletica di evacuazione;
• cartello indicante l’eventuale utilizzo di sistemi di videosorveglianza;
• autorizzazione comunale per intrattenimenti, anche danzanti, nel locale e relativi pagamenti SIAE;
• comunicazione circa le modalità di trattamento dei dati tramite un’informativa sulla privacy.
Le forme di ristorazione
Considerando che cosa si vuole produrre, per chi si vuole produrre (individuando una tipologia di cliente), come si vuole servire (in relazione a modalità di preparazione, luoghi e tempi), è possibile individuare quattro forme ristorative
Ristorazione commerciale
È una particolare modalità di soluzione del pasto che comprende le strutture ristorative dislocate lungo strade e autostrade, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti, ed è realizzata anche su strutture in movimento come aerei, navi, traghetti, treni (ristorazione on board)

Ristorazione viaggiante

Riunisce le operazioni di preparazione, consegna e somministrazione di alimenti e bevande in un luogo diverso da quello di produzione. Quindi presuppone l’utilizzo di tecniche e procedure specifiche per il mantenimento della temperatura e per il rinvenimento delle preparazioni
FORME DI RISTORAZIONE
Comprende strutture di servizio o di produzione-servizio come, per esempio, ristoranti, trattorie, pizzerie, snack bar, fast food, self-service, distributori automatici


IN SINTESI
Le aziende possono essere classificate in quattro :
• la ristorazione
comprende strutture di servizio o di produzione-servizio;
• la ristorazione provvede ai pasti di consumatori riuniti in comunità;
• il consegna e somministra alimenti e bevande in un luogo diverso da quello di produzione;
• la ristorazione è realizzata in strutture dislocate lungo strade e autostrade, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie o si colloca all’interno di mezzi di trasporto come treni, aerei, navi. Comprende tutte le strutture che provvedono ai pasti di consumatori riuniti in comunità, come mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, carcerarie, militari e istituzionali (ospizi, convitti)

Le influenze d’acquisto
Le aziende ristorative devono definire offerte costruite su misura cliente per cliente, offrendo la massima personalizzazione del servizio. Per farlo, bisogna tenere presenti i fattori che influenzano le scelte d’acquisto del cliente, che dipendono sia da caratteristiche personali (per esempio l’età, il sesso e la posizione sociale) sia dal contesto esterno.
FATTORI CHE INFLUENZANO L’ACQUISTO
Fattori culturali
• Cultura
• Subcultura
• Classe sociale
Fattori sociali
• Gruppo di riferimento
• Ruolo
• Status
Fattori personali
• Età
• Esperienze passate
• Occupazione
• Situazione economica
• Stile di vita
• Personalità
• Concetto di sé
COMPETENZE PROFESSIONALI
La prossemica
La prossemica analizza come vengono gestiti spazi e distanze durante la comunicazione. Nel servizio ristorativo diviene un utile strumento per mettere in atto comportamenti in grado di soddisfare il cliente
In prossemica si distinguono quattro “bolle” di distanza interpersonale:
• la distanza intima (entro 50 cm), riservata a persone con cui si ha un forte legame emotivo, come partner, familiari e amici intimi;
• la distanza personale (da 50 a 120 cm), tipica di interazioni quotidiane con persone conosciute ma non intime;
• la distanza sociale (da 120 a 350 cm), propria di contesti professionali e pubblici, dove il contatto è impersonale, come per esempio tra un cliente e un fornitore di servizi;
Fattori psicologici
• Motivazione
• Percezione
• Apprendimento
• Opinione
• Atteggiamento

• la distanza pubblica (oltre 350 cm), tipica di presentazioni, spettacoli, comizi e più in generale di tutte quelle situazioni in cui ci si rivolge a un pubblico.
La conoscenza di queste distanze aiuta a evitare comportamenti inappropriati. Ad esempio, entrare nella bolla della distanza intima del cliente può attivare in lui una reazione di difesa: l’operatore che si avvicina troppo per sistemare il tavolo o dare indicazioni sul menu, invadendo spazi non consentiti, potrebbe mettere a disagio il cliente. Un altro atteggiamento da evitare è rivolgersi al cliente con le mani dietro la schiena, in quanto può essere percepito come un gesto di scarsa trasparenza. La prossemica suggerisce di tenere le mani ben visibili, con i palmi rivolti verso il cliente, in modo da trasmettere apertura e fiducia.
I FATTORI CULTURALI
I comportamenti di consumo di un individuo sono influenzati innanzitutto dalla sua cultura di appartenenza. Infatti, nelle diverse culture del mondo, le materie prime utilizzate come alimenti sono diverse: ad esempio le cucine orientali considerano commestibili insetti, coccodrilli e altri animali non ammessi nella cultura occidentale.
I FATTORI SOCIALI
Ogni soggetto si confronta quotidianamente con un gruppo di riferimento, che ne influenza i comportamenti. I gruppi di riferimento possono essere distinti in:
• primari: sono quelli che plasmano il carattere e la personalità di un individuo, come la famiglia, gli amici, i colleghi di lavoro;
• secondari: sono quelli che intrattengono con il soggetto un rapporto meno diretto ma altrettanto importante, come i gruppi religiosi o le associazioni che si interessano di ambiti specifici.
I FATTORI PERSONALI
Tra i fattori personali rientrano i tratti individuali del soggetto, come l’età, le esperienze passate, l’occupazione e la situazione economica, ma anche il suo stile di vita e la personalità. Da tutti questi fattori scaturiscono i suoi comportamenti d’acquisto. Dal punto di vista economico, la disponibilità a spendere denaro determina i possibili acquisti che il soggetto può permettersi.
I FATTORI PSICOLOGICI
A creare nell’individuo la motivazione necessaria a fare un acquisto è generalmente un bisogno. Un bisogno nasce da una mancanza per l’individuo, che decide quindi di agire per soddisfarla. Gli individui cercano di soddisfare innanzitutto i bisogni necessari alla sopravvivenza (bisogni fisiologici), per passare poi a quelli appartenenti a livelli immediatamente superiori, di natura sociale e in genere più complessi. Come evidenziato nello schema, il soggetto si realizza attraversando i vari stadi individuati dalla piramide di Maslow, nella quale, dal basso verso l’alto, sono collocati:
• i bisogni fisiologici, ovvero quelli che ogni essere umano deve necessariamente soddisfare per vivere (mangiare, bere, dormire, respirare);
• i bisogni di sicurezza (protezione sia fisica sia emotiva, del lavoro, della salute, tranquillità);
• i bisogni di appartenenza (amore, affetto, amicizia, socialità, appartenenza a un gruppo, cooperazione);
• i bisogni di stima (autostima, riconoscimento, status e stile, rispetto e ammirazione, indipendenza);
• i bisogni di autorealizzazione (sviluppo e realizzazione di se stessi, moralità, creatività, spontaneità).
bisogni di stima
bisogni di appartenenza
bisogni di sicurezza
bisogni fisiologici
I ruoli d’acquisto
Il cliente, nel momento in cui acquista un pasto o un servizio offerti da un ristorante, assume un ruolo ben preciso. Gli studiosi di marketing hanno identificato cinque ruoli diversi che ogni individuo può di volta in volta assumere.
1 Iniziatore: quando il soggetto ha per primo l’idea di acquistare un bene o un servizio o la suggerisce ad altri, dando lo stimolo iniziale al processo di acquisto.
2 Influenzatore: quando i consigli del soggetto assumono un peso nella decisione finale, ovvero gli è attribuita una certa attendibilità.
3 Decisore: quando il soggetto determina, almeno in parte, la decisione d’acquisto finale.
4 Acquirente: una volta deciso cosa e come acquistare, bisogna che qualcuno esegua materialmente l’acquisto, ovvero che un soggetto diventi acquirente.
5 Utilizzatore: l’acquirente non coincide necessariamente con la persona che usufruirà del servizio o userà il prodotto che è stato acquistato. Si pensi, per esempio, a quando una persona decide di regalare a un amico un buono per una cena al ristorante.
Bisogna tenere presente che:
• uno stesso soggetto può assumere più ruoli contemporaneamente: quando una persona acquista un caffè al bar, assume il ruolo di iniziatore, decisore, acquirente e utilizzatore;
• nel caso di acquisti più complessi, i ruoli tendono a dividersi tra persone diverse: quando un gruppo di amici decide di organizzare una cena e si dibatte su quale ristorante scegliere, per quale menu optare ecc.
Le tipologie di comportamento
In linea generale, il cliente decide di acquistare un bene o un servizio seguendo quattro tipologie di comportamento sulla base di diversi fattori di coinvolgimento e percezione delle differenze tra i prodotti offerti da aziende diverse.
COMPORTAMENTI D’ACQUISTO

• Comportamento d’acquisto complesso
Il cliente è molto coinvolto nel processo d’acquisto e percepisce differenze significative tra lo stesso bene o servizio erogato da aziende diverse. Prima di prendere una decisione, il cliente analizza in modo approfondito le diverse opzioni, soppesando i pro e i contro.
• Comportamento d’acquisto finalizzato alla ricerca della varietà
Il cliente acquista per il piacere di provare qualcosa di diverso: anche se non è necessariamente insoddisfatto dei beni o servizi dell’azienda che già conosce, è spinto a cambiare dalla curiosità o dal desiderio di novità. Pertanto non rimane fedele allo stesso prodotto o servizio, ma cerca stimoli e varietà, senza valutazioni approfondite.
• Comportamento d’acquisto finalizzato alla riduzione della dissonanza
Il cliente percepisce poche differenze tra le alternative offerte da aziende diverse, non è disposto a perdere tempo per raccogliere maggiori informazioni sul bene o servizio, pertanto decide e acquista rapidamente. Solo dopo l’acquisto, in genere, cerca conferme di aver fatto la scelta giusta.
• Comportamento d’acquisto abituale
Il cliente acquista sempre determinati beni o servizi in maniera ripetitiva e automatica. L’acquisto è guidato più dall’abitudine che dalla valutazione ponderata delle alternative e il cliente ripete l’acquisto per la comodità di non dover prendere una nuova decisione ogni volta.
Il servizio ristorativo
8 L’erogazione del servizio
Secondo il modello del sistema di erogazione dei servizi, l’impresa ristorativa è composta da due parti:
• una visibile (ad esempio le pietanze servite, il personale di sala, la sala del ristorante, che può essere ampia, ristretta, ben illuminata, poco areata, arredata con gusto, ecc.);
• una non visibile agli occhi del cliente (ad esempio la cucina).
Nel caso della ristorazione, il cliente acquista un pasto per soddisfare la sua necessità di cibarsi, ma l’acquisto di questo servizio va ben oltre perché, come si è detto, per il cliente rappresenta un’esperienza. Ad esempio, una sala luminosa e arredata con gusto può contribuire a lasciare un buon ricordo nella mente del cliente, mentre la presenza di persone che schiamazzano o si comportano in modo maleducato può rovinare l’esperienza. Per un ristorante, la soddisfazione del cliente passa attraverso diversi fattori e va perseguita in tutte le fasi del servizio.

LA PRENOTAZIONE
È fondamentale che il primo contatto tra cliente e struttura sia gradevole e trasmetta un’idea di efficienza e cordialità. Ciò vale non solo sia per i nuovi clienti, sia per quelli che già conoscono il locale.
Come gestire la prenotazione: annotare l’ora di arrivo; informarsi sull’eventuale presenza di anziani, bambini e diversabili, su esigenze alimentari specifiche, sull’eventuale ricorrenza in occasione della quale l’evento è organizzato, sulla preferenza per un tavolo all’interno o all’esterno, così da favorire la massima personalizzazione del servizio. Nel caso in cui la prenotazione avvenga per e-mail o tramite social network, la risposta deve essere fornita rapidamente usando un linguaggio formale.
L’ACCOGLIENZA
L’accoglienza, che inizia con l’ingresso del cliente nel locale, dura dai due ai quattro minuti e in questo brevissimo lasso di tempo il cliente si fa già un’idea della struttura, anche in base al modo in cui il personale lo riceve.
Come gestire l’accoglienza: non far attendere il cliente troppo a lungo; accogliere l’ospite guardandolo negli occhi e chiamandolo per nome; mantenere viva la comunicazione evitando toni e modo troppo confidenziali; dare a tutti gli ospiti la stessa attenzione.

LA RELAZIONE CON IL CLIENTE

Per l’operatore di sala è importante costruirsi uno stile, fatto di accuratezza, eleganza, finezza, distinzione nel presentarsi, nel muoversi, oltre che nel parlare. II professionista che ha stile e buon gusto esprime autorevolezza e ottiene rispetto e fiducia, contribuendo in larga misura alla qualità del servizio.
Come gestire la relazione: un buon operatore di sala deve essere: competente; capace; desideroso di migliorare se stesso; producente e proficuo. Un operatore di sala non deve essere: indifferente; poco collaborativo; pigro; litigioso; permaloso; irritabile.