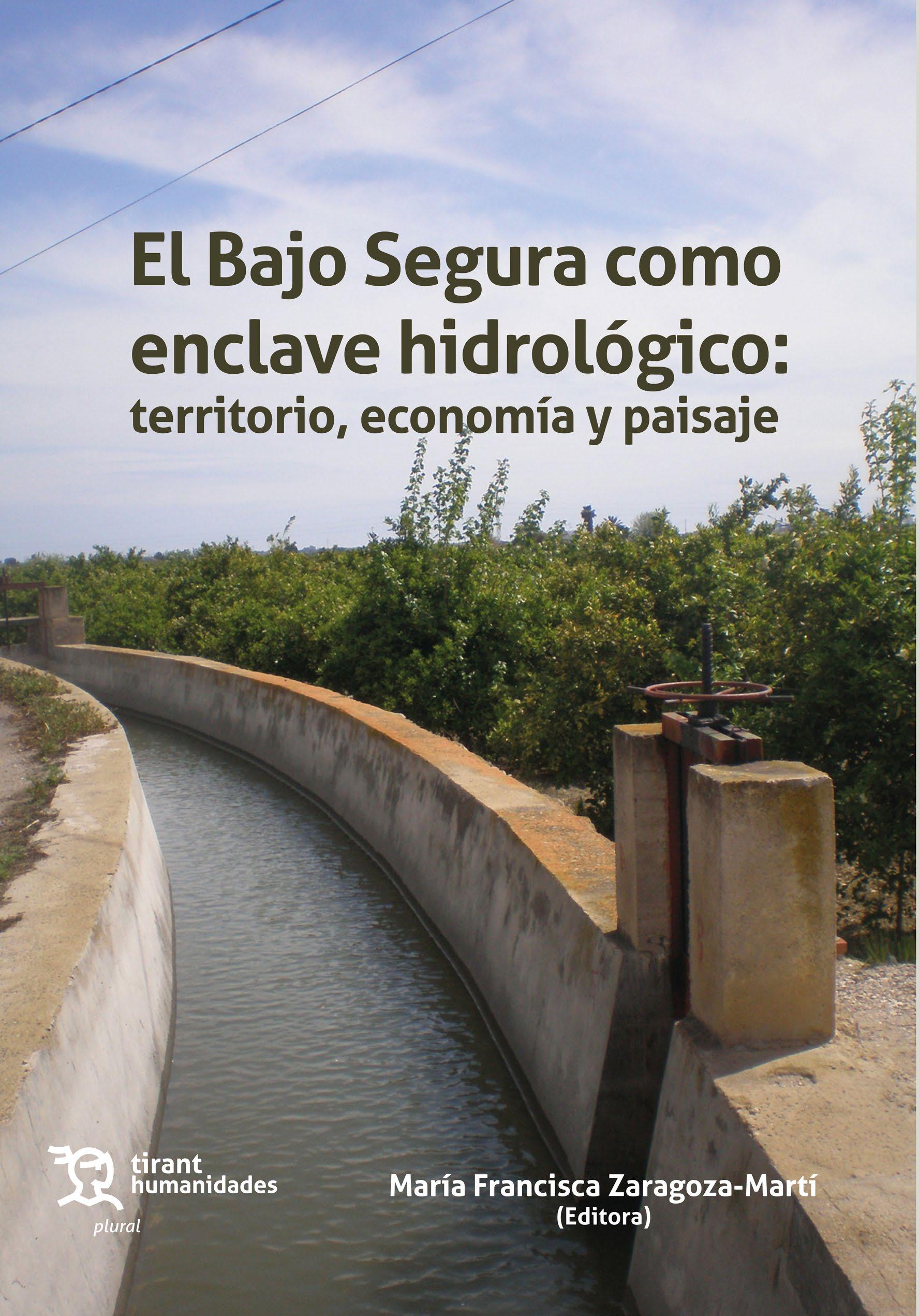
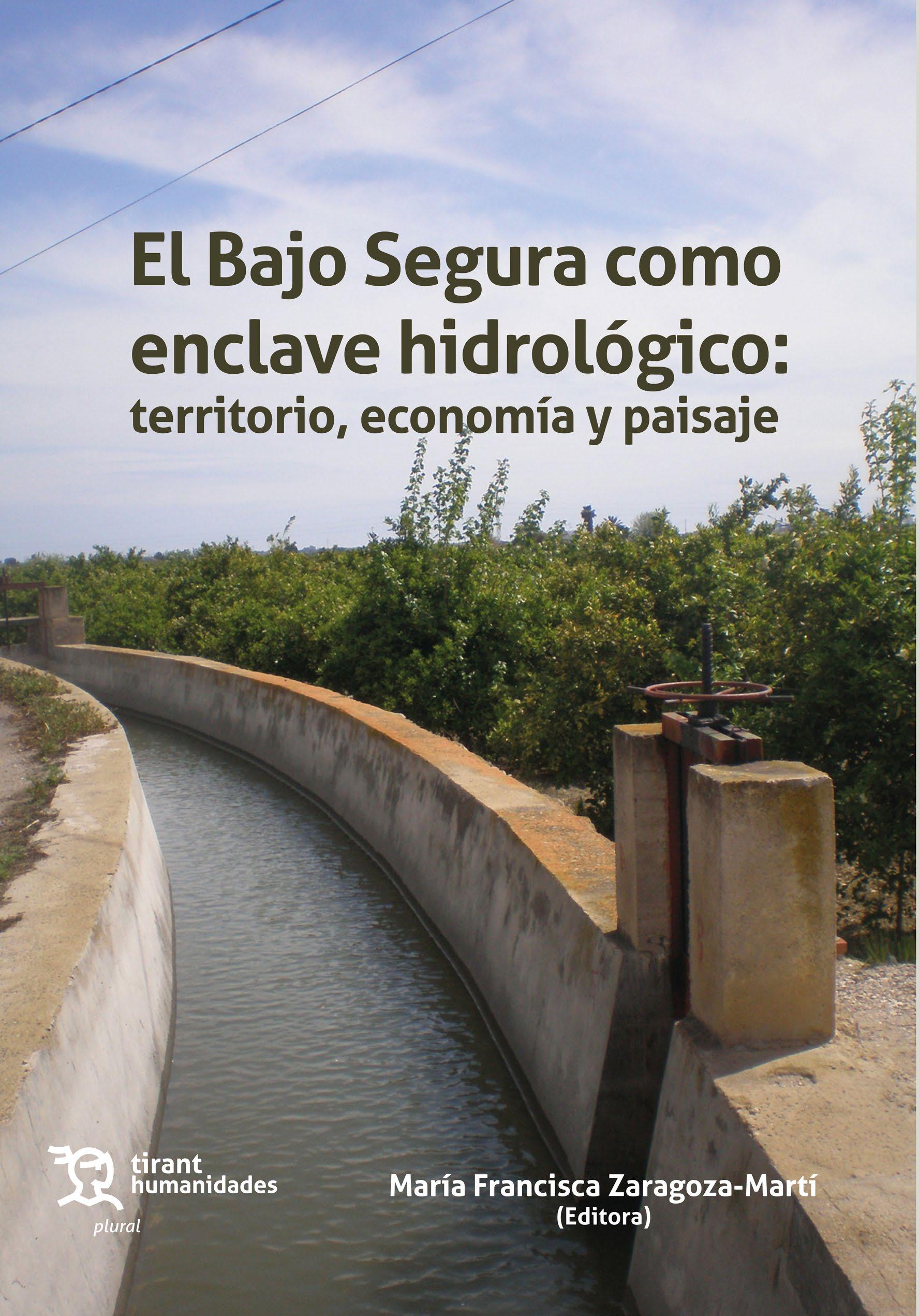
EL BAJO SEGURA COMO ENCLAVE HIDROLÓGICO: TERRITORIO, ECONOMÍA Y PAISAJE
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT HUMANIDADES
Manuel Asensi Pérez
Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Mª Teresa Echenique Elizondo
Catedrática de Lengua Española Universitat de València
Juan Manuel Fernández Soria
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València
Pablo Oñate Rubalcaba
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València
Joan Romero
Catedrático de Geografía Humana Universitat de València
Juan José Tamayo
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
EL BAJO SEGURA COMO ENCLAVE HIDROLÓGICO: TERRITORIO, ECONOMÍA Y PAISAJE
MARÍA FRANCISCA ZARAGOZA-MARTÍ
Editora
tirant humanidades
Valencia, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email:tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
DEPÓSITO LEGAL: V-1015-2023
ISBN: 978-84-19588-83-8
MAQUETA: Disset Ediciones
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
© María Francisca Zaragoza-MartíEran las cuatro de la madrugada y como un reloj mi abuelo acudía a recibir la tanda de agua que por derecho y buen hacer para con los demás le correspondía.
Respetar la tradición y el valor de la Tierra, vivir en sintonía con nuestro entorno y entre iguales es lo que debo agradecer a mis antepasados; Convicciones y principios que nos han seguido inculcando nuestros padres y que reciben mis hijos para su futuro, como el mismo hilo conductor que emana del agua como memoria de nuestra Historia.
María. A la familia
DIRECTRICES JURÍDICAS
LA AGRICULTURA DEL BAJO SEGURA EN EL MAPA HÍDRICO DE LA
LOS PAISAJES FLUVIALES
Prólogo LE TRACCE DELL’ACQUA
CARLO BERIZZI SILVIA LA PLACA
GAIA NEREA TERLICHER
(Università degli Studi di Pavia -Italia-)1 .
L’acqua è oggetto di venerazione sin dalle civiltà più arcaiche (Thommen, 2014). Un duplice aspetto muove l’interesse dell’uomo verso questo elemento: alla fascinazione dell’ignoto, di ciò che cela, di dove conduce, si contrappone la consapevolezza della sua necessità per la vita. La costruzione di miti, culti religiosi e spiegazioni filosofiche hanno mantenuta viva e vivace la discussione sul ruolo fondamentale dell’acqua fino all’approdo di una sua conoscenza di tipo scientifico. Il culto dell’acqua è presente in tutte le civiltà assumendo significati diversi a seconda dei contesti geografici e culturali. Nella ricchezza delle opere dedicate nel tempo all’acqua dolce, ogni epoca e civiltà le conferisce da sempre rinnovati significati, definendo delle vere e proprie creazioni sociali, attraverso le quali emerge il rapporto tra l’elemento idrico e lo spazio, e tra questi ultimi e l’uomo (Illich, 1988). L’acqua assume un valore di rito nelle diverse religioni del mondo legato quasi sempre alla purificazione, tema comune nella cultura mussulmana con le abluzioni, cristiana con il battesimo, ebraica, buddista e induista. Nel racconto biblico Mosè, abbandonato nel fiume Nilo per poter essere salvato, salva poi il suo popolo facendo scaturire acqua dalla roccia.
Dalla storia, all’architettura, alla chimica, alla biologia, alla geografia, fino al generarsi di studi tematici di approfondimento, si può affermare che esista, relativa ad ognuno degli ambiti sopra citati, una specifica narrativa, dedicata alla descrizione dell’acqua e declinata nelle diverse forme, dai racconti, ai romanzi, alle guide, agli atlanti, ai saggi e ai manuali.
1 Contributo degli autori: la nota “S.L.P.” alla fine del testo indica il contributo Silvia La Placa; la nota “G.N.T” alla fine del testo indica il contributo di Gaia Nerea Terlicher; supervisione di Carlo Berizzi.
Carlo Berizzi - Silvia La Placa - Gaia Nerea TerlicherGià nell’antica Grecia cultura e tecnica si intrecciavano in maniera sinottica portando a considerare l’acqua come bene da tutelare per una duplice ragione: l’esigenza del suo impiego quotidiano e la devozione religiosa, da intendersi quest’ultima non come sentire personale ma come aspetto fondativo della società (Illich, 1988). L’acqua è infatti arkhétypon, arkhḗ “principio” e týpos “modello”, cioè origine, elemento primigenio, presupposto alla vita, e dal carattere trasversale e atemporale. Ad affiancare il mito, nella ricerca di spiegazioni ai fenomeni ancora sconosciuti, i greci pongono anche la scienza della natura e della filosofia: lo fece Talete di Mileto definendo il Principio dell’Essere ma anche Platone nei dialoghi Timeo e Crizia. Quest’ultimo descrivendo le trasformazioni dei paesaggi della regione dell’Attica, un tempo fertile e rigogliosa e ora diventata asciutta, descrive: «Oggi il nostro paese è simile alle ossa di un corpo malato, e di questa terra è rimasto solo lo scheletro... dai monti una volta boscosi che oggi offrono alimento soltanto alle api, non è molto che si tagliavano alberi per costruire i tetti a grandi edifici. Si potevano ancora vedere tempietti di ninfe sorgive, ma le sorgenti erano essiccate» (10 Plat. Critias 110112e.). Tuttavia, l’attenzione dell’autore ai cambiamenti degli aspetti idrografici, tema ricorrente in tutta l’opera, sottolinea anche il tema di estrema attualità, di quella perdita di equilibrio nel rapporto uomonatura (Sunseri, 2018). Gli interventi ad opera umana hanno infatti segnato troppo profondamente l’ambiente e le conseguenze, come la siccità, non appaiono più gestibili, con l’effetto di una definitiva modifica dei territori regionali. Platone nelle “Leggi” ad approfondisce il tema dell’importanza dell’acqua e della necessità quindi di evitarne lo spreco, stilando una sorta di manuale d’istruzione per risolvere i conflitti legati alla pochezza del bene.
Mentre nell’antica Grecia la venerazione delle divinità fluviali trovava fondamento nella poesia, nella cultura romana questa si esprime soprattutto nel tramandarsi di pratiche di culto. L’impiego dell’acqua nei riti purificatori è talmente radicato da permanere ancora oggi nel battesimo cristiano. D’altra parte, assume rilevanza fondamentale, per il controllo dell’impero, manifestata in un’ampia produzione trattatistica che mette in luce gli aspetti significativi dell’ambiente dal punto di vista geografico, storico e militare. L’approvvigionamento dell’acqua, la conoscenza dei fiumi e le capacità tecniche e idrauliche divengono fondamentali per garantire il successo delle strategie mi-
litari di espansione prima e la produttività della terra dopo. Oltre a ciò, le città risultano sovrappopolate e i Romani fanno tesoro degli insegnamenti greci sull’importanza di disporre di acqua pulita per la buona convivenza degli abitanti (Thommen, 2014). L’acqua non solo è indispensabile per l’espletazione dei bisogni fisiologici della popolazione, ma è anche necessaria per garantire uno standard igienico ed evitare epidemie. Le testimonianze romane a carattere tecnico sulla tutela dell’acqua spaziano da numerosi testi giuridici, a pratiche amministrative, a norme e notizie eterogenee sul tema, fino a vere e proprie opere geografiche (Tolle-kastenbein, 1993). Anche se non mancano le descrizioni poetiche o trattatistiche, in cui trovano di nuovo spazio personificazioni dell’acqua, riferimenti alle divinità, simbolismi e racconti mitici, in generale nella letteratura romana i riferimenti all’acqua divengono perlopiù mezzo per nobilitare le azioni umane.
Con Roma si assiste allo sviluppo di una “cultura dell’acqua”, intendendo per “cultura” l’insieme degli impegni fisici e di intelletto che una società compie per migliorare il modo di soddisfare le proprie esigenze (Illich, 1988). Le espressioni tecniche, artistiche e scientifiche del mondo romano sull’acqua sono trattate da un cospicuo numero di autori. Storici e geografi incentrano le loro descrizioni su tre aspetti in particolare: la navigazione, la protezione delle città da inondazioni e l’irrigazione, comprensiva quest’ultima delle modalità di approvvigionamento dell’acqua. Strabone, nell’opera Geografia, XVII volumi dedicati alle regioni del mondo conosciuto, evidenzia il ruolo dell’acqua nella definizione della complessità geomorfologica dell’ambiente. La descrizione dell’elemento idrico e dell’ambiente da questo permeato è strettamente connessa a quella delle attività umane: l’acqua, offerta dalla natura, è considerata un bene nel momento in cui l’uomo sa gestirla e controllarla a proprio vantaggio, così come fanno i Romani, bonificando paludi, indirizzandola ai campi da coltivare, garantendo l’approvvigionamento e lo scarico per le grandi città.
Nonostante i differenti approcci alla risorsa da parte delle società antiche, l’acqua è stata sempre protagonista di costruzioni ad essa correlate per il piacere estetico e il valore terapeutico stimolando le competenze tecniche e artistiche dell’uomo. L’utilizzo dell’acqua per fini ricreativi ha dato infatti vita al gymnasium ellenico, centro educativo nella vita greca e luogo di interazione sociale in cui si svolgevano esercizi di ginnastica per il benessere fisico e avvenivano le discussioni
filosofiche. Oppure i noti acquedotti della Roma Imperiale che fornivano acque a più di 100 fontane oltre che a terme e bagni pubblici.
Se da un lato il progresso delle conoscenze geografiche e scientifiche illustra in modo sempre più autonomo origine e moti dell’elemento idrico, non rendendo più necessaria la ricerca di spiegazioni (traposte nella scrittura di miti e leggende) che esulino dal campo empirico; dall’altro l’impronta culturale, i simbolismi e i significati attribuiti all’acqua permangono in maniera robusta nell’identità collettiva. Nella convinzione che sia necessario volgere uno sguardo nuovo (e forse stupito) ai paesaggi d’acqua storicamente plasmati dall’uomo e ai quali oggi l’abitudine ci ha resi indifferenti, relegandogli come unico valore quello d’uso dell’elemento, appare opportuno evidenziare la qualità, i meriti e l’attenzione della scienza, dell’ingegneria e dell’architettura applicati all’acqua, arricchendo il tema dell’elemento idrico come bene economico, strumento di produzione agricola, di navigazione e di commercio, del valore dato dallo sforzo del lavoro sapiente di popolazioni nei secoli2. I paesaggi d’acqua, infatti riflettono anche il valore economico di questa risorsa. La presenza, l’estensione e la numerosità dei corsi idrici hanno influenzato e influenzano ancora oggi anche la dimensione del paesaggio modificato per fini agricoli, che oltre a definire nuovi usi del suolo conferiscono forme infinite di paesaggio. Nell’economia occidentale il “settore primario” è stato all’origine delle trasformazioni del paesaggio (Pandakovic y Dal Sasso, 2013). Trasformazioni che costituiscono ancora oggi la maggior parte delle forme che percepiamo nel territorio rurale europeo. Il paesaggio produttivo prende forma in stretta relazione con l’acqua, che costituisce il fertilizzante per la terra coltivata e caratterizza pertanto i paesaggi in base al tipo di coltura. Già in natura il paesaggio si modifica e cambia costantemente in relazione alla disponibilità idrica, ne risulta che la necessità di diverse quantità di acqua per le differenti destinazioni d’uso darà vita a paesaggi diversi in cui vi si legge quella che nel passato costituiva una relazione intrinseca tra la fisicità dell’acqua e l’aspetto sacrale che rappresentava. La trasformazione dell’acqua attraverso il suo prelievo, raccolta e conduzione mediante diversi tipi di infrastrutture sono stati nei secoli atti “suggeriti dalla
necessità, supportati dalla volontà e messi in campo da uomini tormentati dal confronto con la dimensione sacrale e confortati dalla possibilità di risarcire la natura” (Oldani, 2020). In questo senso, i paesaggi d’acqua, frutto di un’artificializzazione della natura, costituiscono la sintesi perfetta di quel rapporto tra armonia e conflittualità che l’uomo ha sempre instaurato con la natura. Ed esprimono tutta la tenacia e sforzi dell’uomo nella lotta ad una realtà dura. La potenza di questi paesaggi risiede infatti nella capacità dell’uomo di accogliere, confluire, assecondare e plasmare l’acqua nel giusto punto di equilibrio tra artificio e natura.
La disponibilità idrica ha portato infatti l’uomo a modificare, nei secoli, il territorio per motivi di sopravvivenza e di benessere. La sua necessità ha influenzato gli insediamenti, delineando paesaggi antropizzati manifesto di uno stretto legame e conoscenza con il luogo. Le diverse condizioni e realtà territoriali hanno favorito nei secoli la costruzione di architetture e tecnologie differenti, che costituiscono ancora oggi modelli di studio per la loro capacità di integrazione tra ambiente, natura e artificio. Queste costruzioni, spesso di natura collettiva, costituiscono dei veri e propri archetipi di controllo e gestione dell’acqua. L’elemento idrico, leitmotiv nel tema cruciale del rapporto uomo-ambiente, è fondativo degli equilibri ecologici (indispensabili per lo sviluppo di una società) e influenza la collocazione delle attività umane, l’economia ma anche la morfologia degli spazi, fino a definire l’immagine della città. Le narrazioni, le discipline e le forme di adorazione di questa risorsa fanno emergere il suo rapporto con lo spazio antropico di cui l’architettura si fa interprete nella storia attraverso la costruzione di fontane, acquedotti, monumenti fino alla costruzione della città e del paesaggio. L’acqua molto spesso ha definito il layout della città e la sua architettura (Wylson, 2013).
Nei secoli, il progresso nella tecnica ha permesso una grande capacità di controllo e dominio della natura, mutando e talvolta stravolgendo quel rapporto che l’uomo aveva per secoli stabilito con l’acqua. Con l’avanzamento del progresso tecnologico in epoca moderna, l’acqua come parte di un processo produttivo, è stata anch’essa settorializzata (Van Aken, 2012) e pure le opere che la riguardavano hanno assunto un aspetto sempre più monofunzionale. Questo processo ha segregato il valore dell’acqua, che è divenuta meramente funzionale. E per questo motivo molti dei corsi d’acqua che caratterizzavano le città
europee fino all’età preindustriale, sono stati chiusi e cementificati o collegati alle reti fognarie. Tali azioni hanno inevitabilmente modificato il paesaggio e il suolo provocando una perdita di biodiversità e di interazione della popolazione con l’acqua, rendendo questa materia quasi “scontata” (Oldani, 2020).
I modelli di convivenza con l’ambiente acquatico, che divennero quasi di dominio e che si sono sviluppati dall’età industriale in poi, vengono messi in discussione dalla società contemporanea in cui sicuramente gli effetti del cambiamento climatico in atto giocano un ruolo principale. I cambiamenti climatici e le trasformazioni sociali del XXI secolo coinvolgono infatti un cambio di paradigma sulle modalità di coesistenza da parte dell’uomo con l’ambiente acquatico presente sul nostro pianeta. La sensibilità sempre maggiore sul tema è strettamente collegata alla considerazione di questi ambienti come habitat, e la consapevolezza che una corretta gestione dell’acqua è necessaria per adattare il territorio ai cambiamenti climatici.
L’acqua costituisce una risorsa fondamentale per il ripristino ecologico e per la mitigazione degli effetti dovuti al cambiamento climatico e progetti di rigenerazione urbana come il Cloudburst Management Plan del 2012 di Copenhagen e la piazza Benthemplein a Rotterdam evidenziano come il ripensamento dell’uso e della funzione dell’acqua siano fondamentali per rispondere alle istanze della contemporaneità. Riportando la natura in città e ripristinando quel legame con l’acqua che nella storia ha sempre accompagnato l’uomo, questi progetti esprimono in maniera chiara l’obiettivo che la città contemporanea si deve porre. La necessità di una riorganizzazione, riprogettazione e gestione degli insediamenti nel rispetto dell’ambiente, dimostrano l’importanza di attivazione di un processo in cui l’acqua è fondativa per il progetto. In questa visione l’acqua non assume un ruolo monofunzionale ma crea luoghi, apre spazi per l’interazione sociale e di relazione con la natura. Queste attitudini fanno allora emergere la necessità di svelare gli atteggiamenti delle antiche civiltà verso questa risorsa, influenzando positivamente gli approcci contemporanei e la valorizzazione della memoria dei paesaggi d’acqua (Vallerani y Vistenin, 2019).
L’acqua può assumere pertanto un ruolo preciso e decisivo nello spazio, orientandone il suo sviluppo e identificando il paesaggio. Il
