DAL 1906 LA VOCE DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

#16
gennaio/2026


#16
gennaio/2026
VOCI DELLO SPORT ITALIANO
Giuseppe Manfredi: il volley tra vertice e base
ATLANTE SPORTIVO
Educare o produrre campioni? La sfida globale
DOSSIER
Tra muri e periferie si impara la pace
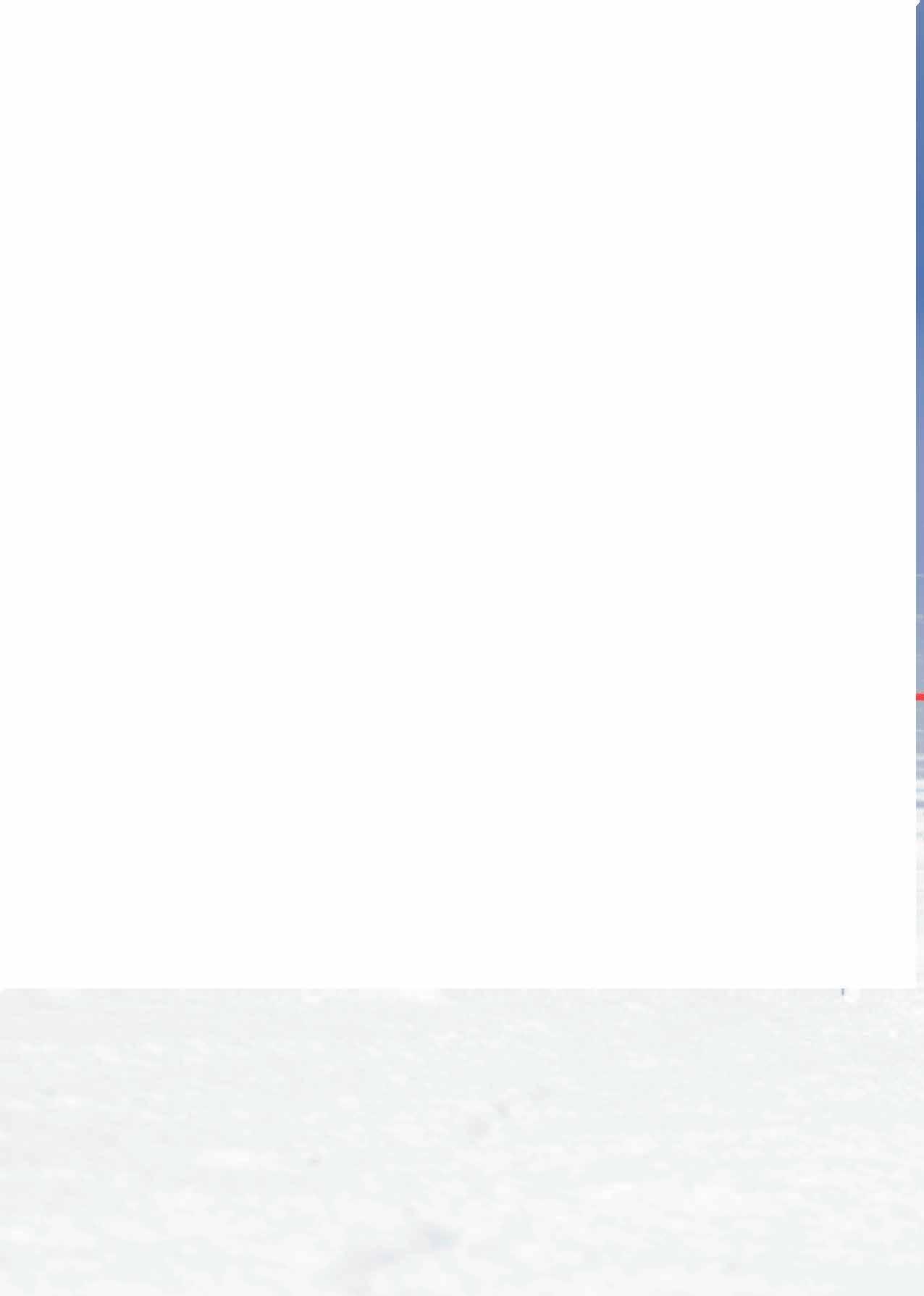


Vittorio Bosio
Presidente nazionale CSI
Tra i numerosi articoli degni di nota in questo numero di Stadium, dedicato in modo particolare al binomio sport e pace, mi permetto di segnalarne tre che, nella profondità dei temi che affrontano, non mettono in ombra il resto della rivista ma la valorizzano, perché aiutano a leggere il presente e il senso più autentico del nostro impegno a favore dello sport alla luce disincantata di chi vede il dramma e intravede le soluzioni, proponendole con sincerità e amore per la verità.
È da non perdere, e da leggere con la dovuta attenzione, la bella intervista al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, che si confronta ogni giorno con la tragedia della guerra, della violenza, della crudele sopraffazione dei più deboli e degli indifesi.
Con il linguaggio sincero e profetico che lo contraddistingue, il Card. Pizzaballa, a Stadium, spiega, tra
l’altro, che «la pace non coincide con la sola cessazione delle ostilità: la fine della guerra non è automaticamente l’inizio della pace; è, semmai, il primo passo di un cammino lungo e paziente. Questo processo, però – aggiunge –, non si regge su slogan: richiede verità, giustizia, riconciliazione e perdono tenuti insieme; separati, diventano facilmente armi retoriche o spirituali che alimentano altro conflitto». Il cardinale ricorda che non possiamo lasciare che odio e vendetta prendano il cuore degli uomini. Bisogna – sottolinea –saper «chiedere giustizia senza spargere odio, e dire parole che aprano prospettive invece di chiudere porte». Ho scelto di proporre le precise parole del cardinale perché ogni parola è una pietra miliare sulla quale si edifica il pensiero dell’amore per il prossimo: l’unica alternativa alla reciproca distruzione, che è l’amore tra fratelli.
Da non tralasciare la sottolineatura sul valore dello sport e del gioco, per i bambini dei territori devastati dalla guerra: «Perché lo sport non resti “narrazione”, servono almeno due condizioni: un contesto educativo che contrasti stereotipi, segregazioni e indottrinamento alla violenza, aiutando le nuove generazioni a interiorizzare regole di vita comune e fiducia nell’altro; e una cultura dell’incontro, quella “ostinazione” dell’ascolto e del dialogo che fa cedere paura e sospetto e trasforma le differenze in ricchezza».
Raccomando la lettura di questa intervista perché, nella sua
integralità, offre parole che aprono orizzonti di speranza senza edulcorare la realtà, ma guardandola nella sua attuale tragica dimensione. Condividiamo inoltre con piacere l’intervista al Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi. Si tratta del primo incontro di un nuovo spazio di approfondimento per dialogare con i protagonisti del sistema sportivo italiano. Cerchiamo, con queste nuove analisi, di evidenziare le diverse competenze e le diverse potenzialità che, se messe in comune, nel rispetto reciproco dei ruoli, portano a risultati straordinari, sia per la diffusione capillare dello sport di base, sia per il conseguimento dei risultati che fanno la storia dello sport nazionale. Non a caso è stato scelto il Presidente della FIPAV, Manfredi, da sempre fautore di una proficua sinergia con gli Enti di Promozione Sportiva. Grazie alla sua capacità di promuovere collaborazioni concrete tra le istituzioni, Manfredi ha saputo guidare un movimento dalle enormi potenzialità, trasformando il contributo di ogni realtà nei traguardi importanti che la pallavolo italiana ha raggiunto a livello internazionale negli ultimi anni.
La rubrica Dossier dà voce a tanti protagonisti dello sport e della promozione sociale. Tornano i temi della pace, anche nella nostra nazione, in particolare a Scampia, dando parola a don Manganiello o raccontando le meravigliose attività di chi, nei teatri di guerra, propone occasioni di sport e di attenzione verso i più piccoli.
Editore e Redazione
dell’Assistente
Sport in Comune
Assisi: luogo di pace, santità e cultura 4
Dossier
Dai campetti alla diplomazia: la quotidianità di uno sport che costruisce la pace 6
L’intervista
Il Cardinale Pizzaballa: costruire il futuro tra le macerie 17
Attualità
Dal “bianco e nero” al futuro: il CSI festeggia ottant’anni di sport e comunità 20
Voci dello sport italiano
In campo con… Giuseppe Manfredi 22
Focus
Scuola: la “prima palestra” 26
Nati nel CSI
Buffa racconta... il suo CSI 29
Atlante sportivo Sport tra Italia e USA: confronto fra due modelli
e produttivi
PER CONTATTARE LA REDAZIONE
Telefono 06 68404550
Email stadium@csi-net.it
Web www.stadiumcsi.it Parola di
Centro Sportivo Italiano
Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma www.centrosportivoitaliano.it comunicazione@csi-net.it
Periodicità
Trimestrale
Direttore responsabile
Alessio Franchina
Direttore editoriale
Vittorio Bosio
Redazione
Felice Alborghetti, Daniela Colella, Massimiliano Dilettuso, Giorgia Magni (caporedattrice), Alessio Molinari Bucarelli, Laura Politi, Laura Sanvito
Foto
Comune di Assisi, Don Guanella Scampia 1996, Douglas Schneiders, Federico Cavana, Gabriele Lugli, Mauro Berruto, Pasotti David Fotografia, Patriarcato Latino di Gerusalemme, Phototoday, Ufficio stampa FIPAV.
La foto di copertina è stata gentilmente concessa dal Patriarcato Latino di Gerusalemme.
Segreteria di redazione
Laura Sanvito
Grafica
Roberto Mattiucci, Loretta Pizzinga
Hanno collaborato
Mario Beschi, Giorgio Borgognoni, Filippo Ciregna, Stefania De Fazio, Manuel Garattini, Michele Lepori, Francesco Luterotti, Martina Magno, Gilberto Manfrin, Giacomo Mattioli, Massimo Montanari, Miranda Parrini, Francesco Piccone, Gilberto Pilati, Maurizio Polizzi, Cristina Speziale, Daniele Zaccardi
Stadium è iscritto presso il Tribunale di Roma
Sezione Stampa al n. 158/2021 del 5/10/2021
Stampato da Varigrafica Alto Lazio, Zona Ind.le Settevene - 01036 Nepi (VT) Italia - su carta Fedrigoni Arena White Smooth da 140 gr. biodegradabile e riciclabile
Un dono e un compito da accogliere e testimoniare, ponendo un freno all’indifferenza

don Luca Meacci
Assistente Ecclesiastico nazionale CSI
Una nota canzone di Raf diceva: “Cosa resterà degli anni ’80”. Potremmo dire la stessa cosa oggi, del Natale che abbiamo da poco celebrato e dell’anno di Giubileo della Speranza appena chiuso. Possono sembrare domande retoriche, ma sono molto sfidanti, perché corriamo il rischio di essere come la Gerusalemme al tempo della nascita di Gesù: fervente e attiva in tante cose, ma distratta al punto da non rendersi conto che a pochi chilometri è nato il Re dei Re, il Messia. Perfino i Sacerdoti e gli Scribi di Gerusalemme sono stati costretti dai Magi a documentarsi nella Bibbia e a trovare in Michea 5,1 la risposta, ma nemmeno quello li ha messi in cammino. Ma torniamo alla domanda della canzone: cosa resterà? Cosa rimane in noi del Natale celebrato? Se guardiamo al percorso associativo, l’anno concluso ci ha riservato momenti belli e indimenticabili,
ma non ci distraiamo, perché dalla consapevolezza di quanto abbiamo celebrato si determina il nostro vivere cristiano.
L’evangelista Giovanni, nel Prologo alla sua opera, afferma: «E il Verbo si fece carne». Questo ci aiuta a non perdere di vista la forza dirompente del Natale: Dio ha tanto amato il mondo da inviare suo Figlio in mezzo a noi. Guai a far diventare scontato il fatto che Dio si sia fatto bambino diventando come uno di noi in tutto e per tutto, eccetto il peccato. Guai a dimenticare che Dio onnipotente e glorioso è nato in una mangiatoia, ha pianto ed è stato avvolto in fasce. Guai a dimenticare tutto ciò: significherebbe perdere di vista l’originalità stupenda della fede cristiana.
Sempre nel testo di Giovanni si dice che «il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi», cioè pose la sua tenda in mezzo alle nostre case. In ebraico “tenda” è “shekinah”, cioè dimora. Dio ha voluto stabilire la sua dimora in mezzo agli uomini. La sua presenza ci ricorda che Gesù è il dono della pace all’umanità intera, dove questo dono non va solo accolto, ma anche testimoniato: la pace di Dio è un dono e un compito. Papa Leone, nel messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per la pace del 1° gennaio, ci ha consegnato parole di forte responsabilità: la pace che viene da Dio ed è posta nelle nostre mani è una «pace disarmata e disarmante». Il mondo dello sport non può rimanere indifferente, deve avvertire che questa “consegna”
è rivolta ad atleti, dirigenti, tecnici e arbitri. A noi, amanti del gesto sportivo, è affidata la pace disarmata e disarmante, perché non ci può essere violenza, né nel linguaggio né nei gesti. Questo vale per tutti coloro che sono coinvolti nell’esperienza sportiva, genitori compresi. C’è ancora troppa violenza nei contesti sportivi: per questo lo sport ha bisogno di redenzione. Svuotare di aggressività, nelle parole e nei gesti, il momento sportivo. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina avrebbero potuto essere l’occasione per riaffermare “la tregua olimpica”, ma la cattiveria umana prevale. Noi, uomini e donne del CSI, sentiamoci destinatari di questa pace, e proviamo a costruire relazioni e gare sportive dove il linguaggio e i gesti violenti sono banditi. La Pace ha bisogno di testimoni credibili; ecco che Papa Leone, richiamando questa necessità, aggiunge: «Sia che abbiamo il dono della fede, sia che ci sembri di non averlo, cari fratelli e sorelle, apriamoci alla pace! Accogliamola e riconosciamola, piuttosto che considerarla lontana e impossibile. Prima di essere una meta, la pace è una presenza e un cammino. Seppure contrastata sia dentro sia fuori di noi, come una piccola fiamma minacciata dalla tempesta, custodiamola senza dimenticare i nomi e le storie di chi ce l’ha testimoniata. È un principio che guida e determina le nostre scelte. Anche nei luoghi in cui rimangono soltanto macerie e dove la disperazione sembra inevitabile, proprio oggi troviamo chi non ha dimenticato la pace».
Il sindaco Stoppini racconta le diverse anime di una città memore del proprio legame con la storia e proiettata verso il futuro
DLo sport unisce, educa, crea senso di comunità. Per questo stiamo investendo in impianti, in progetti per i giovani, in eventi che utilizzano lo sport come linguaggio universale di dialogo e rispetto
a secoli Assisi è simbolo di una cultura di pace e spiritualità che affonda le sue radici nella storia. Tra la valorizzazione dell’eredità della città e la volontà di renderla sempre più una “comunità educante”, anche attraverso il ruolo dello sport, le parole del sindaco Valter Stoppini ripercorrono e annunciano volti e progetti del Comune umbro.
sul piano internazionale, come dimostra “Assisi per Betlemme”, un messaggio fortissimo: la pace non è solo un valore da raccontare, è un gesto concreto di fraternità. Infine, c’è lo sport, un’altra via alla pace per Assisi. Lo sport unisce, educa e crea comunità; per questo investiamo in impianti, progetti per i giovani ed eventi che utilizzano lo sport come linguaggio universale di dialogo e rispetto.

Sindaco Stoppini, Assisi è conosciuta in tutto il mondo per il suo legame con San Francesco e la cultura di pace che la anima. Non si tratta però solo di un’eredità storica. I valori che hanno reso celebre Assisi sono vivi ancora oggi ed emergono nelle attività della città, come dimostra il successo della mostra “Peace on Earth” che indaga il valore della pace nell’opera di Banksy. In che modo la sua struttura amministrativa tiene viva l’eredità di storia e valori della città attraverso eventi e iniziative? Assisi è un ponte tra spiritualità, arte, bellezza e impegno civile. Governarla significa custodire un’eredità secolare, ma anche avere il coraggio di innovare. La mostra “Peace on Earth” di Banksy nasce da questa visione: abbiamo portato alla Rocca Maggiore un artista incisivo della contemporaneità perché la sua denuncia parla la stessa lingua di questa città, quella della pace concreta, che chiede responsabilità. Abbiamo riportato la Rocca al ruolo di polo culturale, riattivato il Teatro Lyrick e avviato patti civici. Tenere viva l’identità di Assisi significa anche agire
La Rocca Maggiore è solo uno dei luoghi assisiati riconosciuti come patrimonio mondiale dell’UNESCO. Proprio lo scorso dicembre Assisi ha festeggiato i 25 anni dal prestigioso riconoscimento. Cosa significa per la città e quali sono i progetti per rendere Assisi sempre più un luogo di incontro?
Celebrare i 25 anni del riconoscimento UNESCO significa riconfermare che Assisi non è solo patrimonio artistico e storico: è responsabilità. Vogliamo fare della città un laboratorio internazionale di pace, dialogo e cultura. Nel 2026, per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco, daremo vita a un progetto condiviso: un docufilm, una mostra sulla memoria del 1926 e un percorso educativo per i giovani. E poi il “Cantiere UNESCO”, spazio permanente di ricerca e valorizzazione. Assisi è già simbolo mondiale di pace: ora vogliamo essere una città che non solo testimonia, ma genera pace.
La città è meta e luogo di passaggio di migliaia di pellegrini ogni anno. Secondo i dati della Statio Peregrinorum della Basilica di San Francesco, i camminatori
sono stati 4.483 nel 2024, registrando un equilibrio tra italiani e stranieri e tra donne e uomini. Ci sono progetti in atto per promuovere e sostenere gli amanti del turismo lento e sostenibile? Assisi è città di cammini da secoli: una terra che si attraversa, si respira, si assapora. I quasi 4.500 visitatori del 2024 confermano che qui si cerca un passo diverso, più umano ed essenziale. Per noi il turismo lento non è solo un segmento da valorizzare, ma una scelta culturale e politica su cui investiamo molto. Abbiamo rilanciato i cammini francescani, sosteniamo l’ostello donativo “Laudato Si’” e coordiniamo associazioni e realtà religiose per rendere l’esperienza accessibile, sicura e ricca di significato. C’è un impegno politico fondamentale: coinvolgere i giovani. Camminare verso Assisi è un percorso educativo: un incontro con il silenzio, la natura e una spiritualità che non impone, ma accompagna.
Infine, stiamo costruendo una rete regionale e nazionale sui cammini, con la Regione Umbria e le comunità locali, affinché il pellegrino trovi un’esperienza omogenea. È una sfida enorme, ma puntiamo a rendere Assisi la capitale italiana del turismo lento per qualità dell’accoglienza e autenticità dell’esperienza.
La Chiesa di Santa Maria Maggiore di Assisi, nota anche come Santuario della Spogliazione, ospita il corpo di Carlo Acutis, canonizzato pochi mesi fa e simbolo, tra gli altri, del rapporto tra giovani, religione e tecnologia. Il 15enne, portato via troppo presto a causa della leucemia, è un punto di riferimento per tanti giovani e non solo. Quale significato ha per la città il legame con Carlo Acutis? Assisi ha la grazia di essere la casa terrena di San Carlo Acutis, il primo santo millennial. Carlo non era nato qui, ma ha scelto Assisi per l’eternità: per noi è un valore immenso. Migliaia di pellegrini da ogni parte del mondo arrivano per
pregare sulla sua tomba e Assisi è diventata, ancora una volta, un faro per chi cerca speranza. Carlo è un ponte tra i giovani e la fede, tra la tecnologia e il Vangelo, tra il mondo frenetico di oggi e quella ricerca autentica che conduce sui sentieri francescani. La sua presenza nel Santuario della Spogliazione — dove Francesco si spogliò delle ricchezze per abbracciare il Cielo — crea una continuità spirituale potente: il giovane del nostro tempo accanto a quello di otto secoli fa; il “gigante” e il “ragazzo”, come ha detto il vescovo Mons. Domenico Sorrentino, insieme a ricordarci che la santità non è lontana o impossibile. È vicina, giovane, viva. Per la città, questo legame è un dono e una responsabilità. Un dono, perché Carlo porta ad Assisi freschezza, entusiasmo e una fede che si rinnova. Una responsabilità, perché ci chiama a essere sempre più casa dell’accoglienza e della fraternità. Carlo rende Assisi fedele alla sua vocazione: siamo la città che ispira, che raccoglie i passi dei pellegrini e custodisce i santi che parlano al mondo. Grazie a lui, diciamo a milioni di giovani: «La santità è possibile anche oggi, anche per te». Assisi porta nel cuore San Carlo Acutis e, ne sono certo, Carlo porta nel cuore Assisi. Sempre.
Il CSI ha un legame speciale con la città umbra. Assisi ha ospitato per anni il Meeting dell’Associazione, accogliendo centinaia di dirigenti, operatori e volontari, diventando culla di riflessioni sul passato e nucleo di progetti sul futuro sportivo, associativo, educativo di Comitati e società sportive. Quali sono le principali azioni messe in campo dal Comune per sostenere il tessuto sportivo locale e per rendere lo sport uno strumento di aggregazione e formazione per la comunità?
Il legame tra Assisi e il CSI è speciale: ci ha aiutato a capire quanto lo sport possa essere un vero strumento educativo e comunitario.

Abbiamo scelto di investire con forza nello sport non solo come attività ricreativa, ma come motore di benessere e inclusione. Abbiamo lavorato sulle infrastrutture, riqualificando gli impianti e sostenendo le società che li gestiscono. Penso al nuovo Palazzetto dello Sport e alla rigenerazione dell’area ex Montedison. Resta la partita, complessa ma fondamentale, dello stadio e della piscina comunale: il progetto è pronto e stiamo cercando le risorse necessarie. Parallelamente abbiamo lavorato sull’accessibilità per permettere a tutti di fare sport, attraverso sostegni dedicati, collaborazioni con associazioni, contributi per la promozione giovanile e premi alle eccellenze del territorio. Ma la parte più importante è quella educativa. Assisi ha costruito una “comunità educante”: patti con le scuole, campus sportivi, spazi di aggregazione creati con i ragazzi e percorsi contro la povertà educativa. Lo sport è dentro tutto questo: un luogo in cui ci si sente visti, accolti e accompagnati, che crea relazioni sane e senso di appartenenza. Vogliamo che Assisi sia una città dove lo sport non è solo movimento, ma comunità e futuro. Farlo al fianco del CSI, che interpreta lo sport come educazione e responsabilità, per noi è un valore aggiunto enorme.

Storie, regole e responsabilità dello sport tra comunità, conflitti e scena internazionale

di Giorgia
Magni
ABetlemme c’è un piccolo campetto da calcio che dal 2020 è diventato luogo di ritrovo, di futuro immaginabile e di comunità per il campo profughi di Aida, che oggi ospita circa 7.000 palestinesi, di cui oltre 1.000 bambini, adolescenti e giovani. A fare ombra sul terreno di gioco, costruito grazie all’impegno dell’Aida Youth Center attraverso un accordo con la Chiesa Armena e un regolare contratto di affitto, non sono le fronde degli ulivi tipici di questi luoghi, ma il muro di separazione eretto da Israele per dividere i territori della Cisgiordania occupata, da quelli israeliani. Su questo terreno di gioco — e non c’è coppia di parole che suoni più bella e necessaria in un’area così tormentata — si incontrano ogni giorno tentativi di normalità e sogni ancora interi per migliaia di giovanissime e giovanissimi. Qui si allenano anche le atlete della nazionale giovanile palestinese di calcio, arrivate terze al campionato dell’Asia occidentale. Ci sono allenatori, educatori, allenamenti, partite. C’è una breccia da cui filtra la vita, fragile ma ostinata, in un luogo che un reportage esclusivo della testata L’Indipendente ha spiegato essere stato nominato «il luogo più esposto ai lacrimogeni del mondo, a causa dei costanti gas lanciati dall’esercito per reprimere manifestazioni o proteste».
Nel momento in cui scriviamo, il campo potrebbe non esserci più. L’esercito israeliano ha dato mandato di abbatterlo entro la prima metà di gennaio
2026, nonostante quell’area ricada sotto la giurisdizione del governo palestinese. L’ultimatum è arrivato il 31 dicembre 2025, sul giro di boa di un nuovo anno che sembra minacciare vecchia violenza. Nonostante tutto questo, il campetto, che una mobilitazione internazionale sta cercando di salvare tramite una petizione rivolta a FIFA e UEFA, è un luogo che costruisce la pace tenendo viva la libertà* . Perché pace, per dirla come Papa Francesco, «non è soltanto silenzio delle armi e assenza di guerra; è un clima di benevolenza, di fiducia e di amore che può maturare in una società fondata su relazioni di cura». Ogni volta che lo sport protegge e si prende cura, là — anche sotto un muro, anche tra i lacrimogeni — costruisce una pace resistente nel quotidiano. Il centro giovanile del campo profughi di Aida ha creduto che attraverso un rettangolo di gioco si potesse tenere viva la dignità della vita, la capacità di restare umani crescendo costretti tra le mura e la responsabilità di prendersi cura dei più piccoli. Ed è forse proprio da qui che passa, oggi, una delle forme più radicali e necessarie di pace possibili.
Don Manganiello: il calcio per educare e costruire pace a Scampia
Lo sport non “porta pace” per natura. Produce pace solo quando riesce a costruire regole plausibili in un contesto dove le regole, fuori dal campo, non sono più credute, o non valgono per tutti. È
esattamente quello che accade a Scampia, dove da anni la legge è percepita come distante, mentre altre regole — quelle della camorra — sono quotidiane, chiare, coercitive. In un territorio così, la questione non è solo educare ai valori, ma rendere credibile un’alternativa.
Il progetto sportivo nato attorno all’Opera Don Guanella, voluto e difeso con ostinazione da don Aniello Manganiello sin dal 1994, si inserisce proprio in questo vuoto di fiducia. Qui lo sport non è solo un’attività ricreativa, è un’alternativa che può togliere i ragazzi dalla strada. È soprattutto un tentativo concreto di costruire un micromondo in cui le regole valgono davvero: arrivare puntuali, rispettare l’arbitro, riconoscere l’altro come avversario e non come nemico, rispettare l’impegno, costruire una società sportiva all’interno della legalità. Non eliminare la guerra, ma costruire la pace. Don Aniello arriva nel 1994 all’Oratorio Don Guanella, nella Parrocchia Santa Maria della Provvidenza di Scampia, dopo due esperienze romane molto diverse tra loro ma accomunate da un forte senso di comunità. A Roma aveva conosciuto una Chiesa capace di trascinare i parrocchiani in un impegno concreto e quotidiano fatto di volontariato a servizio dei più fragili, di attenzione culturale e di relazioni autentiche.
*Nel momento di andare in stampa è giunta la notizia del successo della petizione. FIFA e UEFA hanno trovato un accordo con l’istituzione israeliana, e il campo non verrà demolito.
Dai campetti alla diplomazia: la quotidianità di uno sport che costruisce la pace
«La mia esperienza da prete inizia a Prati, quartiere della Roma bene, dove il coinvolgimento dei parrocchiani era qualcosa che mi stupiva e mi riempiva il cuore — spiega don Aniello —. Dopo un’esperienza a Tor Bella Monaca, area invece popolare della Capitale dove si faceva messa in un garage, non presi bene l’assegnazione a Scampia. Una volta arrivato, però, capii che non c’era spazio per le nostalgie romane, che qui si poteva, e doveva, fare tanto e che c’era da rimboccarsi le maniche». Scampia non concede tempi di adattamento. È un territorio dove la presenza della criminalità organizzata non è sfondo, ma struttura. Dove il potere si esercita attraverso il controllo e l’intimidazione. Dove manca la pace. Proprio da uno degli spazi più simbolici e fragili — il campetto dell’oratorio — prende avvio il lavoro di don Aniello. Quel campo, fino a quel momento, era sotto ricatto: la camorra si allacciava illegalmente all’erogazione dell’acqua a spese della società sportiva, rendendo evidente chi decidesse davvero le regole. Don Aniello parte da lì. Taglia gli allacci abusivi,
licenzia il dipendente che gestiva il campo nell’omertà, rompe un equilibrio criminale che sembrava intoccabile. È un gesto semplice solo in apparenza. In realtà è un atto di rottura netta, che gli costa minacce di morte. Ma è anche l’inizio di una ricostruzione lenta, quotidiana. Nel contesto di Scampia questo ha un significato politico preciso. Un campo sportivo con regole applicate sempre, per tutti, diventa uno spazio di rottura culturale. Non garantisce automaticamente salvezza, ma introduce un’esperienza rara: una regola che non umilia, non minaccia, non compra consenso. Lo sport torna a rompere schemi per aprire varchi. Non ripara da solo le fratture sociali, ma in molti contesti impedisce che tutto precipiti definitivamente. Produce una pace fragile forse, ma reale, fatta di piccoli successi: una sera senza violenza, un ragazzo che torna a casa, un detenuto in messa alla prova che regge una regola, un giovane che sceglie di allontanarsi da un futuro che sembra segnato e decide di mettersi a servizio. Non è retorica. È la pratica sportiva che smette di essere neutra e diventa, nel

senso più concreto possibile, un esercizio quotidiano di pace. «Non sappiamo quanti giovani abbiamo accompagnato con la nostra attività, togliendoli dalla strada e mettendoli sulla via virtuosa; non abbiamo un numero preciso di quanti ne abbiamo attrezzati per un futuro pulito e sereno di scelte oneste e rispetto delle regole — racconta don Aniello —. Però, alcuni di questi ragazzi hanno dato una direzione diversa al loro destino; hanno capito, attraverso la frequentazione dello sport e dell’oratorio, che potevano fare della loro vita un’altra storia, darle un’altra dimensione, non arrendersi ad un destino da spacciatori solo perché nati in una famiglia di camorristi». È una testimonianza che non cerca assoluzioni né semplificazioni. «Molti di quei ragazzi giocavano e allo stesso tempo spacciavano. Vivevano una doppia appartenenza. Ma nel tempo alcuni hanno scelto il cambiamento. Oggi sono allenatori, genitori, presenze educative. Hanno svolto percorsi di messa alla prova all’interno della società sportiva e ora sono lì, pronti a dare una mano, a restituire ciò che hanno ricevuto. Si rendono utili. Costruiscono relazioni». Sbagliano anche come tutti i giovani. E lo sport, proprio perché non è uno spazio separato dalla realtà, riflette le stesse tensioni, gli stessi stigmi culturali e sociali del contesto in cui è immerso. Le cronache recenti lo hanno mostrato con chiarezza: la società Don Guanella Scampia è stata coinvolta in un episodio spiacevole durante un’amichevole, quando alcuni giovanissimi atleti hanno insultato e denigrato le calciatrici del Napoli Woman.
Per don Aniello è stato un colpo duro. Conosceva quei ragazzi, aveva condiviso con loro anche l’ultimo camp estivo, e il percorso fino a quel momento era apparso solido ed efficace. Ma invece di minimizzare o rimuovere, ha scelto di affrontare l’errore come
parte integrante del cammino educativo. Non una macchia da cancellare, ma un punto da cui ripartire. La linea è stata tracciata subito, con chiarezza: trasformare l’episodio in un’occasione di consapevolezza e crescita. «Dopo questi fatti ho già istituito percorsi di educazione e sensibilizzazione al rispetto della parità di genere. Faremo anche meno allenamenti magari, ma ci ritroveremo per discutere e partecipare a convegni sulla sensibilizzazione».
Provare a incidere con lo sport sul cambiamento culturale di un’area così intrisa di criminalità significa provare ad accorciare i tempi di una transizione generazionale verso la legalità. Agire sui piccoli significa crescere uomini e donne che rifiuteranno un destino deciso dalle famiglie della camorra. Significa avviare, da subito, un processo di abbandono di quei codici e di quelle logiche, costruendo una prospettiva di vita diversa non solo per i singoli, ma per l’intera comunità. Quanta speranza vera di pace concreta c’è in questo lavoro quotidiano!
«Che la gente trovi nella nostra società sportiva e nell’oratorio un riferimento valoriale diventa un’alternativa importante — racconta don Aniello —. Il rispetto, la comprensione, l’ascolto, l’incoraggiamento sono ciò che le famiglie possono trovare in questa esperienza. Qui incontrano testimonianze di cambiamento come quelle di ex detenuti che ora parlano di possibili vite diverse, esempi viventi di scelte importanti».
La portata sociale di questo impegno arriva anche oltre i confini del quartiere, dietro le sbarre. Alcuni detenuti appartenenti a clan camorristici fanno arrivare a don Aniello una richiesta speciale: continuare a portare i loro figli in oratorio, farli giocare, proteggerli, tenerli lontani dalla strada e dalle faide. È una richiesta che pesa come una responsabilità enorme. «Prima o poi, però, i ragazzi vanno via e allora il nostro compito è
attrezzarli con dei vincoli valoriali. Se non lo facciamo, falliamo. Possono vincere sul campo, ma, se non trovano una griglia di valori con cui possono affrontare la vita, abbiamo fallito». È una riflessione che va oltre Scampia e riguarda ogni esperienza sportiva educativa. «Ogni oratorio e società sportiva dovrebbe porsi questo obiettivo attraverso la pratica di uno sport libero, educativo, spirituale, semplice, formativo, di cui oggi ho molta nostalgia perché lo vedo sparire dietro a adempimenti burocratici e pressioni delle famiglie». Anche dal punto di vista prettamente sportivo, i risultati arrivano. Dalla prima squadretta, oggi la Don Guanella Scampia 1996 — nata già due anni prima nel 1994 — conta tredici squadre e diversi titoli, tra cui la vittoria del campionato CSI nel 1995 e la doppia conquista della Junior TIM Cup nel 2017 e della Philadelphia Junior Cup nel 2025. Ma il risultato più significativo resta invisibile alle classifiche: aver reso pensabile, in uno dei luoghi simbolo del potere mafioso, l’idea che un’altra regola fosse possibile. E che, a volte, proprio da un campo di calcio possa prendere forma una pace concreta, non proclamata ma praticata. Perché costruire pace, in questi contesti, non è un gesto simbolico. È un esercizio di coraggio continuo. Coraggio nel promuovere il cambiamento quando non esistono garanzie. Coraggio nel lavorare ogni giorno nel piccolo di quartieri e comunità segnate dalla fragilità, lontano dai tavoli della politica e della diplomazia, senza alleanze strutturate, senza reti di protezione, spesso senza riconoscimenti. È una pace che non nasce da accordi ufficiali, ma dall’assunzione di responsabilità individuali e collettive. Questo è il coraggio che anima, dal 1994, l’opera di Aniello Manganiello. Un coraggio che non si è tradotto in dichiarazioni, ma in scelte
Il centro giovanile del campo profughi di Aida ha creduto che attraverso un rettangolo di gioco si potesse tenere viva la dignità della vita, la capacità di restare umani crescendo costretti tra le mura e la responsabilità di prendersi cura dei più piccoli
Dai campetti alla diplomazia: la quotidianità di uno sport che costruisce la pace
coerenti, capaci di riaccendere speranza e di restituire credibilità all’impegno educativo e sociale. Una credibilità riconosciuta e rispettata dalla comunità di Scampia, proprio perché costruita sul campo, nel tempo, senza scorciatoie. Le sue azioni di rottura con la camorra hanno suscitato clamore, attirato attenzione mediatica e minacce di morte da parte di esponenti apicali dei clan del rione Don Guanella e delle aree limitrofe. Ma soprattutto hanno acceso negli sguardi dei più giovani la possibilità di un’alternativa. Un’idea semplice e radicale insieme: non tutto è già deciso, non ogni destino è obbligato. Don Aniello non ha mai accettato la scorta. Non per incoscienza, ma per coerenza. Chiedere alle famiglie di uscire dall’omertà, di liberarsi da una condanna criminale che spesso attraversa generazioni, non sarebbe stato credibile se fatto dalla posizione protetta di chi vive ogni giorno
separato dal rischio. La sua scelta è stata quella di condividere la vulnerabilità del territorio, assumendone il peso insieme alla comunità.
Il lavoro continua ancora oggi, in una fase in cui riconoscere la camorra è diventato più difficile. Non opera più nel clamore, ma nel silenzio. Non si mostra, ma controlla. Non spara, ma occupa spazi, case, relazioni. Utilizza codici nuovi, meno visibili, che rendono complesso intercettare le “giovani leve” e ancora più difficile offrire loro uno sguardo alternativo, aprire una breccia e costruire fiducia. È dentro questa complessità che lo sport prova a farsi spazio non come soluzione definitiva, ma come possibilità; come luogo in cui una regola diversa può essere sperimentata e interiorizzata; e dove, giorno dopo giorno, la pace smette di essere una parola astratta e diventa una pratica esigente, fragile, ma reale.
Ma il risultato più significativo resta invisibile alle classifiche: aver reso pensabile, in uno dei luoghi simbolo del potere mafioso, l’idea che un’altra regola fosse possibile
Le esperienze di Scampia e di Betlemme mostrano come lo sport possa costruire pace solo quando riesce a rendere credibili le regole, o a creare spazi praticabili di relazione e a restituire dignità in contesti segnati dalla violenza e dalla guerra. Quando questo accade, il campo sportivo smette di essere un luogo imparziale e diventa un dispositivo politico nel senso più concreto del termine: uno spazio in cui il conflitto non viene, purtroppo, azzerato, ma reso abitabile. È a partire da questa dimensione di prossimità che lo sguardo può allargarsi alla scena internazionale. Qui prende forma ciò che oggi viene definito diplomazia sportiva. Non una teoria astratta, ma una pratica che esiste da decenni e che utilizza lo sport come linguaggio di relazione, contatto e riconoscimento nei momenti in cui la diplomazia tradizionale è bloccata o inefficace. Quando la pace attende risposte politiche, ma la gente ha bisogno di azioni concrete,
lo sport diventa risorsa reale. Il termine Sport Diplomacy inizia a circolare in ambito accademico e politico tra gli anni Settanta e Ottanta, all’interno degli studi sulla Public Diplomacy e sul soft power. La sua origine simbolica viene fatta risalire a un episodio ormai canonico nella storia delle relazioni internazionali: la ping-pong diplomacy del 1971. In piena Guerra Fredda, una serie di incontri di tennistavolo tra atleti statunitensi e cinesi contribuì ad aprire un canale informale di comunicazione tra Stati Uniti e Cina, preparando il terreno alla visita del presidente Nixon a Pechino nel 1972. Lo sport non risolse il conflitto ideologico, ma rese possibile il dialogo là dove il linguaggio politico era irrigidito. Da allora, la diplomazia sportiva ha assunto forme diverse in contesti e decenni differenti. La cricket diplomacy tra India e Pakistan, avviata esplicitamente nel 1987 e riproposta in momenti chiave come il 1999 e il 2004, ha accompagnato tentativi di distensione tra due Paesi segnati da conflitti armati e rivalità identitarie profonde. Allo stesso modo, la baseball diplomacy tra Stati Uniti e Cuba ha rappresentato uno spazio simbolico e concreto di riavvicinamento: nel 1999 con la doppia amichevole tra i Baltimore Orioles e la nazionale cubana, e nel 2016 con la partita giocata a L’Avana dai Tampa Bay Rays alla presenza di Barack Obama e Raúl Castro, nel pieno del tentativo di normalizzazione diplomatica. Questi episodi, riconosciuti e analizzati dalla letteratura accademica sulle relazioni internazionali, mostrano che la diplomazia sportiva non consiste nel far pace giocando, ma nel creare spazi intermedi di contatto, contesti in cui l’altro smette di essere una categoria astratta e torna a essere un corpo, un volto, una storia. È la stessa logica che, su scala diversa, si ritrova nei campetti di Scampia o di Betlemme. È all’interno di questa cornice che si colloca una testimonianza recente e

particolarmente significativa, che rende evidente come la diplomazia sportiva non sia soltanto una categoria teorica, ma una pratica viva, attraversata dal conflitto.
Mauro Berruto, coach di volley in Palestina
Il deputato del Partito Democratico Mauro Berruto, ex allenatore della Nazionale Italiana di Volley, a fine novembre si è recato a Ramallah, in Palestina, su invito del Comitato Olimpico Palestinese. In quei giorni Berruto è stato ufficialmente il coach della nazionale palestinese di pallavolo: ha allenato, formato, incontrato atlete e atleti di discipline diverse, entrando in contatto con storie e famiglie che, fino a quel momento, viste dall’Italia erano solo volti indistinti e numeri dietro titoli di giornale e immagini televisive. È un progetto che restituisce dignità alla vita attraverso
l’attività sportiva, sottraendola alla narrazione esclusiva del dolore. «L’accoglienza per questa iniziativa è stata enorme ed entusiasta — ci racconta Berruto —. La vita che pulsa riparte dallo sport in un Paese che ha bisogno di riacquistare la sua identità e riaffermarsi attraverso una narrazione che non sia solo di dolore e morte». Lo sport, in questo racconto, assomiglia ai papaveri che crescono ai bordi delle massicciate ferroviarie o tra le crepe dell’asfalto: fragile, inatteso, ma capace di adattarsi e crescere nei luoghi più impervi e impensabili. È lo sport che, col rumore dei passi svelti di chi corre dietro ad una palla o salta per colpirne una, smuove una terra che ha sepolto in due anni oltre 67.000 uomini e donne — di cui oltre 18.400 bambini — e che ha visto fuggire 1,9 milioni di abitanti su 2,4 milioni che risiedevano in quei territori (dati Oxfam 2025). In un contesto simile, ogni
proposta che soffia vita diventa ossigeno. Va oltre la semplice assenza di conflitto: diventa l’inizio di una prospettiva. «In una giornata che per me resterà indimenticabile, ho incontrato un folto gruppo di allenatori e allenatrici, molti di loro un po’ assonnati perché, per arrivare puntuali, si erano messi in strada alle quattro del mattino — scrive il deputato in un articolo pubblicato su Avvenire il 7 dicembre 2025 —. La Cisgiordania è lunga solo 130 chilometri e Ramallah sta nel mezzo, le distanze non sarebbero un problema se non si dovessero superare i check point che, invece, possono ritardare o proprio impedire di arrivare». Eppure, giovani e adulti si mettono in cammino. Lo fanno perché l’istinto a vivere, quando riesce ancora a farsi sentire, non può essere soppresso neppure nella devastazione più estrema. Arrivare a un allenamento, a un incontro, diventa un atto di
Dai campetti alla diplomazia: la quotidianità di uno sport che costruisce la pace

resistenza silenziosa.
Prima della partenza Mauro Berruto ci aveva parlato della sua «emozione, che tiene dentro sia paura che speranza». Ora che è rientrato, nelle sue parole torna spesso lo sguardo di chi non dimentica i volti, le storie e le ore di allenamento professionale che, pur simili a tante altre nella sua carriera, non sono uguali a nessuna. «Quando la palla vola, la lingua diventa universale e allora basta uno sguardo o un’occhiata, per capirsi — si legge ancora nel suo scritto su Avvenire — […]. Vedo, nei loro occhi, una luce che non dimenticherò mai, vedo corpi che si muovono liberi, vedo cervelli che per due ore si concentrano su altro. Ed è già una vittoria». C’è una fotografia del gruppo allenato da Berruto a Ramallah. È la classica foto sportiva, felice, di chi si stringe ai compagni soddisfatto. C’è però un’altra foto che il coach ha pubblicato prima della partenza. Ritrae la nazionale palestinese su un campo. Anche qui gli atleti sono abbracciati, ma nell’immagine a colori quattro di loro sono ritratti in bianco e nero. Non è un errore di stampa, né un difetto di produzione, ma una desaturazione voluta e simbolica: sono atleti morti nei bombardamenti e negli attacchi israeliani degli ultimi anni. «Ho avuto modo di verificare allenando questa squadra, incontrando allenatori e allenatrici — racconta Berruto in un reel pubblicato sul suo profilo Instagram —, come questo
progetto di pulizia etnica, perché così va chiamato, ovviamente interessi anche lo sport […]. Abbiamo incontrato atleti molto giovani, vittime di tortura o dura carcerazione. Ci hanno raccontato come una cosa per noi normale, come fare sport, in questo momento sia impedita. Tutto ciò è in violazione a qualsiasi principio della Carta Olimpica». La missione che il deputato del Partito Democratico ha vissuto insieme a un gruppo di parlamentari — Laura Boldrini, Ouidad Bakkali, Sara Ferrari, Valentina Ghio e l’ex ministro Andrea Orlando — rientra a pieno titolo nella diplomazia sportiva: una pratica che non pretende di risolvere i conflitti, ma che sceglie di stare dentro le fratture, di attraversarle con il linguaggio del corpo, del gioco e della relazione.
Nazioni Unite, sport e diplomazia multilaterale.
A dare struttura istituzionale alle pratiche che utilizzano lo sport come strumento di costruzione della pace è intervenuto, negli ultimi decenni, il sistema delle Nazioni Unite, che ha riconosciuto formalmente l’attività sportiva come una leva utile alla promozione dello sviluppo umano, della coesione sociale e della riduzione dei conflitti. Questo riconoscimento si inserisce in un quadro più ampio di diplomazia multilaterale, in cui lo sport non è considerato fine in sé, ma come
mezzo operativo capace di incidere su alcune fragilità strutturali che attraversano le società contemporanee.
L’approccio noto come Sport for Development and Peace si fonda proprio su questa consapevolezza: lo sport, se progettato in modo intenzionale e accompagnato da politiche educative e sociali, può contribuire all’educazione delle giovani generazioni, all’inclusione delle persone più vulnerabili, all’empowerment dei gruppi marginalizzati, alla prevenzione della violenza e alla costruzione di comunità più resilienti. In questa prospettiva, l’attività sportiva diventa uno spazio di sperimentazione concreta di regole condivise, di convivenza possibile, di gestione non violenta del conflitto. Le Nazioni Unite hanno progressivamente integrato questo approccio all’interno dell’Agenda 2030, riconoscendo allo sport la capacità di contribuire in modo trasversale a numerosi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: dall’accesso all’istruzione alla parità di genere, dalla salute alla riduzione delle disuguaglianze, fino alla promozione di società pacifiche e inclusive. Non si tratta di una visione astratta o celebrativa, ma di un orientamento che trova applicazione in programmi,
Quando la pace attende risposte politiche, ma la gente ha bisogno di azioni concrete, lo sport diventa risorsa reale
partenariati e interventi rivolti a contesti segnati da povertà, conflitti armati, migrazioni forzate ed esclusione sociale. Una delle espressioni più chiare e riconoscibili di questa visione è la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2013 e celebrata ogni anno il 6 aprile. La Giornata non nasce come ricorrenza simbolica, ma come strumento politico e culturale volto a rafforzare la consapevolezza del ruolo che lo sport può svolgere nella costruzione di percorsi di pace concreta. In questa occasione, Stati membri, istituzioni sportive, scuole, organizzazioni della società civile e comunità locali sono invitati a promuovere iniziative sportive inclusive, momenti di riflessione pubblica, attività educative e campagne di sensibilizzazione. Il messaggio che l’ONU affida a questa giornata è chiaro: la pace non coincide esclusivamente con l’assenza di guerra, ma si costruisce attraverso pratiche quotidiane che favoriscono l’accesso ai diritti, la partecipazione e il riconoscimento reciproco. All’interno della diplomazia multilaterale, l’azione delle Nazioni Unite mostra come lo sport possa diventare un terreno di connessione tra livelli diversi — locale, nazionale e internazionale — e contribuire ad aprire varchi di dialogo anche in contesti segnati da tensioni profonde. Una diplomazia imperfetta, ma necessaria, che sceglie di investire nella relazione, nella presenza e nella realizzazione di possibilità reali.
Lo sport, i conflitti, le responsabilità politiche
Questo sguardo sullo sport trova una radice simbolica profonda nella storia stessa dei Giochi Olimpici. Nell’antica Grecia, infatti, lo svolgimento delle Olimpiadi era accompagnato dall’ekecheiria, la tregua sacra che prevedeva la sospensione temporanea dei combattimenti. Non si trattava di
una pace universale né definitiva, ma di una pausa condivisa e rispettata, necessaria affinché gli atleti potessero raggiungere Olimpia in sicurezza, le competizioni potessero svolgersi e la popolazione potesse assistervi. Già allora, lo sport non fermava la guerra, ma la interrompeva simbolicamente, creando uno spazio separato, regolato, riconosciuto come inviolabile.
Quella tradizione è spesso evocata anche oggi nel dibattito internazionale sul rapporto tra sport, conflitti armati e responsabilità politiche. In un mondo attraversato da invasioni, guerre, stermini e violazioni sistematiche dei diritti umani, la domanda torna con forza: è legittimo permettere la partecipazione alle competizioni sportive internazionali di atleti provenienti da Stati che si sono resi protagonisti di gravi crimini? Oppure l’esclusione diventa essa stessa uno strumento politico, strumentalizzato e sanzionatorio? Il dibattito non è nuovo e non ha risposte univoche. Negli ultimi decenni, federazioni internazionali come FIFA, UEFA e il Comitato Olimpico Internazionale hanno adottato decisioni di esclusione o sospensione di Stati e rappresentative nazionali, facendo riferimento ai principi fondativi dello sport internazionale.
Tra gli esempi più noti c’è quello del Sudafrica dell’apartheid, escluso dal 1964 al 1992 dai Giochi Olimpici, dai Mondiali e da gran parte delle competizioni internazionali su decisione del CIO e di numerose federazioni, come sanzione contro un sistema istituzionalizzato di discriminazione razziale; la Jugoslavia, sospesa nel 1992 a causa delle guerre nei Balcani ed esclusa dagli Europei di calcio e dalle Olimpiadi su decisione di UEFA, CIO e organismi internazionali; l’Iraq, la cui federazione calcistica fu sospesa tra il 2008 e il 2010 dalla FIFA in
tutte le sue competizioni, per le gravi violenze e le torture inflitte agli atleti da parte del regime; e la Russia, colpita prima nel 2018 per il doping di Stato e poi dal 2022 a oggi per l’invasione dell’Ucraina, con l’esclusione o la forte limitazione della partecipazione a Olimpiadi, Mondiali e competizioni internazionali, su indicazione del CIO e delle principali federazioni.
In questo contesto, è oggi apertissima la discussione internazionale sulla possibilità che lo stesso destino possa essere riservato a Israele, alla luce di quanto commesso negli ultimi due anni a Gaza. È in questa tensione — tra l’ideale di neutralità dello sport e la necessità di non legittimare la violenza e tutelare i diritti umani — che si colloca il dibattito attuale.
La Carta Olimpica, in particolare, richiama esplicitamente il rispetto della dignità umana, della pace e dei diritti fondamentali come pilastri del Movimento Olimpico, pur lasciando al CIO un ampio margine di valutazione politica e istituzionale. Ancora una volta, lo sport non offre soluzioni semplici, ma costringe a prendere posizione. Come accadeva nell’antichità, la tregua sportiva non elimina il conflitto, ma lo rende visibile, lo sospende, lo interroga. È proprio per questo che continua a essere, ieri come oggi, uno spazio carico di significato politico.
Il CSI e lo sguardo sportivo alle cause internazionali
Da tempo il Centro Sportivo Italiano ha scelto di rivolgere lo sguardo oltre i confini nazionali, intercettando una dimensione globale in cui l’attività sportiva diventa strumento di accompagnamento umano e educativo in contesti segnati da precarietà estrema, disuguaglianze profonde e assenza di opportunità per le nuove generazioni.
Il volontariato sportivo internazionale
Questa visione ha trovato una struttura stabile nella Fondazione CSI per il Mondo, costituita nel 2025 ma operativa dal 2011 con una prima esperienza ad Haiti. Da allora, il progetto di volontariato sportivo internazionale ha conosciuto uno sviluppo progressivo, costruendo relazioni, programmi e missioni in quattro dei cinque continenti. Nel tempo, alcune esperienze sono diventate punti di riferimento: Camerun, Congo, Perù, Cile, Madagascar e Bangladesh rappresentano oggi nodi consolidati di una rete che ha saputo estendersi anche a Burundi, Kenya, Zambia, Libia, Albania, Bosnia, Cina e in molte altre realtà attraversate da povertà materiale, fragilità sociali e mancanza di orizzonti per bambini e giovani. Non si tratta di presenze episodiche, ma di percorsi che si sviluppano nel tempo, adattandosi ai contesti e alle persone incontrate. Dal 2011 a oggi, sono 1.837 i giovani volontari e i formatori coinvolti. Accanto all’intervento diretto, infatti, CSI per il Mondo ha investito in modo significativo nella formazione locale, attivando 103 missioni in quasi quindici anni, di cui 17 dedicate in modo specifico alla preparazione di allenatori e educatori del posto. Qui non c’è diplomazia nel senso classico del termine, né un coinvolgimento diretto delle istituzioni politiche, eppure, in questi contesti, l’attività sportiva finisce per svolgere una funzione che va oltre l’intervento educativo: crea connessioni dove le infrastrutture mancano, accorcia distanze che sembrano insormontabili, anticipa tempi che altrimenti sarebbero lunghi generazioni. Lo fa attraverso la presenza costante, l’insegnamento di una disciplina e il valore del gioco come spazio sicuro. Costruiscono pace così, i volontari di CSI per il Mondo. Nei primi anni di missione ad Haiti,
i militari deposero le armi per partecipare alle Olimpiadi dello sport organizzate proprio dal CSI. Sport e pace si diceva… Ecco. Per i più piccoli, tutto questo significa avere un luogo in cui stare, un tempo protetto, un gruppo di riferimento. Per le comunità, vuol dire costruire fiducia, rafforzare legami, immaginare traiettorie diverse. È un lavoro che non promette trasformazioni immediate ma incide in profondità, perché si prende carico della complessità e prova, giorno dopo giorno, a semplificare la vita delle persone. Senza dichiararlo esplicitamente, CSI per il Mondo dimostra che, anche lontano dai tavoli della diplomazia e dalle grandi narrazioni internazionali, esiste una forma concreta di costruzione di futuro che passa dall’incontro, dalla cura, dalla responsabilità condivisa.
L’istinto a vivere, quando riesce ancora a farsi sentire, non può essere soppresso neppure nella devastazione più estrema. Arrivare a un allenamento, a un incontro, diventa un atto di resistenza silenziosa
Dentro questa trama di esperienze, lo sguardo internazionale è la prosecuzione naturale di un’idea di impegno sportivo che non si ferma ai confini, perché le fragilità, oggi, non hanno geografia stabile. È recente, in questo senso, la collaborazione siglata dal Centro Sportivo Italiano con Focsiv (Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana), una rete composta da 100 enti associati in circa 80 Paesi. In oltre 50 anni di attività ha coinvolto più di 28.000 volontarie e volontari, costruendo percorsi di sviluppo umano orientati alla dignità della persona e alla riduzione delle disuguaglianze. Un impegno che si sviluppa tanto nei contesti internazionali quanto in Italia e in Europa, attraverso iniziative pensate per attivare cittadinanza, responsabilità collettiva e dialogo con le istituzioni, in coerenza con gli Obiettivi dell’Agenda 2030. Dal legame tra le due realtà è nata la campagna “Sport contro la fame – Lo sport nutre la speranza”, promossa in collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). L’obiettivo, si legge nella presentazione dell’iniziativa, «è mobilitare la comunità sportiva italiana e l’opinione pubblica sul tema del diritto al cibo e della sovranità alimentare». L’intento è nobile, ma come può lo sport, anche questa volta, mettersi al servizio? «Attraverso eventi sportivi, attività di sensibilizzazione e attivazione — si legge ancora — la campagna mira a sostenere 58 progetti di sicurezza alimentare promossi dalla rete dei soci Focsiv nei Paesi più colpiti da fame e denutrizione». Si compie la valorizzazione di uno strumento come quello dell’attività sportiva, affinché nel suo essere inclusiva possa essere anche mezzo di educazione alla cittadinanza globale.
Le mobilitazioni sul territorio: “leghiamoci alla Pace”
L’attenzione nazionale alle grandi cause globali, e in particolare alla costruzione della pace attraverso lo sport, parte dalla sede centrale di Roma del CSI e, a cascata, raggiunge i Comitati territoriali. Tra le molte iniziative di sensibilizzazione sul tema del ripudio della guerra, la mobilitazione social promossa dal CSI Milano nel novembre 2025 ha generato un’adesione ampia e significativa da parte dei tesserati del Comitato.
“Leghiamoci alla Pace” era il nome della campagna, pensata per coinvolgere le società sportive milanesi e brianzole in una riflessione condivisa sul significato della pace. A presidenti, dirigenti e allenatori è stata recapitata una lettera: non una circolare, ma un pensiero. Tutte le squadre sono state invitate a scendere
in campo con uno straccetto bianco legato al braccio, al polso, ai capelli, alla fronte o alle caviglie. Anche i gruppi arbitrali del Comitato di Milano hanno risposto con piena adesione. Nella settimana compresa tra il 10 e il 16 novembre 2025 sono stati pubblicati oltre duemila contenuti, tra fotografie e video realizzati dalle società sportive e ricondivisi nelle storie Instagram del profilo CSI Milano (sono tuttora visibili nelle storie in evidenza dedicate alla pace). Un’adesione che ha superato le aspettative, non solo in termini quantitativi, ma anche per qualità e creatività. Le società, infatti, non si sono limitate a una singola immagine, ma si sono messe in gioco con veri e propri video in cui lo straccetto bianco diventava protagonista di sequenze e montaggi di grande efficacia comunicativa.
Dalle immagini emergeva con chiarezza il senso profondo di
un bisogno condiviso: ristabilire un’umanità sincera a partire proprio dai campetti e dalle palestre. Un mondo ideale, forse, in cui lo sport si faceva megafono di una voce consapevole di non poter cambiare gli equilibri del mondo, ma altrettanto consapevole di non potersi permettere l’indifferenza. Perché l’educazione che attraversa lo sport non può che essere, anche, educazione alla pace. Forse il punto non è decidere chi far giocare e chi no, ma capire cosa chiediamo allo sport. Se lo usiamo solo come intrattenimento globale, ogni scelta pesa poco. Se invece lo consideriamo un linguaggio pubblico, la pace non è uno slogan da esibire ma un metodo. È il lavoro quotidiano sul non-conflitto, sulla relazione, sul valore condiviso. Non ferma le guerre, ma può impedirne la normalizzazione, educando a stare insieme prima che dividersi diventi inevitabile.


di Antonella Stelitano
Il 19 novembre scorso è toccato al governo italiano insieme al CIO presentare all’Assemblea generale dell’ONU la risoluzione per la Tregua Olimpica. Un appello rivolto al mondo, che è stato scelto come strumento attraverso il quale il mondo olimpico ha voluto esprimere e promuovere ai più alti livelli la volontà di essere strumento di pace e promozione dei diritti umani in maniera ampia e trasversale. L’alleanza con l’ONU, formalmente ufficializzata nel 1993, è basata sulla condivisione dello stesso apparato valoriale e della stessa missione: lavorare per cancellare le discriminazioni e per portare la pace. La Tregua Olimpica è uno di questi strumenti, certamente il più suggestivo. Ammantata del fascino della sua più antica versione, vuole sensibilizzare gli Stati membri ad accogliere l’appello a fermare tutte le guerre in corso in corrispondenza di ogni celebrazione dei Giochi, per vivere un’autentica esperienza di incontro e fratellanza. Dalla prima risoluzione, approvata il 25 ottobre 1993, ne sono seguite altre, una ogni due anni, in corrispondenza della celebrazione di ogni edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici, estivi e invernali. È curioso notare che il titolo di queste risoluzioni non è mai stato cambiato e ripropone parole che De Coubertin per primo aveva pronunciato: «Building a peaceful and better world throught sport and the olimpic ideal».
Ma, al di là del fascino del richiamo all’antica Grecia, la Tregua Olimpica moderna differisce totalmente da quella antica perché, una volta scaduti i termini della tregua, non torna tutto come prima. Il progetto di pace che nasce dalla collaborazione tra CIO e ONU è un progetto da seminare e da alimentare ogni giorno. Un progetto di pace positiva, che comprende non solo l’assenza di guerra, ma un insieme di atteggiamenti, istituzioni e strutture in grado di favorire, creare e sostenere la pace. Da qui l’istituzione di una seconda serie di risoluzioni, finalizzate a dare forza e continuità al progetto, che oggi portano il titolo di “Sport come strumento per uno sviluppo sostenibile”, in coerenza con l’Agenda 2030. Quando parliamo di sport, pace e diritti umani, dobbiamo tener conto anche di questi atti finalizzati a creare il terreno più idoneo per abbattere discriminazioni e disuguaglianze che sono alla base dei conflitti. Un costante e continuo impegno per la pace che sposa la missione dei Giochi Olimpici di essere una forza unificante e transnazionale.

Il progetto di pace che nasce dalla collaborazione tra CIO e ONU è un progetto di pace positiva, che comprende non solo l’assenza di guerra, ma un insieme di atteggiamenti, istituzioni e strutture in grado di favorire, creare e sostenere la pace

tra le macerie
Lo sport come rieducazione alla non-violenza e argine contro l’odio

di Alessio Franchina
In una terra segnata e piegata da conflitti, odio e intolleranze, Sua Beatitudine il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, parla di un cammino concreto per costruire la pace, attraverso un’educazione che contrasti gli stereotipi e inviti alla speranza. In cui anche il gioco e lo sport si fanno strumenti al servizio dell’ascolto e del dialogo.
Lei vive ogni giorno immerso in una realtà segnata da violenza, lutto e fratture profonde. Alla luce di ciò che vede e ascolta, oggi ha ancora senso parlare di pace come processo e non solo come desiderio? E quali gesti minimi, realistici, possono davvero essere “costruttori di pace” in questo momento storico?
Custodire la dignità dell’altro anche nel modo di parlare: perché
un linguaggio violento e disumanizzante
è già una forma di violenza che prepara altra violenza
Sì, ha ancora senso parlare di pace come processo. Anzi, oggi è forse l’unico modo serio di parlarne. La pace non coincide con la sola cessazione delle ostilità: la fine della guerra non è automaticamente l’inizio della pace; è, semmai, il primo passo di un cammino lungo e paziente. Questo processo, però, non si regge su slogan: richiede verità, giustizia, riconciliazione e perdono tenuti insieme; separati, diventano facilmente armi retoriche o spirituali che alimentano altro conflitto. Quanto ai gesti minimi, oggi li vedo così: non lasciare che odio e vendetta occupino tutto il cuore e il linguaggio, chiedere giustizia senza spargere odio, e dire parole che aprano prospettive invece di chiudere porte. Fare spazio all’altro (non “occuparlo”): cercare un posto per l’altro invece di negarlo, nella vita quotidiana e nelle comunità. Custodire la dignità dell’altro anche nel modo di parlare: perché un linguaggio violento e disumanizzante è già una forma di violenza che prepara altra violenza. Tessere fiducia con piccoli atti concreti e perseveranti (relazioni, collaborazione, ascolto): la pace si costruisce “capillarmente”, nei luoghi dove la vita reale forma le coscienze. Sono gesti piccoli, ma non insignificanti: sono “artigianato” della pace, lo spazio dove ciascuno può davvero essere fermento.
Lo sport viene spesso raccontato come linguaggio universale. Ma in un contesto come quello di Gaza e della Terra Santa, dove tutto sembra dividere, lo sport potrà mai essere, una volta ripristinata una normalità civile, uno spazio reale di incontro o rischia di restare una narrazione distante dalla vita quotidiana delle persone? Lo sport può diventare uno spazio reale di incontro, ma non automaticamente. In Terra Santa (e in molti contesti di frattura) la convivenza non è un’idea astratta: è una fatica concreta, legata a identità, appartenenze, paure e memorie. Perché lo sport non resti “narrazione”, servono almeno due condizioni: un contesto educativo che contrasti stereotipi, segregazioni e indottrinamento alla violenza, aiutando le nuove generazioni a interiorizzare regole di vita comune e fiducia nell’altro; e una cultura dell’incontro, quella “ostinazione” dell’ascolto e del dialogo che fa cedere paura e sospetto e trasforma le differenze in ricchezza. Se queste condizioni maturano, lo sport non è un accessorio: diventa un laboratorio concreto di convivenza, perché insegna che l’altro non è solo “avversario” ma persona, compagno di regole, limite e rispetto.

Pensando ai più piccoli, a bambini che conoscono prima il rumore delle bombe che quello di una palla che rimbalza: che valore può avere il gioco oggi, non come evasione, ma come atto profondamente umano? E cosa significa, per un bambino, poter giocare in un luogo dove la pace non è garantita? Ha senso pensare che serva o è troppo distante dall’annientamento che si vive ora in quei territori?
Per un bambino, poter giocare dove la pace non è garantita non è un lusso: è una affermazione di umanità. In tempo di guerra la tentazione è credere che l’unica cosa reale sia l’annientamento; invece, proprio nelle macerie, un gesto di vita – anche fragile – può diventare resistenza del cuore. Ma va detto con molta onestà: perché questo non suoni “romantico”, occorre fermarsi davanti al trauma e non banalizzarlo. Le ferite non si cancellano con una pace intesa come sola “assenza di guerra”; se non sono curate, elaborate, condivise, restano attive e generano altra violenza, spesso per generazioni. Per questo il gioco, oggi, ha senso se è inserito dentro un cammino più grande: protezione, prossimità, cura, educazione alla speranza. La speranza non è ottimismo: è “iniettare” futuro quando domina la paura, e l’educazione (scuole, comunità, spazi sicuri) è decisiva. In una mia recente visita e in vari incontri ho percepito quanto, oltre agli aiuti materiali, le persone – e in particolare i più vulnerabili –abbiano bisogno di parole e segni di vicinanza che non cedano all’odio ma aprano alla luce. Spesso i bambini con la loro innocenza sono coloro che
danno concretezza alla speranza e diventano la misura della ricostruzione possibile. Sono convinto che sono stati proprio loro, i bambini, a dare forza ed energia agli adulti, a salvarli e a resistere dentro questa guerra.
Lei incontra comunità ferite, famiglie spezzate, giovani cresciuti dentro il conflitto. Secondo la sua esperienza, in un discorso generale che esula dalla singola Terra Santa, come atto quasi preventivo del conflitto, il gioco e lo sport possono ancora insegnare qualcosa che la realtà sembra smentire ogni giorno: il rispetto dell’altro, la regola, il limite, la fiducia?
Sì: gioco e sport possono ancora insegnare ciò che la realtà sembra smentire, ma solo se non li trattiamo come “tecniche neutrali”. In contesti feriti, la regola non è solo disciplina sportiva, ma educazione al limite e alla convivenza; il rispetto non è galateo, bensì riconoscimento della dignità dell’altro; la fiducia non è ingenuità, ma scelta, spesso faticosa, di non ridurre l’altro a nemico. E qui torno a un punto che considero centrale: la pace richiede tempi lunghi, percorsi complessi, e soprattutto persone e comunità capaci di orientare, accompagnare, creare contesti dove ci si possa esprimere e incontrare senza essere subito tradotti in schieramenti. In generale, direi che gioco e sport possono essere “preventivi” del conflitto solo dentro una più ampia rieducazione alla pace e alla non-violenza, perché il conflitto si alimenta anche (e spesso soprattutto) con ciò che si insegna, si ripete, si normalizza.
Il traguardo e la nuova linea di partenza dell’Associazione
OOttant’anni di sport e di comunità non sono un punto d’arrivo, ma una promessa.
Il CSI guarda al futuro con la forza di una storia condivisa, mettendo al centro il “noi” e i valori che uniscono

di Massimiliano Dilettuso
ttant’anni non sono soltanto un traguardo: sono un racconto collettivo. Un intreccio di vite, volti e storie che, insieme, hanno dato forma a un progetto educativo e sportivo unico nel panorama sportivo italiano. La grande festa per l’ottantesimo anniversario del Centro Sportivo Italiano, celebrata a Roma il 4 ottobre 2025, ha restituito proprio questo: l’immagine di una comunità viva, grata del proprio passato e coraggiosa nel proiettarsi al futuro.
La giornata si è aperta nella prestigiosa cornice dell’Auditorium Conciliazione, a pochi passi dalla storica sede nazionale del CSI. Qui, fin dal mattino, si è respirata un’atmosfera densa di emozione. Oltre un migliaio sono stati i dirigenti, gli allenatori, gli atleti e i volontari arancioblu che hanno preso parte all’appuntamento. Le prime testimonianze, le immagini d’archivio e i saluti istituzionali hanno scandito un’introduzione che ha ricordato quanto il Centro Sportivo Italiano abbia saputo incidere nella storia sociale e sportiva del Paese.
A portare il proprio contributo, attraverso videomessaggi e interventi dal vivo, sono state alcune tra le voci più rappresentative del mondo ecclesiale, istituzionale e sportivo italiano. Dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, al cardinale Matteo Zuppi, passando per il presidente di Azione Cattolica Italiana Giuseppe Notarstefano, il presidente
del CONI Luciano Buonfiglio, il presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis e il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò.
L’attenzione delle istituzioni ha ribadito un punto cruciale: lo sport è davvero un diritto solo quando diventa accessibile a tutti. Accessibile non a parole, ma nei fatti, in grado di superare barriere economiche, sociali, culturali e fisiche. È una sfida impegnativa, che richiede coraggio, visione e alleanze solide. Proprio per questo, accanto al CSI, sono intervenute realtà associative, fondazioni, enti sportivi e partner che negli ultimi anni hanno collaborato per rendere più ampio e più forte il raggio d’azione dell’Associazione.
«Siamo sempre qui, presenti sul territorio per favorire l’attività sportiva che è gioia di incontro fra persone, aggregazione, dialogo, sfida leale e rispetto dell’avversario, mai nemico.
L’esperienza ci ha insegnato che ci si salva insieme, solo con un vero gioco di squadra, mettendo al centro il “noi”. Il CSI è chiamato a mettersi in gioco nella vita come nello sport, spendendosi per ciò che vale per davvero», ha affermato il presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano, Vittorio Bosio, nel suo accurato e acclamato intervento.
Tre momenti di approfondimento hanno animato la mattinata.
Il primo ha messo in dialogo alcuni dei principali compagni di viaggio che hanno contribuito a sviluppare progetti innovativi e ad ampliare le possibilità di

intervento del CSI sul territorio. Si è parlato di responsabilità sociale, giovani, sport come strumento di cittadinanza attiva con il presidente di Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, il Community Relations Coordinator di F.C. Internazionale Milano, Alberto Bassani, il responsabile nazionale Servizio Civile di Focsiv, Primo Di Blasio, e Maria Cristina Alfieri, segretario generale e direttrice di Fondazione Conad ETS. Il secondo momento è stato dedicato ai campioni “nati nel CSI”: atleti che hanno mosso i primi passi proprio nei campetti delle società sportive “ciessine”, e che oggi portano con sé i valori ricevuti in quelle esperienze formative. Dal nuotatore paralimpico Simone Barlaam alla mezzofondista Sinta Vissa, il mito del ciclismo Francesco Moser e la pallavolista Barbara Fontanesi, una delle prime medagliate (era il bronzo 1989 a Stoccarda) nella storia del volley azzurro. Le loro storie hanno ricordato quanto il CSI sappia essere, da sempre, una palestra di vita oltre che di sport. Il terzo panel ha dato voce alle società sportive: il cuore pulsante dell’Associazione. Dai quartieri difficili alle periferie, dai piccoli
paesi alle realtà metropolitane, i racconti delle comunità locali hanno mostrato la concretezza quotidiana dell’impegno associativo. Qui il CSI non è un acronimo, ma un volto familiare: è l’allenatore che accompagna i ragazzi dopo la scuola, è il volontario che apre la palestra ogni giorno, è il dirigente che si mette a disposizione per costruire opportunità dove spesso mancano. La mattinata si è chiusa con uno degli interventi più attesi: il monologo di un grande narratore sportivo, Federico Buffa, capace di tratteggiare, con il suo stile inconfondibile, un viaggio attraverso otto decenni di storia italiana intrecciati a quella del CSI. Dal dopoguerra alle sfide del presente, la narrazione ha restituito immagini vivide, ricordi condivisi e la consapevolezza di quanto il Centro Sportivo Italiano abbia saputo evolversi restando fedele alla propria missione originaria. Nel pomeriggio, il clima di festa si è trasformato in un cammino spirituale: un pellegrinaggio che ha condotto tutti i presenti da Piazza Pia verso la Basilica di San Pietro. Il passaggio della Porta Santa e la Celebrazione
Eucaristica, presieduta da mons. Nunzio Galantino, ex altista e arbitro del CSI, oggi vescovo emerito di Cassano all’Jonio, hanno rappresentato un momento di intensa partecipazione, che ha unito idealmente il percorso sportivo e quello di fede che da ottant’anni camminano parallelamente nel CSI. L’omelia ha richiamato gli sportivi a vivere con coraggio, responsabilità e speranza: valori che, nello sport come nella vita, non invecchiano mai.
La celebrazione dell’ottantesimo anniversario del Centro Sportivo Italiano non è stata soltanto una ricorrenza. È stata un’occasione per fermarsi, ascoltare, rileggere il cammino fatto e rimettersi in viaggio con rinnovato entusiasmo. Perché ottant’anni di storia non sono un punto d’arrivo: sono una promessa per il futuro. E il CSI, con la sua comunità di società sportive, volontari, dirigenti, arbitri, atleti e famiglie, ha dimostrato ancora una volta di essere pronto a proseguire il suo cammino, continuando a crescere restando giovane. Un traguardo che sancisce, a tutti gli effetti, un nuovo inizio.

Il ruolo e il futuro della pallavolo nelle parole del Presidente della FIPAV

di Alessio Franchina
Con questo numero di Stadium inauguriamo uno spazio di confronto e approfondimento che ci accompagnerà per i prossimi mesi. L’idea nasce dal desiderio di dare voce e concretezza ai tanti spunti arrivati in redazione: una richiesta diffusa di comprendere quale direzione stia prendendo il nostro sistema sportivo e in che modo le grandi visioni nazionali si intreccino con la vita quotidiana delle società sportive di base. Abbiamo scelto di aprire una finestra privilegiata sulla governance sportiva del Paese, incontrando i vertici delle Federazioni, del CONI, del Governo, di Sport e Salute e i più influenti dirigenti del settore. Non saranno semplici interviste tecniche, ma vere e proprie “chiacchiere di spogliatoio” ad alto livello: momenti di confronto per rileggere quanto è stato costruito finora e, soprattutto, per interrogarsi insieme sulle prospettive future e sull’evoluzione del modello sportivo italiano. In un tempo segnato da profondi cambiamenti legislativi e sociali, riteniamo essenziale accorciare le distanze tra chi programma lo sport “dall’alto” e chi lo vive e lo anima ogni giorno sui campi, negli oratori, nei quartieri e nelle periferie. Vogliamo comprendere quale visione abbiano i nostri interlocutori su temi per noi centrali: inclusione, valore educativo dello sport, sostenibilità sociale, economica e ambientale. Perché lo sport, quando fa bene al Paese, resta fedele alle sue radici ma guarda sempre avanti. Ad aprire questo viaggio è un protagonista d’eccezione: Giuseppe Manfredi, Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, l’uomo che ha guidato il ciclo dei recenti grandi successi azzurri. La sua rielezione per il quadriennio 2025–2028, con il 96,8% dei voti, è un segno fortissimo di fiducia, ma anche una responsabilità nuova: continuare a mettere in dialogo l’alto agonismo con lo sport di base su un binario comune, quello della crescita educativa e umana delle giovani generazioni.
Presidente Manfredi, la sua lunga esperienza nella Pubblica Amministrazione le ha permesso di inquadrare lo sport come pilastro del tessuto sociale più che come semplice attività agonistica. Guidare oggi la FIPAV è, per lei, una forma di servizio al Paese? E in che cosa la logica di una Federazione sportiva l’ha costretta a ripensare categorie e metodi tipici della PA?
Ho sempre considerato lo sport parte integrante del tessuto sociale del Paese, non un mondo a sé. Guidare oggi la FIPAV è per me una forma
di servizio pubblico, anche se con strumenti e linguaggi diversi da quelli della Pubblica Amministrazione. La grande differenza è che nello sport le decisioni incidono immediatamente sulle persone, sulle famiglie, sui territori. Questo mi ha portato a ripensare categorie tipiche della PA, come tempi e procedure, mettendo al centro l’ascolto, la concretezza e la capacità di mediazione. Una Federazione deve saper programmare, ma anche capire cosa succede ogni sera nelle palestre.
Il quadriennio appena concluso è stato ricco di crescita e risultati, dentro e fuori dal campo. Guardando al 2028, qual è oggi la sfida più grande che immagina per questo nuovo percorso?
La sfida principale è confermarsi senza fermarsi. I risultati ottenuti ci hanno dato grande credibilità, ma ora dobbiamo trasformare i successi sportivi in un sistema ancora più solido, equilibrato e sostenibile. Guardando al 2028, il mio obiettivo è rafforzare il legame tra vertice e base, garantendo stabilità tecnica sia alle Nazionali che alle società. Vincere è importante, ma lo è ancora di più costruire un movimento che resti forte anche quando non si vince.
Nel suo programma ha richiamato spesso il ruolo educativo della pallavolo. Se dovesse sintetizzare in poche parole la “visione educativa” della FIPAV per i prossimi anni, quali elementi metterebbe al centro?
La pallavolo è prima di tutto un’esperienza educativa. La nostra visione si fonda su alcuni pilastri chiari: rispetto delle regole, inclusione, lavoro di squadra, parità di genere e centralità della persona. Vogliamo che ogni ragazzo e ogni ragazza che entra in palestra trovi un ambiente sano, accogliente e formativo, indipendentemente dal talento sportivo. Lo sport deve aiutare a diventare adulti consapevoli, non solo atleti vincenti.
Allenatori e dirigenti sono i veri educatori del nostro movimento. Per questo stiamo investendo molto sulla loro formazione, non solo tecnica ma anche umana e relazionale

Allenatori e dirigenti di base sono spesso i primi “maestri di vita” per i giovani atleti. In che modo la FIPAV sta investendo – o intende investire – sulla loro formazione non solo tecnica ma anche pedagogica, relazionale e valoriale?
Allenatori e dirigenti sono i veri educatori del nostro movimento. Per questo stiamo investendo molto sulla loro formazione, non solo tecnica ma anche umana e relazionale. I nostri allenatori sono tra i migliori al mondo, tanto che vengono richiesti ovunque, ma questo ci impone di formarne sempre di più. Vogliamo dirigenti preparati, capaci di gestire persone prima che risultati, e allenatori che sappiano leggere i bisogni dei giovani atleti, soprattutto nelle età più delicate.
Lei ha più volte richiamato la necessità di riportare “equilibrio nei costi”, in un contesto in cui la riforma del lavoro sportivo porta maggiori tutele ma anche nuovi oneri per le società. Come immagina una pallavolo più solida, meno dipendente dalle oscillazioni degli sponsor e allo stesso tempo capace di sostenere il lavoro quotidiano dei dirigenti di base?
La riforma del lavoro sportivo ha introdotto tutele sacrosante, ma anche nuovi oneri. Il nostro compito è aiutare le società a trovare un equilibrio sostenibile. Dobbiamo ridurre la dipendenza dagli sponsor occasionali e costruire modelli più stabili, fatti di programmazione, contenimento dei costi e servizi federali di supporto. Una pallavolo solida è una pallavolo che non vive nell’emergenza.
All’inizio del suo primo mandato, un tema su cui si sono accesi i riflettori è stato quello dei diritti contrattuali e della maternità nello sport femminile. A che punto siamo oggi? Quali passi concreti ha compiuto la FIPAV per garantire alle atlete la possibilità di conciliare carriera sportiva e vita privata?
Rispetto all’inizio del mio primo mandato abbiamo fatto passi concreti per tutelare le atlete, soprattutto sul tema della maternità. Oggi c’è una maggiore consapevolezza e strumenti più chiari per conciliare carriera sportiva e vita privata. Non è un percorso concluso, ma la direzione è tracciata: una pallavolo moderna non può prescindere dai diritti.
I successi delle Nazionali, a partire dallo storico oro di Parigi 2024, generano entusiasmo e un boom di iscrizioni. Come intende la FIPAV supportare le piccole società che accolgono questa ondata di nuovi atleti? E pensa ci sia spazio per un’alleanza più strutturata tra Federazione, mondo scolastico e società di base?
I successi delle Nazionali generano entusiasmo e aumentano i numeri, soprattutto nei club più piccoli. È lì che dobbiamo intervenire con maggiore forza, offrendo supporto organizzativo, formativo e, quando possibile, anche strutturale. L’alleanza con la scuola è fondamentale: senza scuola e società sportive non avremmo i risultati che oggi celebriamo. È un rapporto che va reso sempre più strutturato.
Tra la fine del settore giovanile e l’ingresso nei top club c’è una fascia d’età delicata. Qual è oggi la strategia della FIPAV – anche attraverso il progetto Club Italia – per accompagnare questi atleti nel passaggio più complesso della loro crescita sportiva e personale?
Il passaggio tra settore giovanile e alto livello è il momento più critico. Club Italia resta uno strumento importante, soprattutto se inserito in una visione più ampia. In passato ho avuto dei dubbi, ma oggi vedo un lavoro di qualità. L’obiettivo è accompagnare i giovani non solo come atleti, ma come persone, evitando dispersioni e scelte affrettate.
Il CSI rappresenta per migliaia di ragazzi il primo contatto con la pallavolo. Quali passi concreti possono essere fatti per rendere la collaborazione tra FIPAV e CSI sempre più una vera sinergia tecnica e formativa? E che ruolo può avere l’attività proposta dal CSI per contrastare il drop-out che coinvolge tanti ragazzi che lasciano il volley tra i 14 e i 16 anni? Il CSI rappresenta una porta d’ingresso fondamentale per tanti ragazzi. Rafforzare la collaborazione significa condividere visioni educative, formazione tecnica e percorsi comuni. L’attività promozionale e non esasperata è uno strumento prezioso per contrastare il drop-out tra i 14 e i 16 anni. Dobbiamo offrire quante più alternative possibili, in maniera da non perdere ragazzi per strada.
Oltre al sitting volley, disciplina dedicata alla disabilità, vede margini per progetti comuni tra FIPAV e CSI che portino la pallavolo nelle periferie, nei contesti di fragilità sociale e nei percorsi educativi del territorio? Che tipo di alleanze immagina con enti locali e Terzo Settore? Oltre al sitting volley, vedo grandi margini per progetti comuni che portino la pallavolo nelle periferie e nei contesti di fragilità. Lo sport può essere uno straordinario strumento di inclusione. Le alleanze con enti locali e Terzo Settore sono decisive: da soli non si va lontano.
I risultati della pallavolo di vertice sono sicuramente il frutto del lavoro svolto da tante società sportive che operano con dedizione e professionalità nei settori giovanili ma che, anche a causa della riforma, si trovano a sostenere
Dal 2021, sotto la presidenza di Giuseppe Manfredi alla Federazione Italiana Pallavolo, la pallavolo italiana ha vissuto uno dei periodi più vincenti della sua storia recente.
Governance: eletto a marzo 2021 e riconfermato nel febbraio 2025.
Nazionale Femminile: oro olimpico a Parigi 2024, titolo Mondiale 2025, Europeo 2021 e Volleyball Nations League 2022, 2024 e 2025.
Nazionale Maschile: doppietta Mondiale consecutiva (2022 e 2025), titolo Europeo 2021 e oro alle Universiadi 2023.
Settore Giovanile: en plein storico nel 2022 con 8 medaglie d’oro tra Campionati Europei ed EYOF; titoli mondiali vinti dalle categorie U21F e U17M nel 2024-2025.
Sitting Volley: nazionale femminile campione d’Europa per due edizioni consecutive (2023 e 2025).
costi e responsabilità sempre più impegnative. Come, e se, la FIPAV intende sostenere il lavoro di tanti allenatori e dirigenti spesso volontari, che ogni giorno entrano in palestra animati da tanta passione ma vivendo tante difficoltà che potrebbero nel tempo portare alla chiusura di molte società sportive, come già avvenuto dopo la pandemia?
Il nostro movimento vive grazie a migliaia di volontari. Sappiamo che le difficoltà sono tante, soprattutto dopo la pandemia e con le nuove responsabilità normative. La Federazione deve essere al loro fianco con formazione, semplificazione e supporto concreto. Se chiudono le società, si ferma tutto. Questo è un tema centrale del nostro quadriennio.
L’Italia del volley è oggi un punto di riferimento mondiale. Pensa che la pallavolo possa diventare, in prospettiva, uno strumento di diplomazia sportiva?
La pallavolo italiana è un riferimento mondiale. Credo debba diventare anche uno strumento di diplomazia sportiva, soprattutto nei Paesi dove lo sport femminile fatica ad emergere. Condividere competenze, modelli e valori è un modo per far crescere lo sport e, indirettamente, le comunità.
Se potesse rivolgere un messaggio diretto a un giovane allenatore o dirigente che inizia oggi il proprio servizio in una piccola società di pallavolo, cosa gli direbbe?
Direi di non perdere mai di vista il senso del proprio impegno. I risultati arrivano e passano, le persone restano. Fare sport significa assumersi una responsabilità educativa enorme. È faticoso, spesso poco riconosciuto, ma è uno dei servizi più belli che si possano rendere a una comunità.

Con la legge “Palestre Aperte” a firma Berruto, le palestre scolastiche tornano ad essere luoghi di comunità
Le palestre potranno
restare aperte anche in orario extrascolastico, estate compresa, sia per allenamenti sia per partite ufficiali di campionato, tornei e progetti sportivi a carattere sociale


C’è una generazione intera che lo sport lo ha imparato lì: sotto canestri storti, tra righe del campo sbiadite e porte da calcio dipinte sui muri. Non in palazzetti scintillanti, ma nelle palestre delle scuole. Alzi la mano chi ci ha giocato almeno una volta in questi spazi scolastici… «Io! Ci ho giocato poco e male, a dire il vero, ma ricordo bene quella palestra con il muro ad un metro dalla linea di fondo campo, dove non si poteva nemmeno battere in salto». Il primo ad alzare la mano è Mauro Berruto, oggi deputato del Partito Democratico, ieri allenatore di una nazionale di volley rimasta raramente giù dal podio (due argenti europei nel 2011 e nel 2013, un bronzo olimpico a Londra 2012, due bronzi in World League
nel 2013 e 2014 e un bronzo alla Grand Champions Cup del 2013). Il suo è lo sguardo consapevole di chi sa che la pallavolo italiana che ha fatto la storia — quella della cosiddetta “generazione di fenomeni” degli anni ’80 — è nata nelle palestre delle scuole molto prima che nei club professionistici. «Era tutto lì — spiega —, i gruppi sportivi scolastici erano il cuore del movimento. Gli allenatori erano insegnanti di educazione fisica e in quelle palestre si iniziava già a costruire il futuro. È successo così per la grande Kappa CUS Torino, ad esempio». Dalla pallavolo al basket il passo è breve, essendo due sport che, per struttura, si sono sempre adattati perfettamente alle palestre scolastiche.
Ma, se allora la palestra era un punto di partenza, oggi rischia di diventare un freno per la pratica sportiva. Alzi la mano adesso chi si è visto annullare allenamenti, partite, stagioni intere perché una palestra non c’era, era chiusa o semplicemente inaccessibile. Qui il numero diventa tristemente alto, visto che, come sottolinea Berruto: «In Italia in più del 55% delle scuole non esiste una palestra. Del restante 45% non sappiamo con precisione quali siano le condizioni strutturali né se questi spazi vengano realmente aperti alla pratica sportiva comunitaria».
I numeri aiutano a fotografare la situazione. Chi è nato in Liguria ha buone probabilità di aver utilizzato uno spazio pubblico o scolastico per fare sport: la regione registra infatti il 61,61% di palestre scolastiche sul totale dei propri istituti. Anche Puglia (55,87%) e Lombardia (53,52%) salgono sul podio, con la provincia di Barletta-Andria-Trani indiscussa regina tra le province italiane (67% di palestre sul totale delle scuole). Per chi è nato in Calabria, Sicilia o Campania, invece, l’accesso alle strutture sportive scolastiche è stato — e spesso è tuttora — più complesso. Le percentuali scendono rispettivamente al 25,65% in Calabria, al 33% in Sicilia e al 34,49% in Campania. Il divario Nord-Sud, dunque, non è solo una narrazione che torna ogni tanto, ma è anche, in questo caso, testimonianza che racconta uno scarso e difficoltoso accesso alla pratica sportiva nelle regioni meridionali del Paese (*).
È con questi dati davanti agli occhi, con una storia sportiva vissuta nelle palestre e con un amore per lo sport nato sui campetti dell’oratorio San Bernardino di Borgo San Paolo a Torino, che l’ex allenatore dell’Italvolley arriva a una convinzione precisa: il discorso sullo sport non può essere lasciato all’improvvisazione. Così quel percorso diventa oggi
una linea di intervento politico chiara: restituire pienamente alle comunità spazi pubblici come le palestre scolastiche, riportandoli alla loro destinazione d’uso originaria. Nasce qui la proposta di legge n. 505, “Palestre Aperte”, di cui Mauro Berruto è primo firmatario. «Sappiamo che esistono realtà in cui tutto funziona bene — chiarisce il deputato — ma una legge deve avere uno sguardo nazionale: non interpretabile, incisivo in ogni contesto, capace di sanare le ingiustizie». Anche nelle regioni più attrezzate, infatti, possono verificarsi situazioni paradossali: «Due comuni confinanti possono offrire opportunità completamente diverse. In uno il dirigente scolastico concede l’uso degli spazi e l’attività sportiva si pratica; in quello accanto l’accesso viene negato e lo sport si ferma. Eppure, parliamo di luoghi pubblici. Com’è possibile che tutto dipenda da una decisione arbitraria? La legge interviene proprio per risolvere questa evidente ingiustizia, introducendo un protocollo chiaro e uniforme».
Il cuore del provvedimento stabilisce che saranno direttamente i Comuni — per le scuole primarie e secondarie di primo grado — e le Province — per le scuole superiori — a concedere l’utilizzo degli spazi sportivi scolastici alle società, senza più l’assenso dei consigli di circolo o di istituto. Questi ultimi dovranno limitarsi a indicare tempi e spazi riservati alle attività scolastiche, sulla base del piano triennale dell’offerta formativa. Le scuole comunicheranno il proprio piano di utilizzo entro il primo giorno del calendario scolastico; gli enti locali predisporranno a quel punto protocolli diretti con le società sportive per l’assegnazione degli spazi.
Ne consegue che le palestre potranno restare aperte anche in orario extrascolastico, estate compresa, sia per allenamenti
sia per partite ufficiali di campionato, tornei e progetti sportivi a carattere sociale. «L’apertura in orari extrascolastici — osserva Berruto — schiude prospettive interessanti che vanno oltre l’agonismo: penso alle attività per la terza età, alla prevenzione, alla cultura del movimento e, perché no, anche ai centri estivi. Le strutture tornano così a rispondere ai bisogni di un’intera collettività».
Approvata alla Camera all’unanimità l’8 ottobre 2025 con 234 voti favorevoli, questa proposta di legge mette evidentemente al centro l’utilizzo delle palestre e la pratica sportiva, ma va anche oltre. Osservandola bene, manda un messaggio chiarissimo sul valore e sull’intenzione di prendersi cura delle comunità rafforzando i servizi ai cittadini attraverso lo sport, inteso come strumento di costruzione collettiva. Lo si coglie con chiarezza nel terzo punto del testo, forse il più innovativo e rivoluzionario, in un certo senso: la possibilità, per le APS senza fini di lucro che ottengono in concessione una palestra scolastica, di presentare progetti di riqualificazione, ammodernamento e rigenerazione della struttura. In cambio, è prevista la concessione gratuita dello spazio per un periodo proporzionale al valore dell’investimento effettuato, e comunque non inferiore a cinque anni. «Dal punto di vista culturale — sottolinea — questo è l’aspetto più rilevante: si innesca un circolo virtuoso tra pubblico e privato. La società sportiva migliora lo spazio per svolgere al meglio le attività, ma allo stesso tempo restituisce quella struttura alla comunità, agli studenti, alla scuola, alla città».
Il testo, che interviene modificando il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e il n. 38 del 28 febbraio 2001, introduce un cambiamento di grande portata, ma le criticità nel sistema restano. Le società sportive senza scopo
Scuola: la “prima palestra”
di lucro, infatti, non possono da sole rimettere in piedi strutture fatiscenti né tantomeno costruire ex novo dove la palestra non esiste. «Possono sostenere interventi di ammodernamento e riqualificazione leggeri, ma resta aperta la questione di come intervenire nei contesti in cui gli spazi fisici mancano del tutto o sono inagibili — spiega Berruto —. Il problema strutturale degli spazi sportivi nelle scuole va inserito in una questione ancora più vasta: l’edilizia scolastica. Sarei già soddisfatto se vedessi studi di architettura presentare progetti di scuole in cui la palestra viene considerata uno spazio imprescindibile. Invece, accade ancora troppo spesso il contrario». Per migliorare davvero le percentuali di accesso alle strutture sportive scolastiche, è dunque necessario ragionare a 360 gradi su tutti gli spazi che rientrano nel perimetro delle scuole, compresi quelli esterni. In questa direzione va un ordine del giorno — non inserito nel testo di legge ma già accolto con interesse dal Governo — che guarda ai cortili e ai playground degli istituti. Un’idea di ampio respiro che potrebbe offrire una risposta: «Immagino interventi di copertura con architetture leggere, come tensostrutture ad arco in legno; soluzioni che trasformerebbero semplici campetti in spazi polifunzionali a disposizione degli studenti e della collettività grazie alla cooperazione tra pubblico e privato».
Questo traguardo politico non è un punto di arrivo per Mauro Berruto, ma piuttosto una tappa di un percorso più lungo: quello di chi continua a interrogarsi su come restituire allo sport una funzione pubblica, quotidiana, accessibile. L’idea di immaginare soluzioni, progettarle e adattarle alle esigenze reali delle persone non nasce oggi, né esclusivamente dal ruolo istituzionale. È un’attitudine che l’ex allenatore coltiva da sempre, ben prima dell’ingresso in Parlamento. A cinquecento
metri dal suo oratorio, mentre prendeva forma la storia della Kappa CUS Torino — squadra di Serie A capace di vincere quattro scudetti di pallavolo e una Coppa dei Campioni —, Berruto era già lì, osservatore curioso e tifoso appassionato. «Ero ancora minorenne ed ero un grande tifoso di quella squadra — ricorda —. Volevo entrare in contatto con la società e la prima cosa che feci fu proporre un progetto di minivolley per le scuole elementari del quartiere in cui vivevo». Le scuole, lo sport, i più piccoli, ecco come ritornano le cose.
E ritorna anche il tema dell’accesso alla pratica sportiva, quella dei giovanissimi e non solo, perché il costo dello sport è un peso che grava di molto sulle famiglie. «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme», recita il nuovo comma dell’articolo 33 della Costituzione italiana, introdotto il 20 settembre 2023. Se allo sport, dunque, viene istituzionalmente riconosciuto un ruolo così centrale, non dovrebbe essere accessibile a tutti i cittadini su più livelli della scala sociale? «Senza dubbio — risponde Mauro Berruto —. In Italia lo sport lo pratica soprattutto chi se lo può permettere: qualunque attività ha costi elevati e, per chi ha più figli, diventa un impegno economico enorme». È questo l’imbuto che blocca l’accesso diffuso alla pratica sportiva. Per allargarlo, una delle strade è quella della detraibilità fiscale. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate si legge che possono essere detratte le spese per l’iscrizione e l’abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni presso associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture destinate alla pratica dilettantistica, nella misura del 19% e fino a un massimo di 210 euro per ciascun ragazzo. Su questo punto, Berruto
ha avanzato diverse proposte di legge: «Oggi abbiamo la massima detraibilità solo per gli under 18. Un’idea è aumentare la quota detraibile, prevedendo un’agevolazione significativa sia nella primissima fase della vita, fino ai 14 anni, sia nella terza età, ovvero nei due momenti in cui lo sport può davvero fare la differenza, mantenendo comunque forme di detrazione anche nelle altre fasce d’età, con importi modulati».
In conclusione, se ritorniamo al binomio scuola-sport, il punto è capire da dove si decide di cominciare a leggere e valorizzare questo rapporto. Se si vuole davvero costruire una cultura sportiva diffusa, inclusiva, capace di educare prima ancora che di selezionare, il primo luogo non può che essere la scuola. Le palestre scolastiche non sono spazi accessori né contenitori neutri: sono luoghi di apprendimento, di incontro, di scoperta del corpo, delle regole, dell’altro. È lì che lo sport smette di essere privilegio e diventa esperienza collettiva. Non solo. È lì che spesso ci si scopre atleti dotati, si costruiscono nuove passioni, si coltivano i sogni, si iniziano le carriere. Investire in quelle strutture, renderle accessibili, vive, aperte alle comunità, significa scegliere che tipo di società si vuole formare. In questo la legge “Palestre Aperte” indica una strada precisa tutta da percorrere. Perché prima dei palazzetti, dei podi e delle medaglie, lo sport nasce negli spazi delle scuole, sotto canestri con le reti mezze rotte e righe sbiadite di campi da volley o porte da calcio improvvisate tra due pertiche.
E da lì, se glielo si permette, può ancora insegnare molto.
*I dati riportati sono tratti dallo studio sulla presenza di palestre scolastiche in Italia commissionato da Sport e Salute e realizzato da Studio Ghiretti.

A tu per tu con un maestro della parola. Oggi il più famoso storyteller italiano. Ieri playmaker ed arbitro del CSI Milano

di Felice Alborghetti
Negli ottant’anni di sport e passione vissuti dal CSI vi sono numerosi campioni di vari sport che hanno mosso i loro primi passi nell’Associazione. Molti atleti provenienti dall’oratorio sono arrivati a vestire una maglia azzurra, a partecipare e – perché no – a vincere alle Olimpiadi o alle Paralimpiadi. C’è chi, grazie a un talento straordinario, anche se non direttamente su un campetto, su una pista o in palestra, è comunque diventato un grandissimo campione dello sport. Uno tra i più grandi storyteller sportivi in Italia nel nuovo millennio, capace di ispirare intere generazioni, in grado di narrare come nessun altro sogni, sfide e passioni di uomini, donne, persone, squadre che hanno fatto la storia dello sport.
Stiamo parlando di Federico Buffa, classe 1959, oggi voce di punta di Sky Sport, mentre ieri – molti anni fa, a dire il vero – poliedrico playmaker a Milano, numero 7 di una squadretta, l’ARS, del CSI.
E allora, se in TV Federico racconta episodi enciclopedici di miti e aneddoti dei protagonisti di ogni sport, cosa invece racconta il CSI a Federico Buffa?
Beh, la mia adolescenza. Non so se hai presente quella tremenda foto dell’autonomo sovversivo che, nel 1977, spara a un agente della Polizia. Anni di piombo. Io stavo giocando all’Oratorio Sant’Ambrogio, una partita del CSI, mentre quella scena correva in linea d’aria a 70-80 metri da me. Questo significa che l’amore della mia vita, cioè il basket, è coinciso, a livello di sport organizzato – cioè quello con gli arbitri e non la semplice partitella tra amici – con quella palestra piccolissima di Sant’Ambrogio: meravigliosa chiesa, un po’ meno il campo, ma poco importa. A me sembrava il Madison Square Garden. Dai 15 anni fino quasi ai 20 penso di aver giocato tutti i giorni lì. Sono stati degli anni fantastici nella mia vita.
La storia ci racconta poi di un Buffa anche arbitro nel CSI.
Quando passammo a giocare in prima divisione, con la FIP, pensavo che fosse giusto fare l’arbitro. E ho arbitrato per due o tre anni per il CSI, con la nostra divisa grigia a strisce verticali, arancio e blu. Davo la mia disponibilità la domenica mattina, andavo in provincia, a Brusuglio o a Bresso, ad arbitrare le partite delle ragazze, che ricordo si battevano come leonesse.
Sai, non credo oggi ci sia quella stessa passione, secondo me, nel mondo contemporaneo, quella stessa voglia di fare fatica. All’epoca c’era più amore per il gioco, era più spontaneo.
A livello calcistico, quando si giocava nel CSI, non c’era il fuorigioco e già questo rendeva più divertenti le partite. Guardavo le gare di quelli grandi del mio oratorio, che era a San Vito, Milano, zona Giambellino, e li guardavo come fossero campioni. Ti potrei dire la formazione adesso a memoria – è vero che da anziani si tende a ricordare quello che succedeva allora e non quello che è successo ieri –, ma ciò vuol dire che per me quei giorni lì sono stati indimenticabili. È stato importantissimo per me, da ragazzo, fare questo sport e fare l’arbitro. Penso che sia stata una scelta giusta da parte mia. Soprattutto è ciò a cui educa anche adesso il Centro Sportivo Italiano, insegnando a essere attori dello sport, non solo spettatori televisivi. Voglio dire, che è bello vedere Buffa raccontare storie in TV, ma è più bello forse giocare. Facciamo 300 volte più bello, non ci sono dubbi.
Conoscere le regole del gioco. Quanto ti è stato d’insegnamento poi nelle telecronache, nel rispettare i giocatori, gli spettatori, i telespettatori…
Non esiste parlare di sport se non hai giocato. Devi aver sentito che cosa vuol dire essere in campo, anche a un livello modesto, però quella sensazione devi averla vissuta. Il CSI chiedeva di avere una formazione completa; secondo me era un bel modo di insegnare a un ragazzo a stare al mondo dal punto di vista sportivo. Mi piaceva tantissimo l’idea di vedere che cosa volesse dire essere dentro la storia della partita. Mi sembrava formativo. La parola giusta poi è proprio quella, è inutile girarci attorno: ci sono sinonimi, ma la parola chiave è “rispetto”. È il più olimpico dei concetti, secondo me. Ovunque c’è rispetto, c’è creanza; se c’è creanza, ci sono gli uomini al loro meglio.
È stato importantissimo per me, da ragazzo, fare questo sport e fare l’arbitro. È ciò a cui educa anche adesso il CSI, insegnando a essere attori dello sport, non solo spettatori televisivi
Ecco, ad esempio, l’arbitro che figura è? Necessaria. Un mestieraccio, ma pur sempre imprescindibile. Come essenziale è il CSI, un mondo che evolve, inquieto per natura ma che evolve, ed è molto rapido a riconoscere i messaggi che arrivano, rielaborarli e riproporli.
A proposito, ora con questa deriva del digitale, i ragazzi perdono quei rapporti immediati, si parlano nello spogliatoio su WhatsApp, non si fanno più passaggi, ma solo messaggi. Sono del 1959, il mio mondo era un altro, non ho voglia di fare né il romantico né il nostalgico, però secondo me, se si perde la base della comunicazione – ovvero guardarsi negli occhi o sentire la voce – e la si sostituisce con uno schermo lucente, a mio avviso si perde l’80% della relazione. Alla fine noi siamo chi abbiamo incontrato e le relazioni sono ciò che ci ha reso quello che siamo.
Invece sugli spettatori, si fanno chiamare sportivi ma molti, troppi sono sportivi da salotto o peggio da divano?
Secondo me è sbagliatissimo utilizzare l’aggettivo “sportivo” per chi sta a casa e guarda: lo sport si pratica, si insegna, lo sport si vive; a stare seduti sono capaci tutti.
Federico, sarebbe impensabile un’Italia nel calcio ancora senza Mondiali, ma invece ci risiamo. Come mi sento? Siamo anche recidivi. È un danno non configurabile, secondo me. È un danno talmente grande da non essere configurabile. Due Mondiali consecutivi, per tutto il movimento, sono veramente una mezza tragedia in senso sportivo. È impensabile. Incredibile. È una cosa paradossale. Preferisco non pensarci agli spareggi.
Ripensiamo allora a quell’Italia di Bearzot. Chi è stato a tuo avviso il più incredibile degli eroi di Spagna ’82?
Quello più facile da dire è Paolo Rossi, perché ci fa fisicamente vincere il Mondiale. In più veniva da un periodo molto controverso e difficile per lui. Il Brasile, quasi immediatamente dopo quel Mondiale, ebbe una sorta di epidemia di influenza che venne chiamata “la Paolo Rossi”. Lui veniva visto veramente come l’uomo che aveva fatto piangere il Brasile e quindi avrebbe continuato a farlo stare male.
Ma dico Bruno Conti e Marco Tardelli, i più incisivi complessivamente, per motivi diversi. Bruno perché ci regala un passaggio di prima classe con la sua straordinaria immaginazione calcistica, a partire dalla partita con l’Argentina.
E Marco perché i compagni si domandavano come potesse giocare tutte le partite così, alla luce del fatto che vomitava tutto prima delle partite. La sua tensione nervosa era tale che vomitava quello che aveva mangiato. I compagni si domandavano:
“Come fa? Come fa? Vive solo di energia nervosa?”. Ed evidentemente la risposta era sì.
Marco, come tutti questi ragazzi, non ha avuto un inizio semplice. Marco Tardelli, oggi, a 13 anni sarebbe un professionista. Avrebbe il procuratore a 13 anni, e invece loro andavano all’oratorio. Poi le squadre li prendevano, ma i genitori non si facevano le illusioni che si fanno adesso.
Il papà di Marco Tardelli gli ha buttato via la prima maglia delle giovanili del Pisa. Quando Bruno Conti doveva andare negli Stati Uniti perché aveva vinto una borsa di studio per giocare a baseball addirittura, il papà disse: “Ma state scherzando?
Dove devi andare a giocare? A Santa Monica?
Per me Santa Monica è una martire cristiana. Il ragazzino sta qui perché deve fare il muratore e consegnare le bombole del gas”.
È anche questo il motivo per cui la squadra è ricordata con più affetto di quella del 2006, anche se ha giocato molto prima: perché si aveva la sensazione che questi qua avessero fatto la fatica che fanno anche quelli che li guardano. Mentre oggi non hai questa impressione. Ognuno di loro aveva una storia precedente al calcio. Anche Dino Zoff è stato in fabbrica e faceva il meccanico.
Ci hai raccontato tutto o ci sono storie di campioni di cui non hai ancora fatto arte?
Papa Francesco. Sì. Non ho avuto il coraggio di raccontare quell’episodio sulle guardie svizzere. Bergoglio, dal 1990, aveva fatto il voto che non avrebbe più visto la partita della domenica del suo San Lorenzo. Ma quella volta era importante. Si giocava ovviamente con 7 ore di distanza, quindi nella notte italiana, e la mattina le guardie svizzere dovevano dirgli il risultato.
Praticamente la scena era: “No, non glielo diciamo, hanno perso”. “Ma no, perché se non glielo diciamo vuol dire che lui ha già capito che hanno perso”.
E quindi la scena che mi hanno raccontato è questa. Il Papa li guarda e dice loro: “Mal?”.
Risposta: “Mal!”. “Ma quanto mal?”. “Mal”. E lui che allora se ne andava con i suoi pensieri.
E il polacco, invece? Wojtyła è uno che è cresciuto con lo sport; questa idea di rubare la chiave della stanza della televisione del suo seminario per vedere Muhammad Ali ci dice tantissimo.
Tornando a Papa Francesco, invece, al settantesimo del CSI, dieci anni fa, disse: «Mettetevi in gioco nello sport e nella vita, non accontentatevi di un pareggio mediocre». Che parole sono per te?
Amen. Non puoi dire meglio di così. Ovvero, se non pensi allo sport come metafora della tua vita, hai perso quel passaggio che c’è tra quando giochi e quando vivi, che in certi momenti sono la stessa cosa. E che cosa devi fare con i due grandi impostori della nostra vita: la vittoria e la sconfitta.
A proposito di predicatori, c’è oggi un grandissimo narratore di basket, parlo di Flavio Tranquillo, che ti allenava. O giocavate insieme? Ho avuto, sì, Flavio Tranquillo come allenatore, pensa te. Eravamo in un campionato da prima divisione o da CSI e facevamo tre zone-press. Gli altri neanche capivano perché noi dovessimo fare tutta questa fatica, ma poi, quando hanno visto lui in televisione, hanno capito perché. Essendo un appassionato come pochissimi e avendo molto chiaro il concetto del valore educativo dello sport – pur lui commentando i giocatori più prestigiosi e pagati del mondo –, Flavio non prende mai la distanza dal gioco, dall’amore per il gioco, e quindi riconosce anche in un gesto di un giocatore fuori dal pianeta quella capacità tecnica, la purezza del gioco. È uno che ti fa notare che Michael Jordan e Kobe Bryant non hanno mai commesso un’infrazione di passi perché avevano rispetto per il gioco. E allora torniamo a ripetere l’importanza che ha aver giocato e soprattutto aver amato il gioco, e quindi Love of the Game: si gioca sempre e ogni volta che si può per tutta la vita.
In ultimo gli auguri: dai un messaggio da Federico Buffa al CSI, al milione e mezzo di tesserati, ai dirigenti, agli allenatori, a chi appunto frequenta questa Associazione. C’è un passaggio interessantissimo del fondatore Gedda, che è: “Noi dobbiamo andare a portare lo sport e il nostro messaggio, che è consustanziale con lo sport, nei posti persi; nei villaggi alpini non va nessuno, tanto ci sarà una chiesa, tanto ci sarà uno spiazzo”. È così che si fa, secondo me. Certo che stai facendo proselitismo, ma lo fai nel modo più sincero possibile, perché attraverso lo sport si formano le persone. Gente che non sarebbe venuta tornerà. Io mi ricordo quando c’era il mese della Madonna, a maggio, quando il parroco ci dava la palla ma molto tardi, e noi stavamo lì fino alla fine, quindi alle 6 e mezza di pomeriggio. A maggio c’era ancora la luce e lui finalmente concedeva il pallone. Sono ricordi d’infanzia, però ce li ho chiarissimi; anzi, proprio perché d’infanzia, li ho carissimi.
Un racconto teatrale sulla leggenda mondiale del basket Kobe Bryant Federico Buffa ritorna alla sua grande passione con uno spettacolo dedicato a uno dei più leggendari campioni del basket americano di tutti i tempi. Speciale tariffa dedicata in esclusiva ai tesserati del Centro Sportivo italiano. Scopri tutte le piazze
Nato nel CSI, l’Associazione ha riabbracciato Federico Buffa in occasione della festa celebrativa dell’80° dalla sua fondazione. Con gratitudine e senso di appartenenza, Federico, prossimo al suo ritorno in scena, ha voluto offrire a tutti i tesserati del Centro Sportivo Italiano una specialissima ed esclusiva tariffa per assistere al suo prossimo tour teatrale: “Otto infinito – Vita e morte di un Mamba”, un’opera dedicata alla storia di una leggenda del basket come Kobe Bryant.
Per ciascuno spettacolo di Federico Buffa, gli sportivi del CSI potranno acquistare biglietti per ogni teatro del tour, fino a esaurimento disponibilità, utilizzando appositi codici sconto che tesserati, società sportive e Comitati del CSI possono trovare nella sezione “Convenzioni” dell’App MyCSI o sul sito www.mycsi.it.
Prodotto da IMARTS, con Sky Sport, official broadcaster e main sponsor del tour, per la regia di Maria Elisabetta Marelli, “Otto infinito – Vita e morte di un Mamba” è un racconto teatrale che ripercorre la vita e l’eredità della leggenda mondiale del basket Kobe Bryant: la sua ossessione per il successo, la sete di conoscenza e la capacità di ispirare generazioni. Un viaggio narrativo coinvolgente, ricco di aneddoti e spunti di riflessione. Da febbraio ad aprile, il tour 2026 approderà in 31 città sui palchi di prestigiosi teatri italiani, nelle principali basketball cities del Paese, tra cui: Pesaro, Fermo, Pistoia, Bologna, Bitritto, Brindisi, Brescia, Milano, Trento, Cremona, Reggio Calabria, Rimini, Napoli, Roma, Pescara, Rieti, Firenze, Verona, Cagliari, Sassari, Varese, Udine, Torino, Trieste, Mestre, Trapani, Palermo, Barcellona Pozzo di Gotto, Livorno. Con questo spettacolo Federico Buffa torna a teatro con un omaggio a un campione, una riflessione sui valori universali, alla ricerca di un significato che va oltre il successo sportivo. Nel raccontare la vita di Kobe Bryant, Buffa umanizza l’atleta, mettendo in evidenza le difficoltà che è riuscito a superare, creando una connessione profonda tra il personaggio e il pubblico. Lo spettacolo è un’esperienza visiva e sonora coinvolgente grazie alle musiche di Alessandro Nidi (pianoforte), sul palco insieme a Sebastiano Nidi (percussioni) e Filippo Nidi (trombone).
Calendario tour: https://internationalmusic.it/artisti/federico-buffa
Dallo sport come diritto costituzionale al business delle università: come le diverse visioni di governance e scuola plasmano il talento e il futuro

di Alessio Molinari Bucarelli
LIl confronto tra l’assetto sportivo italiano e quello degli Stati Uniti è particolarmente significativo, perché mette a confronto due visioni molto diverse del ruolo dello sport nella vita collettiva
o sport, si sa, non è mai soltanto sport. È uno spazio simbolico in cui una società rende visibili le proprie priorità, chi può accedere alle opportunità, come viene premiato il merito, quale equilibrio viene costruito tra inclusione e competizione. Analizzare un sistema sportivo significa, quindi, analizzare un modello sociale. Da questo punto di vista, il confronto tra l’assetto sportivo italiano e quello degli Stati Uniti è particolarmente significativo, perché mette a confronto due visioni molto diverse del ruolo dello sport nella vita collettiva. Nel nostro Paese, lo sport è storicamente concepito come un diritto sociale, qualcosa che deve essere garantito, promosso e diffuso sul territorio, indipendentemente dalla capacità di produrre campioni o risultati. L’idea di fondo è che la pratica sportiva rappresenti un valore in quanto tale: educativo, sanitario, sociale. Recentemente, nel 2023, questa visione è stata sancita formalmente con l’inserimento dello sport nella Costituzione Italiana (Art. 33), che ne riconosce il valore educativo e di benessere. Negli Stati Uniti, al contrario, lo sport è strutturalmente visto come un’industria competitiva, selettiva e orientata alla performance.
Più che un diritto da assicurare, dunque, un’opportunità da conquistare. Gli impatti di questa diversità sono molti e sfaccettati, con ripercussioni su tutta la filiera sportiva.
In Italia, lo sviluppo dello sport moderno è legato al secondo dopoguerra e alla necessità di
ricostruire un tessuto sociale profondamente danneggiato dalle conseguenze del conflitto. Le società sportive dilettantistiche diventano, in quel contesto, presidi territoriali fondamentali, spesso legati a parrocchie, circoli o associazioni culturali. Il volontariato rappresenta la colonna portante del sistema: allenatori, dirigenti e accompagnatori operano più per vocazione che per ritorno economico. Lo sport viene inteso come luogo di socializzazione e di educazione informale, più che come percorso professionale. In questo contesto, lo Stato assume un ruolo centrale per finanziare e regolare il sistema. Le federazioni — nate fra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento — diventano interlocutori pubblici, chiamati a garantire la diffusione della pratica sportiva. Questo modello consente allo sport di raggiungere anche territori periferici o economicamente fragili, ma costruisce nel tempo una struttura che tende a essere conservativa, a volte refrattaria al cambiamento.
Negli Stati Uniti, invece, lo sport segue una traiettoria radicalmente diversa. Fin dalle origini, il contesto culturale americano — sportivo e non — attribuisce grande valore alla competizione e al successo individuale. Lo sport si sviluppa all’interno del sistema educativo come attività altamente organizzata e gerarchica. Le scuole superiori e, soprattutto, le università non sono semplici luoghi di formazione accademica, ma veri e propri centri sportivi.
Sport tra Italia e USA: confronto fra due modelli sociali e produttivi
Le competizioni scolastiche diventano eventi pubblici, seguiti dalla comunità, in certi casi persino sostenuti da sponsor e media. Il sistema è apertamente selettivo e non c’è interesse nel mascherarlo, con gli atleti che vengono valutati continuamente, inseriti in percorsi che premiano la performance e riducono al minimo l’intermediazione pubblica. Lo sport si sviluppa come spettacolo, intrattenimento e, ovviamente, business. Le grandi leghe americane — NBA, NFL, MLB — sono di fatto dei cartelli privati o “franchigie”, dove non esistono retrocessioni e l’obiettivo è proteggere l’investimento economico dei proprietari, garantendo uno spettacolo vendibile. Anche i modelli di governance, di conseguenza, sono profondamente diversi. In Italia, la presenza dello Stato nel sistema sportivo è impattante, e i finanziamenti pubblici — diretti o indiretti — rappresentano una componente essenziale per la sopravvivenza di molte federazioni e società. Questo garantisce stabilità e continuità, ma introduce anche, appunto, rigidità: i processi decisionali sono lenti, i cambiamenti faticosi. La riforma dello sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ne è un esempio. Negli Stati Uniti, al contrario, lo Stato rimane ai margini, e il sistema sportivo si regge quasi esclusivamente su risorse private quali sponsor, fondi universitari, donazioni, diritti di trasmissione. Le organizzazioni che non riescono a sostenersi economicamente vengono ridimensionate o scompaiono. È un modello meno protettivo, ma estremamente dinamico, che premia l’efficienza e la capacità di attrarre risorse. A questa divergenza nei modelli di governance si somma oggi l’impatto della rivoluzione tecnologica e dei big data, che sta scavando un solco ulteriore tra le due sponde dell’Atlantico. Negli Stati Uniti, l’approccio industriale ha trasformato lo sport in un laboratorio di
innovazione: dall’analisi predittiva delle prestazioni — il celebre metodo Moneyball — all’uso di wearable per il monitoraggio della salute dell’atleta, la tecnologia è parte integrante del business per massimizzare il ritorno sull’investimento. In Italia, sebbene le eccellenze non manchino nei centri di preparazione olimpica, il sistema capillare delle piccole società fatica a digitalizzarsi. La mancanza di infrastrutture tecnologiche condivise e di competenze specifiche nei quadri dirigenziali volontari limita la capacità di raccogliere dati e monitorare la crescita dei giovani atleti su scala nazionale, rendendo l’individuazione del talento un processo ancora troppo spesso affidato all’intuito dei singoli osservatori piuttosto che a una strategia di sistema supportata dall’evidenza scientifica.
Tornando sul tema della scuola, il rapporto di questa con lo sport rappresenta uno dei punti di maggiore distanza tra i due sistemi. In Italia, l’educazione fisica occupa uno spazio marginale nel curriculum scolastico, con ore limitate, strutture a volte inadeguate e un debole collegamento con il sistema sportivo esterno. La scuola, come risultato, non è il luogo in cui si intercetta il talento sportivo, ma rappresenta solo una tappa obbligatoria del percorso formativo. Il sistema americano intreccia, invece, profondamente formazione accademica e sport: le scuole superiori e le università rappresentano, di fatto, il cuore del sistema sportivo nazionale. I campionati scolastici hanno una propria attrattiva, creano identità locali e fanno circolare le risorse. Le borse di studio sportive trasformano la performance atletica in un canale di mobilità sociale. Il risultato di tutto questo è che per molti giovani lo sport non ostacola lo studio, anzi ne è la condizione di possibilità. Se il rapporto tra scuola e sport segna una prima, netta linea di
demarcazione tra i due modelli, è il tema dell’accesso a rendere la distanza ancora più evidente. In Italia lo sport continua a essere formalmente aperto a tutti. L’iscrizione a una società sportiva è — o era, almeno in teoria — possibile per chiunque. Tuttavia, anche nel nostro Paese, questa universalità è sempre più spesso messa in discussione da fattori economici e strutturali. I costi delle quote, delle attrezzature, degli spostamenti e del tempo richiesto rendono la pratica sportiva un’attività tutt’altro che indifferente dal punto di vista sociale ed economico. L’assenza di un forte presidio scolastico amplifica queste disuguaglianze: lo sport diventa possibile solo dove esistono famiglie in grado di sostenerlo.
Negli Stati Uniti, al contrario, l’accesso è dichiaratamente selettivo: il sistema non promette sport per tutti e la selezione è esplicita e spesso precoce. Tuttavia, il modello americano presenta una coerenza interna che manca a quello italiano: quando il talento emerge, viene immediatamente riconosciuto e sostenuto. Le borse di studio, i programmi di sviluppo e gli investimenti mirati trasformano la performance atletica in una leva concreta di crescita personale e sociale. Va anche considerato, però, che oggi lo sport giovanile americano — il cosiddetto Pay-toPlay — è diventato costosissimo. Spesso, per arrivare al college con una borsa di studio, le famiglie devono spendere migliaia di dollari in club privati sin dall’infanzia, creando una barriera d’accesso censitaria molto forte. In questo panorama, sta mutando anche la natura stessa del luogo fisico e sociale in cui si pratica sport. In Italia, la storica funzione della società sportiva come “piazza” e presidio di coesione sociale sta subendo la pressione di un mercato sempre più esigente. Se il volontariato resta la linfa vitale, la crescente complessità burocratica e i costi di gestione degli impianti

spingono molte realtà verso una professionalizzazione forzata che rischia di snaturare la vocazione inclusiva del modello italiano. Di contro, il modello americano ha visto l’esplosione delle Academy private d’élite, strutture extratemporali rispetto alla scuola che operano con logiche puramente commerciali. Questi centri offrono una formazione tecnica di altissimo livello, ma contribuiscono a una segregazione sportiva: il talento viene coltivato in bolle di eccellenza accessibili solo a chi può permetterselo, trasformando lo sport giovanile in un investimento finanziario familiare ad alto rischio, dove il valore della comunità viene spesso sacrificato in favore della specializzazione precoce. Profondamente diversi sono anche i percorsi che conducono dallo sport giovanile all’élite. In Italia, il passaggio dai settori giovanili allo sport di alto livello è uno dei punti più critici dell’intero sistema, perché i percorsi sono frammentati e spesso dipendenti più dalle singole realtà locali che da una visione nazionale. Molti giovani atleti si trovano a dover
scegliere prematuramente tra sport e studio, e la dispersione del talento, in determinati contesti, diventa un fenomeno strutturale legato non a limiti tecnici, ma a carenze organizzative e di accompagnamento. L’Italia compensa almeno parzialmente la mancanza del modello universitario americano con i Gruppi Sportivi Militari. Senza lo Stato che sostiene gli atleti degli sport meno commerciali — quali il nuoto, la scherma o l’atletica —, il sistema italiano d’élite crollerebbe.
Certamente più lineare è il percorso americano: high school, college, professionismo. Ogni fase del cammino è regolata e supportata, e gli atleti vengono seguiti non solo dal punto di vista tecnico, ma anche accademico e mediatico. Imparano presto a convivere con la pressione e con l’idea che la loro prestazione abbia un valore economico e simbolico. Questo produce una continuità che consente al sistema di alimentare costantemente l’élite, ma comporta anche un elevato carico psicologico. I risultati sportivi internazionali riflettono
in modo abbastanza fedele queste differenze strutturali. Gli Stati Uniti dominano numerose discipline olimpiche e mondiali non solo grazie a un bacino demografico ampio, ma per la capacità del sistema di selezionare, sviluppare e rinnovare costantemente il talento. Il processo non si interrompe mai. L’Italia, al contrario, ottiene spesso risultati di alto livello, ma in maniera meno sistematica e legata a cicli, singole generazioni o contesti federali particolarmente virtuosi. La differenza sta nella capacità di un sistema di accompagnare, nel tempo, lo sviluppo del talento. Un’ulteriore, profonda discrepanza tra i due modelli emerge quando si osserva la gestione della cosiddetta Dual Career, ovvero la capacità del sistema di preparare l’atleta a una vita oltre l’agonismo. Negli Stati Uniti, il legame strutturale tra sport e università risolve il problema alla radice: il sistema NCAA impone standard accademici minimi per poter competere. Se non studi, non giochi. Questo garantisce che la stragrande maggioranza
Sport tra Italia e USA: confronto fra due modelli sociali e produttivi
degli atleti, anche quelli che non raggiungeranno mai il professionismo milionario, concluda il percorso sportivo con una laurea in mano e un network di relazioni spendibile nel mercato del lavoro. In America, l’ex atleta è una figura ricercata dalle aziende per la sua disciplina e capacità di leadership, e lo sport è visto come un master accelerato di competenze trasversali. In Italia, invece, la doppia carriera rimane un percorso a ostacoli affidato alla buona volontà del singolo. Non esistendo un sistema di borse di studio universitario diffuso o di tutoraggio scolastico dedicato, l’atleta italiano vive spesso in un limbo: se si dedica totalmente allo sport, rischia di ritrovarsi a trent’anni senza titoli di studio o competenze professionali; se cerca di studiare, deve farlo lottando contro un sistema burocratico che non riconosce le ore di allenamento come valore formativo. Solo recentemente alcune università hanno iniziato a introdurre programmi per atleti di alto livello, ma siamo ancora lontani da una sinergia sistemica. Il paradosso italiano è che i Gruppi Sportivi Militari, se da un lato garantiscono uno stipendio durante l’attività, dall’altro spesso vincolano l’atleta a un futuro nell’arma, una sicurezza preziosa che però non sempre corrisponde alle aspirazioni o alle attitudini personali del dopo-gara. La dispersione del capitale umano, in questo senso, è il costo occulto che il sistema italiano paga per la sua frammentazione, lasciando spesso l’atleta solo nel momento più difficile: quello in cui le luci dei riflettori si spengono e bisogna reinventarsi cittadini produttivi in un mondo che non riconosce il valore dei sacrifici fatti in campo.
Un’ulteriore differenza risiede nella gestione del patrimonio infrastrutturale. In Italia, lo sport soffre di un cronico invecchiamento degli impianti, spesso di proprietà pubblica e
gravati da iter burocratici che rendono ogni ammodernamento un’impresa decennale. Lo stadio o il palazzetto in molti casi sono percepiti come costi per la collettività, e la mancanza di strutture agili e polifunzionali limita la capacità delle società di generare ricavi propri.
Negli Stati Uniti, al contrario, l’impianto sportivo è il fulcro di un ecosistema economico con gli stadi e le arene universitarie visti come macchine da profitto e progettati per l’esperienza del tifoso, integrati nel tessuto urbano e capaci di trasformarsi in centri di intrattenimento continuo. Se il modello americano eccelle nella creazione di valore immobiliare attorno all’evento sportivo, l’Italia sta faticosamente cercando una via mediana attraverso il partenariato pubblico-privato, tentando di trasformare i vecchi campi di periferia in hub sociali tecnologici. Questa sfida, oltre che architettonica, è anche culturale, perché significa passare dalla manutenzione dell’esistente alla progettazione di spazi che siano, allo stesso tempo, palestre di cittadinanza e motori di sostenibilità economica. Per concludere, esiste anche una differenza narrativa: il successo sportivo viene percepito e raccontato in maniera differente fra i due Paesi. In Italia, lo sport è fortemente legato alla dimensione emotiva e identitaria, la vittoria è celebrata come evento straordinario, il fallimento come una delusione collettiva. Per riprendere una celebre citazione di Winston Churchill, «gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio». Negli Stati Uniti il successo sportivo è apertamente legittimato come carriera: vincere è un obiettivo dichiarato. In ogni caso, entrambi i modelli hanno i propri limiti. Nel caso del sistema italiano il principale problema è quello della rigidità, della dipendenza strutturale dal pubblico e di una scarsa
integrazione tra sport, scuola e lavoro. In quello americano, gli atleti sono esposti a selezioni precoci, pressioni psicologiche estreme e un rischio elevato di esclusione per chi non regge il livello richiesto.
Si può anche dire che oggi i confini si stanno sfumando. Il calcio europeo — e italiano — si sta avvicinando al modello americano, con la ricerca sempre più aggressiva di ricavi e stadi di proprietà, mentre negli USA cresce la consapevolezza dello sport come strumento di giustizia sociale e attivismo politico. La vera sfida è quella di superare la dicotomia tra sport come diritto e sport come industria. Costruire modelli capaci di garantire accesso senza rinunciare alla competitività. In fondo, il modo in cui organizziamo lo sport continua a porre sempre la stessa domanda: che tipo di società vogliamo essere e quale spazio vogliamo riservare al talento, al sacrificio e alla possibilità di fallire?
In America, l’ex atleta è una figura ricercata dalle aziende per la sua disciplina e capacità di leadership, e lo sport è visto come un master accelerato di competenze trasversali


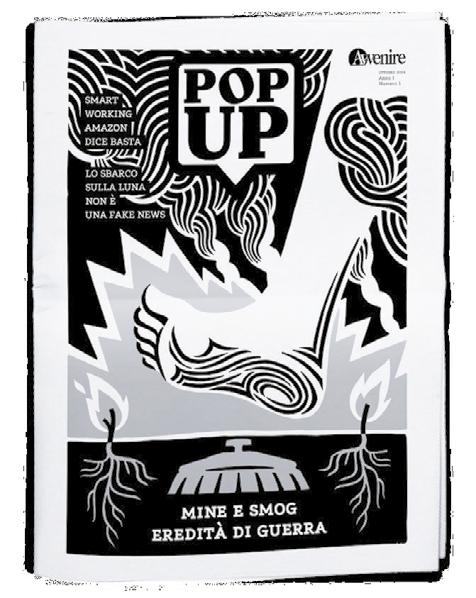

e
Il percorso sportivo, in campo e dietro le quinte, come esperienza formativa riconosciuta

CÈ la consacrazione del volontariato come bene pubblico. Non solo gesto altruista, ma scuola di cittadinanza che genera competenze utili alla società e al mondo del lavoro
i sono leggi che nascono per restare confinate nelle scrivanie dei ministeri e altre che, quasi senza fare rumore, finiscono per incidere davvero nella vita quotidiana delle persone. Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre, appartiene senza dubbio a questa seconda categoria. Non promette rivoluzioni epocali, non occupa titoli a tutta pagina, ma introduce un cambiamento silenzioso e profondo nel modo in cui guardiamo al volontariato e, più in generale, all’apprendimento. A una prima lettura può sembrare un testo per addetti ai lavori, uno di quei provvedimenti che scoraggiano già dall’incipit. E invece, se si ha la pazienza di andare oltre il linguaggio tecnico, si scopre che il decreto apre una prospettiva nuova e tutt’altro che marginale: riconoscere valore formativo e professionale alle esperienze di volontariato, in particolare a quelle dei giovani. Un passaggio che riguarda da vicino il mondo dello sport di base e gli enti di promozione sportiva, che da sempre – ben prima che diventasse una parola di moda – sono luoghi di educazione, responsabilità, partecipazione e crescita delle persone.
Dal “fare” al “saper fare” Il decreto, firmato insieme ai Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e al Dipartimento
della Pubblica Amministrazione, stabilisce come le competenze acquisite attraverso il volontariato possano essere riconosciute nei percorsi scolastici, universitari e lavorativi, collegandosi al Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze. Tradotto in termini comprensibili: ciò che si impara sul campo, fuori dalle aule e lontano dai manuali, può finalmente diventare qualcosa che conta anche nel curriculum e nella vita professionale. È un cambio di paradigma che sposta l’attenzione dal semplice “fare” al “saper fare”, e soprattutto al “saper essere”. Allenare i più piccoli, organizzare un torneo, gestire un impianto sportivo, coordinare una segreteria, tenere insieme una squadra di volontari non è più solo “dare una mano”. È apprendere competenze reali, strutturate, trasferibili. Non si tratta semplicemente di “fare del bene”: il volontariato diventa un percorso di crescita personale e di costruzione di professionalità. Una piccola rivoluzione culturale, che arriva senza proclami ma con effetti destinati a durare nel tempo. Questo decreto non nasce dal nulla. È l’ultimo tassello di un percorso che parte da lontano: il Codice del Terzo Settore, la legge sull’apprendimento permanente, fino al DM 9 luglio 2024 che ha messo ordine nei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Il filo rosso che li attraversa è chiaro: si impara lungo tutto
l’arco della vita, in contesti diversi, e ciò che si impara merita riconoscimento. È una visione moderna, ma paradossalmente anche molto antica, che restituisce dignità all’esperienza concreta come fonte di sapere. Nel mondo dello sport questa affermazione suona così ovvia da apparire quasi banale. Da sempre qui si sviluppano competenze che difficilmente entrano in un voto o in un attestato: lavorare in squadra, gestire conflitti, comunicare con persone diverse per età, cultura e sensibilità, pianificare attività, affrontare imprevisti, assumersi responsabilità. Sono abilità che difficilmente finiscono in un curriculum, ma che raccontano una persona molto meglio di qualsiasi elenco di titoli. Eppure, fino a oggi, sono rimaste in gran parte invisibili agli occhi delle istituzioni.
Il ruolo degli enti del Terzo Settore
Un punto centrale del decreto riguarda il ruolo degli enti del Terzo Settore, individuati come soggetti titolati a gestire i percorsi di identificazione e validazione delle competenze dei volontari. Non si tratta di un ruolo simbolico,

né di un incarico calato dall’alto. È una responsabilità affidata a chi ha dimostrato nel tempo di avere struttura, metodo e capacità organizzativa. In concreto, saranno questi enti ad aiutare le persone a far emergere ciò che sanno fare davvero, dando parole, strumenti e riconoscimento a esperienze che spesso restano implicite.
Come funziona in concreto Il modello operativo previsto è chiaro e, sorprendentemente, realistico. Ogni percorso deve prevedere almeno 60 ore di attività nell’arco di dodici mesi, accompagnate da un tutor e formalizzate in un progetto personalizzato che definisce obiettivi e risultati attesi. Durante il percorso si raccolgono evidenze concrete: azioni svolte, problemi affrontati, soluzioni trovate, responsabilità assunte. Non più il generico “ho fatto volontariato”, ma un più preciso e onesto “ho imparato a gestire, a organizzare, a comunicare”. Cambia il linguaggio, ma soprattutto cambia lo sguardo sul valore dell’esperienza.
Un riconoscimento pubblico
La vera svolta, però, arriva con il riconoscimento pubblico. Le competenze acquisite potranno essere considerate da scuole, università e pubbliche amministrazioni, e persino valutate nei concorsi pubblici. È la consacrazione del volontariato come bene pubblico: non solo gesto altruista, ma vera scuola di cittadinanza che produce competenze utili alla società e al mondo del lavoro. Un messaggio forte, che mette finalmente sullo stesso piano chi apprende sui banchi e chi impara sul campo, tra persone vere, relazioni, responsabilità concrete e problemi da risolvere.
E per lo sport cosa cambia
Per il mondo dello sport di base, e quello del CSI in particolare, si tratta di un’occasione storica. Centinaia di migliaia di volontari, ogni giorno, insegnano, educano,
organizzano, accompagnano: allenatori, dirigenti, arbitri, addetti agli impianti; dietro ogni ruolo si nasconde un patrimonio di competenze spesso invisibile. Ora tutto questo può diventare formazione riconosciuta. Bastano un progetto chiaro, un tutor preparato e una documentazione coerente per dare a un percorso sportivo la dignità di una vera esperienza formativa, senza snaturarne lo spirito.
Qualità, rete e responsabilità
Certo, serviranno qualità, rete e responsabilità. Diventare o essere “ente titolato” comporta requisiti e richiede organizzazione. Non tutti sono pronti, e non tutto sarà immediato, ma si può crescere attraverso alleanze, reti territoriali e formazione interna. La sfida sarà mantenere la promessa di semplicità contenuta nel decreto, evitando che gli standard si trasformino in burocrazia sterile. E sarà fondamentale garantire equità territoriale: queste opportunità devono essere accessibili ovunque, non solo nei grandi centri. Qui la rete sportiva, con la sua capillarità, può fare la differenza.
Lo sport come scuola di vita
In fondo, chi vive lo sport lo sa da sempre. Allenare, arbitrare, dirigere non significa solo organizzare partite, ma imparare disciplina, rispetto, puntualità, gestione delle difficoltà. È una scuola di vita, anche quando la stampante si blocca due ore prima dell’evento o il campo è impraticabile all’ultimo momento. Il decreto del 31 luglio 2025 non inventa nulla di nuovo: riconosce ufficialmente ciò che lo sport pratica da decenni.
Non chiede di cambiare identità, ma di rendere visibile ciò che già siamo. E forse è proprio questa la notizia migliore. Perché, questa volta, vincere non significa alzare una coppa. Significa dare valore al percorso, riconoscere l’impegno, costruire futuro. Allenare alla vita, finalmente, diventa anche una competenza riconosciuta.
A Morbegno, in provincia di Sondrio, nel quarto weekend dello scorso ottobre si è svolto il Trofeo Vanoni, gara internazionale di corsa in montagna a staffetta, che ha richiamato 1.100 atleti da tutta Europa (e anche dal Messico), un pubblico di 5.000 persone e 100 volontari del GS CSI Morbegno coinvolti nell’organizzazione. Questa manifestazione, giunta ormai alla 68a edizione, presenta tre caratteristiche principali: corrono tutte le categorie e atleti di ogni livello, dai giovani under 18 ai campioni blasonati della corsa in montagna, fino agli appassionati e ai runner locali; il tifo assiepato lungo tutto il percorso è un valore aggiunto apprezzatissimo dagli atleti, che vengono incitati dal primo all’ultimo metro; infine gli eventi collaterali, in particolare la sfilata degli atleti e la Messa alla vigilia della gara, sono un concreto esempio di fratellanza, condivisione e amicizia. Vedere atleti di così tante nazionalità
partecipare insieme alla funzione religiosa, officiata da don Nicola Schivalocchi, assistente ecclesiastico del Comitato CSI di Sondrio e atleta del GS CSI Morbegno, fa davvero percepire che tutti siamo fratelli e sorelle e che ognuno di noi, nel proprio piccolo, può essere seme di pace: stringendoci la mano, incitandoci a vicenda, promettendoci di ritrovarci quest’anno al Trofeo Vanoni.

Nelle Marche è ripartita alla grande la lunga stagione del tennistavolo. Dopo la tappa di apertura svoltasi a Pesaro lo scorso 16 novembre, presso la Palestra Don Gaudiano, e quella di Senigallia il 21 dicembre 2025, si proseguirà con altri quattro tornei regionali, per un totale di sei appuntamenti valevoli per la qualificazione al Campionato Nazionale CSI 2026. Quest’anno l’appuntamento pongistico è fissato per il 1° febbraio, per poi proseguire il 22 febbraio e ancora l’8 marzo. Gran finale in programma il 19 aprile. Per quanto riguarda le sedi di gioco, sono previste le conferme di quelle storiche, ma non si esclude anche qualche new entry grazie all’espansione del movimento in regione. Programma quindi work in progress, che però mantiene i capisaldi dello sport targato CSI: coinvolgimento di tutte le fasce di età, da Giovanissimi, Ragazzi, Allievi e Juniores fino a Seniores, Adulti, Veterani ed Eccellenza, senza dimenticare gli atleti con disabilità. Per il CSI Marche si tratta della conferma del buon lavoro svolto negli ultimi anni, per tornare a crescere in una disciplina che, associativamente, ha sempre contraddistinto la regione in giro per l’Italia.

BARI A Triggiano il CT dell’Italvolley maschile e il presidente FIPAV al battesimo del nuovo centro sportivo polifunzionale

Triggiano si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per lo sport e il territorio. Il 13 novembre 2025 è stato inaugurato, nel quartiere San Lorenzo di Bari, il nuovo centro sportivo polifunzionale, una struttura moderna di circa 8.000 mq progettata per ospitare numerose discipline: dalla pallavolo alla pallamano, dal pattinaggio al futsal, fino alla pallacanestro. Un investimento importante per la crescita sociale, educativa e sportiva della comunità, che permetterà a società, famiglie e giovani atleti di vivere lo sport come luogo di incontro, formazione e benessere. A tagliare il nastro sono stati il sindaco di Triggiano, Pino Toscano, e Fefè De Giorgi, CT della nazionale italiana maschile di pallavolo. Alla cerimonia hanno partecipato anche il direttore di ASSET Puglia Elio Sannicandro, il presidente nazionale FIPAV Giuseppe Manfredi, la presidente del CSI Bari Serafina Grandolfo e il presidente regionale del CSI Puglia Roberto Brandi. Nel corso dell’inaugurazione, le istituzioni e gli ospiti hanno sottolineato l’importanza di avere un luogo capace di accogliere discipline diverse e promuovere uno sport accessibile, educativo e davvero aperto a tutti. Il nuovo centro diventa così un simbolo di cooperazione tra enti locali, federazioni, associazioni e realtà sportive del territorio.

Una strada già percorsa, che ha incontrato grande entusiasmo da parte delle società sportive coinvolte nel progetto. Il Ponte del Sorriso ONLUS supporta le pediatrie della provincia di Varese in tanti modi diversi: dalla raccolta
fondi per strumenti diagnostici all’ospitalità per pazienti provenienti da altre regioni. Fra le tante attività proposte in reparto, anche quella di disegno e attività didattiche, per portare sorrisi e normalità ai bambini ricoverati. Per riuscire a offrire questo servizio, ai volontari dell’associazione servono molti materiali, che incidono sul bilancio in maniera significativa. «Lo scorso anno abbiamo raccolto tantissime donazioni, che hanno sostenuto questo progetto, ma possiamo fare ancora tanto e sono convinto che le nostre società non ci deluderanno» ha commentato il presidente del CSI Varese, Diego Peri. La raccolta dei materiali andrà avanti fino al 30 gennaio 2026, mentre la consegna in reparto avverrà il 7 febbraio prossimo.
Aperto l’anno sportivo del

La Parrocchia di San Basilio, a Palermo, ha ospitato domenica 23 novembre 2025 l’incontro di inaugurazione del nuovo anno sportivo e formativo del CSI Palermo con la Santa Messa concelebrata da padre Francesco Di Pasquale, assistente ecclesiastico del CSI Palermo, e padre Alessandro Imburgia, parroco di San Basilio. Presenti molte parrocchie del capoluogo siciliano e associazioni, a cui sono state consegnate le fasce da capitano, un pallone e altri gadget. Presenti diversi consiglieri, arbitri e giudici, allenatori,
animatori, presidenti e dirigenti, oltre a tante famiglie. «Abbiamo voluto affidare nelle mani del Signore tutto il CSI palermitano, affinché tutte le attività del prossimo anno siano occasione di crescita nella fede, nella speranza e nella carità, vera testimonianza dei valori del Vangelo nel mondo dello sport». A esprimere tutta l’immensa gratitudine alla comunità ciessina, al termine della stagione dell’Anno Santo e del Giubileo della Speranza, è stato il numero uno del Comitato arancioblù, il presidente provinciale del CSI, Maurizio Polizzi.
Il progetto “Per una società senza disuguaglianze”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e coordinato dal Movimento Shalom ONLUS in collaborazione con organizzazioni ed enti attivi sul territorio nazionale, fra i quali il CSI, ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare le nuove generazioni sulle cause strutturali delle disuguaglianze e di potenziare le loro competenze sociali per promuovere azioni concrete contro la dispersione scolastica e altre forme di esclusione sociale. Una parte significativa del progetto è stata declinata in ambito sportivo con iniziative gratuite rivolte ai gruppi giovanili, coinvolgendo dirigenti, educatori e animatori. Lo scopo è stato quello di accrescere il protagonismo dei ragazzi fin dalla scuola primaria. Nello specifico del CSI Liguria, gli allenatori di 13 gruppi sportivi (basket, pallavolo e pattinaggio) hanno ricevuto una formazione sui temi delle disuguaglianze sociali, economiche, culturali e di genere, potendo sperimentare alcune attività che hanno poi riproposto ai ragazzi per una riflessione su questi argomenti. Sabato 8 novembre 2025, presso l’Istituto Don Bosco di Sampierdarena, c’è stata la festa conclusiva, durante la quale è stato presentato quanto fatto a Genova nei mesi scorsi. Erano presenti i gruppi sportivi, le loro famiglie e una rappresentanza delle Scuole della Pace della Comunità di S. Egidio. Nel corso della mattinata è stato raccontato nel dettaglio il progetto e le attività svolte, anche con l’ausilio di foto e cartelloni, ed i ragazzi hanno potuto sperimentare i tre diversi sport, pallavolo, basket e pattinaggio, ricoprendo anche il ruolo di allenatori.

Il Mar Mediterraneo che divide e unisce popoli, il luogo dove le differenze possono diventare possibilità, bacino e culla dell’incontro e del confronto. Da questa visione è nato “This Is Me – Pace e dialogo tra i popoli del Mediterraneo”, iniziativa ambiziosa che intende coniugare diplomazia, saperi accademici e arti performative come strumenti di cooperazione e crescita condivisa tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, trasformando Bari in un ponte simbolico tra le diverse sponde del Mare Nostrum. L’evento è stato promosso dalla ASD Never Give Up, con il patrocinio del Comune di Bari e la collaborazione del CSI Puglia e della Sezione ricerca e affari internazionali della Regione Puglia. Il primo appuntamento è stato al Teatro AncheCinema di Bari, con un convegno internazionale aperto agli studenti e al pubblico. Tra i relatori, consoli, ambasciatori, docenti universitari, giornalisti sportivi e rappresentanti di enti culturali mediterranei per un confronto sui temi della diplomazia culturale, delle migrazioni, dell’educazione e della cooperazione transnazionale. Sabato 29 novembre 2025 è poi stato interamente dedicato alla danza come linguaggio universale, con un workshop internazionale presso il Ballet Center e l’Accademia dello spettacolo Unika. Il progetto è culminato infine domenica 30 novembre con la grande festa del canto, della danza e del folklore mediterraneo al Teatro AncheCinema. Sul palco si sono alternate rappresentative artistiche da Albania, Spagna e Italia, insieme ai finalisti dei concorsi Baridanza e Baricanta 2025.


Ottant’anni di attività sportiva – e non solo – praticata sul territorio. Ottant’anni di storie, di volti e passioni che si intrecciano con la crescita della comunità. Ottant’anni in cui il Comitato CSI di Cuneo ha scelto di mettere al centro la persona, lo sport educativo, l’inclusione e l’impegno sociale. L’importante traguardo raggiunto dal Comitato piemontese è stato celebrato venerdì 14 novembre 2025 a Cuneo presso il salone parrocchiale del San Paolo, dove si è svolto l’incontro dal titolo “Lo sport: opportunità per crescere insieme”. L’appuntamento, inserito all’interno del programma di “Camminare insieme”, il percorso di analisi e di testimonianza promosso in collaborazione con il settore Cultura della Diocesi di Cuneo-Fossano, ha visto l’importante partecipazione del presidente nazionale del CSI, Vittorio Bosio. «È stata una bellissima serata di sport dove abbiamo ricordato la nostra storia, i nostri valori fondanti e gli 80 anni vissuti dal Comitato provinciale sul territorio di Cuneo – le parole del presidente del CSI Cuneo, Mauro Tomatis –. La nostra storia e il nostro percorso dicono che siamo una realtà importante che in questi anni ha dato tanto ai giovani della provincia. E contiamo di continuare a farlo. Un ringraziamento speciale va al nostro presidente nazionale, giunto a Cuneo per il nostro compleanno, per aver festeggiato questo importante traguardo con tutto il consiglio direttivo». I festeggiamenti per gli 80 anni del Comitato territoriale erano iniziati già domenica 9 novembre in occasione della Stracôni 2025, dove il CSI era presente all’interno del Villaggio di Piazza Galimberti con uno stand celebrativo dei propri 80 anni di fondazione e in altri due stand simili, in largo Audifreddi e in viale Angeli nei punti di passaggio della manifestazione.
Anche l’undicesima edizione della Calvario Alpin Run – Memorial Tullio Poiana è andata in archivio. Domenica 16 novembre 2025 si è svolta la sfida conclusiva del calendario di gare di corsa in montagna del circuito FVG Trail Running Tour, sotto l’egida del CSI Gorizia. Gli iscritti, nonostante il meteo sfavorevole, sono stati oltre 211, decisi ad affrontare il tracciato di 17,2 km nel bosco fangoso con un dislivello positivo di oltre 600 metri, reso ancora più impegnativo dalla pioggia che ha trasformato diversi passaggi in tratti molto tecnici. Ricco di salite il percorso, con alcuni strappi impegnativi e discese, un po’ d’acqua e pietrisco che lo hanno reso assai scivoloso. Il paesaggio è quello delle colline affacciate su Gorizia e Nova Gorica, con un panorama che si estende a 360 gradi e permette di spaziare dal Collio al Carso, passando per il Sabotino fino alle Alpi Giulie, per concludersi con una vista sulla pianura isontina. La vittoria nel maschile è andata a Denis Neukomm del Gruppo Sportivo Stella Alpina ASD di Forni di Sopra. In campo femminile si è imposta Marta Pugnetti della Carniatletica. La classifica riservata agli Alpini in servizio ha visto ancora una volta il successo di Marco Mosolo del Comando Brigata Alpina Julia, appartenente al Team Aldo Moro Nortec di Paluzza. Tra le Sezioni ANA ha prevalso la Sezione ANA Carnica, che ha preceduto Udine e Palmanova. Il Premio Memorial Tullio Poiana è stato assegnato al primo assoluto iscritto all’ANA, Giuseppe Puntel della Sezione ANA Carnica.

BERGAMO
“Due Piedi Sinistri” è l’iniziativa dedicata allo sport inclusivo che la Diocesi di Bergamo ha organizzato il 7 dicembre 2025, a margine della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre, attraverso l’Ufficio per la Pastorale delle Persone con Disabilità e in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano di Bergamo. L’obiettivo semplice e ambizioso è stato trasformare l’attività sportiva in un terreno d’incontro dove ogni persona, con i propri punti di forza, le proprie fragilità e la propria storia, potesse sentirsi parte del gioco. Per un’intera giornata, quattro luoghi della città (l’Oratorio di Sant’Anna, l’Oratorio di Monterosso, il CSI Bergamo e l’Urban Ski Lab in zona Polaresco) si sono trasformati in spazi aperti, animati da sedici società e da un ventaglio di discipline che raccontano quanto il territorio bergamasco sia vivo nel campo dello sport inclusivo. Dimostrazioni e laboratori hanno fatto conoscere discipline tradizionali e paralimpiche, dal baskin allo sci adattato, dall’atletica all’handbike, passando per proposte rivolte a persone con disabilità cognitive, sensoriali o con disturbi dello spettro autistico. La giornata del 7 dicembre ha segnato l’avvio di un cammino più ampio: nel 2026 sono previsti percorsi formativi destinati a oratori e società sportive, e la realizzazione di un catalogo delle opportunità inclusive presenti nella provincia. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione della Comunità Bergamasca, che ne condivide la visione di uno sport capace di abbattere barriere e generare legami.

Si è svolta il 29 novembre dello scorso anno al Forum Sport Center la cerimonia di premiazione dei Campionati Regionali di ciclismo del CSI Lazio per la stagione 2025. Atleti, dirigenti e società provenienti da tutto il territorio hanno celebrato i titoli regionali conquistati nelle seguenti specialità: Ciclocross, MTB XCO, MTB XCC, Esacrono, MTB XC24H, MTB XC24H Team, Ciclo Tour CSI del Centro Italia. Nel corso dell’evento sono stati premiati anche i vincitori del nuovo “Ranking 2025”, la classifica sperimentale che valorizza la costanza di partecipazione alle gare CSI. Alla cerimonia hanno preso parte il coordinatore nazionale dell’Area Sviluppo, Promozione sportiva e Formazione tecnica del CSI, Giuseppe Basso, il presidente CSI Umbria Alessandro Rossi, il presidente CSI Roma Daniele Pasquini e Biagio Saccoccio, responsabile della Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo. A inaugurare la cerimonia è stato il presidente regionale del CSI Lazio, Salvatore Bertolami, che ha evidenziato la crescita del movimento ciclistico e il valore della presenza costante degli atleti. L’evento, presentato da Daniele Rosini, si è concluso con uno sguardo alle attività e al calendario sportivo del 2026.

RAVENNA
“Correndo senza frontiere”: la carica dei 100!

A vincere la Maratona di Ravenna Città d’Arte 2025 non sono stati solo gli atleti e le atlete africani che hanno regalato un’edizione dagli altissimi contenuti tecnici. Sono state anche le cento persone con disabilità che hanno partecipato alla 7a edizione di “Correndo senza frontiere”, iniziativa promossa dal CSI di Ravenna in collaborazione con la cooperativa sociale La Pieve. Partiti dalla stessa linea dei runner professionisti e arrivati sotto lo stesso arco del traguardo, i cento atleti con disabilità intellettivo-relazionale o con disturbi dello spettro autistico hanno vissuto la loro domenica di gloria lungo i 3 km del percorso disegnato per loro, per le loro famiglie e i loro accompagnatori. «In tanti sono venuti a dirci che così è davvero la festa sportiva della città e dell’inclusione – ha voluto con orgoglio sottolineare il presidente del CSI Ravenna, Alessandro Bondi –. Partire e arrivare insieme a tutti i runner, per i ragazzi di “Correndo senza frontiere”, è stata anche quest’anno un’esperienza da ricordare. Anche chi fa molta fatica a camminare vuole comunque arrivare fino alla fine, proprio per la soddisfazione di passare sotto l’arco della Maratona». I cento atleti in gara hanno rappresentato diverse associazioni e cooperative: La Pieve, rappresentata da più della metà dei partecipanti, Solidarietà Fattiva, Selenia, L’Onda, e numerose famiglie. Dopo aver confermato i numeri dello scorso anno, il CSI ora punta a far crescere ancora di più la manifestazione. «Abbiamo constatato da tempo che le cose belle si fanno in rete e non da soli –precisa Bondi –. E noi auspichiamo che nel tempo tantissime altre realtà vengano a partecipare a questa giornata di festa».
MANTOVA


Venerdì 28 novembre 2025, il centro storico di Mantova ha visto tantissimi bambini, ragazzi, giovani e adulti appartenenti a molte società sportive di tutto il territorio virgiliano riunirsi in un unico abbraccio per celebrare l’evento giubilare presieduto dal vescovo mons. Marco Busca. La manifestazione, promossa dal CSI Mantova, ha visto la collaborazione delle istituzioni locali, del CONI e di vari Enti di Promozione Sportiva. L’evento è stato programmato nell’ambito delle varie iniziative rientranti nel “Festival del Libro e della Cultura Sportiva”, dando spessore e sensibilità al valore educativo della pratica sportiva. La giornata giubilare, iniziata dinanzi alla sede della Curia Vescovile, dove il vescovo ha accolto tutti i partecipanti, ha avuto il suo epilogo all’interno della basilica giubilare di Sant’Andrea. Durante la celebrazione, diverse sono state le testimonianze presentate da atleti e istruttori su come lo sport, attraverso il gioco, la sfida e il rispetto reciproco, possa diffondere tra i ragazzi valori fondamentali quali la solidarietà, la perseveranza, il rispetto e l’amicizia. Come ha affermato mons. Busca, «sono proprio questi valori che il Giubileo ci invita a riscoprire e a mettere al centro delle nostre vite, promuovendo un cammino di speranza e di fraternità». Al termine della riflessione liturgica, il presidente del CSI Mantova, Gilberto Pilati, ha ringraziato tutti coloro che in più ambiti hanno garantito il pieno successo dell’iniziativa.
SIENA Salute, sport e spiritualità nella “Coppa della Pace”
Presentato a Siena, nel mese di ottobre 2025, il Torneo “Coppa della Pace”, in onore di Maria Santissima, promosso dall’Associazione Le Scintille di Maria –ODV in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano della regione Toscana. Il progetto, sostenuto da personaggi dello sport italiano tra cui Alberto Gilardino, Bernardo Corradi e Luciano Spalletti, coinvolge giovani tra i 12 e i 15 anni di otto diocesi toscane, con l’obiettivo di unire sport, fede e costruzione della pace. Il torneo prevede discipline come calcio a 5 e pallavolo, con fasi locali e interdiocesane, fino alla finale regionale in programma il 10 giugno 2026 a Coverciano e a quella internazionale a Spalato, a cui farà seguito un trasferimento a Medjugorje, in occasione dell’inizio del Festival dei Giovani, per vivere giornate all’insegna della spiritualità. A testimoniare il legame tra sport e fede, alla presentazione del torneo c’era il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e presidente della CET, che ha sottolineato come «lo sport, se educa, realizza la persona umana ai suoi massimi livelli. Noi adulti abbiamo la responsabilità di far crescere i giovani con la consapevolezza che il mondo può cambiare».
singolo e doppio femminile Open e doppio misto Open. La prima fase – a gironi da 4 – si è giocata tra novembre e dicembre, mentre la seconda fase a eliminazione diretta è in programma da gennaio. Parte del successo del torneo tennistico sta nella possibilità di organizzare gli incontri liberamente, autoarbitrati rispettando sempre il vincolo delle date del calendario. Le finali sono fissate per il 25 marzo 2026 sulla terra rossa della società Vittorino da Feltre. PIACENZA
Molti 5-0 e qualche 3-2 sono stati fra i risultati riscontrati nella prima giornata di gare a inizio novembre scorso del campionato provinciale di tennis del CSI Piacenza, giunto nel 2025 alla sua quinta edizione. Uno Slam in crescita costante, essendo passato dai 90 iscritti del 2023 ai 152 del 2024, fino ai 220 iscritti dell’ultima edizione. Si gioca sui campi in terra battuta di Piacenza città e provincia. Varie le categorie in campo: singolo e doppio maschile Amatori ed Open,

TOSCANA
Continua a crescere il volley in regione. Via ai campionati!

Dopo i successi delle squadre toscane alle finali nazionali di Cesenatico 2025 e la forte spinta arrivata dalle vittorie mondiali delle nazionali maschile e femminile, il movimento del volley del CSI Toscana è in continua crescita. Ha preso il via a novembre dello scorso anno il primo campionato della categoria Under 12 femminile. Sugli spalti genitori super carichi e in campo Carrarese Volley contro Tiger Volley, in una partita da batticuore vinta 2-1 dalla squadra di casa. A metà novembre si è svolto inoltre il primo concentramento della categoria Supervolley femminile, con bambine che apprendono i principali fondamentali tecnici per arrivare, poi, a giocare nelle categorie superiori. In programma anche il circuito di gare “Volley School”, aperto alle ragazze nate tra il 2004 e il 2010. A gennaio via anche ai campionati Under 14 maschile e femminile e Under 18 maschile, proprio per venire incontro alle richieste delle società, per evitare l’accavallamento dei rispettivi tornei con quelli federali. Alla stagione dei campionati indetti dal Comitato regionale toscano del CSI parteciperanno numerose società del volley regionale, tradizionalmente provenienti dai Comitati provinciali di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Livorno e Pistoia.
Sabato 15 novembre 2025 l’Arena Beach di Cellatica ha ospitato i primi set della CSI Beach Cup, il neonato campionato di beach volley 2×2 misto. Da novembre scorso ad aprile di quest’anno, presso la struttura dotata di una tensostruttura con ben 4 campi indoor, sono sei le tappe previste, una per mese, sempre di sabato mattina (il 20 dicembre, il 10 gennaio, e a seguire in calendario il 14 febbraio, il 14 marzo e il 18 aprile), con le Finals in primavera nella “Master Beach”. La formula del campionato prevede in ogni tappa due fasi di gioco: la prima a gironi, la seconda a eliminazione diretta. Nel caso il numero di squadre sia di dodici o più, la fase a gironi distinguerà un tabellone principale, il Gold, e uno secondario, il Silver. Al termine di ogni tappa verrà assegnato un punteggio individuale, quindi uno a giocatore, in base al risultato raggiunto. Ogni atleta ha bisogno di un partner, ma allo stesso modo concorre per sé, tanto che sarà possibile cambiare coppia di tappa in tappa. Al termine delle sei tappe, verrà stilato un ranking in base ai punti accumulati da ogni atleta: i migliori otto uomini e le migliori otto donne saranno invitati alla “Master Beach”, la tappa finale del campionato che eleggerà i campioni provinciali 2026.

Cesena. Di corsa contro la violenza di genere

Domenica 23 novembre dello scorso anno, sotto un cielo limpidissimo, si è tenuta la classica WIRun Cesena, corsa e camminata per tutti, non competitive, dalla duplice lunghezza di 8,5 o di 11 km, quest’ultima più ardua con l’ascesa e i gradini fino alla Basilica del Monte. Si è trattato di un percorso cittadino ad anello, la cui partenza è avvenuta presso il Club Ippodromo di Cesena. Il ricavato della manifestazione è stato devoluto in beneficenza ai Centri Donna e Antiviolenza dei Comuni di Cesena e Cesenatico per sostenere progetti e iniziative atte a contrastare la violenza di genere. La WIRun Cesena è stata organizzata dall’ASD Women In Run Cesena, con il patrocinio dei Comuni di Cesena e Cesenatico e dell’Ordine degli Psicologi della Regione EmiliaRomagna. Ogni partecipante ha indossato il suo pettorale di gara, che conteneva una frase significativa relativa a tale emergenza, con l’impegno di viverla per un anno intero e divulgarla sui social. Due le novità nel 2025: il pettorale n. 1 assegnato alla forlivese Carlotta Fedriga, atleta in forza alle Fiamme Oro, velocista specializzata nei 100 e 200 metri, e la presenza di 50 cadetti della Polizia di Stato di Cesena, che hanno partecipato per gridare il loro no ai femminicidi e alla violenza di genere. Ristori succulenti con acqua, tè, frutta e biscotti, e all’arrivo, oltre alle classicissime piadine, gli Alpini hanno servito tè caldo e vin brulé. L’adesione è stata rilevante e ha confermato i numeri delle ultime edizioni, con 1.500 iscritti, provenienti da ogni parte della Romagna.
Il primo Congresso del CSI unificato nei giorni dall’1 al 4 giugno 1972

di
Leonio Callioni
Per i giovani è difficile immaginare, e forse anche comprendere appieno, quanto diversa fosse la società italiana mezzo secolo fa. Uno sguardo, pur fugace, sulla nostra storia, ci permette invece di riscoprire scorci ormai dimenticati, pur se veramente di portata storica. Chi ha vissuto più inverni ricorda che nel maggio del 1975 in Italia entrò in vigore la Riforma del diritto di famiglia, introducendo un concetto che oggi può sembrare tanto ovvio da far pensare che “è sempre stato così”. Invece no. Venne, per esempio, introdotta la parità tra i coniugi (e se non è incredibile che prima non fosse così…); venne introdotta la comunione dei beni e, insieme con l’abrogazione della separazione per colpa, fu abolita la distinzione tra figli legittimi e naturali. Di qualche mese prima, esattamente del marzo 1975, è la legge che abbassava la maggiore età dai 21 ai 18 anni. Le premesse di tanti cambiamenti attuati negli anni ’70 si collocano nel 1968, con l’esplosione dei primi movimenti di protesta studenteschi, seguiti successivamente da quelli operai. In quegli anni la nostra Associazione portò a compimento, a sua volta, alcune scelte epocali, che determineranno il futuro del Centro Sportivo Italiano. Ci immergiamo nella lettura della storia del CSI, nel secondo
volume del libro Cent’anni di storia nella realtà dello sport italiano, per apprendere – o ricordare – che «nel 1971 vengono indetti congressi straordinari del CSI e della FARI [N.d.R. Federazione Attività Ricreative Italiane, dedicata alle donne] per la riforma dei rispettivi statuti. Nella seduta unitaria, in apertura dei congressi, le due presidenze nazionali propongono ai delegati un documento di unificazione delle due associazioni in una associazione autonoma (non più promossa dall’Azione Cattolica Italiana), nuova e diversa». Cambiamenti straordinari, come si vede, che modificarono la struttura dell’Associazione. Prosegue il racconto della storia del CSI: «Il documento di unificazione viene approvato immediatamente, pur in presenza di alcune riserve. In esso si afferma: “Il CSI e la FARI… intendono esprimere la volontà di unificare le proprie esperienze proponendosi insieme come nuova associazione, aperta ai giovani e alle giovani, dove il modo di vita è caratterizzato dal fatto che le componenti maschili e femminili sono insieme presenti, partecipi e responsabili della vita associativa a tutti i livelli, cogliendo anche, con questa
scelta, una delle sollecitazioni sociologiche giovanili più evidenti che nasce dalla tendenza dei giovani a sperimentare in gruppo, ragazzi e ragazze insieme, momenti significativi della loro esistenza”». Il senso di questa unificazione non stava nel puro e semplice accostamento di due storie significative e nella somma delle due realtà associative. Stava, piuttosto, nell’aver scelto di procedere insieme come premessa per un nuovo associazionismo sportivo giovanile. L’unificazione si attiva, quindi, non tanto con uno sguardo rivolto all’interno, sul comportamento delle due componenti CSI e FARI, quanto piuttosto con uno sguardo lontano, proiettato nel futuro, avendo per meta un modello associativo nuovo da proporre al mondo sportivo organizzato italiano. «Si vuole creare un’associazione che rovesci il tradizionale e scontato rapporto di subordinazione del cosiddetto “settore femminile” per fare spazio ad una paritetica e corretta collaborazione tra uomini e donne che pensano insieme e che insieme gestiscono la loro attività e la loro vita associativa». Come si vede, una vera rivoluzione, totalmente positiva.


GESÙ È PIÙ FORTE
DELLA CAMORRA
Dalla Campania alle Scampia d’Italia
Di Don Aniello Manganiello e Andrea Manzi
Ed. Europa Edizioni
A Scampia puoi scegliere di non vedere, oppure puoi camminare, insieme. Don Aniello Manganiello ha scelto la seconda strada: sedici anni passati con la gente del quartiere, passo dopo passo, perché solo così si capisce davvero il ritmo di chi vive ai margini, e «se il tuo passo è cadenzato su quello dei ragazzi». Questo libro racconta quella scelta e le sue conseguenze. È il resoconto crudo e onesto di una presenza quotidiana tra tossicodipendenti, malati di AIDS, famiglie schiacciate dall’etichetta di “camorriste”, ragazzi che cercano una via d’uscita. Don Aniello non si è limitato a pregare: è entrato nelle case, ha ascoltato i boss, ha sfidato poteri visibili e invisibili. E qualcosa è cambiato: conversioni impensabili, vite salvate, dignità ritrovate. Il libro è una sfida per chi usa belle parole sulla legalità restando a distanza di sicurezza. Mostra che contro la camorra non bastano operazioni di polizia: serve chi crede che nessuno sia irrecuperabile e lo dimostra ogni giorno. Una testimonianza scomoda che ricorda quanto sia difficile, e necessario, stare dove fa più male.

Di Vito Cozzoli
Ed. Piemme
C’è uno sport che corre, salta, si allena. E ce n’è un altro che costruisce ponti, crea lavoro, rigenera quartieri e tiene insieme le comunità. In L’anima sociale e industriale dello sport, Vito Cozzoli racconta queste due dimensioni come parti della stessa storia: lo sport che fa bene alle persone e lo sport che muove energie, progetti e innovazione. Con una scrittura limpida, l’autore mostra quanto lo sport sia oggi un vero patrimonio culturale, capace di educare, curare, includere e allo stesso tempo di alimentare un’intera filiera economica fatta di imprese, professionisti e territori. Le pagine scorrono tra esempi concreti tratti dalla realtà italiana e riflessioni che invitano a superare il vecchio confine tra “gioco” e “lavoro”: lo sport è entrambe le cose, e molto di più. È un diritto da difendere per ogni cittadino, uno spazio per crescere insieme, una risorsa strategica per il futuro del Paese e delle nuove generazioni. Un libro che apre lo sguardo e ricorda che, quando lo sport funziona davvero, migliora la vita di tutti e costruisce comunità più coese e solidali.

IL CALCIO A 7
Uno sport che fa crescere
Di Federico Pistone con Giorgia Magni
Ed. Ultra
Il calcio a 7 non è una versione ridotta del calcio a 11, ma una disciplina con una propria identità che mette al centro i fattori educativi di cui lo sport è portatore. È una versione di calcio che ha impostato il proprio regolamento e la propria giustizia sportiva, in modo da costruire un forte messaggio valoriale attorno al calcio. Questo libro, firmato dal giornalista de “Il Corriere della Sera” Federico Pistone, con un’introduzione di Giorgia Magni, giornalista, e un contributo tecnico del formatore sportivo Daniele Tacchini, è il primo ad affrontare il calcio a 7 in modo organico: dagli aspetti prettamente tecnici, tattici, di organizzazione del gioco e dell’allenamento, sino agli aspetti più legati alle origini della disciplina, strettamente connessi alla storia del Centro Sportivo Italiano, precursore e ora leader indiscusso del calcio a 7 in Italia. Le pagine approfondiscono le specificità di questa disciplina, raccontando anche storie di crescita e riscatto, offrendo un punto di riferimento per chi già pratica il calcio a 7 e per chi cerca uno sport autentico e educativo.
La storia vera del giocatore di football americano in libertà vigilata. Per uno stupro mai commesso. Come certezze la madre e la fede.
Quando lo sport è molto di più di un campo e di un placcaggio.

di Andrea Barbetti
Diciassette anni e un campo di football davanti. La vita è tutta sole: una borsa di studio per libri e sport e la lega NFL che verrà a momenti. Poi. Racconta una storia vera il bel film di Tom Shadyac, già regista di commedie da botteghino come “Il professore matto”, “Una settimana da Dio” e l’imperdibile “Patch Adams” con lo straripante Robin Williams nei panni di un medico americano che ha inventato la terapia del buonumore. Qui la macchina da presa segue il percorso di verità e riabilitazione di un giovanissimo atleta di football americano, condannato per stupro ai danni di una sua coetanea. Spaventato dalla composizione della giuria, il suo avvocato gli consiglia il male minore: confessarsi colpevole di un atto mai compiuto. Da lì l’abisso: carcere prima, libertà vigilata dopo, ma con braccialetto elettronico e distanziamento obbligatorio di almeno 600 metri da scuole e luoghi pubblici, pena il ritorno in cella prima della scadenza della condanna decennale. Tutto giusto e sensato, se non fosse che Brian è innocente. Per lui trovare e mantenere un lavoro diventa complicato, riprendere a giocare su di un campo di football quasi impossibile; costruire un intreccio d’amore con una ragazza significa il dilemma maledetto: raccontare la verità d’origine e perderla, o tacere, venire scoperto e perdersi? Il buio oltre la meta. Per fortuna c’è un porto sicuro: sua madre. Per fortuna in lui cresce un fuoco sincero: la fede. Così non molla, anzi, perché «la libertà non nasce in un campo da football, ma inizia nella mente». Studia le carte del processo; scende nei rivoli del guazzabuglio di norme che murano il suo caso; tampina fino all’esaurimento l’associazione no profit “California Innocence Project”, il cui avvocato fondatore Justin Brooks si batte concretamente contro le storture del sistema giuridico americano. E... Il resto è tutto dentro il film: bugie e verità; amori e tradimenti; giustizia e discriminazione. Fino all’ultimo si resta col fiato sospeso, confusi da una giustizia americana che a volte pare negare ritorni e ribaltamenti, anche quando la prima sentenza
risulti ormai inverosimile. Per non soffrire troppo ci aggrappiamo al sapiente motivatore carcerario, un Morgan Freeman a cui bastano due scene per riempire l’intero film, al battagliero e frenetico occhio azzurrino del bravissimo Greg Kinnear nei panni dell’avvocato Brooks, alla tosta figura materna di Leomia Banks, portata sullo schermo da una commovente Sherri Shepherd. «Il football mi ha dato un’alternativa, mi ha insegnato la disciplina, la dedizione e, stranamente, mi ha dato la fede perché mia madre diceva che il mio talento era un dono di Dio»: quando lo sport è molto di più di un campo e di un placcaggio. Parola di Brian Banks.
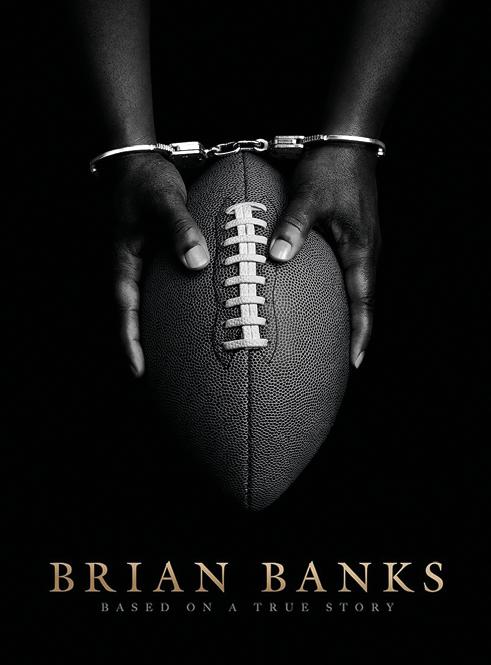




www.sportcontrolafame.it
scendi in campo: DONA ORA.
Con Focsiv e CSI lo sport diventa solidarietà: insieme sosteniamo progetti internazionali per il diritto al cibo, dalle merende scolastiche alla formazione agricola, per garantire sviluppo e futuro alle comunità più fragili.
