Giornale dei Biologi



Sottoscritto l’accordo tra Fnob e Figc : 13mila nutrizionisti “alleneranno” stile di vita e alimentazione degli atleti


Arlecchino e il destino dei Biologi di Vincenzo D’Anna
PRIMO PIANO
I biologi al servizio del calcio italiano: accordo tra FNOB e FIGC di Rino Dazzo
Nuova opportunità per la FNOB e gli Ordini regionali: in arrivo la rete digitale nazionale per gli albi dei biologi di Vincenzo D’Anna
FNOB: interoperabilità, tessera digitale e nuova identità professionale grazie al progetto PNRR
Nobel per la medicina 2025: premiati i biologi
Legge sull’obesità: Italia prima al mondo di Rino Dazzo
Gli obesi in Italia: il dramma dei bambini di Rino Dazzo
INTERVISTE
Il gene Hscharme influenza i cardiomiociti e la salute del cuore di Ester Trevisan
Le nuove frontiere della reumatologia: l’IA per la cura e la diagnosi precoce di Matilde Andolfo

Mappate oltre 350mila “conversazioni” tra RNA e proteine nelle cellule di Sara Bovio
Il primo database delle “cicatrici” del DNA per combattere il cancro di Sara Bovio
Colesterolo, cambiano i parametri: l’ultima minaccia è la Lipoproteina-a di Domenico Esposito
Obesità, un nuovo algoritmo aiuta i medici a scegliere i farmaci più efficaci di Sara Bovio
Salute del cuore: italiani poco attenti di Domenico Esposito
L’AI rivoluziona la diagnosi di retinopatia diabetica di Elisabetta Gramolini
Un amminoacido che cura l’intestino di Michelangelo Ottaviano
Tumori, boom di casi entro il 2050 di Domenico Esposito
Nanoparticelle “a scovolino”: una nuova frontiera nella lotta al cancro di Carmen Paradiso
Il metabolismo come orologio dello sviluppo, la scoperta dell’Embl di Carmen Paradiso
La longevità si può ereditare grazie alla proteina messaggera di Carmen Paradiso
Parkinson: bersagli terapeutici per potenziare i trattamenti di Carmen Paradiso
Neurocosmesi, interazioni pelle e sistema nervoso di Carla Cimmino

La vita animale nasce dalle spugne di Michelangelo Ottaviano 52 54
Il biologo ambientale: figura chiave per la tutela della biodiversità di Matilde Andolfo
Il biologo e la medicina del futuro: in 400 all’evento di Reggio Calabria
AMBIENTE
Il biologo ambientale: pilastro scientifico e garante ecosistemico nelle grandi opere infrastrutturali di Pierlisa Di Felice
Progetti rigenerativi in Liguria trasformano il fondale in laboratorio di Gianpaolo Palazzo
Film innovativi proteggono le celle solari, aumentandone l’efficienza di Gianpaolo Palazzo
Dalla tavola al cestino: la crisi invisibile del cibo che non consumiamo di Gianpaolo Palazzo
I nuovi numeri dello spreco alimentare in Italia: come fare la differenza di Livia Galletti
Smog fotochimico, il nemico invisibile che soffoca città e campagne del nord di Gianpaolo Palazzo
Riso Tea: rivoluzione nei campi di Michelangelo Ottaviano
Gliobastoma: Seqperglio guida la ricerca di Pasquale Santilio
Sand challenge: la voce analizzata dalla IA di Pasquale Santilio
L’anticorpo che rallenta il gliobastoma di Pasquale Santilio
Diagnosi precoce con la bi-rinfrangenza di Pasquale Santilio
Il biorestauro dei due capolavori del Moncalvo a Chieri di Rino Dazzo
Dalla pluricampionessa ai volti nuovi, ori e podi dell’atletica paralimpica di Antonino Palumbo
Sardegna a “gonfie vele”, fra titoli mondiali e lampi d’azzurro di Antonino Palumbo
Finn, astro nascente del ciclismo italiano di Antonino Palumbo
La milano del volley vince la supercoppa di Antonino Palumbo
Insonnia: dalla genetica ai nuovi approcci di stimolazione cerebrale di Daniela Bencardino
Oltre il DNA: come l’editing genetico riscrive la medicina personalizzata di Davide Cacchiarelli e Daniela Sanges
Storia del rapporto tra uomo e piante - prima parte di Giuliano Russini
Si informano gli iscritti che gli uffici della Federazione forniranno informazioni telefoniche di carattere generale dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Tutte le comunicazioni dovranno pervenire tramite posta (presso Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, via Icilio 7, 00153 Roma) o all’indirizzo protocollo@cert.fnob.it, indicando nell’oggetto l’ufficio a cui la comunicazione è destinata.
È possibile recarsi presso le sedi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi previo appuntamento e soltanto qualora non sia possibile ricevere assistenza telematica. L’appuntamento va concordato con l’ufficio interessato tramite mail o telefono.
UFFICIO CONTATTO
Centralino 06 57090 200
Ufficio protocollo protocollo@cert.fnob.it

Anno VIII - N. 10 Ottobre 2025
Edizione mensile di Bio’s
Testata registrata al n. 113/2021 del Tribunale di Roma
Diffusione: www.fnob.it
Direttore responsabile: Vincenzo D’Anna
Giornale dei Biologi
Questo magazine digitale è scaricabile on-line dal sito internet www.fnob.it
Sottoscritto l’accordo tra Fnob e Figc : 13mila nutrizionisti “alleneranno” stile di vita e alimentazione degli atleti

Questo numero del “Giornale dei Biologi” è stato chiuso in redazione il 30 ottobre 2025.
Contatti: protocollo@cert.fnob.it
Gli articoli e le note firmate esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi.
Immagine di copertina: @ Igor Link/shutterstock.com


di Vincenzo D’Anna Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
Ebbene sì, devo confessarlo,
cari colleghi: ho più volte
riconsiderato la bontà del passaggio dei Biologi nelle professioni sanitarie. Non tanto e non solo perché presiedo una categoria affatto incline a considerare le cose positive, ma dedita a prefigurare quelle negative, vocata al lamento più che al ringraziamento. Non c’è stata conquista, in questi ultimi sette anni - prima con l’ONB e poi con la FNOB - che abbia ricevuto un apprezzamento corale e manifesto da parte della categoria. Quest’ultima, intesa come l’insieme degli iscritti all’Albo e anche di coloro che, non avendo l’obbligo di iscriversi, non hanno comunque risparmiato critiche e rilievi a un Ordine professionale al quale comunque non aderiranno. In quest’ultimo caso, è da quelle fila che vengono infatti le critiche più feroci, alimentate spesso da frustrazioni personali e dalla circostanza che, non conoscendo le vicende, ci si erge comunque a giudici e saccenti. E tuttavia, nel primo quinquennio dal 2018
Non c’è stata conquista, in questi ultimi sette anni che abbia ricevuto un apprezzamento corale e manifesto da parte della categoria
al 2023, l’Ordine Nazionale dei Biologi è stato ricostruito pietra su pietra, rimesso in sesto economicamente, debito pregresso su debito pregresso. Sono state compiute scelte organizzative per migliorare i servizi e l’interlocuzione con gli iscritti, del tutto assente in passato; si è pensato all’inserimento in contesti politici e istituzionali dai quali eravamo esclusi o ignorati. E non è bastato, in quel tempo, redigere un libro bianco riepilogativo e didascalico di quanto fatto, per tacitare commenti puntuti, giudizi malevoli, valutazioni superficiali, figlie di quella pessima e diffusa abitudine che si chiama “il sentito dire”. All’atto dell’entrata in vigore della legge 3/2018, re -
Siamo alla vigilia dell’adozione dei decreti ministeriali che riscrivono, aggiornano e ampliano le competenze professionali
cante il riordino degli Ordini e dei Collegi professionali della sanità, ci è voluto del tempo perché se ne cogliessero i vantaggi. Oggi, infatti, siamo alla vigilia dell’adozione dei decreti ministeriali che riscrivono, aggiornano e ampliano le competenze professionali, rifondano il sistema e l’intera Categoria. Non passa giorno che, pur innanzi a questa rivoluzione copernicana, non compaia la voce di chi chiede altro ancora, puntando - in genere - sulla tutela del proprio microcosmo, quasi che venisse minacciato dalla modernità e dall’evoluzione raggiunta. Ci vorranno diversi anni perché qualcuno prenda nota e si renda conto che soddisfare il proprio piccolo particolare non renda
affatto alla Categoria; che una visione angusta del proprio interesse non fa crescere niente e nessuno. Comunque, ai Biologi - come agli amici più cari - si deve voler bene coi difetti che hanno, con le abitudini che si sono radicate negli anni dell’incuria verso i medesimi, con la necessità di doversi barcamenare nell’esercizio di una professione tanto ampia di prospettive, eclettica per variabilità di impiego, ma quasi sempre priva di normative e tutele legislative. Normative vecchie che fissavano la mera elencazione di aree di indirizzo professionale, genericamente indicate in una legge istitutiva “omnibus”, ma scarna di interpretazioni giuridicamente chiare. Quello che maggiormente pesa, però, è l’assenza di un “senso politico” della Categoria che, ancorché diversamente organizzata - dal centralismo dell’ONB al pluralismo degli Ordini territoriali - risente del solipsismo culturale e della vocazione campanilistica. Gli Ordini territoriali, spesso, sono finiti nelle mani di una dirigenza tetragona alla visione federativa che coordina e indirizza, nel senso degli obblighi di legge, la vita delle realtà regionali. A volte si trae l’impressione che ciascuno curi e difenda la propria organizzazione territoriale con fare malmostoso e sospettoso, quasi che si siano create “ditte” personalizzate. Le fibrillazioni non mancano e spesso qualche Ordine si rapporta con la Fe -
Gli Ordini territoriali, spesso, sono finiti nelle mani di una dirigenza tetragona alla visione federativa che coordina e indirizza la vita delle realtà regionali
derazione con fare competitivo, se non indifferente. Un agire che lascia prevalere le differenze e non le assonanze. Se la FNOB si piegasse a questo modo di intendere le cose, avremmo creato undici repubbliche autocratiche e non solamente autonome per competenze che la legge delega agli ordini territoriali. Un vestito di Arlecchino che non porta né unità d’intenti né concorde collaborazione. Dalla FNOB arrivano, con cadenza ormai frequente, conquiste per i Biologi che in passato erano sconosciute, riconoscimenti insperati per tutti noi. Tutto viene preso come se fosse stato facile ottenerlo e finanche dovuto, come tale non degno di notazione. Per quanto mi riguarda, que -
Dalla FNOB arrivano, con cadenza ormai frequente, conquiste per i Biologi che in passato erano sconosciute
sto tempo di servizio senza riscontro è scaduto: chi non dà segno di resipiscenza nel rispettare la funzione, il ruolo e l’autorevolezza della Federazione, dovrà procurarsi i mezzi in futuro per ottenere le cose che desidera. Così come si dovrà attrezzare per la prossima fase elettorale, dell’Ottobre 2026, in una prospettiva autoctona e autosufficiente sotto il profilo della raccolta del consenso democratico, che è l’unico a conferire legittimità a chi pretende di detenere il potere di governare. Sceglieremo i leali al disegno federativo e i generosi che si offrono al servizio dei Biologi. Perché si governa non per cupidigia di potere, ma per il dovere di fare del bene alla gente.
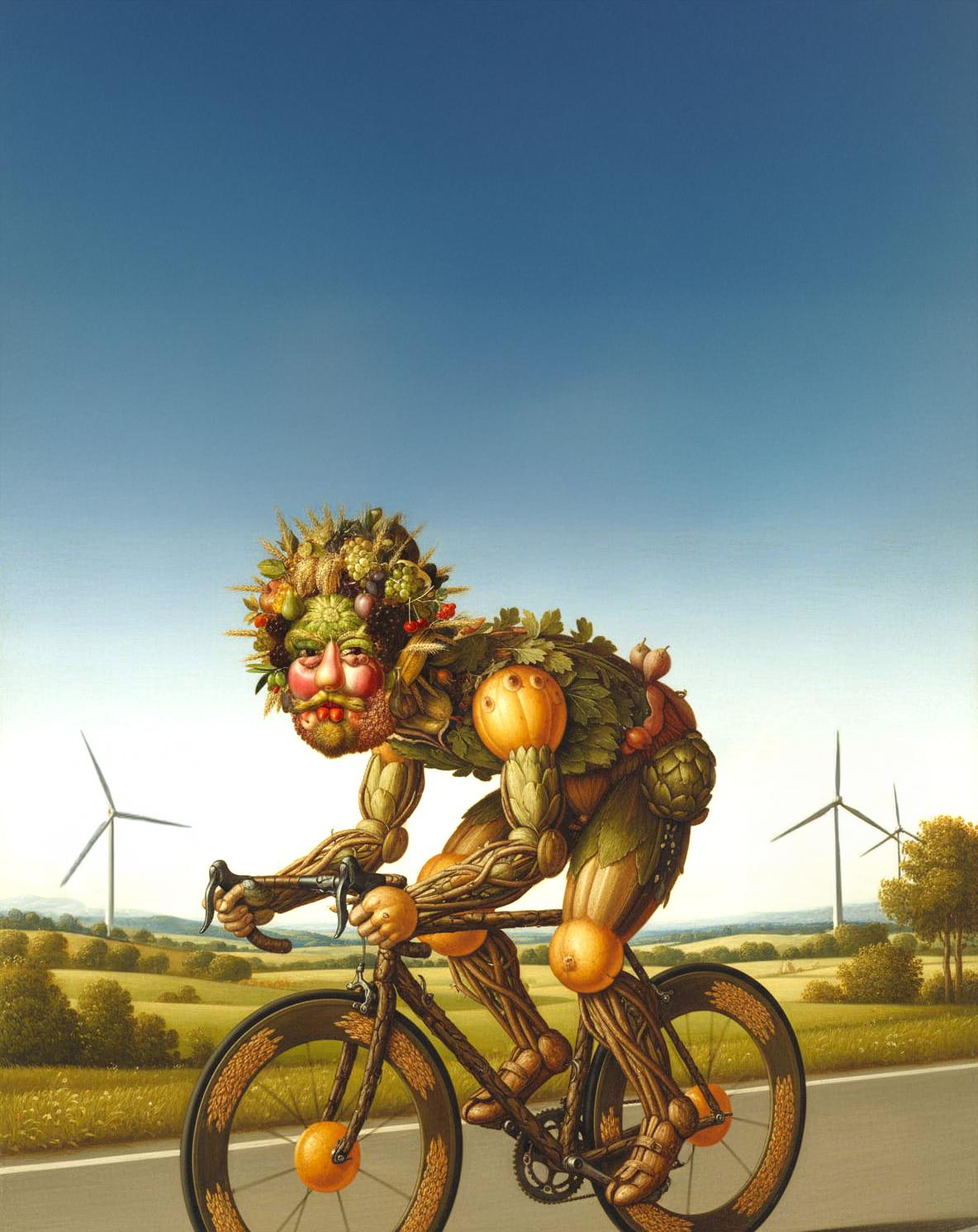
Stretta di mano tra i presidenti D’Anna e Gravina, siglato il protocollo d’intesa
Per 13mila nutrizionisti si aprono interessanti possibilità di carriera nello sport
Un’interessante possibilità di carriera per 13mila biologi nutrizionisti, ma anche e soprattutto un valido supporto all’attività di calciatori, calciatrici, squadre e società sportive. Lo scorso 29 settembre è stato siglato il protocollo d’intesa tra la FNOB e la FIGC: la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi e la Federazione Italiana Giuoco Calcio legate da una partnership allo scopo di garantire ai protagonisti delle partite sul rettangolo verde, siano essi professionisti o dilettanti, una corretta alimentazione e uno stile di vita sano, insomma gli strumenti necessari a migliorare le prestazioni in modo naturale e sotto la stretta osservazione di specialisti competenti.
Per la FNOB si tratta di un primo, cruciale ingresso nel mondo dello sport, preludio ad analoghi accordi con realtà e istituzioni di altre discipline. Il mondo del calcio, dal canto suo, potrà contare su un buon numero di professionisti in grado di stilare piani alimentari ad hoc e programmi specifici per i propri atleti.
Ma cosa prevede il protocollo d’intesa tra le due federazioni, salutato dalla stretta di mano tra i presidenti D’Anna e Gravina? Sostanzialmente, l’organizzazione e la promozione, nell’ambito del Settore Tecnico della FIGC, di periodici corsi di aggiornamento e formazione che comprendono anche i biologi nutrizionisti regolarmente iscritti all’Albo professionale della FNOB. Lo scopo finale è la selezione e la preparazione di biologi professionisti strettamente qualificati nell’ambito della nutrizione applicata al calcio. Una platea di specialisti capace di guidare calciatori e club nel loro percorso alimentare, un passaggio strettamente propedeutico

Per la FNOB si tratta di un primo, cruciale ingresso nel mondo dello sport, preludio ad analoghi accordi con realtà e istituzioni di altre discipline. Il mondo del calcio, dal canto suo, potrà contare su un buon numero di professionisti in grado di stilare piani alimentari ad hoc e programmi specifici per i propri atleti. Come previsto dall’intesa, sarà creato un percorso formativo al cui interno la FNOB provvederà a dare il proprio supporto scientifico e didattico. Il corso di formazione sarà organizzato con cadenza annuale e avrà come oggetto la selezione e la preparazione di almeno venti biologi qualificati nello specifico ambito della nutrizione applicata al calcio

al raggiungimento di uno stato di forma ottimale. Un’intesa che promette di diventare una best practice in ambito calcistico e più in generale sportivo: l’obiettivo a medio e lungo termine, infatti, è coinvolgere un numero crescente di federazioni e discipline sportive (in primis lo stesso CONI), in modo da ottenere un miglioramento dello stato di salute e dei livelli delle prestazioni di tutti gli atleti.
La soddisfazione del mondo dei biologi è pienamente rappresentata dalle parole del presidente Vincenzo D’Anna al momento della firma del protocollo, avvenuta presso la sede della FIGC in via Allegri a Roma. Più precisamente, all’interno della sala intitolata a Paolo Rossi, l’indimenticato Pablito eroe del trionfo mondiale degli Azzurri nel 1982 in Spagna: «Ringrazio il presidente Gravina per aver consentito ai biologi nutrizionisti che si occupano di attività sportive, di accedere ad un riconoscimento qualificato della loro attività, anche in seno alle compagini di calcio. Un traguardo - ha sottolineato D’Anna - da tempo perseguito ed oggi realizzato».
Il presidente, inoltre, ha inteso omaggiare il presidente Gravina donandogli una maschera apotropaica di arte greca proveniente dalla Calabria. Un dono che è stato molto apprezzato dal suo omologo, il numero uno della Federcalcio.
Anche Gravina, dal canto suo, ha espresso analogo compiacimento: «Siamo felici di poter intraprendere questo nuovo percorso con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi. Nello sport, e nel calcio in particolare, c’è bisogno di sempre maggiore professionalizzazione e sono convinto che i biologi nutrizionisti possano contribuire in ma-
niera determinante - ha concluso Gravina - a migliorare le condizioni di salute e l’attività sportiva degli atleti». Dieci gli articoli del protocollo. Come previsto dall’intesa, sarà creato un percorso formativo al cui interno la FNOB provvederà a dare il proprio supporto scientifico e didattico. Il corso di formazione sarà organizzato con cadenza annuale dal Settore Tecnico della FIGC presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, in Toscana, e avrà come oggetto la selezione e la preparazione di almeno venti biologi qualificati nello specifico ambito della nutrizione applicata al calcio.
Il corso, infatti, si intitolerà proprio «Nutrizione Applicata al Calcio» e la selezione dei partecipanti al bando di concorso, per l’accesso al corso di formazione stesso, avverrà anche, se necessario, con il contributo professionale della FNOB. Come specificato nell’articolo 3, la federazione dei biologi «si impegna a proporre, su richiesta del Settore Tecnico, docenti per il citato corso di formazione, nonché a supportare il Settore Tecnico della FIGC nella definizione dei contenuti scientifici e formativi del corso». Nello stesso articolo si sottolinea come le parti «si impegnano, di comune accordo, a stabilire quanti posti del corso di formazione sono riservati ai biologi».
Inoltre, in merito alla partecipazione dei biologi al corso di formazione, «la FNOB provvederà ad erogare, esclusivamente ai biologi iscritti all’Albo professionale, e che saranno ammessi al corso, un contributo pari al 50% della quota d’iscrizione». Quota che sarà versata per intero al Settore Tecnico «da ciascun partecipante ammesso secondo le modalità fissate da medesimo Settore».
D’Anna*
Con l’approvazione del “progetto-obiettivo” da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sta per vedere la luce la rete digitale dedicata agli Albi e ai dati di attività della categoria dei Biologi. L’iniziativa punta a colmare il divario tecnologico rispetto ad altre Federazioni sanitarie, come quelle dei Medici e dei Farmacisti, integrando l’Albo Unico Nazionale dei Biologi (AUN) con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), nell’ambito del programma PNRR.
L’obiettivo è consentire la verifica in tempo reale dell’iscrizione dei Biologi all’Albo, garantendo così un accesso sicuro e qualificato ai dati contenuti nel FSE e migliorando la qualità delle informazioni sanitarie.
Il progetto prevede inoltre l’introduzione di una tessera digitale professionale, integrata nell’IT-Wallet nazionale, che fungerà da moderno strumento di identificazione per gli iscritti. Sebbene l’uso della piattaforma e della tessera digitale resti facoltativo, la novità rappresenta un importante passo avanti verso una gestione più efficiente e trasparente dei dati dell’Albo, arricchiti da ulteriori informazioni sul tipo di attività svolta, sui recapiti professionali e su altri elementi utili all’integrazione con diversi sistemi informatici.
L’investimento previsto, pari a 680 mila euro, consentirà la creazione della “rete digitale” già contemplata daldi Vincenzo
* Presidente FNOB

la legge, che individua nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) il soggetto capofila della rete di collegamento dei sistemi informatici regionali.
In origine, gli undici Ordini territoriali avrebbero dovuto partecipare anche economicamente alla costituzione di tale rete. Tuttavia, al momento del loro insediamento, ciascuno ha optato per soluzioni informatiche autonome, creando notevoli difficoltà alla FNOB nella gestione e nello scambio dei dati con altri enti.
Un esempio emblematico riguarda l’invio dei crediti ECM al COGEAPS: il Centro Elaborazione Dati della FNOB ha dovuto infatti adattarsi ai diversi linguaggi informatici adottati dai singoli Ordini, elaborandoli uno per volta. Oggi, fortunatamente, la tecnologia consente di realizzare - e senza costi aggiuntivi - ciò che in passato risultava complesso, uniformando finalmente i vari sistemi in una rete unica e coerente a livello nazionale. La FNOB dovrà ora procedere, in tempi molto stretti, all’appalto pubblico per la realizzazione della rete, considerando che altre Federazioni hanno già avviato progetti analoghi.
In alternativa, potrà valutare l’affidamento dell’intervento direttamente al Dipartimento dello Stato competente, così da evitare ulteriori ritardi o, peggio, la perdita del finanziamento, eventualità che potrebbe comportare responsabilità personali davanti alla Corte dei Conti.
La speranza, condivisa da tutti, è che il progetto possa procedere senza nuove dispute o cavilli e che la rete digitale dei Biologi diventi presto una realtà operativa ed efficiente.
l progetto presentato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) nasce con l’obiettivo di integrare l’Albo Unico Nazionale dei Biologi (AUN) con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), nell’ambito del programma PNRR.
L’iniziativa consentirà di verificare in tempo reale l’iscrizione dei biologi all’Albo per l’accesso e l’alimentazione dei dati nel FSE, migliorando così la sicurezza e la qualità delle informazioni sanitarie.
Il progetto prevede inoltre l’introduzione di una tessera digitale per gli iscritti, integrata nell’IT-Wallet nazio -

nale, che rappresenterà una forma moderna di identificazione professionale.
L’importo del finanziamento per la realizzazione del progetto è pari a 660.849,60 euro IVA inclusa.
L’intervento rafforza il ruolo della FNOB come soggetto istituzionale pienamente inserito nell’ecosistema digitale della pubblica amministrazione e contribuisce alla trasformazione digitale del sistema sanitario, valorizzando la figura del biologo e rendendo più efficiente la collaborazione tra Ordini territoriali, Federazione e istituzioni nazionali.

Anche quest’anno, il Karolinska Institutet di Stoccolma ha assegnato il riconoscimento a un team di cui fanno parte due biologi per gli studi sul funzionamento del sistema immunitario
Ancora una volta viene riconosciuto l’apporto della Biologia al progresso scientifico e il suo ruolo centrale nel panorama della ricerca internazionale. E ancora una volta, l’attestazione arriva dal Karolinska Institutet di Stoccolma, che ha assegnato il premio Nobel per la Medicina o la Fisiologia 2025 ai biologi Fred Ramsdell e Mary E. Brunkow e all’immunologo Shimon Sakaguchi per le loro “scoperte rivoluzionarie sulla tolleranza immunologica periferica, che impedisce al sistema immunitario di danneggiare l’organismo”.
Nelle motivazioni, l’istituto svedese spiega come i tre scienziati abbiano il merito di aver gettato le basi per un nuovo campo di ricerca che possa stimolare lo sviluppo di innovativi trattamenti per malattie autoimmuni, tumori e trapianti.
Ramsdell, Brunkow e Sakaguchi sono infatti stati de -
• Mary Brunkow, nata nel 1961 a Portland (Oregon), è una biologa. Si è laureata nel 1979 e ha poi conseguito una laurea in biologia molecolare e cellulare all’Università di Washington nel 1983. Ha completato un dottorato di ricerca in biologia molecolare all’Università di Princeton nel 1991. Attualmente è responsabile senior dei programmi dell’Istituto per la Biologia dei sistemi di Seattle Isb, un istituto di ricerca per lo studio delle relazioni tra le varie parti dei sistemi biologici e che promuove un approccio interdisciplinare alla ricerca biologica.
• Frederick Ramsdell, nato a Elmhurst nel 1960, è un biologo. Si è laureato all’Università della California di San Diego nel 1983 e successivamente ha svolto un dottorato di ricerca in immunologia all’Università della California di Los Angeles nel 1987. È direttore di ricerca presso il Parker Institute for Cancer Immunotherapy di San Francisco.
• Shimon Sakaguchi nato a Nagahama nel 1951, è un immunologo. Si è laureato in medicina nel 1976 e ha svolto il dottorato di ricerca nel 1982, entrambi all’Università di Kyoto. Ha svolto studi di post-dottorato alla Johns Hopkins University e all’università di Stanford. Lavora nell’ Immunology Frontier Research Center dell’Università di Osaka.
cisivi nel comprendere il ruolo che hanno nel nostro organismo le cellule T regolatrici, definite “i direttori d’orchestra del sistema immunitario”, le quali sorvegliano il corpo umano e controllano che questo non si comporti in modo anomalo, attaccando se stesso. Tale meccanismo di regolazione, che è alla base dell’insorgenza delle patologie autoimmuni, aiuterà a capire le ragioni per le quali non tutti gli individui sviluppano questa tipologia di malattie in forma grave.
Il progetto di ricerca è iniziato nel 1995 con le intuizioni di Shimon Sakaguchi, convinto che il sistema immunitario fosse molto più complesso di come i suoi colleghi lo consideravano. Secondo la teoria diffusa allora, esisteva un meccanismo definito ‘tolleranza centrale’, per il quale le cellule immunitarie pericolose venivano eliminate nel timo. Sakaguchi dimostrò che il sistema immunitario comprendeva cellule fino ad allora sconosciute, dette “T regolatorie”, specializzate nel controllare che il nostro corpo tolleri i tessuti dell’organismo al quale appartiene. Successivamente Mary Brunkow e Fred Ramsdell scoprirono l’esistenza del gene Foxp3, che si comportava come regista delle cellule identificate qualche anno prima dal collega giapponese.
«La biologia è la scienza del futuro - afferma Vincenzo D’Anna, presidente della FNOB - e come tale si contraddistingue per importanti riconoscimenti in settori, come quello della ricerca, che trovano nel progresso una componente imprescindibile. La nostra è una scienza giovane, prolifera e che sa guardare avanti, dimostrando ogni giorno di avere un’importanza cruciale nella cura e nella tutela della salute umana».
Il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina, istituito dal testamento di Alfred Nobel nel 1895, è assegnato da una giuria di professori di medicina del Karolinska Institutet, Università medica svedese. Viene conferito agli autori di scoperte di vitale importanza, che hanno cambiato i modelli scientifici precedenti e che siano di enorme beneficio per il genere umano.
Nel 2024 il premio è stato assegnato ai due biologi Victor Ambros e Gary Ruvkun per le scoperte sul micro-Rna, un meccanismo che ha aperto la strada a diverse terapie geniche, in particolare alla “regolazione genica post-trascrizionale”.
Finora sono stati assegnati 114 Nobel per la Medicina, il più giovane degli insigniti aveva 31 anni (Frederick G. Banting nel 1923) e il più anziano 87 (Peyton Rous nel 1966), 14 le donne.

Riconosciuta come malattia cronica, progressiva e recidivante
La prevenzione e la cura passano in carico al SSN
Che nel paese ci sia sempre maggior attenzione verso la nutrizione lo dimostra l’approvazione definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge per la prevenzione e la cura dell’obesità, avvenuta a inizio ottobre dopo che lo stesso disegno era stato licenziato a maggio dalla Camera. L’Italia è diventato il primo paese al mondo a dotarsi di una norma specifica su un problema alimentare annoso e, purtroppo, sempre più diffuso.
L’obesità è stata infatti riconosciuta come malattia cronica, progressiva e recidivante, al pari di altre patolo -
gie di interesse e rilevanza sociale, diventando oggetto di un programma nazionale educativo di cura e prevenzione. Le misure previste dalla legge riguardano vari settori: sanità, scuola, mondo del lavoro, informazione pubblica e formazione professionale. Il punto cardine è rappresentato dal diritto delle persone con obesità, esplicitamente riconosciuto dalla norma, ad accedere alle prestazioni sanitarie comprese nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza.
Il Servizio Sanitario Nazionale dovrà farsi carico delle spese sostenute per diagnosi, terapie e monitoraggio,
anche se spetterà alle regioni far rientrare i servizi e le cure sanitarie degli obesi nei Lea. E qui potrebbero sorgere i problemi. Che succederà in quelle regioni, soprattutto al sud, dove i bilanci sono meno floridi, ci sono meno soldi in cassa e dove - per giunta - è concentrato il maggior numero di pazienti obesi? Sarà garantito lo stesso trattamento agli obesi in ogni parte d’Italia, oppure si andrà incontro a diseguaglianze? In attesa che l’applicazione della legge fornisca le prime risposte, sotto la lente di un apposito Osservatorio per lo Studio dell’Obesità creato ad hoc, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha sottolineato la rilevanza e la portata storica della sua approvazione: «Siamo i primi a riconoscere l’obesità come malattia cronica. Parliamo di un problema di salute globale che non riguarda solo gli adulti, ma anche i bambini». Il programma è dotato di uno stanziamento iniziale di 700mila euro per il 2025 destinato a salire a 800mila euro nel 2026 e a un milione e 200mila euro per il 2027. Risorse ripartite tra le regioni e destinate alla promozione dell’attività fisica e di una corretta alimentazione sin dai primi anni di età, al sostegno all’allattamento al seno, a campagne di sensibilizzazione dei genitori, al miglioramento dell’informazione pubblica. Ma non solo. Altri 400mila euro annui a partire dal 2025 sono destinati alla formazione e all’aggiornamento di studenti universitari e personale del SSN, 100mila euro a campagne di informazione, educazione alimentare e promozione dell’attività fisica presso scuole, farmacie, medici di base ed enti locali. Previste inoltre misure di inclusione sociale, volte all’inserimento delle persone con obesità in vari contesti scolastici, sportivi e lavorativi. Un altro ddl riconosce infine il 16 maggio quale Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone: il «body shaming». (R. D.).
Quanto è diffusa l’obesità in Italia? Molto, purtroppo. Un italiano su dieci è obeso, mentre quattro su dieci hanno un peso superiore alla media, finendo dunque nella categoria dei sovrappeso. E ancora: sono affetti da obesità sei milioni di adulti, il 12% della popolazione adulta, mentre un altro 40% è in sovrappeso. Dati che emergono dalle ultime rilevazioni dell’ISS, l’Istituto Superiore di Sanità, e dai più recenti report sulla salute, e che indicano come il trend rispetto agli scorsi non sia migliorato. Anzi.
A fare principalmente i conti con questa particolare malattia sono soprattutto le regioni meridionali: in Campania, Molise, Puglia e Basilicata, in particolare, quasi la metà della popolazione è obesa o in sovrappeso, condizione che - come è noto - predispone allo sviluppo di una serie di condizioni patologiche quali diabete di tipo 2, ipercolesterolemia, ipertensione, problemi cardiovascolari e neurologici, tumori, calcoli biliari, osteoartrite e tante altre ancora. Anch’esse, non a caso, in aumento.
Situazione che diventa ancor più preoccupante se si considera che sono assai elevate le percentuali di bambini e adolescenti obesi o gravemente obesi. Anche in questo caso, con profonde differenze tra una zona e l’altra del paese. Come riportano i dati del rapporto «I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - I dati Regione per Regione 2024», realizzato dal Gruppo di lavoro per l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a fronte di una media nazionale del 9,8% di bambini obesi e gravemente obesi, in alcune regioni si raggiungono picchi del 18,6% (Campania), del 15,5% (Calabria) e del 14,8% (Puglia), mentre nella provincia di Trento la percentuale è appena del 3%. Stili di vita poco salutari, abitudini alimentari sbagliate, l’assenza di efficaci politiche di educazione alimentare contribuiscono all’aumen-
© DementevaJulia/shutterstock.com

Le due velocità della patologia, che viaggia diversamente tra nord e sud e tra disuguaglianze sociali ed economiche
to della percentuale di obesi, particolarmente diffusi tra gli uomini, con un livello di istruzione piuttosto basso e con difficoltà economiche.
I cibi sani come frutta, verdura e prodotti bio, infatti, costano più di quelli industriali. E le disuguglianze economiche si riflettono anche nella difficoltà a praticare sport o a seguire programmi di allenamento in palestre e centri specializzati, nemici naturali di una delle cause più favorevoli dell’obesità: la sedentarietà. Per perdere peso, soprattutto negli ultimi tempi, si sta facendo sempre maggiore ricorso a farmaci come l’Ozempic,
il Wegovy o il Mounjaro, che hanno però costi che escludono le fasce di popolazione meno abbienti (oltre a provocare effetti collaterali che non li rendono adatti a tutti), rafforzando i divari sociali in essere.
E ad avere costi notevoli sono anche gli interventi di chirurgia bariatrica, che tratta l’obesità grave intervenendo su stomaco e intestino per indurre perdite di peso e prevenire le malattie associate: il prezzo può variare tra 2500 e tremila euro per il palloncino gastrico fino ai 12mila euro di un bypass gastrico o di un intervento di gastrectomia a manica verticale. (R. D.).
La scoperta apre la strada a cure personalizzate per le malattie cardiache Ne abbiamo parlato con la professoressa Monica Ballarino, del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università La Sapienza di Roma autrice della ricerca con i colleghi del Cnr
di Ester Trevisan
Professoressa Ballarino, qual è stato il punto di partenza della vostra ricerca?
Il nostro obiettivo era capire se alcuni RNA non codificanti, cioè molecole che non producono proteine, ma regolano il funzionamento dei geni, potessero avere un ruolo chiave nello sviluppo e nelle patologie muscolari.
Partendo da sistemi cellulari murini, abbiamo dapprima identificato e studiato l’RNA non codificante Charme e poi, in uomo, il suo equivalente che abbiamo chiamato HSCHARME. Ci siamo chiesti se anche nell’uomo questo RNA potesse coordinare la formazione e la maturazione delle cellule cardiache, i cardiomiociti, che sono responsabili della contrazione del cuore.
Ci può descrivere la funzione del gene HSCHARME e perché è così importante per il cuore?
HSCHARME è un RNA non codificante particolare, lungo (lncRNA) ed espresso esclusivamente nelle cellule muscolari e nei cardiomiociti. Durante il differenziamento delle cellule staminali verso cardiomiociti, HSCHARME guida l’attivazione di geni essenziali per la contrazione e l’organizzazione del muscolo cardiaco.
Al contrario, quando la sua funzione è bloccata, i cardiomiociti mostrano ritardi nella maturazione, una ridotta capacità di contrazione e anomalie strutturali. Questo dimostra che HSCHARME è fondamentale per acquisire e mantenere l’identità e la funzione di queste cellule cardiache.

HSCHARME è alterato nei cuori di pazienti affetti da cardiomiopatie ipertrofiche e dilatative, due patologie che compromettono la funzione cardiaca. Capire come modulare HSCHARME potrebbe aprire la strada a nuove strategie terapeutiche basate sull’RNA, mirate a ripristinare la corretta espressione dei geni del cuore. È un passo importante verso una medicina più precisa, che agisca direttamente sui meccanismi molecolari alla base della malattia
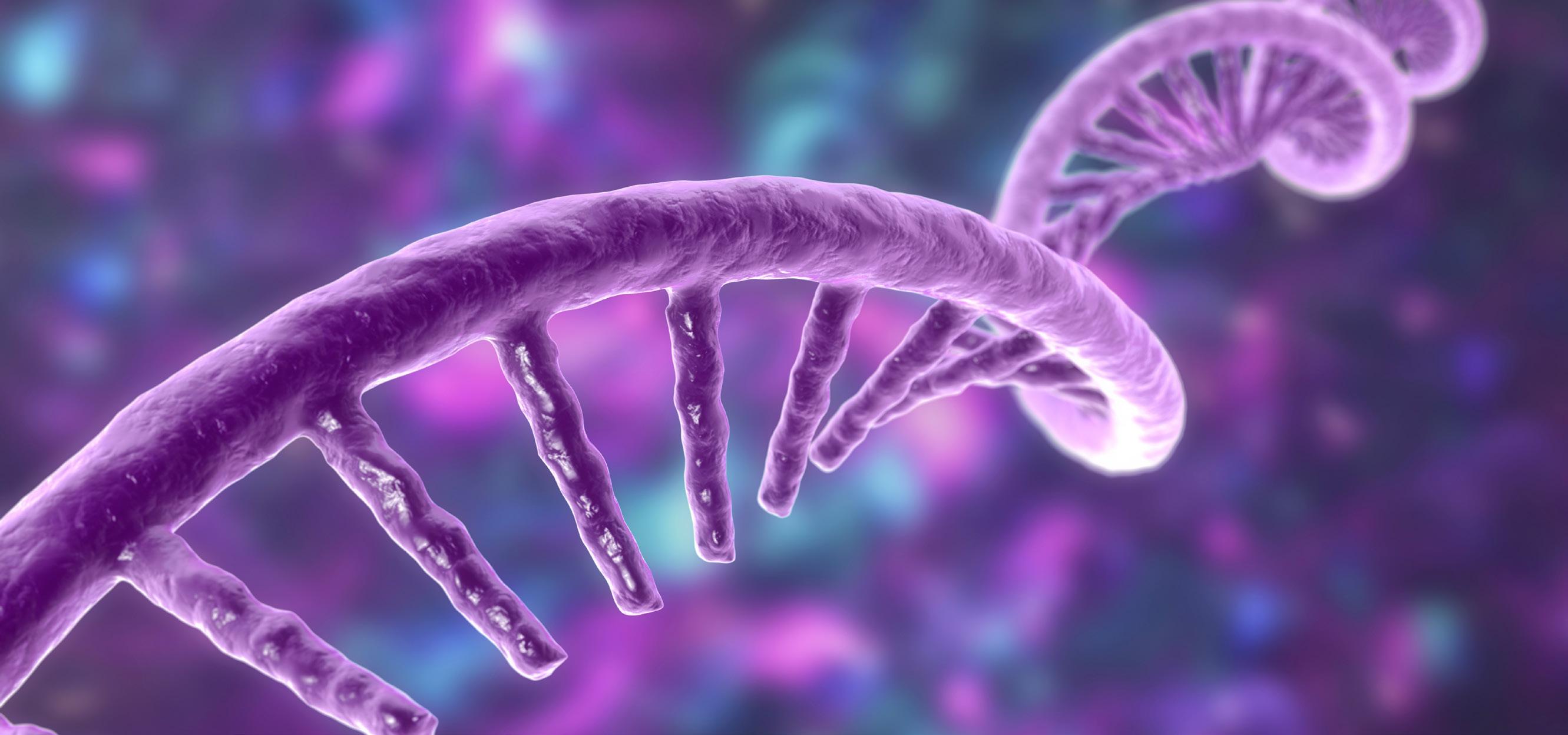
Cosa si intende, in termini semplici, per “splicing alternativo”?
Lo splicing alternativo è un meccanismo con cui una cellula “taglia e cuce” in modi alternativi uno stesso RNA di partenza, producendo trascritti diversi e, di conseguenza, proteine differenti con funzioni differenti. Questo meccanismo aumenta le funzioni del genoma e permette alle cellule di adattarsi a diversi contesti. HSCHARME regola questo meccanismo, assicurando che i geni cardiaci vengano espressi nel modo corretto. Se lo splicing viene alterato, come nel caso in cui HSCHARME non funziona, l’informazione genetica non viene letta correttamente e possono insorgere patologie.
Come interagisce la proteina PTBP1 con HSCHARME?
Abbiamo scoperto che HSCHARME si lega direttamente alla proteina PTBP1, nota per inibire lo splicing di molti RNA. HSCHARME agisce come una sorta di “spugna” in grado di influenzare il legame di PTBP1 ai suoi bersagli e quindi il processo di splicing di trascritti la cui espressione è cruciale nei cardiomiociti. Questa interazione esemplifica un meccanismo di regolazione molto preciso, che mostra quanto sofisticata sia la biologia degli RNA non codificanti.
Quali tecnologie avete utilizzato per ottenere i risultati pubblicati su Nature Communications?
Per questo studio abbiamo combinato approcci all’avanguardia di biologia cellulare e molecolare. Con la tecnologia CRISPR/Cas9 abbiamo generato linee di cellule staminali umane prive di HSCHARME, per analizzare direttamente le conseguenze della sua assenza.
L’RNA sequencing ci ha permesso di studiare l’impatto globale sui geni e sullo splicing, mentre la microscopia confocale e le tecniche di immunoprecipitazione ci hanno consentito di osservare le interazioni dirette tra HSCHARME e PTBP1 nel nucleo delle cellule. In sintesi, abbiamo integrato strumenti di frontiera che spaziano
dalla genomica all’imaging cellulare, per descrivere un meccanismo di regolazione prima sconosciuto.
La scoperta di questo gene può contribuire allo sviluppo di terapie personalizzate per le malattie cardiache?
Assolutamente sì. Abbiamo visto che HSCHARME è alterato nei cuori di pazienti affetti da cardiomiopatie ipertrofiche e dilatative, due patologie che compromettono la funzione cardiaca. Capire come modulare HSCHARME potrebbe aprire la strada a nuove strategie terapeutiche basate sull’RNA, mirate a ripristinare la corretta espressione dei geni del cuore. È un passo importante verso una medicina più precisa, che agisca direttamente sui meccanismi molecolari alla base della malattia.
Come dico sempre ai miei studenti di biologia molecolare, la ricerca non è solo una questione di risultati, ma di domande giuste. È la curiosità a guidare ogni scoperta, ma poi è la capacità di osservare ciò che, a prima vista, sembra marginale a fare la differenza. Questa scoperta ci ricorda che nel genoma umano c’è ancora un mondo inesplorato: quello degli RNA non codificanti, che non vengono tradotti in proteine ma orchestrano la vita delle cellule. Capirli significa aprire nuove strade per la biologia e per il futuro della salute umana.

Monica Ballarino è professoressa associata di Biologia Molecolare e co-coordinatrice del dottorato in Genetica e Biologia Molecolare alla Sapienza. Studia gli RNA non codificanti e il loro ruolo nella regolazione genica e nelle malattie, integrando genomica, microscopia e bioinformatica. Grazie a finanziamenti nazionali e internazionali, il laboratorio sviluppa sistemi modello innovativi, inclusi organoidi neuromuscolari. È impegnata nella sensibilizzazione sulle tematiche di genere in accademia.

Il professore Enrico Tirri sottolinea l’importanza dei nuovi percorsi terapeutici che permettono di intervenire tempestivamente per evitare la progressione della malattia e le sue complicanze
L’“intelligenza artificiale (IA) in reumatologia trova impiego in vari ambiti, tra cui la diagnosi, la valutazione della sintomatologia e il percorso di cura. L’IA non sostituisce lo specialista ma lo supporta nel suo lavoro facilitando il percorso diagnostico e terapeutico del malato reumatico. Di questo e di altro ancora si è parlato a Napoli nel Congresso di Reumatologia in programma il 10 e l’11 ottobre.
Le malattie reumatiche sono circa 200 e si stima che attualmente ne soffra il 10-15% degli italiani - più di 5 milioni di persone. Altro aspetto importante ed attuale è la prevenzione delle malattie reumatiche. Oggi è ampiamente documentato, per esempio, che il fumo è il principale nemico da eliminare per evitare l’insorgenza di molte patologie di questo tipo.
Inoltre, incrementandone la conoscenza da parte del pubblico, si favorisce anche l’eventuale diagnosi precoce e la successiva adesione alle terapie.
Sul tema interviene Enrico Tirri, direttore dell’Unità Operativa di Reumatologia dell’Ospedale del Mare di Napoli, docente della Scuola di Specializzazione di Reumatologia dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, delegato Regionale per la Campania della Società Italiana di Reumatologia (SIR) e consigliere Nazionale Fondazione Italiana Ricerca in Reumatologia.
Professore, qual è l’apporto che l’IA può dare al reumatologo?
«Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha fatto il suo ingresso anche in reumatologia contribuendo ad aiutare il percorso medico del paziente. Viene molto utilizzata per analizzare le tecniche di imaging, risonanza magnetica, ecografie muscoloscheletriche e radiografie. Questo ovviamente consente al medico di abbreviare i tempi di diagnosi, quindi, facilita il percorso della diagnosi precoce».
Può farci un esempio?
«L’Intelligenza Artificiale può aiutare a distinguere i sottotipi di artrite reumatoide di cui soffrono circa quattrocentomila persone in Italia. Distinguere i sottotipi di artrite reumatoide è fondamentale perché ogni forma può rispondere meglio a terapie specifiche».
Professore i dati rivelano che c’è un aumento dei casi delle malattie reumatiche. Qual è il motivo? Si è abbassata l’età di esordio delle malattie reumatiche oppure si è perfezionata la tecnica di diagnosi anche in termini di precocità?
«Nell’immaginario comune le patologie reumatiche colpiscono le persone anziane, ma non è vero. L’insorgenza delle principali patologie reumatiche autoimmuni avviene tra i 40 e i 50 anni. L’artrite reumatoide, ad esempio, colpisce persone di questa fascia d’età o addirittura più giovani.
E ancora, ci sono patologie autoimmuni reumatiche che colpiscono fette di popolazione non anziana. È il caso del lupus erimatoso sistemico, della sclerosi sistemica o della sindrome di Sjogren. Esistono poi malattie reumatiche che colpiscono i bambini, infanto-giovanili. L’artrosi e l’osteoporosi possono invece colpire le persone in un’età più avanzata».
Qual è lo strumento di diagnosi che definisce la malattia reumatica?
«In reumatologia utilizziamo l’ecografia articolare che è un esame ripetibile e poco dispendioso che ci consente di facilitare il percorso diagnostico soprattutto nelle fasi iniziali della patologia reumatica».
Parliamo della sintomatologia. Come distinguere i sintomi propri della malattia reumatica?
«I sintomi con cui ci confrontiamo più frequentemente riguardano l’artrite reumatoide e l’artrite psoriasica. La prima è una patologia infiammatoria articolare sistemica che non

Le malattie reumatiche sono circa 200 e si stima che attualmente ne soffra il 10-15% degli italiani - più di 5 milioni di persone. Altro aspetto importante ed attuale è la prevenzione delle malattie reumatiche. «L’insorgenza delle principali patologie reumatiche autoimmuni avviene tra i 40 e i 50 anni. L’artrite reumatoide, ad esempio, colpisce persone di questa fascia d’età o addirittura più giovani. E ancora, ci sono patologie autoimmuni reumatiche che colpiscono fette di popolazione non anziana. È il caso del lupus erimatoso sistemico, della sclerosi sistemica o della sindrome di Sjogren. Esistono poi malattie reumatiche che colpiscono i bambini, infanto-giovanili. L’artrosi e l’osteoporosi possono invece colpire le persone in un’età più avanzata»

colpisce solo le articolazioni. Tra i sintomi una certa rigidità delle mani al risveglio, “impacciate” in maniera simmetrica soprattutto nelle prime ore del mattino. Nell’artrite psoriasica, che fa parte del gruppo delle spondilo artriti, la sintomatologia caratteristica principale è la lombalgia infiammatoria, presente a riposo e che migliora col movimento».
Come è cambiato, negli anni, l’approccio terapeutico al lupus eritematoso sistemico?
«Fino a cinquant’anni fa erano disponibili soltanto i farmaci immunosoppressori, che recavano una serie di effetti collaterali, o il cortisone somministrato a dosi massicce. Oggi esistono i farmaci biotecnologici che possono intervenire nelle fasi anche più complicate del lupus, soprattutto quando è interessato il rene. Esistono farmaci che consentono una buona gestione della nefrite lupica, una delle complicanze più temibili del lupus eritematoso sistemico».
Esiste una componente ereditaria per l’artrite reumatoide?
«Esiste una genetica predisponente, ma per le patologie autoimmuni più che di ereditarietà parlerei di familiarità

associata ad una predisposizione genetica»
Qual è l’impiego degli anticorpi monoclonali nelle malattie reumatiche?
«Per la terapia dell’artrite reumatoide, già da 20 anni, sono a disposizione i farmaci biotecnologici; si tratta di farmaci che in maniera specifica bloccano le citochine pro-infiammatorie, quindi la “cascata infiammatoria” e quindi l’infiammazione nelle artriti. A differenza di quelli tradizionali i farmaci biologici consentono, più facilmente, la remissione di patologie croniche autoimmuni sistemiche».
E oltre la terapia biologica?
«A disposizione del paziente ci sono anche piccole molecole, le small molecules, vale a dire gli anti JAK che sono farmaci che agiscono in maniera specifica contro l’infiammazione immunomediata. A differenza dei farmaci biotecnologici, che sono somministrati per via sottocutanea, sono assunti per via orale. Sia i farmaci biotecnologici che gli anti JAK hanno dimostrato in questi anni efficacia e sicurezza».
Le malattie reumatiche sono circa 200 e si stima che attualmente ne soffra il 10-15% degli italiani - più di 5 milioni di persone. Solo in Campania si contano circa 650.000 pazienti. Sono caratterizzate dall’infiammazione, spesso immunomediata, di articolazioni, legamenti, tendini, ossa o muscoli, che a volte interessa anche organi interni. Compaiono soprattutto in età adulta, nel pieno della vita sociale e professionale e alcune non danno sintomi immediatamente evidenti. Ma se non diagnosticate e curate in tempo possono causare gravi disabilità con costi sociali elevatissimi. I sintomi sono dolore, gonfiore e rigidità delle articolazioni colpite associati a febbre, stanchezza eccessiva, fino a difficoltà respiratorie, incapacità a ingerire i cibi o insufficienza renale quando vengono interessati anche gli organi interni, per esempio nelle connettiviti come la sclerosi sistemica, il lupus eritematoso sistemico

04 Dicembre 2025 Ore 9:30 - 16:30

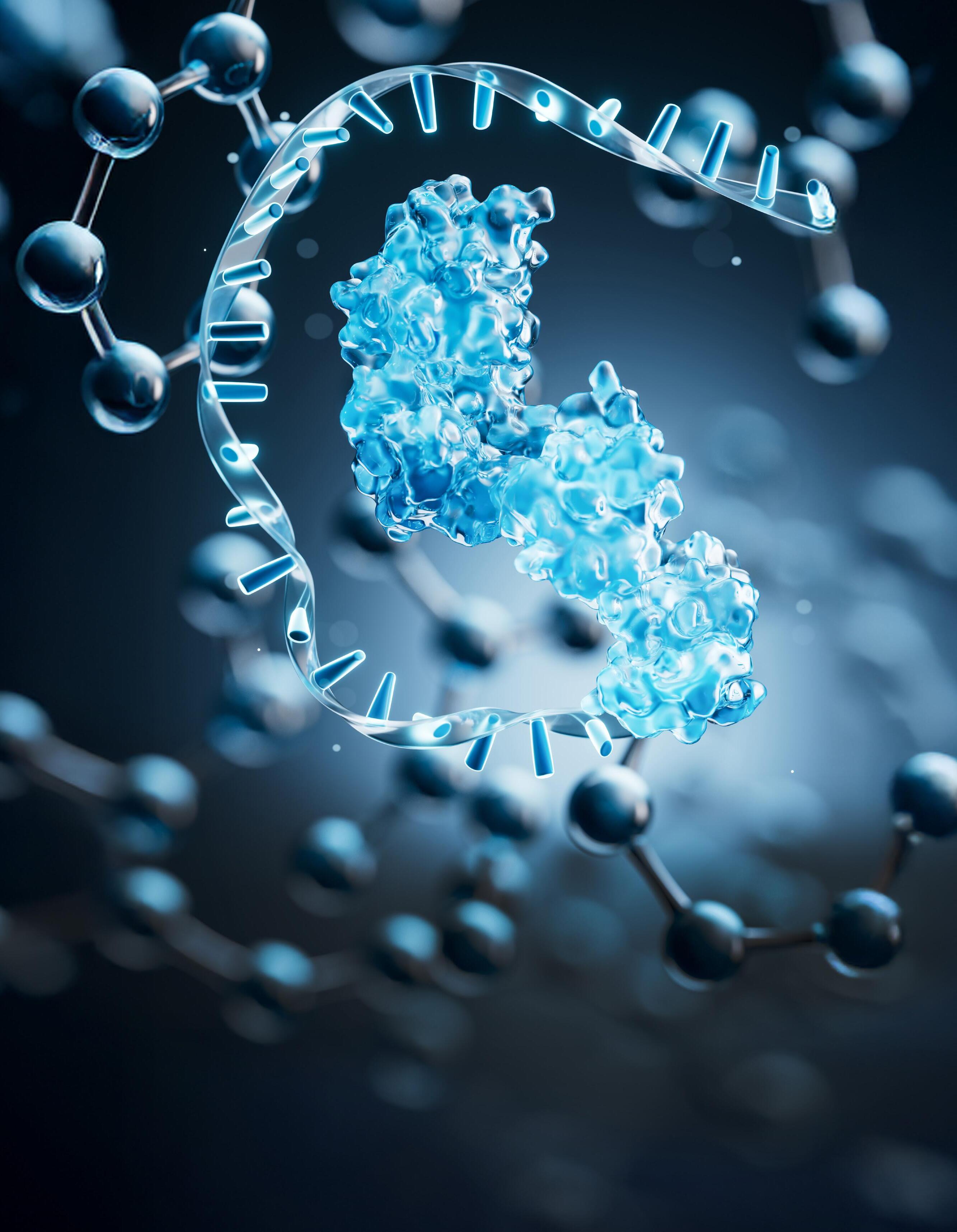
La possibilità di vedere tali interazioni nascoste potrebbe portare alla scoperta di nuovi bersagli farmacologici e approcci terapeutici per il cancro e le malattie cerebrali
All’interno delle nostre cellule esiste una fitta rete di “conversazioni” tra RNA e proteine che regolano in modo critico molti processi essenziali, dall’attivazione e disattivazione dei geni alla risposta allo stress. Fino a oggi però, i ricercatori sono riusciti a catturare solo una piccola parte di queste interazioni, la maggioranza di esse sono rimaste nascoste. Ora, grazie allo sviluppo di una nuova potente tecnica chiamata PRIM-seq (mappatura delle interazioni proteina-RNA tramite sequenziamento) messa a punto dai bioingegneri dell’Università della California di San Diego, sarà possibile mappare l’intera rete delle comunicazioni tra RNA e proteine all’interno delle nostre cellule. Secondo gli autori della ricerca questo importante risultato potrebbe offrire nuove strategie per il trattamento di malattie che vanno dal cancro all’Alzheimer.
Come spiegano gli autori nello studio, PRIM-seq è un metodo per l’identificazione simultanea da zero delle proteine che legano l’RNA e dei loro RNA associati. «Questa tecnica è come una mappa dei collegamenti delle conversazioni cellulari», ha affermato Sheng Zhong, professore presso il Dipartimento di Bioingegneria Shu Chien-Gene Lay della Jacobs School of Engineering dell’Università della California di San Diego, che ha guidato lo studio pubblicato su Nature Biotechnology. «La tecnica mostra quali RNA stanno fisicamente comunicando con quali proteine. Molte malattie, tra cui il cancro e le malattie neurodegenerative, insorgono quando questi “dialoghi” spingono le cellule a compiere azioni errate, come crescere quando non dovrebbero, ignorare i segnali di stress o eludere il sistema immunitario. Una volta individuate le specifiche conversazioni RNA-proteina rilevanti, possiamo progettare farmaci per silenziarle o reindirizzarle».
La nuova tecnica prevede che venga congelato il momento in cui gli RNA e le proteine entrano fisicamente in contatto all’interno delle cellule. Ogni proteina viene contrassegnata e collegata chimicamente all’RNA a cui si lega. Queste coppie RNA-proteina vengono poi convertite in codici a barre di DNA, che possono essere letti utilizzando macchine di sequenziamento standard. In questo modo i ricercatori possono ottenere un catalogo completo delle interazioni RNA-proteina prodotte in un unico esperimento.
Grazie alla nuova metodologia sono state individuate più di 350mila interazioni tra RNA e proteine mai osservate prima. Il team di Zhong ha confermato le proteine note che si legano all’RNA, ma ne ha anche scoperte centinaia di inaspettate. Un esempio è stato la fosfoglicerato deidrogenasi (PHGDH), un enzima che lo stesso team aveva precedentemente identificato come gene causale della malattia di Alzheimer e potenziale biomarcatore ematico per la diagnosi precoce. Dal nuovo studio è emerso che la PHGDH si lega agli RNA messaggeri collegati alla sopravvivenza cellulare e
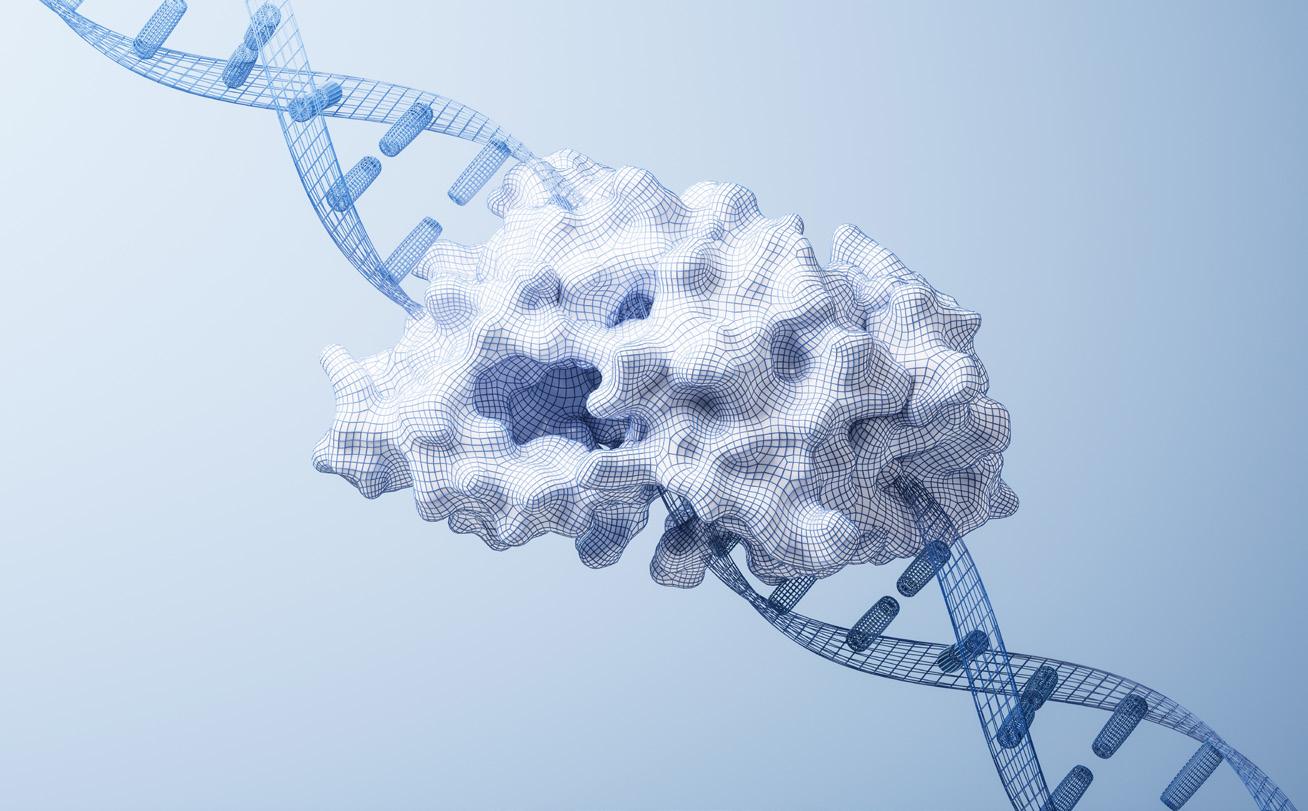
La nuova tecnica prevede che venga congelato il momento in cui gli RNA e le proteine entrano fisicamente in contatto all’interno delle cellule. Ogni proteina viene contrassegnata e collegata chimicamente all’RNA a cui si lega. Queste coppie RNA-proteina vengono poi convertite in codici a barre di DNA, che possono essere letti utilizzando macchine di sequenziamento standard. In questo modo i ricercatori possono ottenere un catalogo completo delle interazioni RNA-proteina prodotte in un unico esperimento
alla crescita nervosa e questo suggerisce che l’enzima può influenzare la salute del cervello anche in altri modi.
Le nuove conversazioni tra RNA e proteine scoperte nello studio potrebbero contribuire inoltre alla scoperta di fattori che favoriscono la crescita e la diffusione dei tumori. Il team ha visto infatti che il lungo RNA non codificante LINC00339 comunica con quindici proteine di membrana ed è elevato in diversi tipi di cancro: le nuove interazioni trovate potrebbero aiutare a comprendere come esso faciliti lo sviluppo e l’espansione della malattia. Sempre partendo dalle interazioni scoperte, secondo il team americano si potrebbero individuare nuovi bersagli farmacologici e approcci terapeutici. «Le interazioni che fungono da leve di controllo per la malattia diventano bersagli farmacologici: l’RNA, la proteina partner o la superficie di contatto tra di essi», ha affermato il coautore dello studio Shuanghong Xue. «Se alcune interazioni RNA-proteina favoriscono la malattia, bloccarle potrebbe essere una potenziale strategia terapeutica. Se altre interazioni proteggono dalla malattia, si potrebbe cercare di preservarle o potenziarle».
Gli autori sottolineano che la tecnica PRIM-seq mostra nell’interazione tra RNA e proteina anche quale regione della proteina è coinvolta e quali sequenze di RNA sono preferite da una data proteina. Questo livello di dettaglio può offrire preziosi spunti per la progettazione di terapie mirate.
Tuttavia Zhong precisa: «Per la maggior parte delle nuove interazioni che abbiamo scoperto, i loro esatti ruoli biologici devono ancora essere definiti». «Il principale progresso in questo campo – continua l’autore - è che abbiamo creato una mappa completa delle potenziali partnership RNA-proteina. Questo apre la strada a future ricerche per capire quali di esse causano la malattia, quali sono protettive e come possiamo colpirle con i farmaci».
Il team di Zhong sta ora applicando la nuova tecnica a modelli di malattie neurodegenerative, tra cui l’Alzheimer e il Parkinson con l’obiettivo di identificare le interazioni RNA-proteina errate che potrebbero servire come base per terapie di nuova generazione. (S. B.).

Iricercatori del Centro Nazionale di Ricerca sul Cancro (CNIO) in Spagna hanno realizzato il primo catalogo di circa 20.000 “cicatrici” del DNA umano, ovvero mutazioni prodotte dai meccanismi di riparazione cellulare che si attivano quando la doppia elica subisce un danno. Il team del CNIO ha identificato i diversi tipi di cicatrici e li ha raccolti e classificati in un portale web, chiamato REPAIRome umano, ora accessibile alla comunità scientifica internazionale. Questo strumento, affermano gli autori, potrà favorire lo sviluppo di nuovi trattamenti personalizzati contro il cancro e migliorare la precisione delle tecnologie di editing genetico attualmente in uso.
Il DNA può subire rotture nei suoi filamenti, causate ad esempio da radiazioni, sostanze chimiche o errori durante la replicazione. Per evitare la morte cellulare, la cellula attiva complessi sistemi di riparazione che, tuttavia, non sono perfetti: nel corso di questi processi possono generarsi modifiche stabili nella sequenza genetica, vere e proprie “cicatrici” del DNA.
Molte terapie antitumorali agiscono proprio provocando rotture nel DNA delle cellule tumorali. Tuttavia, con il tempo, i trattamenti possono perdere efficacia perché le cellule maligne imparano a riparare i danni indotti dai farmaci, sviluppando così resistenza alla terapia. Comprendere in dettaglio come la cellula ripara i danni al DNA, spiegano i ricercatori, può rivelarsi determinante per trovare nuove strategie capaci di superare la resistenza ai trattamenti antitumorali.
Queste “cicatrici” infatti contengono informazioni molto specifiche e rivelano il tipo di danno subito. Svelano anche altri dettagli, ad esempio come la cellula ha riparato la rottura. La conoscenza del REPAIRome può, in tal senso, aiutare a identificare nuovi bersagli terapeutici.
Come spiegano gli autori nello studio, ogni cellula in base ai geni
che esprime o che ha mutati/inattivi, lascia un “pattern” di cicatrici molecolari nel proprio DNA quando tenta di riparare i danni. Il modello di cicatrici varia quindi in funzione dei geni presenti o assenti. Il risultato ottenuto dal gruppo del CNIO è stato quello di rivelare come ciascuno dei nostri geni influisca sulle cicatrici.
Il catalogo, da poco pubblicato su Science, esamina l’impronta mutazionale causata dalle rotture del DNA in 20.000 diverse popolazioni cellulari, ciascuna delle quali priva di un gene specifico. «In questo modo, osservando determinate cicatrici nel DNA dei tumori, è possibile dedurre quali geni non funzionano, e questo è utile per progettare trattamenti specifici», spiega Felipe Cortés, capo del gruppo Topologia del DNA e rotture del DNA del CNIO e autore principale dell’articolo.
Lo sviluppo del REPAIRome umano ha richiesto un lavoro approfondito. I ricercatori del CNIO hanno generato circa 20.000 diverse popolazioni cellulari, disattivando un gene diverso in ciascuna di esse; hanno poi causato rotture in ognuna di esse, utilizzando lo strumento di editing genetico CRISPR. Infine, hanno osservato la traccia (cicatrice) lasciata sulla molecola dopo che la cellula ha riparato la ferita.
Come scrivono gli autori su Science, «REPAIRome è un catalogo che mostra come ciascuno dei circa 20.000 geni umani influenzi i modelli di mutazione derivanti dalla riparazione delle rotture del DNA. Il database può fornire informazioni sui meccanismi di riparazione del DNA, migliorare l’editing genetico e spiegare i modelli di mutazione osservati nel cancro». Il portale web REPAIRome consentirà ai ricercatori di tutto il mondo di verificare rapidamente in che modo ogni gene umano influisce sulla riparazione del DNA, analizzare le correlazioni funzionali tra i geni ed esplorare i percorsi molecolari coinvolti.

Molte terapie antitumorali agiscono proprio provocando rotture nel DNA delle cellule tumorali. Tuttavia, con il tempo, i trattamenti possono perdere efficacia perché le cellule maligne imparano a riparare i danni indotti dai farmaci, sviluppando così resistenza alla terapia. Comprendere in dettaglio come la cellula ripara i danni al DNA, spiegano i ricercatori, può rivelarsi determinante per trovare nuove strategie capaci di superare la resistenza ai trattamenti antitumorali
Grazie a REPAIRome sono già state scoperte nuove proteine coinvolte nella riparazione del DNA, alcune delle quali la favoriscono, mentre altre la ostacolano. Gli stessi autori hanno anche identificato un modello di mutazioni correlate sia al cancro del rene sia a condizioni di ipossia in altri tumori. Queste scoperte aprono la strada a nuove strategie terapeutiche.
Uno dei principali progressi che ha reso possibile lo studio è stato quello di eseguire l’analisi simultaneamente su tutte le 20.000 popolazioni, anziché una per una. Si tratta di uno sviluppo tecnologico specifico che, come afferma Israel Salguero, coautore dello studio «può essere utilizzato per studi futuri che mirano ad analizzare simultaneamente l’effetto di tutti i geni umani».
Gli autori sperano inoltre che il REPAIRome umano contribuirà a migliorare gli attuali strumenti di editing genetico, poiché i nuovi sistemi CRISPR-Cas si basano proprio sull’induzione di rotture per causare cambiamenti specifici nel DNA.
Oltre ad essere uno strumento per gli specialisti nella riparazione del DNA, nell’editing genetico e nell’evoluzione del cancro, il valore aggiunto del catalogo, secondo gli autori, è che consente a qualsiasi ricercatore di esplorare se un gene di interesse influisce sulla riparazione del DNA. (S. B.).
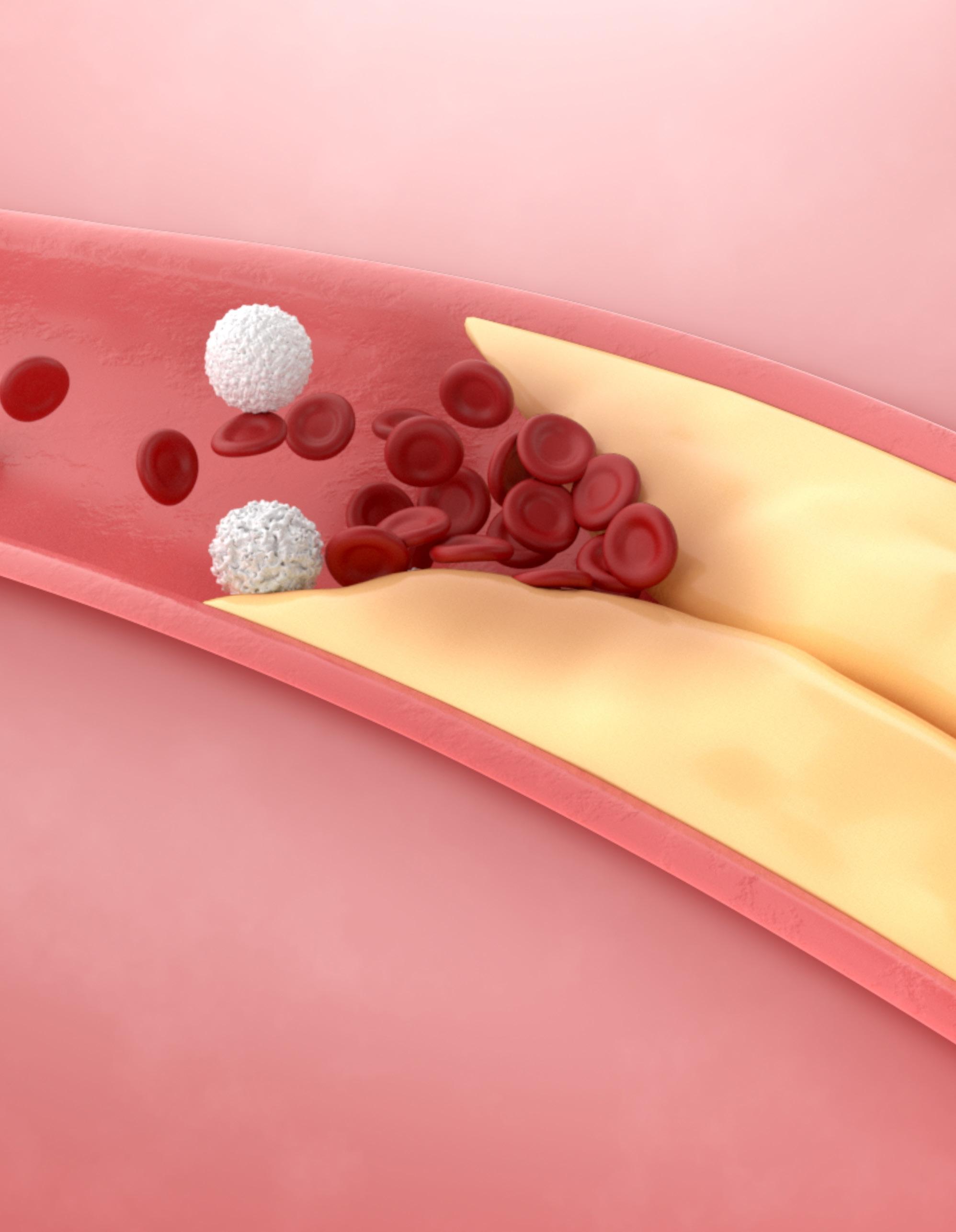
Nelle nuove linee guida Esc-Eas 2025 l’attenzione si sposta su colesterolo Ldl e su una particella ritenuta più subdola e pericolosa: il monito degli esperti
Per anni abbiamo guardato al colesterolo totale come principale indicatore della salute del cuore, ma le nuove linee guida europee dimostrano che quel numero da solo non racconta tutta la storia. Oggi i cardiologi si concentrano sul colesterolo Ldl, il cosiddetto cattivo, e sulla Lipoproteina(a), Lp(a), una particella più subdola e pericolosa, definita dagli esperti il super cattivo.
«Il totale non ha più valore clinico: potrà comparire nei referti, ma non serve a misurare il rischio né a guidare le terapie. Quello che conta davvero è l’Ldl e, d’ora in avanti, anche la Lp(a)», spiega Gianfranco Sinagra, presidente eletto della Società Italiana di Cardiologia. Questa novità sarà al centro della campagna di sensibilizzazione “E tu, hai a cuore il tuo cuore?”, promossa dalla Fondazione Cuore e Circolazione “Il Cuore Siamo Noi” e presentata al Senato lo scorso 2 ottobre in occasione della Giornata mondiale del cuore. La Lp(a) è più pericolosa del classico Ldl perché porta con sé una coda proteica, l’Apolipoproteina(a), che rende il sangue più denso e appiccicoso, favorendo la formazione di placche e trombi. «Il sangue diventa più viscoso e il rischio di trombi e aterosclerosi cresce in modo significativo», spiega Ciro Indolfi, presidente della Federazione Italiana di Cardiologia.
Le linee guida raccomandano di misurare la Lp(a) almeno una volta nella vita di ogni adulto, preferibilmente già al primo controllo del profilo lipidico. Valori superiori a 50 mg/dL devono essere considerati un campanello d’allarme, in grado di spostare una persona in una fascia di rischio più alta, anche se gli altri valori sembrano nella norma. In Italia, il colesterolo alto riguarda circa quattro adulti su dieci, con una prevalenza maggiore negli uomini sopra i 50 anni e nelle donne dopo la menopausa. Circa il 12% della popolazione adulta presenta Ldl superiori a 160 mg/dL, soglia oltre la quale il rischio cardiovascolare aumenta significativamente. Nel
mondo, quasi il 40% della popolazione ha valori di colesterolo elevati e ogni anno circa 4,5 milioni di morti sono collegati a infarti e ictus causati da dislipidemia. L’Ldl rimane il bersaglio principale delle terapie perché l’accumulo di colesterolo nelle arterie può restringere i vasi sanguigni, ridurre il flusso di sangue e provocare eventi acuti, spesso imprevedibili. La Lp(a), invece, rende il quadro più complicato: fino al 20-30% delle persone ha livelli geneticamente elevati, e questi valori non si abbassano facilmente con dieta o attività fisica.

In Italia le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte, con circa 230mila decessi l’anno, e rappresentano anche la principale voce di spesa sanitaria, stimata intorno a nove miliardi di euro l’anno solo per le complicanze acute. Conoscere e misurare il super cattivo può davvero fare la differenza tra un rischio sottovalutato e un infarto evitato
«Prima di passare ai farmaci, occorre curare lo stile di vita: alimentazione equilibrata, movimento regolare, riduzione di alcol e stop al fumo sono le prime mosse vincenti. Raggiungere i target di Ldl così è il risultato migliore possibile», sottolinea Pasquale Perrone Filardi, presidente della Sic. Oggi non ci sono farmaci approvati per abbassare la Lp(a), ma la ricerca è attiva e promettente. Terapie innovative basate su Rna e anticorpi monoclonali hanno mostrato di poter ridurre i livelli fino al 90-98%, aprendo nuove possibilità per
chi ha valori molto alti. Nel frattempo, chi presenta Lp(a) elevata deve prestare attenzione a tutti i fattori di rischio tradizionali: fumo, sedentarietà, ipertensione, diabete e sovrappeso.
La prevenzione resta fondamentale, perché le particelle aterogene agiscono silenziose per anni, accumulandosi prima di manifestare danni evidenti. Anche i più giovani dovrebbero iniziare a monitorare i propri valori lipidici e adottare stili di vita sani fin dall’adolescenza, evitando comportamenti che nel tempo aumentano il rischio cardiovascolare. Le nuove linee guida cambiano anche la pratica clinica: laboratori, software e medici dovranno aggiornarsi e la prevenzione deve diventare più personalizzata.
In Italia le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte, con circa 230mila decessi l’anno, e rappresentano anche la principale voce di spesa sanitaria, stimata intorno a nove miliardi di euro l’anno solo per le complicanze acute. Conoscere e misurare il super cattivo può davvero fare la differenza tra un rischio sottovalutato e un infarto evitato. Secondo studi recenti, nel Sud Italia i livelli di colesterolo alto sono più diffusi rispetto al Nord, legati a stili di vita e accesso ai servizi sanitari, mentre a livello internazionale Paesi con diete ricche di grassi saturi e zuccheri, come gli Stati Uniti, registrano più eventi cardiovascolari rispetto a quelli con regimi mediterranei. La misurazione della Lp(a) può identificare chi, pur avendo Ldl nella norma, è a rischio e ha bisogno di un’attenzione particolare.
Le terapie in sviluppo, insieme a stili di vita corretti e controlli periodici, rappresentano oggi le armi più efficaci per prevenire infarti, ictus e altre complicanze. Oggi il cuore guarda al dettaglio, all’Ldl e alla Lp(a), ma anche alle scelte quotidiane che tutti possiamo fare. Conoscere i propri valori, muoversi, mangiare bene e affidarsi a professionisti aggiornati significa dare a ogni cuore la possibilità di battere a lungo e senza rischi. (D. E.).

Il nuovo strumento clinico si basa su un approccio innovativo Non basta puntare alla perdita di peso, ma occorre considerare anche le eventuali complicanze legate alla malattia
di Sara Bovio
Un nuovo strumento clinico sviluppato dagli esperti dell’European Association for Study of Obesity (EASO) è ora disponibile per aiutare i medici a individuare la terapia farmacologica più efficace e sicura per curare dell’obesità. Si tratta di un algoritmo che mette ordine tra le opzioni farmacologiche stabilendo criteri condivisi per la loro applicazione clinica. Il nuovo algoritmo, pubblicato da un gruppo internazionale di ricercatori sulla rivista Nature Medicine, propone per la prima volta un approccio che tiene conto non solo della perdita di peso, ma anche delle diverse complicanze associate all’obesità come il diabete di tipo 2, le patologie cardiovascolari o la stenosi epatica. Paolo Sbraccia, autore dello studio, professore ordinario di Medicina interna e direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina interna e del Centro medico dell’obesità del Policlinico Tor Vergata, spiega: “Questo algoritmo rappresenta un punto di svolta perché traduce la ricerca scientifica in uno strumento pratico per la clinica. L’obesità non è una condizione temporanea, ma una malattia cronica, che richiede un trattamento continuativo e personalizzato. Offrire ai medici criteri chiari per la scelta del farmaco più adatto significa migliorare la qualità delle cure e prevenire molte delle complicanze più gravi”.
L’indagine di EASO parte da un principio semplice, ma innovativo: la terapia farmacologica deve essere scelta in base alla presenza o assenza delle complicanze legate all’obesità. Non basta, quindi puntare esclusivamente alla riduzione del peso corporeo: occorre valutare il quadro generale del paziente, i rischi metabolici e cardiovascolari, la risposta clinica e la sicurezza del trattamento.
Come spiegano gli autori nello studio, l’obesità è una malattia multifattoriale, cronica, recidivante e non trasmissibile, caratterizzata da un accumulo disfunzionale e/o eccessivo di grasso corporeo. La malattia ha effetti negativi diretti sul funzionamento dei singoli organi, dell’intero organismo o di entrambi e costituisce una porta d’accesso a una vasta gamma di complicanze correlate ad essa. Il numero di farmaci disponibili per il trattamento dell’obesità è in costante aumento negli ultimi anni e si prevede che continuerà a crescere, offrendo ai medici una più ampia selezione di agenti con modalità d’azione distinte da utilizzare insieme agli interventi sullo stile di vita. “Grazie ai nuovi farmaci – precisa Sbraccia – è possibile ottenere risultati che fin a pochi anni fa sembravano impensabili. Ma il vero progresso è imparare a usarli nel modo giusto, integrandoli in un percorso terapeutico personalizzato. L’obesità non è solo una questione estetica, ma una malattia che coinvolge la salute generale e la qualità di vita. Curarla bene significa anche ridurre i costi sociali e sanitari legati alle sue complicanze”.
I ricercatori sottolineano che poiché i diversi farmaci variano nella loro efficacia per la perdita di peso totale e

L’obesità è una malattia multifattoriale, cronica, recidivante e non trasmissibile, caratterizzata da un accumulo disfunzionale e/o eccessivo di grasso corporeo. La malattia ha effetti negativi diretti sul funzionamento dei singoli organi, dell’intero organismo o di entrambi e costituisce una porta d’accesso a una vasta gamma di complicanze correlate ad essa. Il numero di farmaci disponibili per il trattamento dell’obesità è in costante aumento negli ultimi anni e si prevede che continuerà a crescere
nei loro effetti sulle complicanze legate all’obesità, la terapia personalizzata basata sulle caratteristiche individuali del paziente è diventata indispensabile. Nello studio ogni singolo farmaco è stato valutato in base alla sua efficacia nel promuovere la perdita di peso totale, al suo impatto sulle complicanze e al suo profilo di sicurezza. In seguito gli scienziati hanno formulato l’algoritmo con il fine di assistere i medici nella guida del trattamento dell’obesità, allineando il background sanitario di ciascun paziente con i profili d’azione dei farmaci disponibili. Dalla revisione dei principali studi clinici emerge in particolare che i farmaci semaglutide e tirzepatide rappresentano oggi le opzioni più efficaci, in grado di garantire una riduzione significativa del peso e un miglioramento complessivo del profilo metabolico. Per questo motivo, l’algoritmo li indica come trattamenti di prima scelta nella maggioranza dei casi. Quando invece è sufficiente un risultato più contenuto, il documento suggerisce l’impiego di altri farmaci già disponibili, sempre nell’ambito di una strategia di cura continuativa e controllata.
Il lavoro dell’EASO distingue inoltre tra le condizioni legate all’eccesso di massa grassa e quelle causate da un tessuto adiposo disfunzionale, offrendo per ciascuna un orientamento terapeutico specifico. Il team di esperti sottolinea infine la necessità di aggiornare periodicamente lo strumento per includere le nuove evidenze scientifiche che stanno emergendo con grande rapidità nel campo dei farmaci per l’obesità.
La pubblicazione sull’algoritmo arriva a breve distanza dall’importante approvazione della legge Pella che, per la prima volta in Italia, riconosce l’obesità come una malattia cronica, progressiva e recidivante. La normativa, approvata il primo ottobre, garantirà alle persone con obesità l’accesso alle prestazioni sanitarie incluse nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e istituisce un programma organico volto alla prevenzione, al trattamento e all’inclusione sociale delle persone affette.
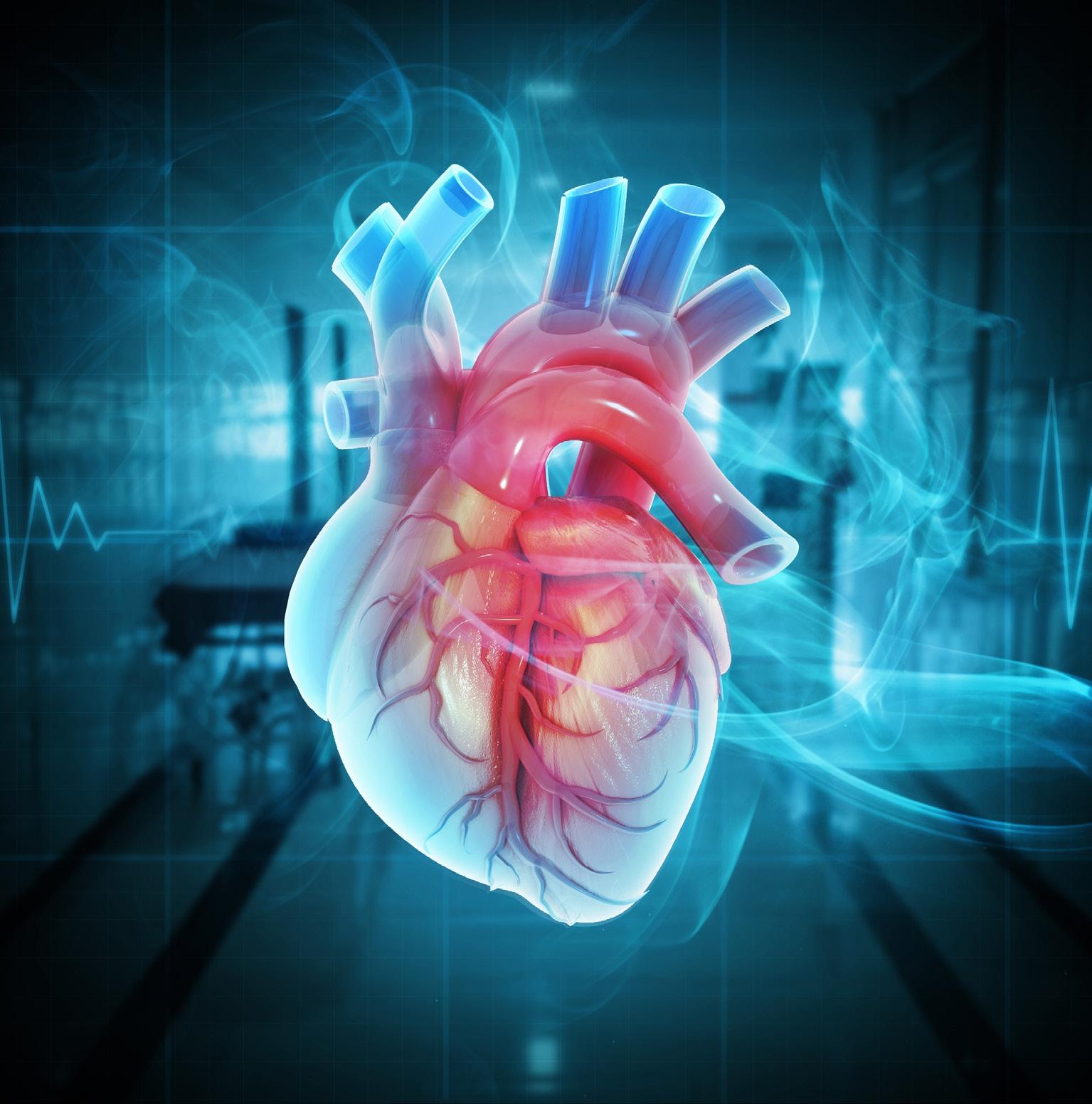
Secondo i dati Passi quattro persone su dieci convivono con almeno tre fattori di rischio: ecco quali sono
Quattro italiani su dieci presentano almeno tre fattori di rischio cardiovascolare. È quanto emerge dai dati della sorveglianza Passi relativi al biennio 2023/24. A mettere a repentaglio la salute del cuore sono soprattutto sedentarietà, fumo ed eccesso ponderale, ovvero sovrappeso e obesità. Poi, le patologie. Come diabete, ipertensione e ipercolesterolemia. Non è una novità e lo certificano anche i dati più recenti snocciolati da Istat e Istituto Superiore di Sanità: il Belpaese è uno dei Paesi più sedentari d’Europa, anche
se in tal senso si registrano - per fortuna - timidi miglioramenti.
I numeri dicono che il 27% degli adulti e il 37% degli anziani non sono in linea con i criteri fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui per mantenersi in forma è necessario svolgere 150 minuti di attività fisica moderata a settimana oppure 75 di attività intensa. La situazione è più preoccupante al Sud, dove si toccano i picchi più alti di sedentarietà con il 38% (24% al Centro, 16% al Nord). Alla ‘pigrizia’ è di riflesso collegata anche la questione bilancia. Le cattive abitudini alimentari
coinvolgono proprio tutti, a partire dai bambini. In Italia già a nove anni un bambino su tre è in sovrappeso e uno dieci presenta obesità. Che è diventata una sfida a livello mondiale. Una novità senza precedenti è rappresentata dalla decisione del Senato di approvare in via definitiva la legge che riconosce l’obesità come malattia cronica, per cui i trattamenti - inseriti nei livelli essenziali di assistenza - diventano a carico del Servizio sanitario nazionale e gratuiti per i pazienti.
L’Italia capofila di una vera e propria rivoluzione a tutela dei suoi cittadini. Perché - lo ricordiamo - l’obesità riguarda anche il 12% della popolazione adulta, cioè circa sei milioni di persone. Tornando ai fattori di rischio cardiovascolare, se l’ipertensione è poco frequente tra i giovani adulti (poco più del 2%), il discorso cambia con l’avanzare dell’età (33% tra i 5069enni): la patologia, come si evince dalle statistiche, è molto spesso collegata all’eccesso ponderale ed è più frequente tra le persone socialmente più svantaggiate. Anche l’ipercolesterolemia è associata all’età (aumento fino al 30% tra i 50-69enni) e all’eccesso di peso: come riferisce il rapporto dell’Osservatorio Passi, colpisce più le donne che gli uomini.
Dai dati raccolti viene fuori che più di quattro persone su dieci che soffrono di colesterolo alto affermano di essere in trattamento farmacologico. Come contrastarlo? Riducendo il consumo di carne e formaggio a favore di frutta e verdura. Abbinando a questi suggerimenti una regolare attività fisica. Un altro elemento chiave è il consumo di sale. La buona notizia è che cinque italiani su dieci ne fanno un uso moderato o comunque provano a gestirlo con attenzione, ma ancora non basta. Sui rischi del sale in eccesso le donne risultano più consapevoli rispetto agli uomini (62% contro il 52) così come gli adulti lo sono più dei giovani (65% tra i 50-69enni; 45% tra i 18-34enni). (D. E.).

Corso Fad
14 novembre 2025
7,5 Crediti Ecm
Una nuova applicazione per individuare i casi di questa e altre patologie retiniche in meno di un secondo

di Elisabetta Gramolini
La battaglia globale contro la cecità prevenibile sta per ricevere un impulso significativo grazie a un’innovazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale (IA). Un nuovo e rivoluzionario tracker retinico, basato sull’IA è stato presentato al convegno annuale della Endocrine Society (Endo 2025), tenuto a San Francisco tra il 12 e il 15 luglio, dimostrando la capacità di analizzare le immagini della retina con una precisione quasi assoluta e di diagnosticare la retinopatia diabetica e altre patologie retiniche in meno di un secondo. Questa scoperta ha il potenziale per ridefinire completamente le strategie di screening oculistico a livello mondiale.
L’applicazione in particolare si chiama Simple mobile ai retina tracker (Smart) e impiega degli algoritmi all’avanguardia per un’analisi rapida e mirata delle immagini del fondo oculare. Ciò che rende Smart particolarmente notevole è la sua funzionalità su comuni dispositivi connessi a Internet, inclusi gli smartphone, democratizzando l’accesso a esami specialistici.
La retinopatia diabetica è una delle principali cause di perdita della vista prevenibile che colpisce oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, un numero destinato a crescere in parallelo all’aumento globale dell’incidenza del diabete. In Italia, i dati epidemiologici dicono che almeno il 30% della popolazione diabetica sia affetto da retinopatia e che annualmente l’1% venga colpito dalle forme gravi e, nonostante l’importanza dello screening, la copertura attuale tra i pazienti diabetici non è ancora ottimale.
L’introduzione di soluzioni tecnologiche avanzate anche nel nostro Paese potrebbe essere di vitale importanza per migliorare la tempestività e la diffusione delle diagnosi. Come ha spiegato Jansi Rani Sethuraj, ricercatore dell’Università del Texas Health Sciences Center di Houston: «L’applicazione Smart AI è stata concepita per ottimizzare il lavoro degli oftalmologi, semplificando le procedure di screening e riducendo i tempi operativi».
sione dell’accesso a valutazioni retiniche di alta qualità anche in quelle regioni meno servite da cure oftalmiche specializzate, superando ostacoli geografici ed economici che in passato limitavano gravemente la prevenzione e il trattamento.
Per garantire la robustezza e l’affidabilità dei modelli di intelligenza artificiale, i ricercatori hanno impiegato migliaia di immagini retiniche anonimizzate, attingendo da diversi set di dati che rappresentano popolazioni eterogenee distribuite in sei continenti. I risultati ottenuti sono stati straordinari: lo strumento ha dimostrato un’impressionante precisione superiore al 99% nella rilevazione e classificazione della retinopatia diabetica, il tutto in meno di un secondo. Oltre a questa velocità sorprendente, il tracker ha anche mostrato la capacità di distinguere la retinopatia diabetica da altre patologie oculari con sintomi simili, un elemento fondamentale per assicurare diagnosi non solo rapide, ma anche altamente accurate.
L’affidabilità e la facilità d’uso di Smart sono state ulteriormente confermate da validazioni indipendenti condotte da professionisti sanitari di varie istituzioni internazionali, che ne hanno riconosciuto l’ampia applicabilità a livello globale. Questa convalida da parte di diverse entità sanitarie rafforza la fiducia nel potenziale dello strumento di affermarsi come una soluzione diffusa e standardizzata per lo screening oculistico.

Inoltre, il dispositivo offre ai medici di base la possibilità di integrare gli esami oculistici nelle visite di routine, favorendo una diagnosi precoce che può salvare la vista. Un altro vantaggio cruciale è l’espanLa retinopatia diabetica è una delle principali cause di perdita della vista prevenibile che colpisce oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, un numero destinato a crescere in parallelo all’aumento globale dell’incidenza del diabete. L’introduzione di soluzioni tecnologiche avanzate anche nel nostro Paese potrebbe essere di vitale importanza per migliorare la tempestività e la diffusione delle diagnosi
L’introduzione di strumenti come il tracker Smart segna un progresso decisivo nella prevenzione della perdita della vista. La retinopatia diabetica, infatti, è una condizione che progredisce spesso in modo asintomatico nelle sue fasi iniziali, causando danni che, se non trattati tempestivamente, possono diventare irreversibili. L’assenza di sintomi rende lo screening regolare un pilastro irrinunciabile per la diagnosi precoce.
Gli esperti, alla luce di questi risultati promettenti, prevedono che questa innovazione abbia la capacità di estendere lo screening a miliardi di persone in tutto il mondo, riducendo drasticamente il numero di casi di cecità evitabile causati dalla retinopatia diabetica e che un futuro, in cui la diagnosi precoce e accessibile diventi la norma grazie ai continui e straordinari progressi dell’intelligenza artificiale nel campo medico sia più vicino.
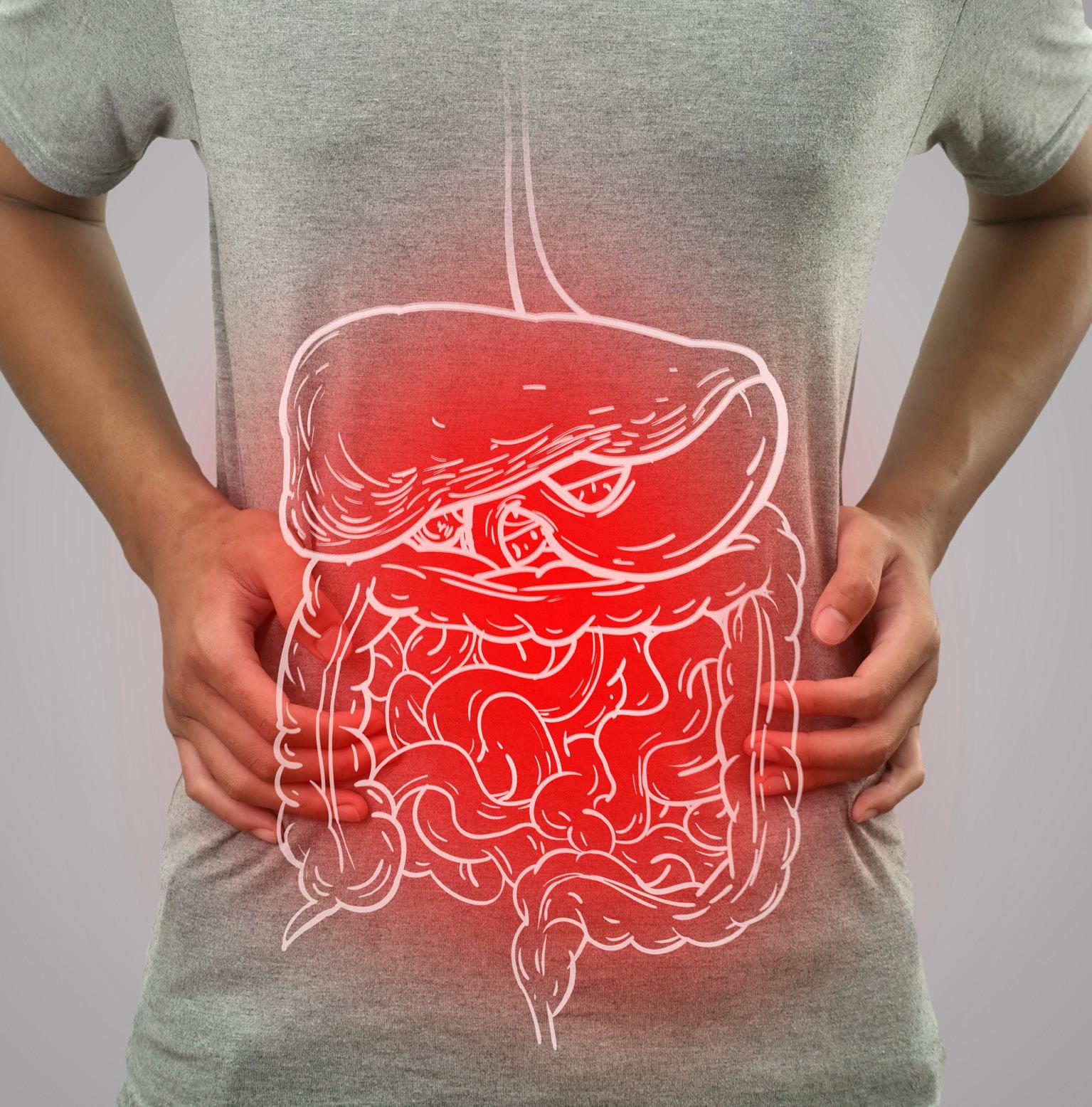
Uno studio del MIT rivela come la cisteina stimoli le cellule staminali e ripari il rivestimento intestinale
L’amminoacido che potrebbe rivoluzionare la medicina rigenerativa è la cisteina. Presente nella carne, nei latticini, nei legumi e nella frutta secca, essa è al centro di uno studio del MIT (Massachusetts Institute of Technology) pubblicato sulla rivista “Nature”, il quale dimostra come una dieta ricca di questo composto favorisca la rigenerazione del rivestimento dell’intestino tenue.
I ricercatori, guidati da Omer Yilmaz e Fangtao Chi, hanno testato venti amminoacidi per osservare l’effetto sulla rigenerazione delle cellu -
le staminali intestinali. La cisteina è l’amminoacido che ha mostrato l’impatto più significativo, attivando un meccanismo immunitario sorprendente: essa, una volta assorbita, viene convertita in CoA, un cofattore che stimola i linfociti T CD8 a produrre IL-22, una citochina (cioè una molecola proteica prodotta da vari tipi di cellule di solito in risposta a uno stimolo) fondamentale per la rigenerazione cellulare. Questo processo si verifica soprattutto nell’intestino tenue, dove avviene l’assorbimento delle proteine.
Gli effetti sono stati evidenti si -
mulando i danni che colpiscono i pazienti oncologici durante la radioterapia. In esperimenti successivi, il team ha osservato che la cisteina protegge anche da quelli causati dal 5-fluorouracile, un comune farmaco chemioterapico.
L’importanza di questa scoperta risiede nell’uso di un composto alimentare naturale e non sintetico, e la ricerca apre a nuove prospettive per la medicina nutrizionale e rigenerativa, suggerendo che un intervento dietetico mirato potrebbe supportare la guarigione dei tessuti danneggiati.
Gli scienziati puntano ora a verificare se la cisteina possa avere effetti simili su altri tessuti e tipi di cellule staminali. Se confermato, questo amminoacido diventerebbe un alleato preziosissimo nella lotta contro le malattie intestinali e gli effetti collaterali dei trattamenti oncologici.
Inoltre, lo studio è il primo a identificare un singolo nutriente capace di attivare una via immunitaria specifica per la rigenerazione intestinale. In passato, si era osservato come diete ipocaloriche o ricche di grassi influenzavano l’attività delle cellule staminali, ma mai era stato verificato con tanta precisione molecolare.
Inoltre, altri studi paralleli, pubblicati su “Nature Metabolism”, hanno mostrato che la cisteina è coinvolta anche nella regolazione del metabolismo lipidico, suggerendo come essa abbia un ruolo perfino più ampio nella salute umana. Nelle sperimentazioni, ridurre la cisteina ha provocato una drastica perdita di peso, mentre la sua reintroduzione ha ripristinato la massa corporea.
Ciò evidenzia quanto sia fondamentale per l’equilibrio metabolico. Da semplice “comparsa” alimentare potrebbe quindi trasformarsi in una protagonista della salute intestinale e metabolica, offrendo la possibilità di comprendere il legame tra nutrizione, immunità e rigenerazione cellulare. (M. O.). © airdone/shutterstock.com
Il progresso non ferma i tumori. Per quanto l’aspettativa di vita in seguito alla scoperta di un cancro sia in costante miglioramento grazie alle ultime scoperte e alle cure sempre più efficaci, uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista The Lancet lancia l’allarme: nei prossimi 25 anni il numero di casi di neoplasie annui potrebbe passare dai 18,5 milioni attuali ad addirittura più di 30 milioni. Tradotto: un aumento del 61%. Ma a preoccupare è anche e soprattutto il dato relativo ai decessi che rischia di registrare un incremento fino al 75%.
Lo scenario dipinto dagli esperti di tutto il mondo che hanno collaborato al programma di ricerca Global Burden of Disease Study riferisce numeri da brividi: le vittime dei tumori potrebbero passare da 10,4 a 18,6 milioni. A fare il punto è l’autrice principale dello studio, Lisa Force dell’Institute for Health Metrics and Evaluation della University of Washington. La scienziata rivela anche quali sono i Paesi più esposti ai rischi di questo aumento che sembra inevitabile: «Nei prossimi decenni prevediamo una crescita sostanziale dei casi, in particolare in quei Paesi che hanno a disposizione risorse limitate».
E si entra nel dettaglio. In base a quanto emerso dallo studio, sono tre i fattori che contribuiscono in maniera determinante all’incremento dei tumori. Il primo è legato alla crescita demografica, il secondo all’invecchiamento della popolazione - e questo è purtroppo un fenomeno che riguarda l’Italia da vicino essendo il quinto Paese più vecchio del mondo per il World Factbook della Cia -, il terzo alla diffusione di fattori di rischio che si rivelano terreno fertile per l’insorgenza di neoplasie.
In prima fila - e non è un mistero, ormai - il consumo di tabacco, già ritenuto responsabile del 21% dei decessi dovuti al cancro. Ma incidono anche l’alimentazione scorretta, l’a -
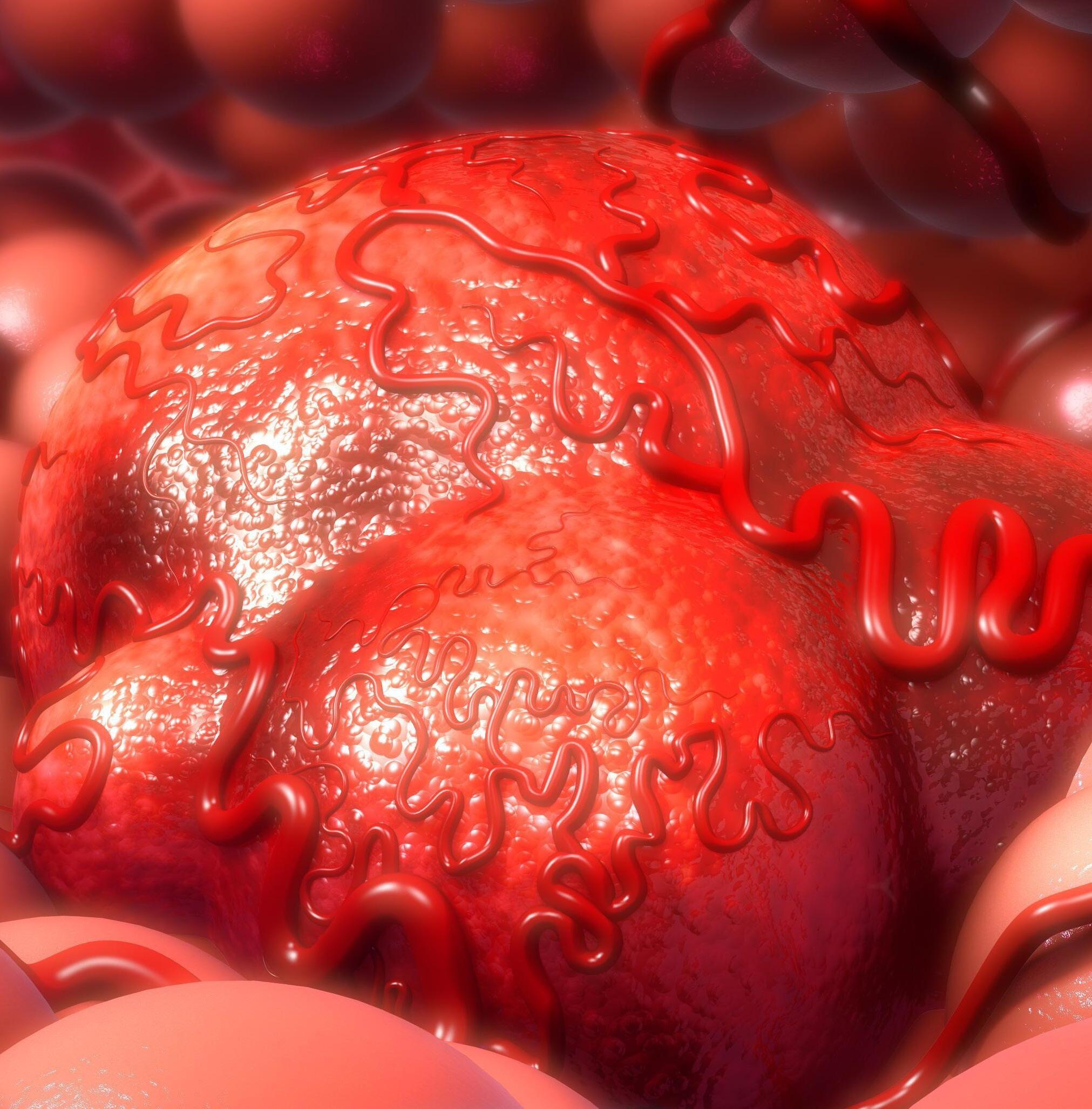
Sos degli esperti: nei prossimi 25 anni i decessi potrebbero passare dai 18,5 milioni attuali a più di 30 milioni
buso di alcol, l’inquinamento atmosferico e l’obesità. La stima, come rivelato dal coautore dello studio Theo Vos, è di «quattro decessi per cancro su dieci legati a fattori di rischio noti, per cui i Paesi hanno l’opportunità di intervenire e salvare vite». Oltre a uno stile di vita corretto, è necessario agire con diagnosi tempestive e terapie efficaci. Dunque, individuare un cancro in tempo può cambiare tutto.
In tal senso va rimarcata l’importanza della prevenzione e anche quella dell’adesione ai programmi di screening. Resta, però, l’allarme legato per i Paesi a basso e medio reddito,
dove con ogni probabilità si registreranno due terzi dei decessi.
Meghnath Dhimal del Nepal Health Research Council e coautore della ricerca non usa certo giri di parole. Arriva dritto al punto. Parla di «disastro imminente», ricordando, però, che «per i Paesi in fase di sviluppo esistono interventi economicamente vantaggiosi». Le risorse ci sono, ma vanno sfruttate e anche implementate. Per invertire il trend negativo, già in corso da anni, è necessario adottare strategie d’intervento mirate che riguardano anche la quotidianità delle persone. (D. E.).
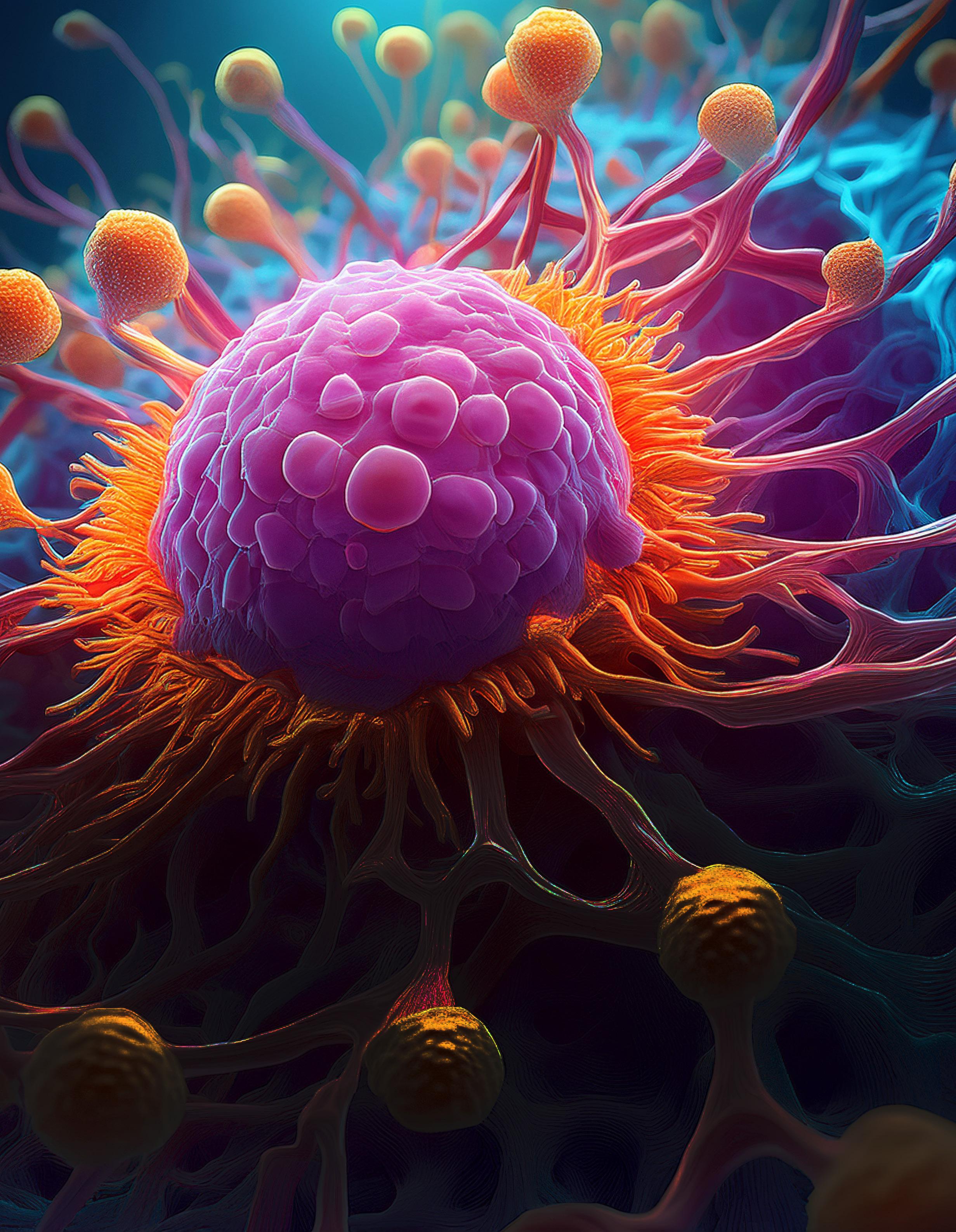
Un team del Mit ha individuato dei nuovi vettori che, con il loro design
Una nuova generazione di nanoparticelle progettate per assomigliare a minuscoli scovolini potrebbe rivoluzionare il modo in cui vengono somministrati i farmaci anticancro. Grazie al loro design innovativo, queste particelle sono in grado di trasportare e rilasciare alle cellule tumorali da decine fino a centinaia di molecole di farmaco, superando di gran lunga la capacità delle nanoparticelle oggi utilizzate, che raramente riescono a veicolarne più di dieci. Il risultato, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Biotechnology, arriva dal Massachusetts Institute of Technology (Mit), porta la firma del gruppo guidato da Jeremiah Johnson, professore di chimica e ingegneria dei materiali. Gli esperimenti hanno mostrato risultati sorprendenti: nella maggior parte dei casi, il trattamento con queste nuove nanoparticelle ha portato alla quasi completa eliminazione dei tumori.
Uno dei principali obiettivi della ricerca oncologica è da sempre quello di trovare strategie terapeutiche capaci di distruggere selettivamente le cellule tumorali, risparmiando quelle sane. La chemioterapia tradizionale, pur restando uno strumento fondamentale, agisce in modo poco selettivo: i farmaci chemioterapici circolano in tutto l’organismo e colpiscono anche cellule in rapida divisione non tumorali, come quelle dei follicoli piliferi o della mucosa intestinale, generando gli effetti collaterali noti.
Per migliorare la precisione dei trattamenti, negli ultimi anni si è affermata la tecnologia dei coniugati anticorpo-farmaco (Adc, antibody-drug conjugates), una classe di farmaci che combina l’elevata specificità degli anticorpi monoclonali con l’efficacia dei chemioterapici. In pratica, il farmaco viene legato chimicamente a un anticorpo che riconosce una proteina presente sulla superficie delle cellule tumorali: una volta raggiunto il bersaglio, il complesso entra nella cellula e rila-
scia il principio attivo, distruggendola. Il limite principale di questa strategia, tuttavia, è legato alla quantità di farmaco che ogni anticorpo può trasportare: di norma si tratta di meno di dieci molecole per anticorpo, una quantità che riduce l’efficacia del trattamento, soprattutto nei tumori più aggressivi. Per superare questo ostacolo, il team del Mit ha ripensato completamente la struttura del sistema di trasporto del farmaco. L’idea è nata da un concetto apparentemente semplice: e se le molecole di farmaco potessero essere agganciate a una struttura capace di contenerne molte di più, senza compromettere la precisione del bersaglio? Da qui la creazione delle cosiddette brush nanoparticles, letteralmente “nanoparticelle a scovolino”. Si tratta di minuscole strutture polimeriche formate da uno scheletro centrale al quale sono fissate numerose setole, ognuna delle quali porta una molecola di farmaco. Queste molecole restano inizialmente inattive, per poi essere attivate solo una volta rilasciate all’interno dell’organismo, evitando così danni prematuri ai tessuti sani. Il risultato è una nanoparticella che può trasportare centinaia di molecole di farmaco contemporaneamente, con un’efficienza mai vista prima. Ma non solo: la particolare architettura dello scovolino permette di caricare diversi tipi di farmaci sulla stessa particella, rendendo possibile la combinazione di terapie mirate e personalizzate. Una delle innovazioni più interessanti del nuovo sistema è la possibilità per ogni anticorpo di legare non una, ma fino a tre nanoparticelle contemporaneamente. Questo significa che, di fatto, ogni molecola di anticorpo può veicolare centinaia di molecole di farmaco verso la cellula tumorale, aumentando in modo esponenziale la potenza del trattamento senza accrescere la tossicità sistemica.
«Con questa tecnologia possiamo esplorare una nuova gamma di combinazioni terapeutiche, ha spiegato Johnson. Possiamo somministrare più
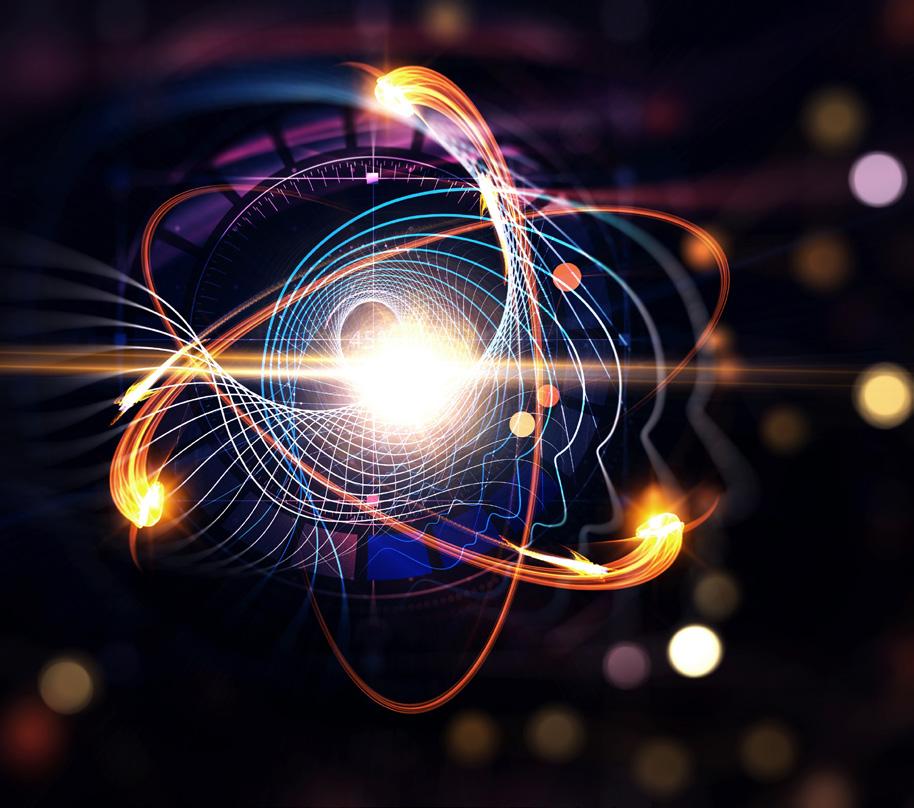
L’idea è nata da un concetto apparentemente semplice: e se le molecole di farmaco potessero essere agganciate a una struttura capace di contenerne molte di più, senza compromettere la precisione del bersaglio?
Da qui la creazione delle cosiddette brush nanoparticles, letteralmente “nanoparticelle a scovolino”.
farmaci insieme, in dosi controllate e mirate, per colpire i tumori su più fronti e ridurre il rischio che sviluppino resistenza.» La ricerca si colloca nel contesto più ampio della medicina di precisione, che mira ad adattare le terapie alle caratteristiche genetiche e biologiche di ciascun paziente. La possibilità di utilizzare nanoparticelle modulari, capaci di trasportare farmaci differenti, apre la strada a trattamenti su misura: per esempio, un singolo paziente potrebbe ricevere un cocktail di farmaci selezionati per agire su specifiche mutazioni del suo tumore.
Un ulteriore vantaggio è la flessibilità della piattaforma tecnologica: le nanoparticelle a scovolino possono essere modificate per trasportare non solo chemioterapici, ma anche molecole di Rna, immunoterapici o altre sostanze bioattive. Questo le rende potenzialmente utili non solo contro il cancro, ma anche per altre patologie complesse, come le malattie autoimmuni o le infezioni croniche. Sebbene i risultati siano promettenti, saranno necessari ulteriori studi per valutare la sicurezza e l’efficacia delle nanoparticelle. «Ogni nuova tecnologia richiede tempo per essere tradotta in applicazioni cliniche - ha sottolineato Johnson -. Ma le potenzialità di questa piattaforma sono enormi: potremmo finalmente superare uno dei limiti più grandi della chemioterapia, offrendo trattamenti più potenti, mirati e tollerabili». (C. P.).
Nel linguaggio comune, metabolismo è sinonimo di energia, nutrimento, trasformazione. Ma un nuovo studio del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (EMBL), pubblicato sulla rivista Science Advances, mostra che questa parola nasconde molto di più: il metabolismo non si limita a fornire carburante alla vita, ma ne regola anche il ritmo. Il gruppo di ricerca coordinato da Alexander Aulehla, esperto di biologia dello sviluppo, ha osservato un meccanismo sorprendente: quando il metabolismo accelera, lo sviluppo rallenta e viceversa.
Un paradosso solo apparente, che apre una finestra su un livello di controllo biologico finora in gran parte sconosciuto. Lo sviluppo embrionale è un processo sincronizzato. Le cellule si dividono, si differenziano e si organizzano secondo schemi temporali precisi, governati da una sorta di orologio molecolare che scandisce il tempo di formazione dei tessuti e degli organi. Questo orologio, studiato da anni, si pensava dipendesse soprattutto da meccanismi genetici e segnali chimici che regolano la comunicazione cellulare.
Lo studio, però, ribalta questa prospettiva: anche il metabolismo contribuisce a regolare il ritmo dello sviluppo. E non come semplice fornitore di energia, ma come un sistema di controllo del tempo biologico. In particolare, i ricercatori si sono concentrati su una piccola molecola: il fruttosio-1,6-bisfosfato (Fbp), un intermedio della glicolisi, la via metabolica che scompone il glucosio per produrre energia.
Durante gli esperimenti, hanno osservato che variazioni nei livelli di Fbp si accompagnavano a modifiche nel ritmo dell’orologio embrionale: quando la concentrazione di questa molecola aumentava, i cicli dello sviluppo rallentavano; quando diminuiva, acceleravano. Per capire il
significato di questa relazione, il team di Aulehla ha utilizzato tecniche avanzate di imaging e tracciamento in tempo reale.
Grazie a marcatori fluorescenti, è stato possibileW seguire l’attività metabolica e il comportamento delle cellule durante le prime fasi dello sviluppo, osservando come le oscillazioni di Fbp si sincronizzassero con i segnali che coordinano la formazione dei tessuti. Il risultato è stato inequivocabile: il metabolismo non è un semplice spettatore, ma un attore centrale, capace di modulare la velocità dei processi di sviluppo.
«Quello che abbiamo scoperto, ha spiegato Aulehla, è una connessione diretta tra l’attività metabolica e il ritmo dell’orologio dello sviluppo. È un po’ come se la cellula aves -
Uno studio rivela che il ricambio ma ne regola il ritmo, sincronizzando
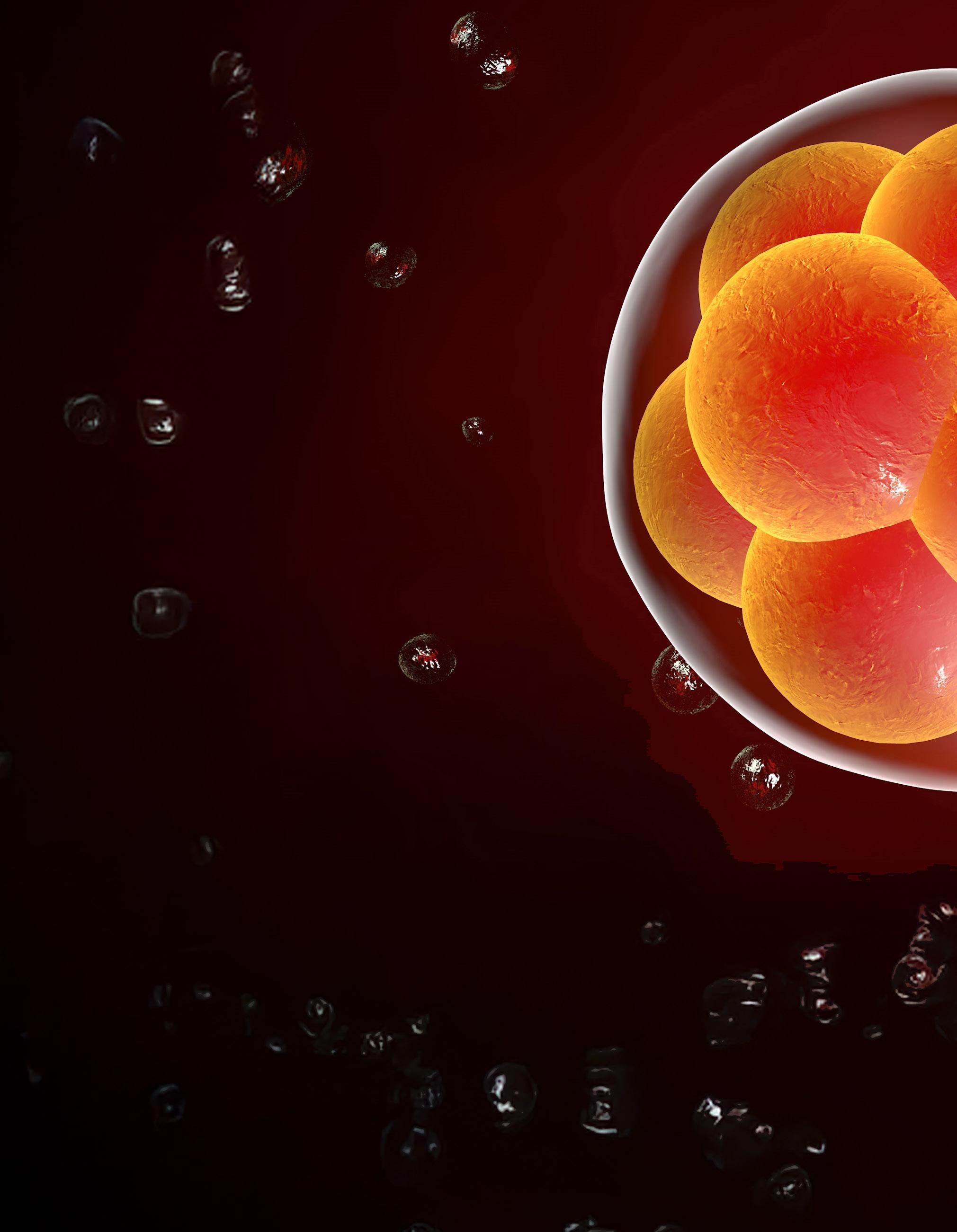
se due orologi che si influenzano a vicenda: quello genetico e quello metabolico». L’analogia più calzante, secondo i ricercatori, è con l’orologio circadiano, il sistema che regola i cicli quotidiani di sonno, veglia e altre funzioni fisiologiche. Come il ritmo circadiano è sincronizzato con l’alternanza tra luce e buio, così il metabolismo sembrerebbe sincronizzare lo sviluppo con i ritmi interni ed esterni dell’ambiente. In questo senso, la molecola
Fbp avrebbe un ruolo simile a quello della luce per l’orologio circadiano: un segnale guida, capace di “mettere d’accordo” le cellule sui tempi del loro comportamento collettivo.
«Ci siamo chiesti, ha aggiunto Aulehla, se il metabolismo stesso possa agire da
ricambio biologico non solo nutre la vita sincronizzando la crescita degli embrioni
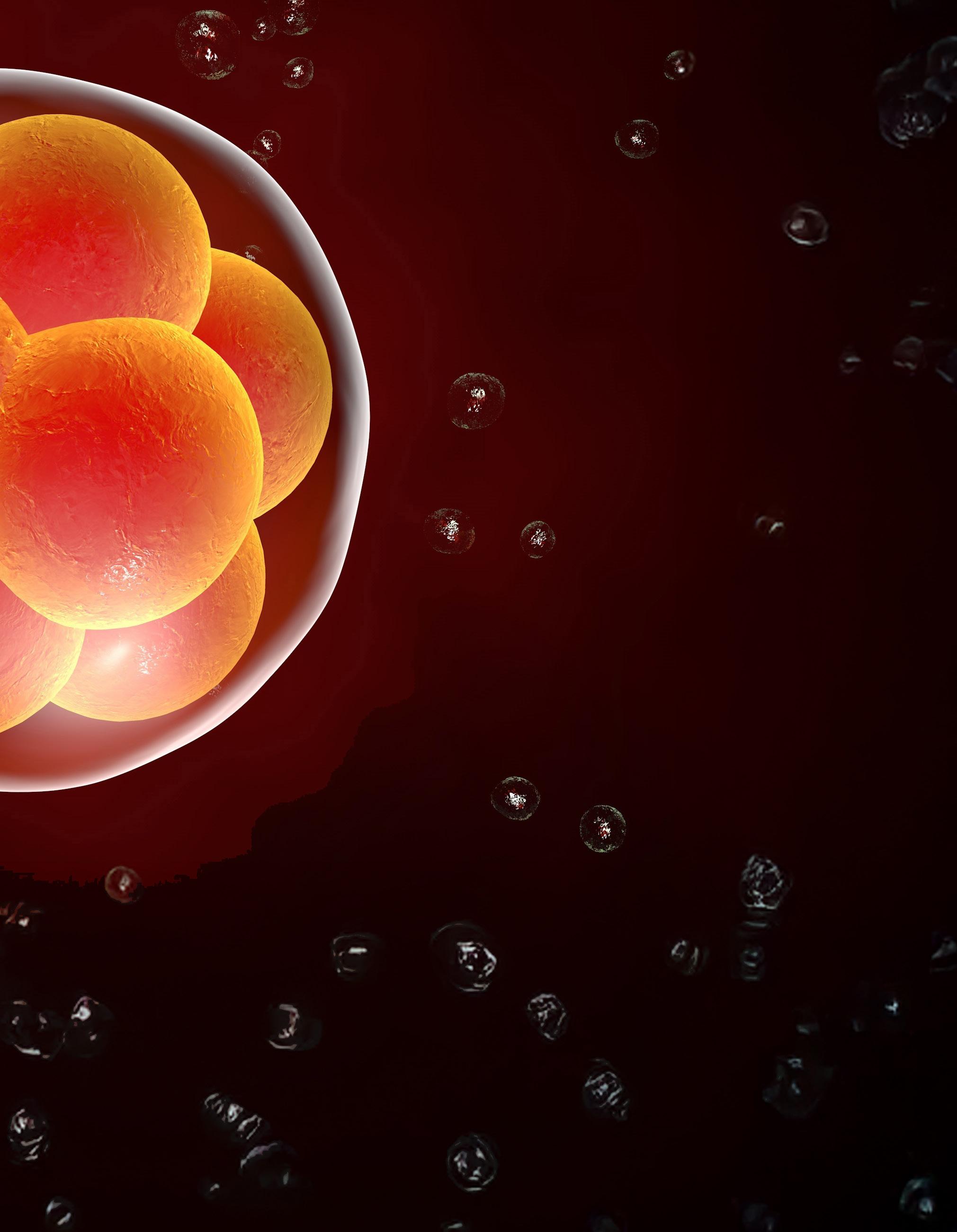
pacemaker, collegando gli orologi interni degli organismi ai ritmi esterni dell’ambiente. Poiché il metabolismo è naturalmente influenzato da fattori come il ciclo giorno-notte o la disponibilità di nutrienti, è plausibile che funzioni da ponte tra l’interno e l’esterno». Le ricadute di questa scoperta vanno ben oltre la biologia dello sviluppo. Comprendere come il metabolismo controlli il tempo dello sviluppo potrebbe, infatti, aiutare a spiegare perché alcune malformazioni congenite si originano da squilibri metabolici o da esposizioni a sostanze che alterano il metabolismo materno.
Inoltre, la ricerca apre prospettive anche per la medicina rigenerativa e lo studio delle cellule staminali. Se il metabolismo è un fattore chiave nel determinare la velocità e la precisione di questi processi, intervenire su di esso potrebbe permettere di accordare il ritmo dello sviluppo artificiale dei tessuti. Infine, questa scoperta rafforza una visione ormai sempre più condivisa della biologia: quella di un sistema integrato, in cui metabolismo, genetica e segnali ambientali dialogano costantemente, senza confini netti tra energia e informazione.
WIl metabolismo si rivela dunque una componente regolatoria fondamentale del processo vitale. La sua capacità di influenzare il tempo dello sviluppo suggerisce che la vita, fin dai suoi stadi più precoci, sia guidata da ritmi interconnessi, dove energia e forma si modulano reciprocamente. «La nostra sfida futura, ha concluso Aulehla, sarà capire se questo principio vale anche per altre specie, inclusi gli esseri umani, e in che modo i ritmi metabolici si intrecciano con quelli circadiani. Potremmo scoprire che il tempo della vita è scritto non solo nei geni, ma anche nel modo in cui le cellule respirano, si nutrono e si scambiano energia». (C. P.).
Giornale dei Biologi | Ott 2025 41
Un nuovo studio svela un meccanismo epigenetico che permette di tramandare la longevità da una generazione all’altra senza modificare il Dna. La possibilità di vivere più a lungo, infatti, potrebbe non dipendere solo dai geni ereditati dai propri genitori, ma anche da segnali molecolari capaci di istruire le cellule riproduttive a trasmettere il segreto della lunga vita. È questa la conclusione a cui è giunto un gruppo di ricercatori dell’Istituto medico Howard Hughes, negli Stati Uniti, coordinato dalla biologa molecolare Meng Wang.
Il team ha dimostrato che una proteina può agire come un vero e proprio messaggero intercellulare, viaggiando dalle cellule somatiche, quelle che compongono i tessuti e gli organi del corpo, alle cellule germinali, cioè quelle destinate a formare la progenie. Nel suo viaggio, questa proteina induce modifiche epigenetiche al Dna delle cellule riproduttive, applicando etichette molecolari che regolano l’attivazione o
la disattivazione di specifici geni. In altre parole, la longevità può essere ereditata senza cambiare la sequenza del Dna, ma solo attraverso un sistema di comunicazione molecolare.
Per arrivare a questa scoperta, gli scienziati hanno aumentato artificialmente la produzione di un enzima lisosomiale. I lisosomi sono i centri

di riciclo delle cellule: degradano e smaltiscono materiali di scarto e proteine danneggiate, contribuendo a mantenere l’equilibrio cellulare. Un’attività lisosomiale efficiente è da tempo associata a una maggiore longevità in diverse specie. Si è così scoperto che le generazioni seguenti, alle quali è stata aumentata l’attività lisosomiale, hanno vissuto più a lungo pur non possedendo la mutazione genetica che aveva esteso la vita dei genitori. Questo dato ha costretto i ricercatori a porsi una domanda cruciale: come poteva la caratteristica della longevità essere trasmessa senza un cambiamento nel Dna? L’indizio è arrivato analiz -
zando l’assetto epigenetico, cioè l’insieme delle modifiche chimiche che influenzano l’espressione genica senza alterare la sequenza del genoma. Il team ha scoperto che le cellule somatiche dei longevi inviavano segnali alle cellule germinali, che reagivano modificando l’attività di alcuni geni legati al metabolismo e alla resistenza cellulare. A mediare questa comunicazione è una proteina associata agli istoni, le strutture che fungono da supporto per il Dna e ne regolano il grado di compattamento.
Gli istoni non modificano il codice genetico, ma possono, attraverso delle piccole molecole, marcare i geni da accendere o spegnere. In questo caso, gli istoni si comportano come un ponte molecolare, trasferendo l’informazione dai tessuti corporei alle cellule riproduttive e garantendo così che la progenie erediti un programma genetico favorevole alla longevità. La scoperta aggiunge un tassello importante al campo dell’epigenetica. Negli ultimi anni, è emerso che numerosi fattori ambientali (dieta, stress, attività fisica, esposizione a tossine) possono lasciare tracce epigenetiche nel Dna, influenzando non solo la salute individuale ma anche
quella delle generazioni future.
Il lavoro di Wang e colleghi mostra per la prima volta un canale diretto di comunicazione tra cellule somatiche e germinali, capace di trasmettere informazioni biologiche acquisite durante la vita. «Questa ricerca cambia la nostra visione della trasmissione ereditaria - ha spiegato la ricercatrice -. Non tutto ciò che ereditiamo è scritto nella sequenza del Dna: esistono altri livelli di informazione che possono influenzare profondamente il destino delle generazioni successive.»
Le implicazioni dello studio vanno ben oltre il semplice allungamento della vita. Se processi simili fossero confermati anche nell’uomo, si aprirebbero scenari straordinari: le esperienze fisiologiche e ambientali di un individuo potrebbero lasciare una memoria molecolare nei suoi discendenti. Questo meccanismo potrebbe spiegare perché alcuni tratti, come la predisposizione a malattie metaboliche, cardiovascolari o neurodegenerative, si manifestano anche in assenza di mutazioni genetiche evidenti. Potrebbe inoltre aiutare a comprendere come interventi sullo stile di vita o sulla dieta in età adulta possa -

Negli ultimi anni, è emerso che numerosi fattori ambientali (dieta, stress, attività fisica, esposizione a tossine) possono lasciare tracce epigenetiche nel Dna, influenzando non solo la salute individuale ma anche quella delle generazioni future
no produrre benefici duraturi per le generazioni future. Naturalmente, gli autori sottolineano che siamo ancora lontani dal poter trasporre questi risultati all’uomo. Tuttavia, la scoperta rappresenta un passo cruciale verso una nuova comprensione dell’eredità biologica. (C. P.).

La scoperta rivela come i segnali epigenetici si trasmettano tra generazioni senza modificare il Dna, ma regolando l’espressione dei geni
Nel sangue dei pazienti affetti dalla malattia di Parkinson si nasconde forse una nuova via per comprendere e trattare la patologia. Lo rivela uno studio tutto italiano, condotto su 69 pazienti dal centro di ricerca Ceinge Biotecnologie Avanzate “Franco Salvatore” di Napoli, e pubblicato sulla rivista internazionale NPJ Parkinson’s Disease. I risultati aprono un nuovo scenario nella comprensione del Parkinson, suggerendo che le alterazioni metaboliche identificate nel sangue potrebbero diventare bersagli terapeutici capaci di potenziare l’efficacia dei trattamenti attuali.
Il lavoro, frutto di una collaborazione tra il Ceinge e numerose istituzioni accademiche e cliniche italiane, tra cui le Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, di Pavia, di Salerno, la Cattolica del Sacro Cuore di Roma e la Federico II di Napoli, insieme alle Fondazioni Mondino di Pavia e al Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, rappresenta un importante passo avanti nella comprensione dei meccanismi biologici alla base della malattia.
Coordinati da Alessandro Usiello (Ceinge e Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), Enza Maria Valente (Università di Pavia e Fondazione Mondino) e Andrea Urbani (Policlinico Gemelli e Università Cattolica del Sacro Cuore), i ricercatori hanno individuato anomalie nel metabolismo degli amminoacidi, le molecole che costituiscono le proteine, e in altre vie metaboliche legate ai mitocondri, le centrali

energetiche delle cellule. La malattia di Parkinson, che colpisce oltre 400mila persone solo in Italia, è una patologia neurodegenerativa cronica e progressiva che comporta la perdita dei neuroni dopaminergici, con conseguenze motorie e cognitive. I trattamenti attuali si concentrano soprattutto sul controllo dei sintomi, attraverso farmaci che compensano la carenza di dopamina o agiscono sui suoi recettori, ma non arrestano la progressione della malattia. Da tempo, la ricerca si sta orientando verso l’identificazione di biomarcatori periferici, cioè segnali misurabili nel sangue o in altri fluidi biologici, che possano riflettere ciò che accade nel cervello dei pazienti. In questo contesto, l’approccio metabolomico (lo studio complessivo dei metaboliti, le piccole molecole prodotte dalle reazioni chimiche dell’organismo) sta emergendo come uno strumento potente per individuare nuovi indizi fisiopatologici.
«Abbiamo osservato che il profilo metabolico dei pazienti parkinsoniani presenta differenze significative rispetto a quello dei soggetti sani, ha spiegato Alessandro Usiello. In particolare, le alterazioni riguardano gli amminoacidi e altre molecole coinvolte nel funzionamento dei mitocondri. Correggere queste anomalie e ristabilire l’equilibrio metabolico potrebbe rappresentare una strategia complementare alle terapie attuali, potenziandone
Nel sangue la chiave della patologia
Uno studio italiano svela nuove alterazioni metaboliche che aprono la strada a terapie combinate
di Carmen Paradiso

l’efficacia». L’osservazione di disfunzioni mitocondriali nei pazienti con Parkinson non è nuova: da decenni si sa che i mitocondri, responsabili della produzione di energia nelle cellule, sono vulnerabili ai processi ossidativi che contribuiscono alla morte neuronale. Tuttavia, questo studio aggiunge un tassello inedito: le alterazioni metaboliche riscontrate nel sangue riflettono probabilmente una disfunzione sistemica, che non riguarda solo il cervellom, ma l’intero organismo. Tra le molecole alterate figurano diversi amminoacidi implicati nella sintesi dei neurotrasmettitori e nella regolazione del metabolismo energetico. «Si tratta di un dato di grande interesse, ha commentato Enza Maria Valente, perché ci suggerisce che il Parkinson potrebbe non essere soltanto una malattia del cervello, ma una condizione in cui l’intero metabolismo è coinvolto. Se confermati, questi risultati potrebbero portare allo sviluppo di terapie combinate, in grado di agire sia sul sistema nervoso centrale sia sul metabolismo periferico». I ricercatori ritengono che questo studio possa costituire una base solida per future ricerche
su campioni più ampi. L’obiettivo è duplice: confermare le alterazioni individuate e comprendere quali siano le cause molecolari che le determinano.
«Restano ancora da chiarire diversi aspetti - ha precisato Usiello -. In particolare, vogliamo capire se queste anomalie metaboliche siano influenzate da fattori genetici o dal sesso dei pazienti. La medicina di precisione, che tiene conto delle differenze individuali, sarà cruciale per sviluppare interventi mirati».
L’identificazione di biomarcatori metabolici nel sangue potrebbe inoltre semplificare la diagnosi precoce del Parkinson, oggi basata soprattutto sull’osservazione clinica dei sintomi motori, spesso quando la malattia è già in fase avanzata. «Un test ematico in grado di rilevare precocemente alterazioni specifiche, ha aggiunto Urbani, permetterebbe di intervenire prima che la degenerazione neuronale diventi irreversibile». Oltre al valore scientifico, il lavoro rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni accademiche, cliniche e centri di ricerca, distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Siamo ancora lontani da una cura definitiva, ma ogni passo verso la comprensione dei meccanismi del Parkinson ci avvicina a trattamenti più efficaci e personalizzati.


Promuovere la salute della pelle e benessere emotivo attraverso percorsi sensoriali mirati
Èstato dimostrato che gli aromi sono utili nella gestione di sintomi come dolore, nausea, benessere generale, ansia, depressione, stress e insonnia anche attraverso l’olfatto, perché attivano i recettori TRPV (canali ionici sensoriali nella pelle che rispondono a stimoli fisici e chimici), presenti nei cheratinociti, nei neuroni sensoriali, nei melanociti e nelle cellule immunitarie, aiutano a regolare il dolore, il prurito, l’infiammazione, la pigmentazione e la guarigione delle ferite.
Il loro malfunzionamento porta a dermatite, vitiligine, alopecia e prurito cronico. I principali tipi di TRP includono TRPV1 (calore, capsaicina), TRPA1 (freddo, stress ossidativo), TRPM8 (rilevamento del freddo) e TRPM1 (pigmentazione); e CBD recettori dei cannabinoidi (CB1 e CB2) coinvolti nell’omeostasi della pelle, modulano funzioni cruciali come l’infiammazione, la nocicezione, la produzione di sebo e la regolazione immunitaria.
L’attivazione di questi da parte dei fitocannabinoidi e dei ligandi endogeni suscita interesse per l’uso clinico dei cosmeceutici. I recettori dei cannabinoidi CB1 e CB2 sono i principali componenti recettoriali del sistema endocannabinoide e appartengono alla famiglia dei recettori accoppiati a proteine G (GPCR), caratterizzati dalla presenza di sette domini transmembrana. I recettori CB1 sono espressi principalmente nel sistema nervoso centrale, ma sene trovano anche nei tessuti periferici. La loro attivazione è associata agli effetti psicoattivi del THC ed è coinvolta nella regolazione di vari processi fisiologici, tra cui nocicezione, risposta allo stress, appetito, lipogenesi e modulazione immunitaria.
Tuttavia, la stimolazione dei recettori CB1 può anche portare a effetti avversi come deterioramento cognitivo, ansia e potenziale dipendenza. I recettori CB2 sono espressi soprattutto nelle cellule immunitarie, inclusi linfociti B, macrofagi, cellule NK e microglia.
Col passare degli anni il concetto di bellezza ha lasciato il posto al benessere emotivo riconoscendo che l’essenza della bellezza e della salute della pelle nell’individuo dipende anche da altri parametri: emotivi, neuropsicologici e sensoriali.
Infatti i neurocosmetici sono definiti prodotti capaci di modulare l’attività del “sistema neuro-immuno-cutaneo” a livello dell’epidermide. Questo approccio ha acquisito importanza come transdisciplinare, che si concentra sulla biochimica delle interazioni pelle-nervo, che si sta affermando come un’area di progresso nella scienza cosmetica. La pelle è considerata un organo neuroendocrino e immunologico altamente specializzato, collegato
* Comitato Centrale FNOB
al sistema nervoso centrale attraverso una diffusa e precisa rete di recettori sensoriali, terminazioni nervose, neuropeptidi e neurotrasmettitori, che consente ad alcuni ingredienti attivi, (e. peptidi biomimetici, estratti botanici o composti volatili), di colpire percorsi molecolari che:
1. modulano i processi chiave in atto nella pelle (come infiammazione, invecchiamento e rinnovamento dei tessuti);
2. influenzano anche gli stati emotivi calmando stress e ansia e favorendo un senso generale di benessere.
Nello stesso momento, l’aromaterapia ha sollevato molto interesse da parte della comunità scientifica, perchè attraverso gli odori riesce a modulare il sistema limbico, a differenza di altri sistemi sensoriali, che invece richiedono la trasmissione attraverso il talamo. Questo consente agli oli essenziali utilizzati in aromaterapia, di innescare risposte emotive e fisiologiche immediate, il percorso sensoriale inizia nell’epitelio olfattivo della cavità nasale, dove le molecole aromatiche si legano a specifiche proteine recettoriali sui neuroni olfattivi, i segnali vengono poi trasmessi attraverso il nervo olfattivo al bulbo olfattivo e successivamente attraverso il tratto

Col passare degli anni il concetto di bellezza ha lasciato il posto al benessere emotivo riconoscendo che l’essenza della bellezza e della salute della pelle nell’individuo dipende anche da altri parametri: emotivi, neuropsicologici e sensoriali. Infatti i neurocosmetici sono definiti prodotti capaci di modulare l’attività del “sistema neuro-immuno-cutaneo” a livello dell’epidermide. Questo approccio ha acquisito importanza come transdisciplinare, che si concentra sulla biochimica delle interazioni pelle-nervo, che si sta affermando come un’area di progresso nella scienza cosmetica
olfattivo a regioni cerebrali all’interno del sistema limbico, tra cui l’amigdala, la corteccia piriforme e la corteccia entorinale; proprio la connessione tra olfatto, emozione e memoria spiega come alcuni profumi possono evocare vividi ricordi o suscitare forti stati emotivi.
Da alcuni studi è emerso che l’aromaterapia modula l’attività cerebrale, ed esercita anche effetti benefici sulla salute mentale. Da uno studio clinico condotto presso il Jeju National University Hospital è stato visto come un programma di massaggio con oli essenziali su variabili neurobiologiche e psicologiche incideva in donne che si prendevano cura di bambini con disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD). Dai risultati è emersa una significativa riduzione dei livelli di ansia, depressione e stress, con diminuzione del cortisolo salivare e un aumento dei livelli plasmatici del fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF). Da questi risultati si evince che l’intervento ha avuto un effetto regolatore sull’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), unito a un meccanismo neuroprotettivo mediato dalla stimolazione olfattiva con oli essenziali.
In un altro studio più recente, è stato dimostrato che la stimolazione olfattiva influenza diverse funzioni cerebrali, soprattutto quelle legate alla cognizione e alla flessibilità mentale. Valutando effetti dell’inalazione di olio essenziale di lavanda sulle dinamiche dell’attività cerebrale e sulle prestazioni cognitive sono stati valutati in 20 adulti sani.
Utilizzando registrazioni elettroencefalografiche (EEG) e analisi della densità spettrale di potenza normalizzata (PSD) su cinque bande di frequenza, i ricercatori hanno osservato che l’inalazione di lavanda aumentava significativamente l’attività delle onde theta, alfa e beta, associate al rilassamento, alla concentrazione e all’agilità cognitiva, mentre l’attività delle onde delta, legata agli stati di incoscienza, risultava ridotta.
Dal punto di vista comportamentale, i partecipanti hanno dimostrato una maggiore accuratezza di risposta e tempi di reazione più brevi, suggerendo una maggiore flessibilità cognitiva. Questi risultati forniscono prove neurofisiologiche del potenziale dell’aromaterapia come strategia non invasiva per migliorare le prestazioni mentali in contesti che richiedono adattabilità e attenzione sostenuta.
Oli essenziali: lavanda, bergamotto, ylang-ylang, neroli e melissa condividono attività ansiolitica e rilassante, attribuita alla presenza di monoterpeni come linalolo, acetato di linalile o citrale. È stato dimostrato infatti che questi composti modulano l’attività del sistema nervoso centrale agendo sui recettori GABAergici e serotoninergici, infatti vengono utilizzati per indurre la calma, migliorare il sonno e ridurre lo stress; oli: menta piperita,

© Kleo foto/shutterstock.com
rosmarino, basilico, cannella, mostrano effetti stimolanti e mentalmente chiarificanti grazie a componenti come mentolo, 1,8-cineolo o metilcavicolo, che migliorano la vigilanza, la concentrazione e le prestazioni cognitive attraverso le vie noradrenergiche e dopaminergiche.
Altri oli presentano una duplice funzione cutanea ed emozionale, es. il gelsomino e la rosa inducono euforia e benessere, ma possiedono anche proprietà antinfiammatorie e rigeneranti della pelle mediate da composti come l’acetato di benzile o il geraniolo; l’elicriso promuove la rigenerazione cutanea, la curcuma e lo zenzero hanno un grande potenziale neuroprotettivo, legato ai loro effetti antiossidanti e antinfiammatori sistemici; es. il timo, l’origano, il tea tree oil e la cannella, possiedono proprietà immunomodulatrici o antimicrobiche, che ne consentono l’utilizzo in cosmetici con funzioni protettive o purificanti. La sinergia tra impatto sensoriale (olfattivo) e attività topica rafforza l’ipotesi dell’asse pelle-cervello come bersaglio terapeutico nella moderna neurocosmesi; es.la valeriana, il vetiver o il Gaultheria, vengono utilizzati nella gestione del dolore, dell’infiammazione o dei disturbi del sonno.
Tuttavia, nonostante il loro fascino i neurocosmetici devono ancora far fronte a notevoli limitazioni scientifiche, tecnologiche e cliniche, che non ne consentono ancora l’ integrazione nella dermatologia, questo perché:
1. la maggior parte delle formulazioni neurocosmetiche si trova ancora in fase preclinica o di sperimentazione clinica iniziale, con una validazione limitata su soggetti umani attraverso metodologie robuste;
2. la maggior parte delle evidenze attuali deriva da modelli in vitro o studi su animali, limitando l’applicabilità traslazionale sull’ uomo, a cui si aggiunge la natura intrinsecamente soggettiva delle risposte emotive, combinata con il marcato effetto placebo comunemente osservato negli studi cosmetici, che ne complica ulteriormente l’interpretazione dei risultati.
Infine la variabilità interindividuale data da: la segnalazione neurocutanea, tipo di pelle, composizione del microbioma, predisposizione emotiva e sensibilità sensoriale non generalizzabile delle diverse popolazioni. Da

La convergenza tra neurocosmesi e aromaterapia rappresenta frontiera nella cura funzionale della pelle, offrendo un duplice approccio che mira sia alla dimensione fisiologica che a quella emotiva della salute cutanea, la pelle risulta un’interfaccia sensoriale, fondamentale nella segnalazione neuroendocrina e immunitaria ©
un punto di vista metodologico, c’è un forte gap nell’integrazione di biomarcatori oggettivi dello stato emotivo: cortisolo salivare, variabilità della frequenza cardiaca o la neuroimmagine funzionale nella ricerca neurocosmetica. Mancando quadri normativi unificati e di linee guida internazionali per la valutazione degli esiti psicodermatologici non ci sono standard di validazione e commercializzazione.
A tutto si aggiunge la veicolazione transdermica di principi attivi neuroattivi, poiché molti composti possiedono proprietà fisico-chimiche, che limitano la penetrazione epidermica. Sistemi a rilascio controllato, nanocarrier o veicoli di veicolazione a base lipidica sono necessarie per garantire un’adeguata biodisponibilità a livello dei recettori neurocutanei.
Dal punto di vista della sicurezza, nonostante ad oggi non siano stati documentati esiti fatali derivanti dall’assorbimento cutaneo di oli essenziali, gli effetti avversi più comuni sono fotosensibilizzazione e dermatite da contatto, sono però stati segnalati anche casi di tossicità sistemica non fatale. Data l’incerta incidenza reale di queste reazioni e l’ampia variabilità nelle stime pubblicate, gli oli essenziali devono essere utilizzati con cautela, rispettando intervalli di concentrazione sicuri e riducendo al minimo l’esposizione cumulativa.
Queste limitazioni pongono l’attenzione su l’esigenza di studi longitudinali e multicentrici, che impieghino rigorosi disegni metodologici e incorporino valutazioni multimodali e biomarcatori psicofisiologici validati. Solo così si potrà stabilire definitivamente l’efficacia, la sicurezza e la rilevanza terapeutica dei neurocosmetici nella dermatologia moderna e nella cura funzionale della pelle basata sulle neuroscienze.
La convergenza tra neurocosmesi e aromaterapia rappresenta frontiera nella cura funzionale della pelle, offrendo un duplice approccio che mira sia alla dimensione fisiologica che a quella emotiva della salute cutanea, la pelle risulta un’interfaccia sensoriale, fondamentale nella segnalazione neuroendocrina e immunitaria.
Sfruttando i composti bioattivi, applicati localmente o veicolati per via olfattiva, le formulazioni sono in grado di modulare percorsi neurosensoriali, promuovere l’omeostasi ed evocare benefici emotivi percepibili: es. rilassamento, comfort e miglioramento dell’umore.


In Toscana si è tenuto l’evento congiunto tra FNOB e Ordine regionale dedicato alla salvaguardia del territorio e degli ecosistemi
La figura del biologo ambientale è destinata a crescere e ad avere un ruolo di fondamentale importanza in una società che punta a migliorare la qualità di vita dei suoi cittadini e a porre rimedio ai danni perpetrati dall’uomo. La natura violata e violentata chiede aiuto e la biologia, la scienza che tutela la vita, è chiamata a fare la sua parte.
Così la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi e il presidente Vincenzo D’Anna, insieme all’Ordine dei Biologi della Toscana e dell’Umbria e al Coordinamento Nazionale Biologi Ambientali (CNBA), ha promosso l’evento “Citizen Science a tutela della biodiversità”, organizzato il 4 e 5 ottobre scorso a Porto Santo Stefano (Grosseto).
A fare gli onori di casa è stato Marco Giampaoli, tesoriere della FNOB e consigliere dell’Ordine dei Biologi di Toscana e Umbria. Con lui anche Carla Cimmino, consigliere segretario della FNOB e responsabile della Formazione, che ha aperto la giornata con una prolusione nella quale ha sottolineato l’importanza della biologia come scienza del terzo millennio e della figura del biologo ambientale di comunità, ossia di un professionista al servizio di una società che cerca una migliore qualità di vita e un ambiente che rispetti la natura e gli esseri viventi. «La FNOB - spiega Carla Cimmino - si impegna a creare un dialogo con

le Istituzioni, le Università e il territorio così da creare un ‘ecosistema’ professionale in grado di rispondere alle esigenze della modernità. In tal senso si inserisce la figura del biologo altamente specializzato, pronto alle sfide del terzo millennio».
La FNOB sta infatti lavorando proprio per l’alta specializzazione e la formazione del biologo, figura professionale in continua evoluzione. In questo ambito si inserisce la lectio magistralis “Green space projects to protect biodiversity” di Elvira Tarsitano, responsabile eventi FNOB, che ha parlato della “landsenses Ecology”, un approccio innovativo e interdisciplinare per affrontare le future sfide ambientali e promuovere lo sviluppo sostenibile. I biologi impegnati in questo campo possono infatti svolgere un ruolo fondamentale nella creazione di ambienti sostenibili e armoniosi tra natura e umanità.
Se la biologia è la scienza del terzo millennio, il biologo che si occupa di ambiente è in grado di percepire le esigenze delle comunità: figura chiave per creare ambienti sostenibili, progettare spazi verdi, edifici e infrastrutture che siano in armonia con l’ambiente naturale e promuovano la biodiversità.
Un altro punto nevralgico è la partecipazione pubblica. Eventi come questo, hanno motivo di esistere quando vengono coinvolte le comunità locali. Non a caso la kermesse è culminata con la visita all’isola di Giannutri, la più meridionale dell’arcipelago toscano.
La sessione pomeridiana si è articolata in più momenti, a cominciare dalla tavola rotonda moderata da Marco Giampaoli e Daniela Arduini, presidente dell’Ordine dei Biologi di Lazio e Abruzzo, dal titolo “Tutela della biodiversità: il ruolo del biologo”. A seguire le relazioni degli esperti in tema ambientale. La prima dal titolo “Prospettive del biologo ambientale nella tutela della biodiversità” di Teresa Verde, Coordinatrice del Cnba,
poi è seguita la relazione “La Citizen science per la tutela della biodiversità” di Roberto Carlucci, ordinario di Ecologia presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. E ancora la relazione di Laura Cutini, consigliera del Parco Regionale della Maremma dal titolo, dal titolo “I parchi per la tutela della biodiversità”. Infine, Marco Giampaoli sul tema “Educazione ambientale ed alimentare”. (M. A.).

La figura del biologo ambientale è destinata a crescere e ad avere un ruolo di fondamentale importanza in una società che punta a migliorare la qualità di vita dei suoi cittadini e a porre rimedio ai danni perpetrati dall’uomo. La natura violata e violentata chiede aiuto e la biologia, la scienza che tutela la vita, è chiamata a fare la sua parte


Il congresso ha sottolineato l’importanza degli iscritti nel comparto sanitario
Nella giornata sottoscritto il protocollo per l’istituzione della Scuola di Biologia Marina

Sono stati oltre 400 i biologi provenienti da tutta Italia che hanno preso parte al Congresso Nazionale di Patologia Clinica dal titolo “Il biologo nella medicina del futuro: diagnostica, prevenzione e personalizzazione delle cure”, organizzato il 28 settembre scorso dall’Ordine dei Biologi della Calabria a Villa San Giovanni (Reggio Calabria).
All’evento, che ha sottolineato l’importanza della figura del biologo nel comparto sanitario e che ha puntato molto sui temi legati allo sviluppo e alle nuove frontiere nel settore, hanno preso parte Vincenzo D’Anna, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB), Domenico Laurendi, presidente dell’Ordine regionale organizzatore, i componenti del Comitato Centrale della Fnob, i presidenti di diversi Ordini territoriali dei biologi e i dirigenti della Fondazione Italiana Biologi (FIB).
«Oggi il biologo è una figura sanita-
ria di altissimo profilo, riconosciuta soprattutto nei settori più avanzati: dalla genetica alle terapie cellulari, dalla diagnostica molecolare alla medicina personalizzata - spiega D’Anna -. A breve sarà pubblicata la nuova legge istitutiva della categoria che disciplinerà in maniera dettagliata le oltre 80 professioni sanitarie connesse all’iscrizione all’Albo dei Biologi».
Domenico Laurendi ha sottolineato come «questo congresso abbia ridisegnato la figura del biologo nel comparto sanitario. Le relazioni e gli interventi hanno posto al centro la biologia e le possibilità che questa offre nell’individuare terapie personalizzate che possano migliorare la qualità di vita di tutti».
La giornata è stata coordinata scientificamente dal dottor Francesco Mannarino, che ha sottolineato l’intento dell’Ordine calabrese e delle istituzioni sanitarie locali di rinnovare e migliorare l’organizzazione della rete laboratoristica regionale. L’evento ha visto
la presenza dei Presidenti degli Ordini professionali reggini, tra cui Pasquale Veneziano (Medici), Marco De Luca (Fisioterapisti) Santina Dattola (Architetti), Francesco Foti (Ingegneri), Rosario Maria Infantino (Avvocati) Antonella Girasole (Ostetriche) Massimo Morgante (Tecnici Radiologia e Professioni sanitarie tecniche). I contributi scientifici dei relatori sono stati arricchiti anche dall’inserimento delle lectiones magistrales di Valter Longo, Pierangelo Clerici, Antonio Antico, Giuseppe Novelli ed Elena Ranieri.
Il convegno è stata anche l’occasione per definire la progettualità della nascente Scuola di Biologia Marina, nata dall’accordo tra FNOB, Ordine dei Biologi della Calabria, FIB, Lega Navale - sezione di Reggio Calabri), Arpacal e Museo di Biologia marina. La scuola avrà sede a Reggio Calabria e presto saranno diffusi i dettagli tecnici e scientifici di questo importante protocollo d’intesa.


Ponte tra esigenza di sviluppo e conservazione, traduce l’ecologia della conservazione in parametri operativi e vincoli progettuali, aderendo al modello One Health che lega salute umana, animale e ambientale
Il dibattito contemporaneo sull’ingegneria infrastrutturale di grande scala (reti di trasporto, hub energetici, sistemi idraulici complessi) converge inevitabilmente sulla questione della sostenibilità ambientale. In questo scenario di elevata complessità tecnica e normativa, il Biologo Ambientale si afferma come l’attore scientifico cruciale, l’unico in grado di assolvere al mandato di tutela del Capitale Naturale imposto dalla legislazione comunitaria e nazionale, a partire dal D.Lgs. 152/2006.
La sua funzione non è meramente consultiva, ma essenziale per la legittimazione ecologica di un progetto. Il biologo, forte della sua conoscenza sistemica, agisce da ponte tra l’esigenza di sviluppo e l’imperativo di conservazione, traducendo i principi di ecologia della conservazione in parametri operativi e vincoli progettuali, in piena aderenza al modello One Health che lega indissolubilmente salute umana, animale e ambientale.
La Fase Ante-Operam: Determinazione della Baseline Ecologica
La prima fase cruciale è l’Ante-Operam, dedicata alla determinazione quantitativa della baseline ecologica nella VIA (Valutazione di Impatto Ambientale). Il fondamento metodologico di ogni successiva valutazione di impatto risiede nella rigorosa definizione dello Stato di Riferimento (baseline).
La fase Ante-Operam della VIA, disciplinata dal Titolo III, Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 , esige che la componente biotica dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) sia determi-
* Direttore Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara, Commissario Commissione Tecnica VIA-VAS VIAVAS MASE, Referente Area Tematica “Normativa Ambientale” CNBA, Consigliere Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo con delega all’Ambiente per la Regione Abruzzo.
nata con un livello di dettaglio spaziale e tassonomico elevatissimo. In termini di metodologie di rilevamento e certificazione tassonomica, la caratterizzazione degli habitat non è un semplice inventario descrittivo, ma richiede una classificazione gerarchica. Il Biologo applica la metodologia fitosociologica per la delimitazione delle unità vegetazionali (fitocenosi), classificandole secondo standard riconosciuti come la nomenclatura EUNIS e correlandole agli habitat prioritari e non prioritari dell’Allegato I della Direttiva Habitat (92/43/CEE), recepita dal D.P.R. 357/1997. L’uso sistematico del GIS (Geographic Information Systems) è assolutamente imprescindibile per calcolare metriche ecologiche quali l’area, il perimetro e la complessità geometrica dei patch di habitat, fornendo la base quantitativa indispensabile per l’analisi della frammentazione.
Contestualmente, si eseguono censimenti faunistici con protocolli scientifici avanzati, differenziati per taxa (ad esem-

Il biologo, forte della sua conoscenza sistemica, agisce da ponte tra l’esigenza di sviluppo e l’imperativo di conservazione, traducendo i principi di ecologia della conservazione in parametri operativi e vincoli progettuali, in piena aderenza al modello One Health che lega indissolubilmente salute umana, animale e ambientale
pio, Distance Sampling per l’avifauna, Acoustic Monitoring per i chirotteri), al fine di stimare la densità di popolazione e l’abbondanza relativa delle specie, con particolare attenzione a quelle tutelate dagli Allegati II e IV della Dir. Habitat e dalla Dir. Uccelli (2009/147/CE). Questi dati alimentano l’analisi della struttura delle comunità mediante il calcolo di indici ecologici fondamentali.
Per quanto riguarda la Conformità con la Direttiva Quadro Acque, la professionalità del Biologo è vincolata al D.Lgs. 152/2006, Parte Terza, che attua la Direttiva Quadro Acque (2000/60/ CE) . In questo ambito, si applicano i sistemi di classificazione basati sugli Elementi di Qualità Biologica (EQB) (come macroinvertebrati, fitobentos, macrofite acquatiche) per determinare il Rapporto di Qualità Ecologica (RQE) e lo Stato Ecologico dei corpi idrici superficiali. Questo approccio è cruciale poiché l’alterazione dello stato ecologico di un corso d’acqua a causa di un progetto (ad esempio opere idrauliche o attraversamenti) costituisce un impatto diretto e normativamente sanzionabile.
Modellazione Predittiva, Ingegneria Ecostrutturale e Servizi Ecosistemici Passando alla fase successiva, si arriva alla modellazione predittiva degli impatti e l’ingegneria ecostrutturale. Qui il biologo trasforma i dati di baseline in previsioni di impatto, focalizzandosi sugli effetti sia strutturali che funzionali degli ecosistemi. La quantificazione della frammentazione e perdita di connettività è centrale: un’infrastruttura introduce una perdita netta di habitat e frammentazione, compromettendo la connettività funzionale delle reti ecologiche. Il biologo utilizza modelli spaziali e calcola metriche per quantificare l’impatto sulla matrice del paesaggio, mentre l’effetto barriera è stimato con modelli che considerano la biologia e la capacità di dispersione delle specie target indirizzando la progettazione delle mitigazioni verso l’efficacia ecologica.
Inoltre, in ottemperanza al D.M. 28 marzo 2017 , si valuta la perdita o il deterioramento dei Servizi Ecosistemici (SE). La conversione di un’area forestale, ad esempio, non è vista solo come una perdita di biomassa, ma come una riduzione dei regulating services, una riduzione che deve essere identificata e, ove possibile, monetizzata, rafforzando così l’analisi costi-benefici ambientale. Questo porta alla progettazione basata sulla natura (Nature-based SolutionsNBS). Le misure di mitigazione e compensazione seguono la gerarchia stabilita dal D.Lgs. 152/2006.
La progettazione dei Faunapass (sovrappassi o sottopassi faunistici) si basa rigorosamente sulla biologia della conservazione: il biologo ne definisce i requisiti ecologici fondamentali (rapporto lunghezza/larghezza, substrato permeabile, vegetazione schermante) per massimizzare il tasso di utilizzazione (permeability rate) da parte dei taxa target, superando la mera conformità ingegneristica. Per i ripristini ambientali, il rigore si estende alla Genetics of Restoration.
Il Biologo specifica in dettaglio l’utilizzo di ecotipi locali e materiale genetico autoctono certificato, aspetto essenziale per prevenire l’inquinamento genetico e garantire la massima resilienza e adattabilità dell’ecosistema ricostruito, in piena linea con le strategie di conservazione della diversità intraspecifica.
Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e Principio di Precauzione
Un’ulteriore e fondamentale procedura in cui è cruciale il contributo del Biologo Ambientale è la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA). L’intervento in siti della Rete Natura 2000 (ZSC, ZPS) rende obbligatoria la VIncA, disciplinata dall’Art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., che attua l’Art. 6 della Dir. Habitat. Lo Studio di Incidenza è il fulcro di questa procedura. Il Biologo deve valutare l’incidenza in stretta relazione con gli obiettivi di Conservazione

Un’ulteriore e fondamentale procedura in cui è cruciale il contributo del Biologo Ambientale è la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA). Il Biologo deve valutare l’incidenza in stretta relazione con gli obiettivi di Conservazione del sito (ovvero, mantenere o ripristinare lo stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie). Ciò richiede un’analisi approfondita degli effetti sinergici e cumulativi con altri piani o progetti già presenti nell’area di studio allargata
del sito (ovvero, mantenere o ripristinare lo stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie). Ciò richiede un’analisi approfondita degli effetti sinergici e cumulativi con altri piani o progetti già presenti nell’area di studio allargata.
Il Biologo è tenuto a dimostrare, con ragionevole certezza scientifica, che il progetto non comporterà alterazioni significative all’integrità ecologica del sito. Questo vincolo di prova è stabilito dalla fondamentale giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (Sentenza C-127/02, Waddenzee) : in presenza di un qualsiasi dubbio scientifico significativo sull’assenza di impatti negativi, deve essere applicato il principio di precauzione e l’autorizzazione negata. Solo in caso di assoluta impossibilità a scongiurare l’impatto e unicamente per
Motivi Imperativi di Rilevante Interesse Pubblico Prevalente (IROPI), è prevista la deroga ex Art. 6, par. 4, Dir. Habitat. In questo scenario eccezionale, il Biologo definisce le misure compensative. Queste devono essere ecologicamente equivalenti all’impatto negativo residuo e devono garantire il mantenimento della coerenza globale della Rete Natura 2000. Ciò comporta, di frequente, la creazione o gestione a lungo termine di siti di compensazione, corredati da specifici management plan e monitoraggio finanziario e operativo.
Infine, la fase di Controllo Post-Operam di un progetto prevede il monitoraggio biologico e l’adaptive management. La fase operativa e post-operativa impone l’adozione di un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) strutturato, previsto dal D.Lgs. 152/2006, per l’applicazione del principio di adaptive management. Il monitoraggio utilizza indicatori di risposta biologica (ad esempio, tassi di ricolonizzazione, abbondanza di specie chiave, indici di qualità del suolo) per misurare l’effettivo successo ecologico degli interventi. I dati raccolti sono sottoposti ad analisi statistiche rigorose per rilevare scostamenti significativi rispetto alla baseline.
Il biologo fornisce un feedback continuo all’Autorità Competente per l’implementazione tempestiva di azioni correttive (remediation) in tempo reale, assicurando così che gli impegni di mitigazione si traducano in effettivo ripristino o mantenimento dell’equilibrio ecologico. In conclusione, il biologo ambientale, grazie alla sua profonda conoscenza della biologia sistemica e dei vincoli normativi, si conferma come un fondamentale attore in grado di garantire la legittimità ecologica e la conformità legislativa di un progetto di grande opera, mediando con competenza tra la necessità di sviluppo e la tutela inderogabile del patrimonio biologico.

Due prototipi di barriera corallina artificiale sono stati messi in acqua a Santa Teresa creando substrati per molluschi e stimolando l’insediamento delle specie marine

Nel Mar Ligure, i palombari hanno posato sul fondale due strutture grigie: da lì, il litorale comincerà a rinascere. È l’inizio del progetto per la rigenerazione ecologica di Santa Teresa, dove l’Enea ha immerso le prime unità prototipali di barriere artificiali progettate per favorire il ripopolamento dell’Ostrea edulis, l’ostrica piatta. Questo organismo autoctono, celebre per la sua straordinaria capacità filtrante, è fondamentale per la depurazione naturale e per il ripristino dell’equilibrio biologico costiero.
Le strutture, cuore di un programma innovativo, sono state realizzate in un composito cementizio ecocompatibile certificato dall’azienda D-shape. La loro collocazione, calibrata al millimetro, è stata resa possibile grazie all’intervento dei militari in forza al Comando subacquei e incursori della Marina militare (Comsubin), in collaborazione con la ditta Submariner. La sinergia tra ricerca, amministrazione locale, mitilicoltori e scuola ha fatto sì che tutti siano impegnati nel risanamento delle aree portuali e nella salvaguardia della biodiversità. Le barriere sommerse fungeranno da substrato per le colonie di ostriche, da sempre protagoniste della fascia costiera, capaci di formare aggregazioni tridimensionali, i cosiddetti reef, che offrono habitat complessi a una moltitudine di specie marine.
Da poche settimane, sulle due unità è stato posizionato un innesco costituito da valve di ostriche e mitili provenienti dagli scarti della filiera molluschicola. Questi frammenti daranno origine a microambienti ideali per la colonizzazione biologica e per l’aumento della biodiversità locale. «I reef creati da queste ostriche - spiega Chiara Lombardi, responsabile del laboratorio Enea di biodiversità e servizi ecosistemici - aumentano la biodiversità agendo sulla produttività degli ecosistemi costieri; inoltre, favoriscono la pulizia dell’acqua grazie alla loro capacità filtrante. Non ultimo, questa specie di ostrica rappresenta un’importante fonte di cibo e la sua coltivazione, come quella di altri molluschi bivalvi, è una delle attività più sostenibili del mare».
miscela che utilizzeremo per produrre dei reef analoghi a quelli appena messi a mare, ma realizzati con scarti della mitilicoltura, secondo i principi dell’economia circolare».
L’iniziativa rientra nel programma “Smart bay S. Teresa”, piattaforma multidisciplinare dedicata allo studio e alla tutela degli ecosistemi calcificanti, al riuso degli scarti dell’acquacoltura e alla rigenerazione delle aree portuali, con l’obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Il progetto coinvolge un’ampia rete di collaborazioni che include il Cnr, l’Ingv, l’università di Bologna (Dipartimento Dicam), la Guardia costiera e la Capitaneria di porto della Spezia.
MyVideoimage/shutterstock.com
©

La sinergia tra ricerca, amministrazione locale, mitilicoltori e scuola ha fatto sì che tutti siano impegnati nel risanamento delle aree portuali e nella salvaguardia della biodiversità
Il team scientifico ha già delineato la fase successiva: la costruzione di altri tre supporti analoghi, realizzati con un composito ottenuto da altri residui della mitilicoltura. È un passo avanti decisivo verso l’economia circolare applicata al mare. «Dopo mesi di prove in laboratorio, - afferma Cristian Chiavetta, responsabile del laboratorio Enea strumenti per la sostenibilità e la circolarità dei sistemi produttivi e territoriali - abbiamo finalmente definito la composizione della
Il progetto “Raise”, finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), segna una tappa fondamentale di questo percorso di risanamento. «La messa in mare di questi primi due reef nella baia, - continua Chiara Lombardi - rappresenta il raggiungimento di uno degli obiettivi di “Raise”, ma, soprattutto, l’inizio di un importante progetto di rigenerazione e tutela della baia, i cui effetti si vedranno sul lungo termine. Gli ecosistemi marini e terrestri presenti nella baia sono un esempio di resistenza di un sistema naturale agli impatti antropici diretti, quali il porto e le sue pressioni, e indiretti, il cambiamento climatico. Enea e tutti gli altri attori di “Smart bay S. Teresa” proseguiranno, con azioni concrete, nel monitoraggio e nella tutela di questo sistema, favorendone la rigenerazione». Il monitoraggio costante e le misure di sostegno in atto favoriranno il recupero dell’equilibrio biologico, migliorando la qualità delle acque e la produttività dell’habitat. Il gruppo operativo subacquei (Gos) del Comsubin ha fornito supporto tecnico e logistico alle immersioni scientifiche, nell’ambito dell’accordo quadro tra lo Stato maggiore della Difesa e l’Enea. Ogni fase del piano, dalla progettazione alla posa delle strutture, dalla scelta dei materiali alla cooperazione tra scienziati, tecnici e operatori militari, conferma l’efficacia di un modello integrato di gestione. Un modello capace di coniugare conservazione delle specie autoctone, innovazione tecnologica e capacità di adattamento alle sfide imposte dal cambiamento climatico. La biologia marina ha beneficiato di un intervento determinante: fondali precedentemente compromessi si trasformano in poli di nuova vita. Scienza, ingegneria e intelletto umano restituiscono vitalità alle comunità marine, trasformando ogni tratto di fondale in un laboratorio di rigenerazione e in un simbolo concreto di rinascita ecologica.




La ricerca sui rivestimenti permette di ottimizzare l’assorbimento della luce ridurre le perdite e offrire strumenti concreti per garantire energia sostenibile
Nel futuro dell’energia solare, la differenza non sarà più determinata dal bagliore dei pannelli sui tetti, ma dai sottili strati trasparenti che li proteggono e trasformano. Invisibili a occhio nudo, questi film rappresentano il punto d’incontro tra chimica, fisica e sostenibilità: un’innovazione discreta, quasi invisibile, che decide quanta energia potrà essere catturata e convertita in elettricità. Nei laboratori del Centro ricerche Enea di Portici, un gruppo di scienziati analizza materiali polimerici avanzati destinati a incapsulare le celle fotovoltaiche, monitorandone resistenza agli agenti atmosferici e capacità di mantenere prestazioni elevate per decenni. L’obiettivo non è solo produrre energia pulita, ma farlo in modo più affidabile, riducendo le perdite e massimizzando la resa dei moduli lungo l’intero ciclo di vita.
I ricercatori hanno confrontato tre “antagonisti”: l’etilene vinil acetato (EVA), la poliolefina elastomerica (POE) e la poliolefina termoplastica (TPO). Ogni campione è stato sottoposto a stress accelerati, simulando esposizione prolungata a luce intensa, calore e variazioni termiche estreme. «Le analisi - spiega Valeria Fiandra, ricercatrice del Laboratorio Enea dispositivi innovativi - hanno evidenziato differenze marcate nella perdita di corrente di cortocircuito, ossia la massima corrente erogabile dal pannello sotto luce piena. Ad esempio, il dispositivo realizzato con il materiale ‘standard’ EVA ha mostrato una perdita dell’1,4%, segnalando degradazione più marcata rispetto a quello incapsulato con la POE, con perdita pari all’1,1%. Sebbene le poliolefine siano sul mercato da anni, mancavano finora verifiche sperimentali su moduli reali a lungo termine. Formulare un materiale trasparente ai raggi UV ma resistente alla degradazione chimica resta una sfida complessa per scienza e industria». Il dato non è banale. La TPO può
essere fusa e modellata più volte senza alterazioni permanenti della struttura chimica: un polimero “intelligente”, riciclabile all’infinito, che unisce prestazioni e circolarità. L’EVA, invece, una volta reticolato diventa inutilizzabile, mentre la POE si distingue per stabilità termica e brillantezza ottica, conservando integrità anche sotto il sole più aggressivo. L’EVA, pur aderendo perfettamente al vetro, soffre della componente acetato: col tempo si forma acido acetico, nemico dei contatti metallici e della produzione energetica.
Per decenni gli incapsulanti hanno agito da filtro, limitando parte dei raggi ultravioletti. Una scelta prudente, ma con un prezzo: minore energia catturata. La nuova generazione di poliolefine rovescia questo paradigma. Materiali trasparenti all’UV, chimicamente stabili e progettati per oltre venticinque anni di funzionamento permettono ai moduli di mantenere quasi intatta la propria efficienza.
Qualunque progresso in laboratorio ha ricadute immediate sull’industria: più energia nel tempo, manutenzione ridotta, costi minori. I test condotti all’Enea permettono di prevedere con precisione il comportamento dei materiali sul campo, offrendo ai produttori indicazioni concrete per le formulazioni più robuste. La ricerca diventa leva competitiva, accelerando la transizione verso energia più affidabile e accessibile.
In parallelo, si sviluppano coating fluorescenti capaci di catturare la luce solare e riemetterla in lunghezze d’onda più efficienti per la cella. È come accordare la radiazione solare su una frequenza più produttiva. Questa strategia apre la strada a una generazione di pannelli che non si limitano a convertire energia, ma ad ottimizzarla.
La sfida del fotovoltaico non è più solo watt o superficie, ma precisione con cui la materia interagisce con l’energia. Sottili polimeri diventano architetti invisibili, progettando strati che difendono, guidano e potenziano

La novità risiede nelle molecole che reagiscono in modo predittivo, negli strati che trattengono ciò che serve e rilasciano ciò che produce energia. Ogni test, misurazione spettroscopica e curva di degradazione genera dati che si traducono in benefici concreti e misurabili
le celle senza apparire. Non si tratta di protezione passiva: questi materiali modulano i fotoni in modi finora impensabili, trasformando un modulo in un sistema dinamico, capace di massimizzare ogni centimetro quadrato. La novità risiede nelle molecole che reagiscono in modo predittivo, negli strati che trattengono ciò che serve e rilasciano ciò che produce energia. Ogni test, misurazione spettroscopica e curva di degradazione genera dati che si traducono in benefici concreti e misurabili. Sul campo, significa tetti, serre e impianti solari urbani e rurali più affidabili, con meno guasti e minore dipendenza da materiali fossili. Non s’inventano solo componenti: si costruisce un modello di sostenibilità reale e tangibile. La rivoluzione del fotovoltaico, ora, non fa rumore: si percepisce nei dettagli invisibili, nelle molecole che sostengono decenni di produzione “verde”, nella tecnologia che traduce ricerca in progresso concreto e durevole.
Ogni strato di polimero avanzato racconta una storia. Non è più solo protezione: è un sistema in grado d’incrementare l’efficienza, prolungare la vita dei moduli e ridurre l’impatto ambientale. È la prova che anche la materia più sottile può contenere idee potenti: un Pianeta che produce energia senza esaurire le proprie risorse, un futuro costruito non sulla quantità di pannelli, ma sulla qualità e intelligenza dei materiali che li avvolgono. (G. P.).

© Pixel-Shot/shutterstock.com
Il profumo inebriante del pane dorato, la fragranza della frutta e il sentore delle primizie di stagione dovrebbero celebrare il trionfo della nostra tavola. Eppure, ogni giorno una quantità impressionante di cibo finisce nel contenitore dei rifiuti, scartata con troppa leggerezza. L’alimento, risorsa vitale del Pianeta, viene dilapidato in misura, ormai, insostenibile. Contrastare questa emergenza non è un esercizio di economia domestica, ma richiede decisioni ponderate negli acquisti, cura nella conservazione e creatività gastronomica. Ogni frutto dimenticato in frigorifero, ogni ortaggio deperito in dispensa rappresentano non solo uno spreco economico, ma un peso ecologico crescente e un’opportunità di salute perduta.
Limitare l’impatto personale significa fare scelte consapevoli, valorizzando la qualità rispetto alla quantità e riconoscendo i prodotti più deperibili: frutta, verdure, pane, insalate, cipolle, aglio e tuberi, protagonisti della tradizione mediterranea e custodi del benessere quotidiano. Consumarli al momento giusto diventa un gesto semplice, ma trasformativo, capace d’infondere energia al corpo e rispetto per l’Ambiente, convertendo la gestione domestica in un atto di responsabilità.
Gli esperti del Reparto alimentazione, nutrizione e salute dell’Istituto superiore di sanità, diretto da Laura Rossi, sottolineano come la pianificazione accurata e un metodo ordinato siano fondamentali. Stilare una lista della spesa basata sulle scorte disponibili e organizzare il menù settimanale riduce gli acquisti impulsivi e previene accumuli superflui. Occorre, inoltre, cautela verso offerte e confezioni sovradimensionate, che spesso inducono all’eccesso e rischiano di deteriorarsi prima di essere mangiate.
dividere con ospiti o richiedere la doggy bag al ristorante e donare l’eccedenza attraverso programmi locali, trasforma ogni residuo in risorsa tangibile. Ogni gesto, anche minimo, contribuisce a un mosaico più ampio, dove responsabilità personale e consapevolezza collettiva proteggono.
La Giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dall’Onu, ricorda quanto la problematica sia urgente e invita ad iniziative immediate. Programmazione accurata, acquisti ponderati, lettura attenta delle etichette, riutilizzo creativo e donazioni non sono consigli astratti, ma strumenti indispensabili per costruire un mondo più equo, dove il cibo smetta di essere dilapidato e la quotidianità diventi sostenibile.

Frutta, verdura, pane e prodotti freschi dominano le statistiche degli scarti. Acquistare quantità proporzionate al fabbisogno reale e privilegiare prodotti esteticamente imperfetti significa unire risparmio e attenzione ecologica, sostenendo una filiera più equa
Frutta, verdura, pane e prodotti freschi dominano le statistiche degli scarti. Acquistare quantità proporzionate al fabbisogno reale e privilegiare prodotti esteticamente imperfetti significa unire risparmio e attenzione ecologica, sostenendo una filiera più equa. Leggere le etichette è un atto di consapevolezza: “da consumarsi entro” indica la scadenza ferrea, mentre “da consumarsi preferibilmente entro” segnala il periodo di qualità ottimale. Comprendere questa distinzione permette di gestire meglio le provviste, ridurre ciò che finisce in pattumiera e salvaguardarsi.
La cucina, luogo della trasformazione, offre strumenti concreti: preparare porzioni adeguate, riutilizzare avanzi in zuppe, passati, omelette, polpettine o torte salate, con-
Minimizzare gli scarti significa preferire alimenti più salutari, rispettare stagionalità e freschezza, trasformando spesa e preparazione in momenti di attenzione e cura, insegnando a grandi e piccoli il rispetto per ciò che nutre la vita. Ogni prodotto conservato correttamente, ogni foglia di verdura cucinata in tempo, ogni reinvenzione diventa un passo verso un futuro in cui aria, terra e comunità respirano armonicamente, al ritmo di una coscienza finalmente risvegliata.
Il cibo non è solo nutrimento: è risorsa, capitale silenzioso, misurabile e finito. Ogni frutto scartato, ogni avanzo ignorato è una perdita economica, ambientale e sociale. La vera rivoluzione parte dai fornelli: pianificare, conservare correttamente, recuperare gli avanzi. Non serve erudizione, ma metodo.
Verdure ammaccate, pane raffermo, frutta matura non sono rifiuti, bensì opportunità. Porzioni calibrate, etichette comprese, riuso creativo trasformano ogni pasto in strategia concreta. In tal modo si riducono gli sprechi, i raccolti sono protetti e, senza sacrifici, si limita l’impatto ecologico.
La gestione domestica diventa modello replicabile ovunque: mensa, famiglia, ristorante. Ogni scelta consapevole ha effetto tangibile: meno rifiuti, meno emissioni, più valore economico. La sostenibilità smette di essere concetto astratto e diventa pratica quotidiana.
Il futuro non si discute: si decide davanti al frigorifero. Pianificare, recuperare, ottimizzare: tre gesti che trasformano ciò che portiamo in tavola una leva di cambiamento. Ogni pasto consumato con attenzione è una politica ambientale concreta, misurabile e immediata. Chi lo applica oggi riduce, tutela risorse e insegna agli altri che l’efficienza domestica è la nuova frontiera della responsabilità. (G. P.).

Il nuovo rapporto Waste Watcher International evidenzia come il nostro Paese sia ancora sopra la media europea per quanto riguarda lo sperpero di cibo
Il 29 settembre scorso è stata la sesta giornata internazionale di consapevolezza delle perdite e sprechi alimentari e il 25 settembre è stato presentato il nuovo Rapporto Waste Watcher International - il caos Italia 2025, redatto nell’ambito della campagna Spreco Zero.
Il nuovo rapporto evidenzia come il nostro Paese, nonostante l’adozione dell’Agenda 2030 e la legge Gadda del 2016, che ha lo scopo di ridurre lo spreco alimentare e promuovere la donazione delle eccedenze anche in campo, sia ancora sopra la media europea per quanto riguarda lo spreco alimentare.
Negli ultimi 10 anni - dall’anno di adozione dell’Agenda 2023 a oggi - lo spreco medio domestico è sceso di meno di 100 grammi alla settimana per ogni persona in Italia: da 650 g a 555,8 g. Lo spreco settimanale per ogni italiana e italiano ammonta a poco meno di 29 kg all’anno, una quantità enorme. L’obiettivo fissato dall’agenda ONU è di 369,7g per persona per settimana ed è ancora molto lontano.
Lo spreco domestico solo in Italia vale circa 8,242 miliardi di euro, mentre l’intera filiera alimentare produce sprechi stimati in 14,101 miliardi di euro e 4,513 milioni di tonnellate di cibo gettato tra produzione e consumo. Questa cifra corrisponde a circa 139,71 euro l’anno per persona.
Per una famiglia di 4 persone significa buttare circa 559 euro nella pattumiera dell’organico ogni anno. Andando ad analizzare i dati per aree geografiche, il Centro Italia spreca meno del nord e del sud, con i suoi 490,6 grammi settimanali per persona. Il nord si piazza al secondo posto con 525,2 g e il sud ha il primato dello spreco con 628,6g alla settimana per persona. Chi ha figli e
* Comitato Centrale FNOB
abita nelle grandi città spreca meno di chi non ne ha e vive in comuni medio/piccoli.
Gli alimenti che vengono sprecati di più sono la frutta e la verdura fresche e il pane, le cipolle, le patate.
Il report evidenzia come il 95% delle persone intervistate dichiara di prestare attenzione a non sprecare cibo: il 59% si reputa molto attento, il 36% generalmente attento e soltanto il 4% ammette di non preoccuparsene.
Sono emerse le strategie più frequenti che gli italiani e le italiane mettono in atto per non sprecare il cibo:
• consumare per primi gli alimenti più deperibili (50%)
• congelare cibo non consumabile immediatamente (47%)
• usare alimenti appena scaduti se ancora in buono stato (39%)
• valutare accuratamente le quantità prima di cucinare (37%)
• fare liste della spesa (35%)
• acquistare formati piccoli (28%)
• programmare i menu settimanali (24%)
Per quanto riguarda gli ostacoli percepiti rispetto allo spreco alimentare, i più citati sono stati:
• 1 su 10 si sente impotente (“il mio gesto non cambia nulla”)
• 1 su 10 afferma che è “troppo costoso”
• il 18% considera le pratiche antispreco troppo dispendiose in termini di tempo
• il 36% ammette di dimenticarsene
Il Rapporto Waste Watcher individua una roadmap per raggiungere l’obiettivo dell’Agenda 2023. Innanzitutto, ogni persona deve ridurre il proprio spreco domestico di 50g ogni anno, obiettivo raggiungibile solamente con azioni personali e degli organi amministrativi. A livello di
amministrazioni, la sfida sarà quella di promuovere leggi, tecnologie e investimenti per ridurre lo spreco nella filiera, cioè prima che entri nelle case.

Il nuovo rapporto Waste Watcher evidenzia come il nostro Paese, nonostante l’adozione dell’Agenda 2030 e la legge Gadda del 2016, che ha lo scopo di ridurre lo spreco alimentare e promuovere la donazione delle eccedenze anche in campo, sia ancora sopra la media europea per quanto riguarda lo spreco alimentare
Per le persone, si gioca tutto sulla consapevolezza del problema, sul sentirsi in grado di fare la differenza con il proprio contributo e, infine, sul trasformare la conoscenza del problema in azioni.
Come abbiamo visto, le scelte di ognuno di noi fanno la differenza, anche quando ci sembra che non sia così.
La roadmap casalinga per aiutare l’Italia a raggiungere l’obiettivo ONU di 369,7g per persona alla settimana parte dalla pianificazione:
1. il plan dei pasti settimanale: organizzare in anticipo cosa si mangerà durante la settimana aiuta ad avere le idee chiare su cosa comprare e su cosa è già in frigo o dispensa
2. la lista della spesa: è uno

strumento fondamentale per comprare solo quello di cui si ha necessità, visto il plan dei pasti. Avere una lista della spesa consente anche di resistere alle offerte promozionali su grandi quantità di cibo, che sono molto allettanti, ma si rischia di comprare più del necessario e di buttarlo
3. frigorifero e freezer vanno tenuti in ordine: sapere cosa contengono consente di non comprare in eccesso e di consumare prima della scadenza
4. la dispensa va tenuta in ordine: una dispensa ben organizzata permette di avere alimenti a lunga conservazione come cereali, legumi, frutta secca, olive e altro per variare a tavola e non far scadere nulla prima di consumarlo
5. ragionare sulle porzioni: comprare e cucinare sul numero di persone che mangeranno e non per una caserma (abitudine tutta italiana) permette di avere meno avanzi
6. consumare gli avanzi: la cucina italiana è ricchissima di ricette del recupero, per esempio a base di pane, di verdure, di legumi, di carne e di pesce.
Polpette, polpettoni, risotti, marmellate, conserve, torte salate, sono alcuni dei modi in cui la tradizione aiuta nel non sprecare
7. conoscere e leggere bene le etichette: alcuni cibi vanno buttati dopo la data di scadenza, altri possono essere consumati dopo la data di consumazione preferibile
8. sfruttare le app e le offerte sui cibi in scadenza: esistono alcune app che consentono di acquistare a prezzi molto convenienti le rimanenze di negozi di alimentari, supermercati, drogherie, aziende di scatolame. Al supermercato spesso ci sono offerte su cibi che stanno per scadere. Soprattutto quando si tratta di alimenti che hanno l’etichetta “da consumare preferibilmente entro il”, comprare tramite questi metodi permette un discreto risparmio economico per cibi ancora sicuri e nutrizionalmente integri, mentre si evita che vengano buttati
9. non solo frigo e freezer: esistono altri metodi di conservazione: essiccazione, sottovuoto, sotto sale, sott’aceto,
© 5PH/shutterstock.com
…sono tecniche molto note e utilissime soprattutto per conservare frutta e verdura, le due tipologie di alimenti che vengono più spesso sprecate
10. differenzia: se dopo avere adottato tutti i comportamenti virtuosi anti-spreco qualcosa deve per forza essere buttato, va ricordato di differenziarlo nel modo corretto. Buttare gli avanzi non più recuperabili nell’organico consente la produzione di compost che servirà a concimare i campi.
Lo spreco alimentare è un problema che si intreccia con disparità sociali, guerre, carestie, crisi climatica. Avviene principalmente in casa e in Italia siamo ancora lontani dall’obiettivo di grammi di cibo buttato per persona alla settimana fissato dall’Agenda 2030.
Oltre al supporto delle amministrazioni, conta principalmente l’impegno di ogni persona. Non è più rimandabile l’assunzione di responsabilità individuale, la piena consapevolezza di dover portare il proprio contributo personale e quotidiano per ridurre di almeno 50g settimanali a persona ogni anno fino al 2029 lo spreco alimentare nelle famiglie italiane.

Consulta gli eventi della Fnob che erogano i crediti formativi
L’aria è minacciata dall’ozono, responsabile di perdite agricole stimate in due miliardi di euro ogni anno, e impone a tutti di trasformare gli impegni in azioni

© hide.m/shutterstock.com
L’arrivo dell’autunno non porta solo la nostalgia dell’estate, ma espone la Pianura Padana a un’amara verità: l’aria, che sembra essersi placata dopo i mesi caldi, è intrisa di smog fotochimico, un cocktail dove l’ozono emerge come agente silenzioso, ma devastante. Non si tratta di semplice foschia, ma di una minaccia acuta, capace di irritare i polmoni, aggravare patologie respiratorie e cardiovascolari e danneggiare coltivazioni e vegetazione. L’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) stima in almeno due miliardi di euro all’anno il costo dei danni agricoli e attribuisce all’ozono 70mila morti premature in Europa, di cui 13mila in Italia.
La Pianura padana si conferma il focolaio di questa emergenza, poiché per l’EEA è la zona più inquinata d’Europa. Ciò che rende critica la situazione è la resistenza ostinata dell’ozono al calo: a differenza di altri inquinanti, esso è alimentato da precursori chimici le cui concentrazioni crescono, in particolare il (CH₄). Se gli ossidi di azoto (NOx) da traffico sono in lenta diminuzione, l’aumento del metano, proveniente da fughe di combustibili fossili, discariche e dagli allevamenti intensivi, compensa e alimenta il ciclo vizioso.
Nelle regioni a forte intensità zootecnica (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna) si concentra il 70% delle emissioni nazionali di quello agricolo, prevalentemente dai liquami e dai bovini. «Cresce sempre più l’evidenza del ruolo del metano non solo come potente gas climalterante, ma anche come inquinante atmosferico - dichiara Damiano Di Simine, responsabile della campagna di Legambiente “MetaNo, coltiviamo un altro clima” - per questo occorre invertire la crescita delle emissioni atmosferiche di questo gas, ciò che l’Italia si è impegnata a fare nel 2021 firmando il Global Methane Pledge. È urgente il superamento delle fonti fossili, metano incluso, ma occorre anche ridurre le emissioni agricole, che per l’Italia sono prioritarie, in particolare per quanto riguarda i troppi allevamenti intensivi della Pianura Padana». Purtroppo, l’accordo globale sul metano non è vincolante per i 160 Paesi firmatari; pertanto, è cruciale che le istituzioni nazionali ed europee trasformino gli impegni politici in strategie concrete, cogliendo benefici congiunti per clima e salute. L’alta correlazione tra ozono e mortalità ha spinto l’Oms e l’UE a definire limiti rigorosi: i primi raccomandano di non superare i 100 µg/m³ (Massima Media Oraria su 8 ore, MM8), mentre la norma europea tollera 120 µg /m³ con
massimo 25 giorni annui di superamento, ridotti a 18 entro il 2030 e a zero entro il 2050. Al 31 agosto, la provincia di Bergamo ha registrato 77 giornate oltre il valore obiettivo; criticità elevate si sono riscontrate anche a Torino, nell’Ovest Lombardia (Lecco, Milano, Pavia, Cremona) e in numerosi centri emiliani e piemontesi. La soglia di allarme (240 240 µg/m³) è stata superata a Pavia e in alcune aree del Milanese. La fotografia è impietosa, specialmente considerando che la stagione non è stata estrema come le siccità del 2022 e 2023. Preoccupa anche l’aumento nelle grandi concentrazioni urbane, effetto collaterale inatteso della riduzione NOx da traffico, che fungevano da “spazzini” chimici nelle ore serali. «Negli anni passati ci occupavamo dell’ozono come di un inquinante atipico, che colpiva soprattutto le aree rurali e pedemontane, danneggiando vegetazioni, colture e salute umana in zone a bassa densità. Oggi la geografia dell’inquinamento non opera più tali distinzioni, le città sono colpite in modo simile alle aree rurali. Ne consegue che una quota crescente di popolazione, soprattutto urbana, è esposta a livelli pericolosi. La sfida per l’aria pulita richiede di abbattere le concentrazioni di tutti i precursori, dai NOx all’ossido di carbonio, dai solventi organici al metano». La mancanza di reti dedicate al monitoraggio è una lacuna critica. «Per questo - conclude Di Simine - chiediamo che le regioni si attrezzino dotando le centraline atmosferiche di sensori per la misura del metano, come indicato dalla nuova direttiva europea». La protezione di salute, raccolti e l clima non è più una scelta, ma una necessità improrogabile che reclama decisioni immediate e coraggiose.

La Pianura padana si conferma il focolaio di questa emergenza, poiché per l’EEA è la zona più inquinata d’Europa. Ciò che rende critica la situazione è la resistenza ostinata dell’ozono al calo: a differenza di altri inquinanti, esso è alimentato da precursori chimici le cui concentrazioni crescono, in particolare il (CH₄) © MC MEDIASTUDIO/shutterstock.com
Agire significa trasformare la Pianura Padano-Veneta in simbolo di resilienza, una bottega vivente dove scienza, sostenibilità e consapevolezza collettiva s’intrecciano, dimostrando che è possibile invertire il corso delle minacce invisibili. Ogni respiro, gesto, scelta diventano strumenti di una rivoluzione silenziosa, capaci di restituire aria pura e vitalità al territorio. Il futuro non è scritto: dipende da tutti, dalle azioni intraprese oggi, mentre il sole cala sulle campagne e sulle città, tingendo l’orizzonte di fiducia. Qualsiasi alternativa consapevole è un seme di rinascita, ogni segno diventa un vento di cambiamento, e lentamente, giorno dopo giorno, la Pianura Padano-Veneta potrà respirare nuovamente, più forte e viva, testimone che la responsabilità è capace di trasformare l’aria, la vita e l’equilibrio ambientale in un’eredità duratura per le generazioni. (G. P.).

In Italia il primo raccolto che segna una svolta
nell’editing genetico agricolo e nella sostenibilità
Il 30 settembre 2025, nei campi sperimentali di Castello d’Agogna (Pavia), è stato raccolto il primo riso italiano ottenuto con le Tecnologie di Evoluzione Assistita (TEA). Il progetto, guidato dalla professoressa Vittoria Brambilla dell’Università Statale di Milano, ha coinvolto tre siti tra Pavia e Novara. Il risultato è “RIS8imo”, una varietà di riso editata geneticamente per resistere al brusone, la più grave malattia fungina che colpisce le risaie.
Le tecniche TEA rappresentano una nuova frontiera del miglioramento genetico: a differenza degli OGM
tradizionali, che prevedono l’inserimento di geni estranei, queste agiscono sul DNA della pianta modificando le sequenze già esistenti, replicando mutazioni naturali in modo preciso e controllato. Tra le tecniche più promettenti c’è CRISPR/Cas9, una sorta di “forbice molecolare” che consente di tagliare e riscrivere il genoma. Questa tecnologia, premiata con il Nobel per la Chimica nel 2020, ha infatti già rivoluzionato la medicina e ora si sta approcciando all’agricoltura. Nel caso del riso RIS8imo, sono stati silenziati tre geni (Pi21, HMA1, HMA2) per renderlo meno vulnerabi-
le al brusone. Le piante editate si sono dimostrate identiche a quelle tradizionali per morfologia e sviluppo, ma potenzialmente più resilienti e meno bisognose di fitofarmaci, acqua e fertilizzanti. Tuttavia, la stagione 2025 ha visto una scarsa presenza del fungo, rendendo difficile misurare l’effettiva resistenza delle piante. I test proseguiranno in laboratorio per analizzare rese, qualità e risposta a stress ambientali. La sperimentazione italiana è la prima condotta da un ente pubblico, con il supporto del Ministero dell’Ambiente e ISPRA.
Il progetto RIS8ttimo, finanziato anche dalla Fondazione Bussolera Branca, fa parte di una rete di otto sperimentazioni TEA attive in Italia, che coinvolgono anche pomodoro, melo e vite. Le TEA sono considerate una soluzione importante rispetto alle sfide poste dal cambiamento climatico e dalla sicurezza alimentare. Secondo il CREA, queste tecniche potranno ridurre l’impatto ambientale dell’agricoltura e aumentare la produttività. In particolare, il riso TEA potrebbe contribuire a diminuire l’uso di fungicidi, migliorare la sostenibilità delle colture e garantire una maggiore stabilità produttiva in condizioni climatiche avverse. Ma parallelamente all’entusiasmo e ai risultati importanti, esiste un dibattito etico e normativo aperto: alcuni esperti sollevano dubbi sull’impatto a lungo termine sulla biodiversità e sugli ecosistemi, soprattutto in caso di incroci con varietà selvatiche. Inoltre, la regolamentazione europea equipara ancora le TEA agli OGM, rendendo difficile la loro diffusione commerciale.
L’Italia, con la Lombardia in prima linea, sta cercando di promuovere un approccio più aperto e basato sull’evidenza scientifica. Il futuro dell’agricoltura potrebbe dunque passare da qui, e il raccolto di RIS8imo è solo l’inizio di una rivoluzione che potrebbe cambiare il modo in cui produciamo il cibo e proteggiamo il pianeta.
Alla domanda «quali sono stati i primi animali sulla Terra?» ingenuamente posta da un bambino curioso, la cui mente fervida già assembla e pregusta tra le possibili risposte teste di leone, corni di rinoceronte o ali di uccello, potrebbe risultare deludente sentirsi dire che, molto probabilmente, sono state le spugne.
Se però si iniziasse a raccontare, un po’ romanzando, di come queste semplici spugne, in un arco di tempo inimmaginabilmente lungo e lento, siano diventate polpi, delfini, aquile, scimmie, elefanti, lupi, esseri umani, calciatrici, scrittori e scienziate, allora, forse, nessun bambino rimarrebbe deluso. Inoltre, l’altra teoria più accreditata, “opposta” a quella delle spugne, è quella che propone gli enigmatici ctenofori (organismi simili a meduse) come prime forme di vita animale.
Una teoria certo non tanto più entusiasmante. Per decenni biologi e paleontologi sono stati divisi sulla questione, ma una nuova ricerca del MIT (Massachusets Institute of Technology) ha portato alla luce delle prove chimiche e genetiche che puntano con decisione verso le spugne. Essendo organismi semplici, privi di muscoli e sistema nervoso, queste non possiedono strutture che si fossilizzano facilmente, come ossa o conchiglie, e i ricercatori hanno dovuto validare la loro ipotesi cercando altrove, ovvero nelle molecole.
Nel 2009, il biologo Roger Summons (MIT) identificò in rocce dell’Oman dei composti organici chiamati steroli C30, tipici delle spugne moderne. Questi “fossili chimici” suggerivano che le spugne fossero presenti negli oceani già 100 milioni di anni prima della grande esplosione della vita nel Cambriano: non tutti ne erano convinti, poiché si ipotizzava che quei composti potessero derivare dalle alghe. La svolta è arrivata nel 2023, quando Lubna Shawar, ricercatrice al Caltech ed ex membro del
© John A. Anderson/shutterstock.com

Una nuova ricerca del MIT conferma che queste sarebbero le prime forme di vita comparse sul pianeta
team MIT, ha individuato un secondo marcatore, uno sterano C31, prodotto dallo stesso gene delle spugne responsabile del C30.
La presenza combinata di questi due composti ha rappresentato una “prova chimica” di inequivocabile origine animale. Di recente, dunque, il team ha simulato in laboratorio il processo di fossilizzazione per verificarne l’autenticità, ottenendo risultati perfettamente sovrapponibili ai campioni geologici. Lo studio, pubblicato su “Proceedings of the National Academy of Sciences”, ha analizzato i campioni provenienti dall’ Oman, dall’India e
dalla Siberia, confrontandoli con gli steroli prodotti dalle spugne moderne. Le linee di prova chimica, genetica e sperimentale convergono tutte verso la conclusione che sono state le spugne i primi animali sulla Terra, organismi la cui semplicità rappresenta una forma di vita primitiva molto sofisticata. Tale scoperta non solo riscrive l’albero della vita e invita a riflettere sulla complessità della storia della biologia, ma lascia margine per trarre un insegnamento da corredare al nostro racconto. E cioè, che si può essere “speciali” anche nella nostra straordinaria semplicità. (M. O.).






















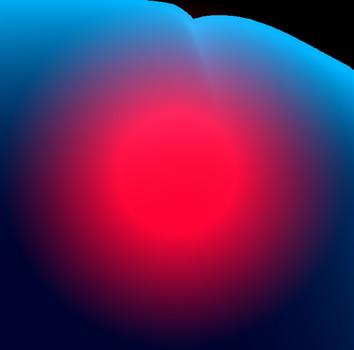



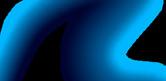







La Toscana in prima linea, nella ricerca internazionale, con un nuovo progetto europeo per la lotta al tumore
Il glioblastoma è un tipo di tumore del cervello molto aggressivo con una prognosi sfavorevole e, attualmente, le strategie terapeutiche disponibili permettono alla maggior parte dei pazienti di sopravvivere poco più di un anno dopo la diagnosi.
Si chiama SeqPerGlio il nuovo progetto europeo dedicato alla lotta contro questa patologia, coordinato da ISPRO (Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica) insieme all’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa, che vede la Toscana in prima linea nella ricer-
ca internazionale. Mettendo insieme terapie farmacologiche all’avanguardia, tecnologie informatiche e pratica chirurgica di alto livello, il progetto SeqPerGlio mira a rendere le terapie più efficaci e personalizzate, affrontando due grandi sfide scientifiche: la difficoltà dei farmaci di attraversare la barriera emato-encefalica e raggiungere il tumore; la necessità di caratterizzare molecolarmente il tumore per fornire una terapia maggiormente efficace e personalizzata.
Mario Chiariello, responsabile della sede senese del Core Research Laboratory di ISPRO, ha affermato: «La
nostra idea è di sviluppare una tecnica per leggere velocemente il codice genetico del tumore durante l’intervento chirurgico. Così si potrà scegliere subito la combinazione di farmaci più adatta a quel paziente. Questi farmaci saranno quindi inseriti in un particolare gel che verrà applicato direttamente nel cervello durante l’operazione, vicino alle cellule tumorali rimaste. Questa modalità di intervento dovrebbe rendere la terapia più efficace e con minori effetti collaterali».
Un ruolo chiave per poter compiere analisi rapide nel tempo di un intervento chirurgico è quello della tecnologia informatica. Romina D’Aurizio, ricercatrice del Cnr-Iit e responsabile del laboratorio CTGLab, ha dichiarato: «Utilizzeremo un sistema di sequenziamento real-time a nanopori, un tipo di sequenziamento genetico rapido e svilupperemo modelli computazionali veloci, capaci di individuare la tipologia specifica di cellule tumorali presenti nel paziente operato in tempo reale ed indicare la terapia farmacologica più efficace». Simona Dei, direttrice generale di ISPRO, ha affermato: «Continua il nostro impegno nell’ambito della ricerca contro il cancro, sempre con attenzione alla qualità della vita delle persone che combattono questa battaglia».
Andrea Passarella, direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, ha sottolineato: «Le attività di ricerca previste nel progetto SeqPerGlio contribuiscono a rafforzare ulteriormente una delle linee di ricerca strategiche per Cnr-Iit, ampliando le partnership nazionali ed internazionali dell’Istituto».
Il progetto di sequenziamento intraoperatorio del tumore per una terapia farmacologica loco-regionale personalizzata contro le recidive del glioblastoma durerà tre anni: sarà inizialmente testato in laboratorio e, se i risultati saranno promettenti, il trial coinvolgerà successivamente anche un piccolo gruppo di pazienti.
Ha preso ufficialmente il via la SAND, Speech Analysis for Neurodegenerative Diseases Challenge, una competizione internazionale che si prefigge di valorizzare il potenziale dell’intelligenza artificiale nell’analisi dei segnali vocali per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie neurodegenerative, con una particolare attenzione dedicata alla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Questa patologia colpisce i motoneuroni, le cellule nervose che controllano i muscoli volontari, causando il loro deterioramento e morte. Tale degenerazione porta a una progressiva debolezza muscolare, che inizia spesso in un singolo gruppo muscolare, come una mano o un piede; difficoltà di movimento con perdita di equilibrio e spasmi muscolari. Con il progredire della malattia, i pazienti hanno difficoltà a parlare, a mangiare senza soffocare e a respirare.
La sfida si svolgerà nell’ambito della conferenza internazionale IEEE ICASSP 2026, ed è generata dall’esigenza di individuare biomarcatori oggettivi, non invasivi e scalabili, in grado di supportare la diagnosi precoce e il monitoraggio di patologie complesse come la SLA. Allo stato attuale, gli strumenti diagnostici si basano prevalentemente su scale cliniche soggettive, che non sempre riescono a rilevare i primi segnali della patologia, ritardando in questo modo l’intervento terapeutico. È proprio questo l’obiettivo della SAND Challenge: colmare questo divario, promuovendo lo sviluppo di algoritmi avanzati che pongano l’analisi del linguaggio al centro della ricerca clinica.
A partire da un dataset contenente segnali vocali di soggetti affetti da SLA e soggetti sani, la competizione prevede due task principali: (i) classificare i soggetti e (ii) prevedere come la malattia peggiora nel tempo. I cinque gruppi che otterranno i punteggi più elevati saranno invitati a presentare i propri risultati nel corso della
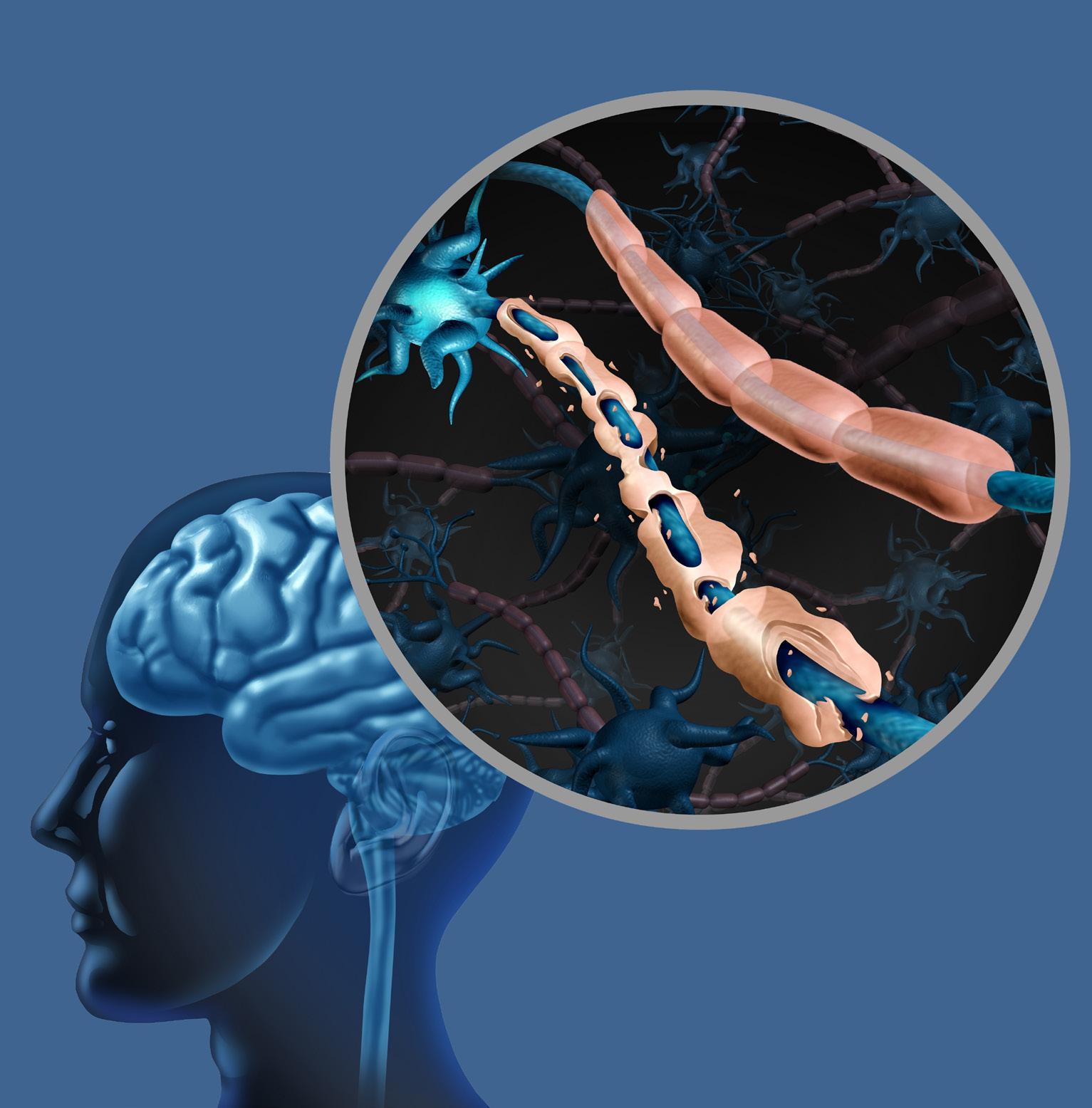
Una sfida internazionale per la diagnosi delle malattie neurodegenerative, con particolare attenzione rivolta alla SLA
conferenza IEEE ICASSP 2026, che si svolgerà a Barcellona dal 4 all’8 maggio 2026. I contributi selezionati saranno pubblicati negli atti ufficiali della conferenza e indicizzati nei principali database accademici, tra cui IEEE Xplore Digital Library, Scopus e Web of Science.
La SAND Challenge rappresenta un’importante opportunità per i ricercatori provenienti dal mondo accademico, professionisti dell’industria e operatori del settore.
Il 1° settembre 2025, c’è stata l’apertura delle registrazioni e il rilascio dei dataset di training. Il 1° ottobre,
sono stati rilasciati i dataset di testing e hanno avuto inizio le sottomissioni. Proseguendo, il calendario della competizione, prevede il 20 novembre 2025 il termine ultimo per la registrazione e la chiusura delle sottomissioni.
Il 2 dicembre 2025, l’annuncio dei risultati e il 18 gennaio 2026, la scadenza per l’invio della versione finale dei paper. Ricordiamo, che gli Enti Organizzatori sono: l’Istituto di calcolo e reti ad alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Università di Napoli Federico II e l’Università della Campania L. Vanvitelli. (P. S.).
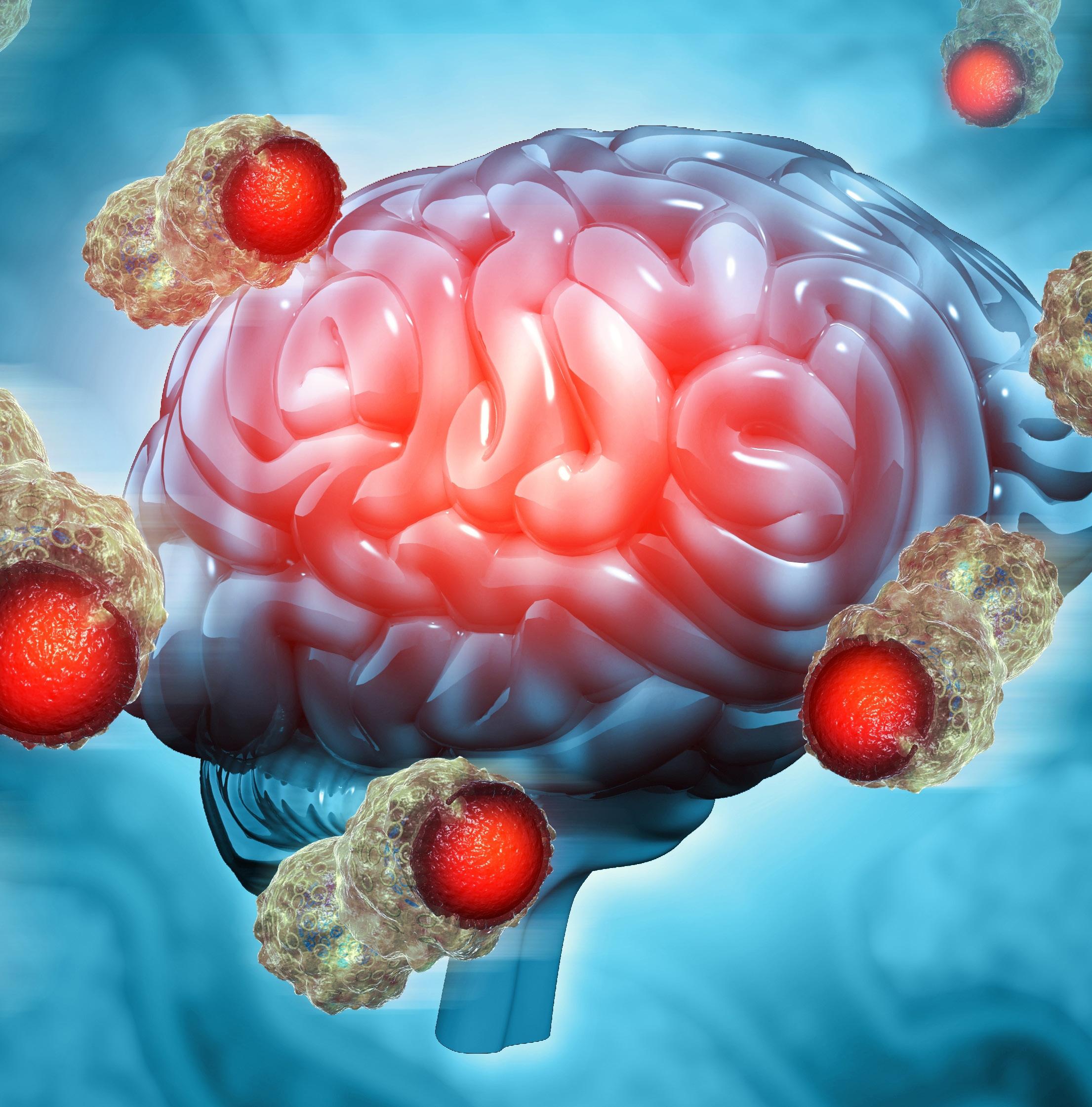
Lo studio, dell’Università di Padova e del CNR, è stato pubblicato sulla rivista Cell Communication and Signaling
Fabio Mammano, docente del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova e associato con incarico di ricerca all’Istituto di biochimica e biologia cellulare del Cnr-Ibbc, ha guidato un team internazionale di ricercatori che ha sviluppato una nuova terapia a base di anticorpi rivelatasi efficace nel rallentare la crescita del glioblastoma, la forma più aggressiva di tumore cerebrale negli adulti. Oltre a ostacolare la progressione tumorale, il trattamento riduce anche l’iperattività neuronale causata dal tumore, una condizione spesso asso -
ciata a crisi epilettiche nei pazienti. In questo studio, i ricercatori hanno mirato a un bersaglio molecolare preciso: i canali emisomici delle connessine, che nei tumori sono iperattivi e rilasciano segnali pro-tumorali come ATP (Adenosin Trifosfato, una molecola energetica essenziale per la crescita e la proliferazione delle cellule) e glutammato.
Utilizzando colture cellulari derivate da pazienti, gli studiosi hanno testato un anticorpo monoclonale chiamato abEC1.1, in grado di bloccare selettivamente alcune connessine (Cx26, Cx30 e Cx32).
Questi i risultati: riduzione della migrazione e dell’invasività delle cellule tumorali; inibizione del rilascio di ATP e glutammato; riduzione significativa del volume tumorale e aumento della sopravvivenza; normalizzazione dell’attività sinaptica anomala indotta dal tumore.
Mammano ha spiegato: «È la prima volta che un anticorpo terapeutico si dimostra capace di contrastare contemporaneamente la crescita del glioblastoma e l’iperattività neuronale che il tumore induce nei tessuti circostanti. Questo approccio apre la strada a nuove strategie terapeutiche che mirano non solo alle cellule tumorali, ma anche alle loro interazioni patologiche con l’ambiente cerebrale».
Daniela Marazziti, ricercatrice del Cnr-Ibbc e coautrice del lavoro, ha aggiunto: «Con questo studio abbiamo chiaramente evidenziato l’importanza di contrastare specificamente i componenti molecolari che attivano e rafforzano la comunicazione tra cellule tumorali ed il tessuto circostante, alimentando la proliferazione incontrollata del glioblastoma».
L’anticorpo è stato somministrato sia come proteina purificata sia tramite terapia genica con vettori virali AAV (virus adeno-associati), una modalità che potrebbe consentire effetti terapeutici duraturi con una sola somministrazione. Lo studio rafforza l’idea che i canali emisomici delle connessine siano un bersaglio farmacologico promettente per il trattamento del glioblastoma.
La tecnologia è oggetto di brevetto in contitolarità tra l’Università di Padova, il Cnr, l’Università degli Studi di Milano e la ShanghaiTech University. La ricerca è stata condotta in collaborazione con istituzioni accademiche in Italia e Cina ed è stata finanziata da Ministero dell’Università e della Ricerca, Fondazione Cariparo, Fondazione Giovanni Celeghin, ShanghaiTech University e Fondazione Umberto Veronesi. (P. S.).
La ricerca, pubblicata sulla rivista Advanced Science, è il frutto della collaborazione tra due Istituti di ricerca del CNR di Napoli, l’Istituto per gli endotipi in oncologia, metabolismo e immunologia e l’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti. Lo studio ha realizzato una tecnica innovativa per la diagnosi precoce dei tumori: si tratta della Polarization-Sensitive Holo Tomography, una metodica completamente label-free, cioè capace di analizzare le cellule senza bisogno di coloranti o marcatori chimici.
In questo modo è possibile osservare le cellule nel loro stato naturale e distinguere con grande accuratezza quelle sane da quelle tumorali. Le cellule tumorali, per sostenere la loro rapida crescita, consumano grandi quantità di glucosio e accumulano lipidi sotto forma di gocce intracellulari, considerate importanti biomarcatori metabolici. Le gocce lipidiche hanno una caratteristica ottica peculiare, la birifrangenza, che ne modifica il comportamento rispetto alla luce. La tecnica messa a punto sfrutta proprio questa proprietà, combinando imaging olografico 3D e sensibilità alla polarizzazione, per visualizzare tali strutture senza far ricorso a coloranti o marcatori esterni, distinguendole nettamente da altri componenti cellulari.
Hossein Khadem (Cnr-Ieomi), primo autore dello studio coordinato da Anna Chiara De Luca per Cnr-Ieomi e Giuseppe Coppola per Cnr-Isasi, ha spiegato: «La ricerca ha dimostrato che la tecnica della PS-HT consente di distinguere cellule sane da cellule tumorali con un’accuratezza quasi totale. Si aprono, così, nuove possibilità nello studio del metabolismo del cancro, offrendo un livello di dettaglio elevatissimo e potenzialmente utile anche per la diagnosi precoce».
Maria Antonietta Ferrara (Cnr-Isasi) ha aggiunto: «La novità dello studio è l’impiego della birifrangen -
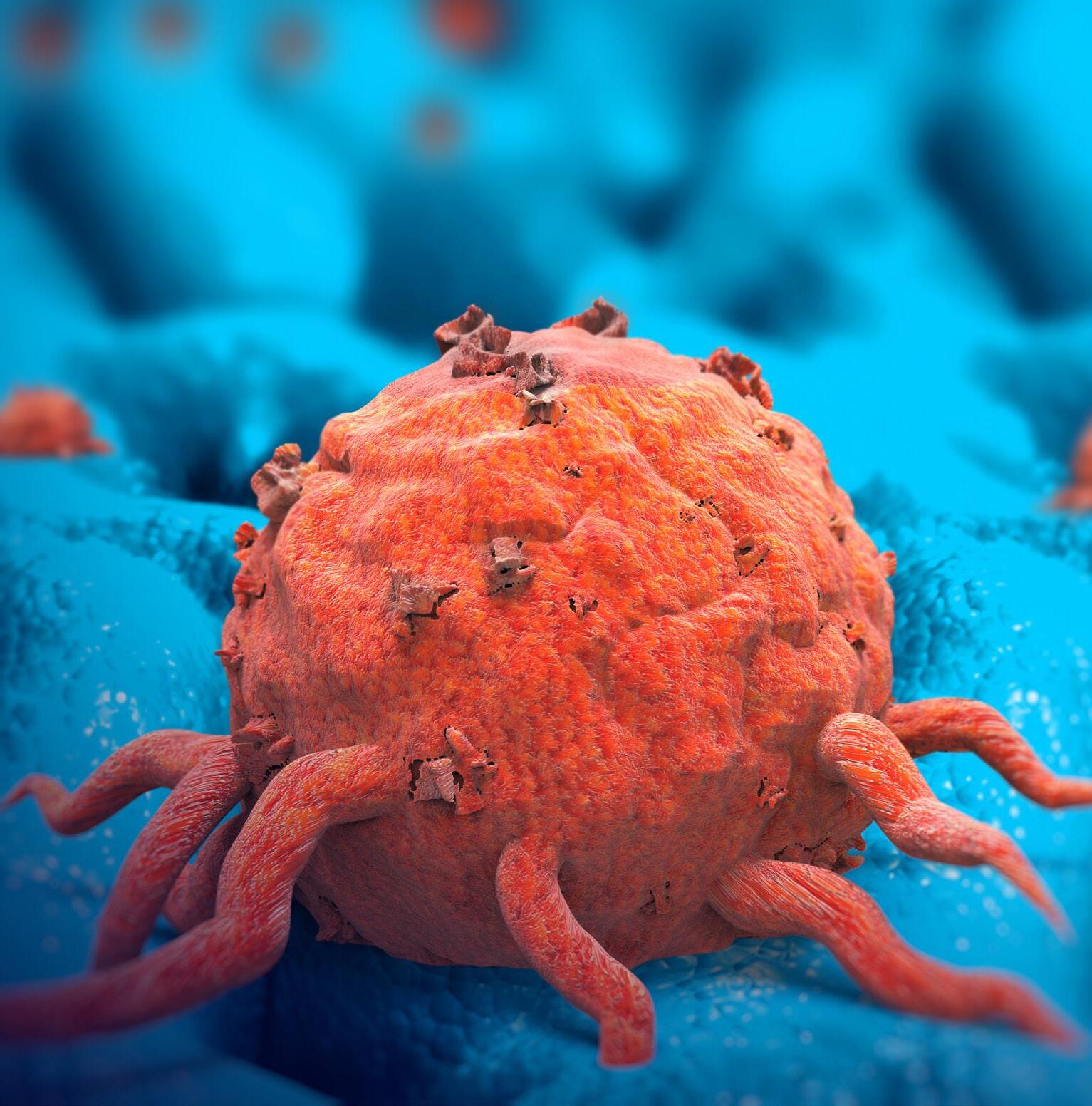
Una tecnica innovativa, messa a punto dal CNR, sfrutta una nuova metodica per l’individuazione dei tumori
za, una proprietà ottica intrinseca delle gocce lipidiche, che consente di riconoscerle chiaramente e in modo affidabile, superando i limiti delle metodiche tradizionali basate solo sull’indice di rifrazione».
«Inoltre, un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che la tecnica non richiede trattamenti invasivi né colorazioni, permettendo di osservare i campioni in condizioni molto vicine alla realtà biologica», ha affermato Maria Mangini, ricercatrice di Cnr-Ieomi. Secondo i coordinatori, l’efficacia della metodologia risiede nel fatto che fornisce simultaneamente informazioni
morfologiche, biofisiche e strutturali, permettendo di osservare differenze significative tra cellule sane e tumorali in termini di volume, massa e organizzazione molecolare delle gocce lipidiche, parametri che si confermano come veri e propri biomarcatori del tumore.
Pertanto, si può sostenere che la PS-HT rappresenta un passo importante non solo per la ricerca di base sul metabolismo cellulare, ma anche per future applicazioni cliniche. Questi risultati mostrano come la sinergia tra competenze diverse, possa generare innovazioni di grande valore scientifico e clinico. (P. S.).

In corso l’intervento su un paio di tele seicentesche nella chiesa di San Domenico Il ruolo determinante dei biologi nell’analisi delle muffe e nella scelta del biocida
Biologi in azione per salvare le opere d’arte. Nella chiesa di San Domenico a Chieri, in Piemonte, è partita una delicata operazione di biorestauro di due pregiate tele seicentesche di Guglielmo Caccia, meglio conosciuto come il Moncalvo: la Resurrezione di Lazzaro e la Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il grande pittore, formatosi nell’ambito della scuola vercellese, dipinse entrambe attorno al 1615, quando soggiornò una seconda volta nella cittadina alle porte di Torino, su incarico di padre Giacinto Broglia, priore dei Domenicani. Ora gli imponenti quadri, posti uno di fronte all’altro ad arricchire il presbiterio della chiesa, sono sotto gli attacchi di funghi e muffe. Soprattutto sulla superficie della Resurrezione si è sviluppata una notevole stratificazione che ha provocato la comparsa di macchie di diverso colore, in particolare bianco o grigio scuro, dalla più recente alla più antica. In alcune zone della tela lo strato è talmente doppio da impedire la visione del dipinto sottostante.
L’azione di funghi e muffe ha mostrato i primi segni alcuni mesi fa e la situazione è notevolmente peggiorata nel corso dell’estate, probabilmente a causa dell’umidità che si è venuta a creare all’interno delle nicchie che ospitavano i quadri, riflesso delle alte temperature estive. Anche l’altro quadro ha mostrato i primi segni di infezione e per questo motivo è scattata la richiesta di intervento per entrambe le opere. Dopo lunghe attese, più di natura burocratica che pratica, la Soprintendenza di Torino ha dato il via libera all’avvio dei lavori, affidati al restauratore Giorgio Perino. Un compito di primaria importanza, però, è stato assegnato al professor Sergio Enrico Favero Longo, docente di biologia applicata al restauro dell’Università di Torino, e alla sua equipe, che hanno prelevato campioni utili a identificare il tipo di fungo e le sostanze di cui si nutre. Un’operazione preliminare di rilevanza cruciale per individuare il tipo di biocida più adatto per mettere in sicurezza le pregiate opere.
Ma perché, dopo 400 anni, le tele hanno subito all’improvviso l’aggressione di agenti infestanti? La ragione, con tutta probabilità, risiede nell’effetto, lento ma inesorabile, di un precedente intervento di restauro eseguito nel 1980, in cui sono stati utilizzati materiali organici. Il collante usato per far aderire le tele dei quadri alla rifoderatura era composto da farina e colla di coniglio, che sono diventati nel tempo un nutrimento ideale per funghi e muffe. Per questo motivo, potrebbe rendersi necessario anche lo smontaggio e la sfoderatura del dipinto, con l’inevitabile rimozione del telaio che comporterebbe la necessità di dover eseguire nuovamente i ritocchi e le stuccature dell’intervento di restauro di 45 anni prima. Il costo dell’intervento è stimato in 63mila euro e ha scatenato una gara di solidarietà da parte della comunità chierese e non solo. Chi vuole, può visionare lo stato dei lavori e seguire le tappe del restauro in visite guidate gratuite e appositamente organizzate dalla Fondazione Comunità Chierese. Nel frattempo la Resurrezione di Lazzaro è stata smon-

Gli imponenti quadri, posti uno di fronte all’altro ad arricchire il presbiterio della chiesa, sono sotto gli attacchi di funghi e muffe. Soprattutto sulla superficie della Resurrezione si è sviluppata una notevole stratificazione che ha provocato la comparsa di macchie di diverso colore, in particolare bianco o grigio scuro, dalla più recente alla più antica. In alcune zone della tela lo strato è talmente doppio da impedire la visione del dipinto sottostante. L’azione di funghi e muffe ha mostrato i primi segni alcuni mesi fa e la situazione è notevolmente peggiorata nel corso dell’estate, probabilmente a causa dell’umidità che si è venuta a creare all’interno delle nicchie che ospitavano i quadri, riflesso delle alte temperature estive
tata dalla parete attraverso un complesso sistema di corde e di ganci, staccata dalla nicchia e spostata in avanti di alcuni metri, protetta da una sorta di camera di decantazione che consente ai restauratori di entrare e uscire liberamente, senza il rischio di diffondere le spore nel resto della chiesa. «Una volta posizionata lontano dalla parete, abbiamo potuto finalmente esaminare il retro del dipinto. La situazione è allarmante», ha ammesso al Corriere di Chieri il direttore Perino, che ha illustrato anche le varie fasi dell’operazione di biorestauro: «La prima prevede l’uso di aspiratori medicali specializzati per rimuovere la massa più grande di muffa. Successivamente verrà applicato un biocida che disinfetti a fondo l’opera, così da evitare lavori più complessi in seguito». Solo l’esito delle analisi sui funghi infestanti chiarirà se dovrà procedersi alla rimozione del telaio.
In quel caso, per il nuovo restauro sarebbe adoperato un diverso tipo di colla, sintetica e resistente all’azione delle muffe, in modo da prevenire possibili ulteriori attacchi negli anni a venire. Un’altra misura di prevenzione sarà rappresentata dal diverso posizionamento dei quadri una volta completate le operazioni di abbellimento e messa in sicurezza. Sia la Resurrezione di Lazzaro sia la Moltiplicazione dei pani e dei pesci, infatti, saranno allontanate dalle pareti che, indirettamente, favoriscono il loro deterioramento. La soluzione è l’utilizzo di apposite staffe capaci di tenere le due opere staccate dai muri, garantendo loro una migliore ventilazione ed evitando che le tele possano risentire degli effetti dell’umidità. Insomma, a Chieri è in corso un intervento complesso e multidisciplinare, un perfetto esempio di come la biologia possa integrarsi al meglio con le altre scienze nella salvaguardia e nel restauro dell’inestimabile patrimonio storico e artistico italiano. (R. D.).

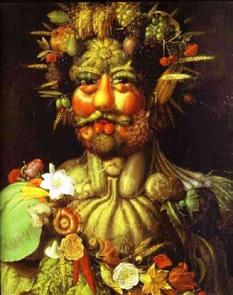

L’Italia ha chiuso i Campionati del mondo di nuova Delhi con 7 successi e 11 medaglie
Tris per Cicchetti, doppio podio per Legnante e Calcagni
Eterne campionesse, volti nuovi, esempi di grinta e determinazione che - senza pretenderlo, né sbandierarlo - finiscono per ispirare altre vite e scrivere altre storie. L’Italia torna dai Campionati del mondo di atletica leggera paralimpica di Nuova Delhi con 11 medaglie, fra cui 7 ori, non tutti “annunciati”.
Fra i grandi protagonisti dei Campionati del mondo c’è Marco Cicchetti, uomo nuovo dell’atletica paralimpica italiana. Un ragazzo 26enne, nato con il piede torto congenito ma cresciuto praticando prima ginnastica artistica e poi atletica. Quello che l’ha portato per tre volte sul podio iridato è stato un percorso di crescita costante. «È stata la mia gara migliore di sempre - la sua esultanza dopo l’oro nel salto in lungo T44, con la misura di 6,98 metri - perché non ho mai saltato così tanto e oggi invece ho stabilito tre volte il record europeo. Grazie davvero a tutti quelli che mi sostengono sempre, sono contentissimo». Una misura ripetuta per due volte, cui si aggiunge un altrettanto notevole 6,97 metri. Dietro di lui Dmitry Bartashevich con 6,90m e Indika
© ChiccoDodiFC/shutterstock.com

Assunta Legnante ha aggiunto al suo medagliere un argento nel lancio del disco F11 con la sua miglior prestazione stagionale in 37,90 metri. Si tratta del terzo podio di fila nella disciplina
Gamage con 6,46m. L’altro oro con primato europeo Cicchetti se l’è preso nei 200m T44, chiusi in 23 secondi netti davanti all’ucraino Pavlo Kaplun e all’indiano Sandeep. A completare il luccicante bottino è arrivata anche la medaglia di bronzo nei 100m T44 con il crono di 11”46, dietro a un Naif Almasrahi che ha stabilito il record del mondo in 10”94 e a un Matheus de Lima nuovo primatista panamericano. Più noto, sinora, è stato il volto di Carlo Calcagni, ex ufficiale dell’Esercito italiano, pilota di elicotteri e paracadutista, che lo scorso giugno a Parigi aveva il primato del mondo dei 400 metri piani categoria T72 con il tempo di 59”43. Favorito della vigilia, si è limitato a stravincere davanti al brasiliano João Matos Cunha e al polacco Piotr Siejwa. C’era poi da difendere la “corona” nei 100m T72, conquistata a Kobe 2024. Ha iniziato a regalare spettacolo in semifinale, firmando il nuovo record del mondo in 14”65 (togliendolo a ... se stesso), poi in finale si è messo negli specchietti Mathos Cunha e il britannico Finlay Menzies, trionfando in 14”80. «In tanti mi hanno chiesto il bis - il suo commento, dopo l’impresa nei 100 metri - e l’ho concesso. Sono contento di com’è andata, ho avuto begli avversari, primo fra tutti il brasiliano Matos Marques, che sono stati uno stimolo in più per dare il massimo. Voglio dedicare questa bellissima medaglia ai colleghi e tutte le persone che mi prendono come esempio per continuare a lottare, perché le mie vittorie sono le vittorie di tutti».
Non poteva mancare all’appello la capitana azzurra, Assunta Legnante, già campionessa europea indoor prima dell’aggravarsi di problemi visivi e poi più volte campionessa paralimpica e del mondo. Nel Jawaharlal Nehru Stadium, il suo “ruggito” si è sentito prima nel getto del peso F12, dove ha centrato il sesto titolo iridato con un miglior lancio da 14,44 metri. «La gara l’ho vissuta con poca grinta perché ho gareggiato quasi da sola - il commento della Tigre - ma come si dice gli assenti hanno sempre
torto e ad avere ragione è chi gareggia. Io c’ero e questo è il mio sesto oro mondiale nel peso. Questa manifestazione è stata bellissima e la nostra squadra è fantastica, composta davvero da grandissimi ragazzi di cui non posso che essere fiera. Li ringrazio come ringrazio tutti quelli che mi hanno permesso di raggiungere questo traguardo: il tempo passa, ma io ci sono ancora!”. Al suo medagliere, l’atleta partenopea ha aggiunto un argento nel lancio del disco F11 con la sua miglior prestazione stagionale in 37,90 metri. Si tratta del terzo podio di fila nella disciplina, dopo l’oro di Dubai 2019 e il bronzo di Parigi 2023.
Conferma d’oro anche per la sprinter Ambra Sabatini, primatista del mondo dei 100m T63 che bissa Parigi 2023 chiudendo in 14”39: «Ho fatto esattamente ciò che mi ero ripromessa, ovvero correre precisa e ordinata senza strafare. Avevo bisogno di questo risultato e di questa sicurezza che oggi ho potuto ritrovare» il commento della campionessa paralimpica di Tokyo 2020.
Già bronzo agli Europei e ai Giochi paralimpici nei 1500 m piani T20, Ndiaga Dieng è il nuovo campione del mondo degli 800m T20. Ha preso il comando delle operazioni a tre quarti di gara, andando a vincere in 1’53”91 davanti al saudita Meshal Mahutan e al turco Mehmet Emin Eğilmez. «Ho lavorato tanto per ottenerla - ha dichiarato, parlando della medaglia - anche se questa stagione non è stata facile. L’obiettivo era conquistare il podio e ci siamo riusciti. Questo mi riempie di orgoglio e festeggiare insieme alla squadra e ai tecnici è per me un grande onore».
Chiudono il conto due bronzi. Quello dell’ex iridata Arjola Dedaj nel salto in lungo, con il balzo di 4,41 metri, a seguito di un nullo e di un infortunio al tendine che non le ha permesso di effettuare ulteriori salti. E quello di Francesco Loragno, terzo nei 200m T64 in 22”56, suo nuovo record personale che gli ha regala la prima medaglia iridata in carriera: «Ma questo è solo un punto di partenza» ha assicurato.

Tra Cagliari e Quartu Sant’Elena, la Sardinia Sailing Cup e il Sardinia Grand Slam hanno attirato i campioni di diverse classi, olimpiche e non. Titoli per Spanu e Pianosi
L’arrivederci all’estate e il benvenuto all’autunno, nel Mezzogiorno della Sardegna, è un intenso mese di vele, tavole, bandiere, sole e sale. Anche quest’anno, fra Cagliari e dintorni, la Sardinia Sailing Cup e il Sardinia Grand Slam hanno catturato l’attenzione di migliaia di appassionati e curiosi delle discipline veliche, quasi tutte olimpiche o con ambizioni a cinque cerchi.
Evento unico nel suo genere, che ha trasformato Cagliari per un mese nella capitale mondiale della vela parlando anche di inclusione, sostenibilità e cultura del mare, la Sardinia Sailing Cup si è aperta con il primo Campionato del Mondo di Formula Wing. E con l’Italia protagonista. Sui soffi del maestrale, la 19enne Maddalena Spanu - nata a Cagliari, residente a Oristano, già titolata nel WingFoil e candidata a velista dell’anno - si è infatti imposta nella finale femminile, dopo una settimana sempre in vetta alla classifica. Viana Picot, 15enne di Guadalupe, si è presa l’argento. Bronzo per la diciassettenne greca Aimilia Kosti. Fra i ragazzi successo del francese Mathis Ghio davanti a un altro tricolore, quello dell’italiano Francesco Cappuzzo, già iridato di Free-fly slalom. Terzo gradino del podio per il neozelandese Sean Herbert.
A seguire il Campionato Mondiale Nacra 17, 49er e FX, che ha assegnato i primi titoli mondiali del nuovo quadriennio olimpico. Circa 200 imbarcazioni provenienti da oltre 60 nazioni si sono sfidate in sei giornate di regate mozzafiato con diversi medagliati olimpici di Parigi 2024. Nel 49er, gli spagnoli Diego Botin e Florian Trittel hanno aggiunto un nuovo oro al loro già importante palmares, imponendosi davanti agli olandesi Bart Lambriex e Floris Van De Werken. Bronzo per i danesi Jonas Warrer e Mathis Lehm Sletten. Iberici al top anche nel 49erFX con Paula Barceló e María Cantero che hanno sfilato l’oro alla Svezia di Vilma Bobeck ed Ebba
Berntsson. Bronzo canadese con le sorelle Georgia e Antonia Lewin-Lafrance. Nel Nacra 17 i britannici John Gimson e Anna Burnet hanno “sverniciato” in finale gli italiani Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, brillanti argento dopo una settimana in vetta all’overall. Terzi gli olandesi Willemijn Offerman e Scipio Houtman.
A chiudere il programma della Sardinia Sailing Cup è stato il Foil Academy International Trophy (1316 ottobre). Sono stati 40 gli atleti, in rappresentanza di diverse nazioni, a sfidarsi in un formato ad eliminazione e super finali in diverse specialità foil, per conquistare il trofeo per Nazioni. Altre gioie per l’Italia, grazie al successo di Mosè Belloni (CV Arco) e del team azzurro Margherita Porro (Luna Rossa)-Mosè Belloni nella classe Waszp, imbarcazione capace di volare sull’acqua grazie ai foil. Successo per Pierluigi Caproni (Lni Cagliari) nell’iQFoil. Dietro di lui i fratelli Jan e Kristof Orlowsky del Windsurfing Club Cagliari.
«Le parole delle centinaia di atleti che hanno vissuto a Cagliari per oltre un mese, prima e durante i mondiali –ha commentato Mirco Babini, coordinatore della Sardinia Sailing Cup - ci spingono a fare sempre meglio. Tutti sono rimasti positivamente colpiti dalle condizioni meteo ideali che hanno accompagnato le regate, da Marina Piccola e dalla città di Cagliari, che è diventata davvero la capitale mondiale della vela per un mese».
Il mare è stato protagonista a 360 gradi. Oltre allo sport, si è parlato di sostenibilità con la Fondazione Medsea e gli studenti del territorio. E si è parlato di inclusione. Ai giovani con disabilità è stato dedicato un progetto del settore para sailing Fiv (sostenuto da UniCredit attraverso il fondo Carta Etica) che ha permesso loro di provare la vela tramite la barca Hansa 303. Il clinic di World Sailing dedicato al seated wingfoil ha invece fatto sperimentare il wingfoil a persone con disabilità motoria.

Il mare è stato protagonista a 360 gradi. Oltre allo sport, si è parlato di sostenibilità con la Fondazione Medsea e gli studenti del territorio. E si è parlato di inclusione. Ai giovani con disabilità è stato dedicato un progetto del settore para sailing Fiv che ha permesso loro di provare la vela tramite la barca Hansa 303. Il clinic di World Sailing dedicato al seated wingfoil ha invece fatto sperimentare il wingfoil a persone con disabilità motoria
Non solo Sardinia Sailing Cup: a dare spettacolo tra fine settembre e inizio ottobre, nella limitrofa Quartu Sant’Elena, sono stati i big della Formula Kite, classe olimpica del kiteboarding. Con un finale dolce per l’Italia. In campo maschile è stato infatti Riccardo Pianosi, marchigiano di nascita ma quartese d’adozione, a laurearsi campione del mondo, sfruttando il “match point” che si era garantito per la Grand Final. “È una bella soddisfazione aver vinto questo titolo dopo aver lavorato tutti questi anni, non potrei essere più felice” il commento a caldo di Pianosi, portacolori della Marina Militare, dopo essere planato in spiaggia col suo aquilone. Sul podio con lui l’iridato uscente Maximilian Maeder, singaporiano, e il francese Benoit Gomez. Fiato sospeso per tutta la prima e unica regata della finale, un testa a testa fra due grandi talenti, alle massime velocità. “C’era tanta emozione durante la regata, è andata molto bene, le sensazioni erano buone, in acqua ho fatto una regata perfetta, sono stato in controllo e sono riuscito a portarmi il titolo a casa”. Prima volta storica anche tra le donne, con l’oro di Jessie Kampman davanti alla plurititolata Daniela Moroz e all’iridata 2024 Lauriane Nolot. (A. P.).

Il 18enne genovese ha bissato al primo anno da under 23 l’oro mondiale vinto nel 2024 da junior
Mentre lo sloveno Tadej Pogacar rivince il Mondiale in linea e conquista il suo quinto “Lombardia” consecutivo, primo nella storia del ciclismo, l’Italia dei pro’ del pedale chiude la stagione con qualche buon acuto. Le due vittorie di tappa e la maglia verde finale (classifica a punti) dello sprinter Jonathan Milan al Tour de France, I successi di Filippo Ganna e Giulio Pellizzari, sesto classificato nella ‘generale’, alla Vuelta a Espana. Quello di Christian Scaroni nella 16esima tappa del Giro d’Italia. E poi i secondi posti di Ganna alla
Milano-Sanremo e nella crono degli Europei e quello di Giulio Ciccone alla Liegi-Bastogne-Liegi, più qualche medaglia nella rassegna continentale. Ma sono stati i Mondiali di Kigali, in Ruanda, a regalarci la maggiore speranza di tornare a essere protagonisti tra gli uomini come riusciamo a esserlo in campo femminile, olandesi e francesi permettendo.
Se Federica Venturelli ha vinto il bronzo a cronometro fra le under 23 e Chantal Pegolo si è presa l’argento fra le juniores, la gara maschile under 23 ha regalato all’Italia il clamoroso bis di Lorenzo Mark Finn, già iridato
juniores a Zurigo l’anno scorso. Un atleta di grande prospettiva, non ancora 19enne (compirà gli anni a dicembre), che quest’anno si è imposto anche nel Giro del Belvedere e, in maglia iridata, nella Coppa San Daniele. Successo, quest’ultimo, che ha sancito definitivamente il trionfo dell’Italia nella Coppa per Nazioni di categoria.
Ligure di Avegno, origini britanniche da parte di padre, Finn è cresciuto fino a dodici anni giocando a calcio e a tennis, poi ha scoperto il ciclismo. Ed è stato amore reciproco. Secondo al Giro della Lunigiana al primo anno da junior, è salito in cattedra l’anno dopo (2024) con la maglia del team tedesco Grenke-Auto Eder. Ai campionati italiani di categoria c’è stato un solo padrone, sia nella prova in linea sia nella cronometro: quattro lettere, inizia con “F”. Finn ha vinto anche la Aubel-Thimister-Stavelot a tappe e si è confermato secondo al “Lunigiana” ma, soprattutto, si è imposto al Mondiale di Zurigo grazie a un attacco solitario a 21 km dall’arrivo.
Quest’anno è passato alla categoria U23 con la squadra Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies. E, malgrado la giovanissima età, ha siglato diversi piazzamenti in importanti corse ciclistiche della categoria. Oltre a imporsi al Giro del Belvedere, su Jakob Omrze e Marco Schrettl, si è classificato secondo al Gp Palio del Recioto dietro a Lorenzo Nespoli, sesto e miglior scalatore al Giro Next Gen, quarto al Tour de l’Avenir. Comprensibile, dunque, attendersi prestazioni di rilievo anche ai Mondiali. Il 22 settembre Lorenzo Mark Finn si è piazzato quarto nella cronometro U23, a 4 secondi dal bronzo. Ma quattro giorni più tardi non ha avuto rivali nella prova in linea, almeno negli ultimi 6,5 km quando ha staccato lo svizzero Jan Huber di mezzo minuto diventando il settimo italiano campione del mondo U23. E accendendo, negli occhi e nel cuore dei tifosi, le speranze di future imprese anche tra i pro. (A. P.).
Diciotto trofei consecutivi in Italia, da sei anni a questa parte. E una stagione 20242025 da incorniciare, con un clamoroso “Grande Slam” che ha visto l’Imoco Volley Conegliano vincere tutto: scudetto, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Mondiale per club e Champions League. A fugare, però, l’ipotesi che le Pantere avessero matrice e origine divina è arrivata la sconfitta contro la Numia Vero Volley Milano, che lo scorso 18 ottobre è stata trascinata da una magnifica Paola Egonu al primo trofeo nazionale della sua storia: la Supercoppa italiana. Mvp dell’incontroovvero la migliore in campo - l’opposta di Milano ha collezionato 30 punti, 9 nel tie-break che ha permesso al team di Stefano Lavarini di movimentare l’albo d’oro. E al tecnico piemontese di prendersi una rivincita su Daniele Santarelli, coach di Conegliano, prodigo di complimenti a fine match. «E ci mancherebbe anche, dopo tutte le volte che glieli ho fatti io» ha scherzato Lavarini, ringraziando l’amico-collega umbro.
Quello di Milano è stato però un successo di squadra, cui ha contribuito il rendimento della coppa Bosio-Fersino, i muri vincenti di Kurtagic, le fiammate offensive di Lanier. Nomi, volti, braccia che hanno scritto una pagina di storia diversa della pallavolo italiana. Dall’altra parte della rete, è stata meno costante la regista Asia Wolosz, faro della macchina dei sogni chiamata Conegliano. E la stessa Gabi, fuoriclasse che aveva quasi eliminato l’Italia dal mondiale con giocate di classe purissima, non era al meglio. Si è salvata, fra le altre, la “regina del Nord” Bella Haak, autrice di 32 punti e devastante in avvio fra diagonali, parallele, pallonetti, piazzati e bordate.
Undici i punti di Haak in un primo set vinto 25-18 dalle venete. Avanti di +5 nel secondo, Conegliano ha subito però il sorpasso di Milano, ispirata da una Egonu in crescita e rimessa in sesto dagli interventi di Lavarini in corsa. Anche Santarelli ha rimescolato

L’Imoco Conegliano, campionessa d’Europa e del Mondo, è “caduta” dopo 18 trofei nazionali consecutivi dal 2019
le carte nel terzo set, lanciando l’ottima 22enne Sillah e Daalderop, senza interrompere l’inerzia favorevole alla Vero Volley. Ma Conegliano non è squadra che si arrende. E trascinata da Lubian, Sillah e dal servizio di Zhu è volata sul 12-5 e poi sul 16-7 nel quarto set. A parziale ormai deciso, Lavarini ha fatto rifiatare tutte le titolari in vista del tie-break. E al rientro Egonu e Lanier hanno spedito subito Milano sul 6-2, per poi continuare a dettar legge e vanificare le belle giocate di Zhu e Adigwe.
Milano è la tredicesima squadra a iscrivere il proprio nome nell’albo
d’oro di una Supercoppa italiana che negli ultimi sette anni aveva avuto una sola padrona.
Intanto è iniziato il campionato e anche lì le rivali hanno voglia di riscatto. Novara è partita forte, correndo fianco a fianco di Conegliano. Scandicci è più incostante, ma ha battuto per 3-0 la Milano “titolata”, ma altrettanto zigzagante, nell’anticipo del tredicesimo turno che coinciderà col Mondiale per club. Ci sarà da divertirsi. Con l’impressione (o l’illusione) di potersela giocare un po’ di più con una delle squadre più vincenti della storia del volley. (A. P.).
Una storia di radici declinata al femminile
Di generazione in generazione in una vita lunga 100 anni
di
Anna Lavinia
Giuseppina Torregrossa
Corta è la memoria del cuore
Mondadori, 2025 – 19,50 euro Libri
“Le femmine della famiglia Accoto erano impastate con la rabbia.” Esordisce così Giuseppina
Torregrossa nella prima pagina della sua ultima fatica letteraria. Anche quando la genetica predispone una certa similarità tra madri e figlie, il legame biologico conta meno della comunione d’intenti. L’amore tra esse non scorre necessariamente come un dono naturale, madri e figlie non sono sempre l’una lo specchio dell’altra. I legami che nascono dal sangue possono smarrirsi nel tempo, nascondersi tra le trame insidiose di incomprensioni e parole, soprattutto non dette.
Torregrossa mostra in poco più di duecento pagine come evolve la maternità, come questa cambia da donna a donna, come si sviluppa in maniera diversa nella stessa famiglia. Elena, Teresa e le altre sono certamente figlie ma possono non essere le mamme che hanno avuto così come da nonne possono essere le madri che non sono state. Fra biologia e amore, la genealogia femminile delineata dalla scrittrice si compone di una costellazione di personaggi indimenticabili che portano il lettore a riflettere su un
tema sempre più ardente: l’essere madre. Può sembrare un impulso naturale ed automatico inscritto nella biologia femminile ma l’istinto materno non è universale.
L’attaccamento primario mediato dagli ormoni che favorisce la cura e la protezione del figlio (o della figlia) può cambiare ed essere influenzato da fattori diversi, esperienze di vita e condizioni psicologiche. Una volta tagliato il cordone ombelicale, il frutto di quel legame biologico indissolubile diventa umano e come tale non più scontato. La biologia interagisce con la dimensione culturale ed emotiva: l’ambiente, le aspettative sociali e la storia personale della donna cambiano il modo in cui si manifesta - o meno - l’istinto materno.
Non c’è maternità senza ombra, le madri amano i proprio figli ma possono anche divorarli. L’elemento oscuro esiste e Torregrossa lo descrive magistralmente. La maternità può essere complicata e quando la fatica si sovrappone all’amore in maniera costante e continua può logorare un sentimento che pian piano diventa insostenibile. È questa la storia di una centenaria, Teresa, la capostipite di una famiglia siciliana e romana che cresce e si evolve insieme

all’Italia del XX secolo in un alternanza di figlie, figli, nipoti e pronipoti. È lei la matrice di tutto, una donna che vive ma non lascia vivere, guarda tutti ma non si lascia guardare e che, in fondo, non si spegnerà mai.
Anche quando non ha più forze, è il filo che tiene in piedi la matassa della schiatta degli Accoto. Una storia suggestiva fatta di verità e bugie ma anche di silenzi che si tramandano col sangue, generazione dopo generazione. Un’esistenza descritta anche attraverso gli oggetti che ci hanno accompagnato nel tempo ed altri che invece ci ricordano solo qualcosa di lontano e appannato. È impossibile non ritrovare nel libro esperienze e dinamiche sociali che hanno fatto parte della nostra quotidianità. Oggetti ma anche luoghi che raccontano il passato, i suoi conflitti e le sue rinascite.
Un salto nei ricordi impolverati delle case dei nonni e dei genitori. Se la memoria è legata indissolubilmente al sentimento, può diventare corta quando non è alimentata giorno per giorno. L’amore, anche quello materno, necessita di essere coltivato, ha bisogno di nutrimento, di luce e di libertà.
Nassir Ghaemi
Una straordinaria follia
Apogeo, 2025 – 25,00 euro
Negli ultimi due secoli, tutti i personaggi che hanno fatto la storia hanno avuto una cosa in comune: un pizzico, più o meno grande, di follia. Per dimostrarlo, l’autore e professore di psichiatria, mette in pratica una dettagliata analisi della vita ma anche dei sintomi e delle diagnosi di leader politici e sociali. (A. L.).
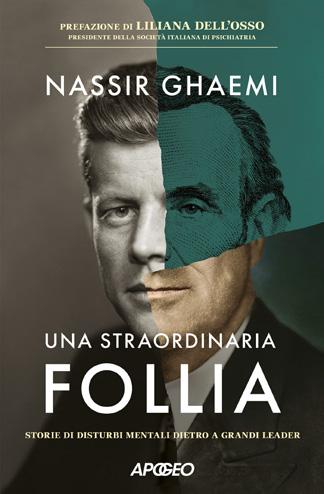
Enrica Tesio
Cose che ti dico mentre dormi
Bompiani, 2025 – 18,00 euro
«Sono oggi una Penelope al contrario. Lei di giorno tesseva e di notte disfaceva, io di notte cerco il bandolo della matassa che il giorno ha il vizio di mandare a rotoli.» Nell’ora in cui tutti dormono, l’autrice raccoglie i discorsi notturni di tutta la famiglia. Dai figli al marito, dall’amica che vive lontano fino alla mamma che non c’è più. (A. L.).
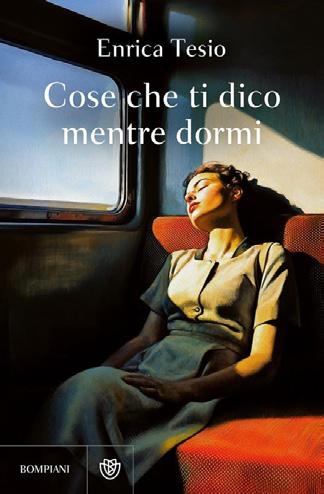
Zed Nelson
The anthropocene illusion
Guest Editions, 2025 - 52,95 euro
Dal rapporto malsano tra essere umano e natura nasce un sorprendente libro fotografico. Alberi tinti, orsi polari nei centri commerciali, qui tutto è naturale purché sia artificiale. Il fotografo documentarista inglese racconta il paradosso dei nostri tempi e l’illusione in cui viviamo. (A. L.).
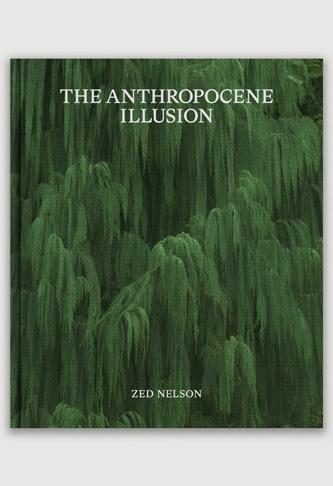
Le prospettive terapeutiche per uno dei disturbi più diffusi e debilitanti del sonno
di Daniela Bencardino*
L’insonnia è definita da sintomi che probabilmente tutti abbiamo sperimentato: difficoltà ad addormentarsi, risvegli durante la notte oppure al mattino presto, seguiti dalla difficoltà di riaddormentarsi. Ma ciò che distingue le persone con insonnia da chi semplicemente ha passato una notte difficile è la persistenza dei sintomi. Per parlare di vera insonnia, quella clinica, questi disturbi devono presentarsi almeno tre volte a settimana, per tre mesi o più, anche quando tutto è perfettamente favorevole al sonno. Ma non basta. Per parlare davvero di insonnia, è necessario che questi fastidi notturni compromettano anche la qualità di vita durante il giorno causando scarsa concentrazione, stanchezza, irritabilità e senso di inefficienza. Quindi non si tratta solo di dormire male, ma in generale di vivere peggio [1]. Attualmente esistono due approcci terapeutici principali per trattare l’insonnia. La più efficace è la terapia cognitivo-comportamentale che, come suggerisce il nome, agisce sia sugli aspetti mentali (come la mente iperattiva che impedisce di dormire) sia su quelli comportamentali, aiutando a ristabilire un ritmo sonno-veglia sano. La terapia cognitivo-comportamentale può essere svolta in presenza, individualmente o in gruppo, oppure da remoto, attraverso programmi online o app dedicate al trattamento [2]. Nonostante le meta-analisi di studi clinici randomizzati riportino effetti complessivamente positivi, una parte considerevole delle persone con insonnia non ottiene benefici clinicamente significativi. Per esempio,
* Comunicatrice scientifica e Medical writer
l’efficienza del sonno, l’indicatore che viene considerato per misurare la qualità del sonno dopo il trattamento, in media non supera l’80%, soglia considerata il minimo per un sonno normale. Inoltre, la terapia cognitivo-comportamentale riduce l’indice di gravità dell’insonnia solo di 4,3 punti in media, ma per poter parlare di un miglioramento clinico moderato questo indice dovrebbe ridursi del doppio [1,3].
Quando questo approccio non risulta efficace, il passo successivo è una decisione condivisa tra medico e paziente sull’eventuale introduzione di un trattamento farmacologico. Tuttavia, le linee guida raccomandano di limitare l’uso dei farmaci a un periodo breve che non dovrebbe superare le 4 settimane, per evitare assuefazione o dipendenza. Solo in alcuni casi può essere previsto un uso prolungato, ma dopo un’attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio da parte dello specialista [2].
Poiché l’insonnia è considerata un disturbo del sonno, i meccanismi che la scatenano sono stati ampiamente indagati nei sistemi cerebrali che lo regolano. Eppure, con grande sorpresa, gli studi hanno rilevato uno scarso coinvolgimento dei fattori circadiani e omeostatici, da sempre considerati i due principali componenti della regolazione del sonno. Negli ultimi vent’anni, infatti, si è fatta strada una nuova prospettiva: il sonno non sarebbe solo un momento di riposo, ma un intervallo di tempo in cui il cervello può attivare in modo ottimale la propria plasticità neuronale, cioè la capacità del cervello di modificare la propria struttura, la propria funzione e connessioni per adattarsi agli stimoli a cui è sottoposto. Secondo questa ipotesi, sonno e veglia riflettono un principio organiz-
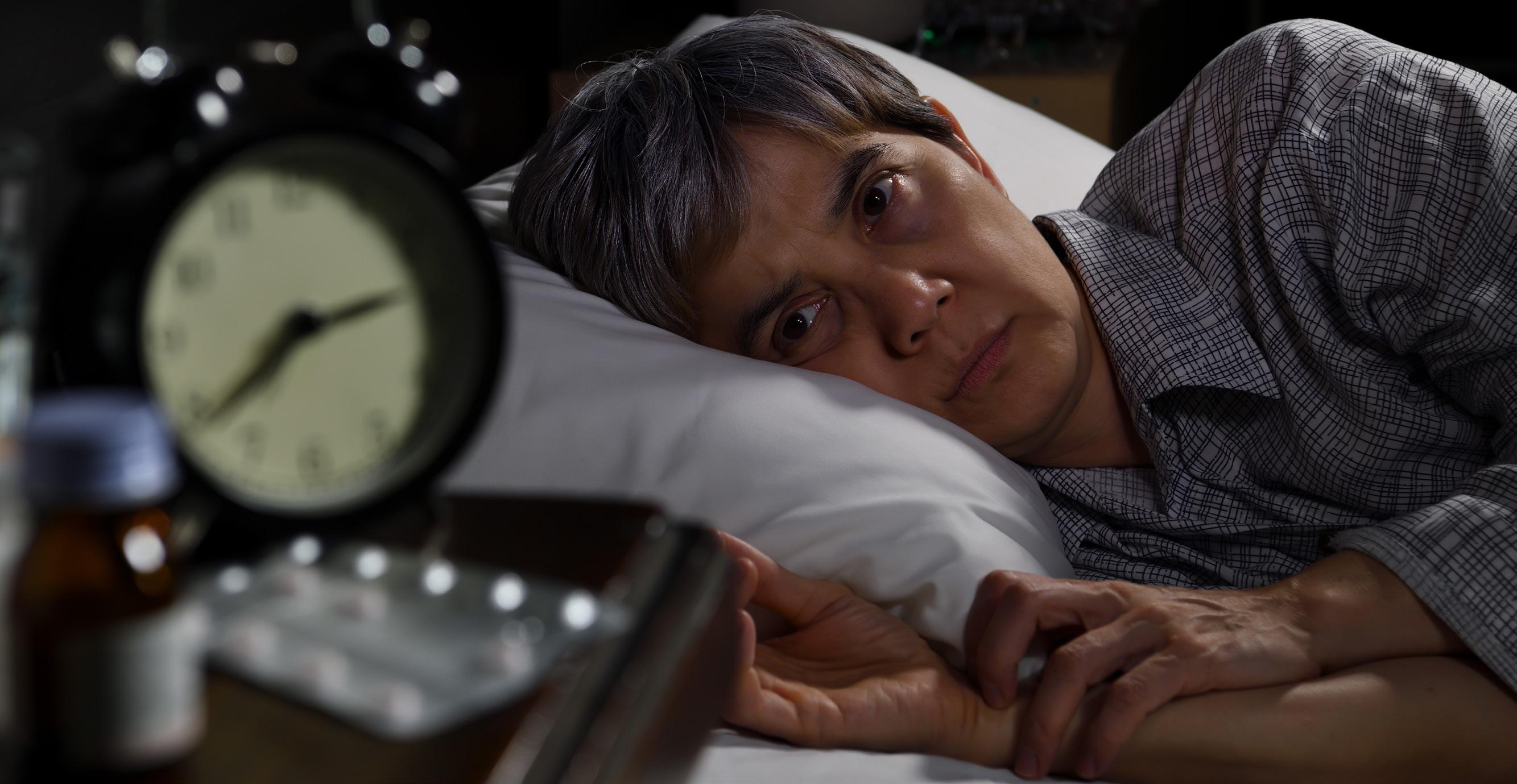
zativo volto a separare nel tempo i meccanismi molecolari da quelli comportamentali. Questi, se avvenissero simultaneamente o troppo ravvicinati, sarebbero sub-ottimali o persino dannosi. La plasticità neuronale si verifica anche durante la veglia, ma il sonno crea condizioni biologiche che rendono possibili forme più organizzate di ristrutturazione sinaptica e funzionale.
Durante il sonno, infatti, si verificano cambiamenti nei livelli dei neurotrasmettitori (serotonina, acetilcolina e noradrenalina) e si instaurano ritmi oscillatori cerebrali, come i fusi del sonno, che non sono presenti, o lo sono in minima parte, quando siamo svegli. Queste condizioni ottimizzano i processi della memoria, della riorganizzazione delle reti neurali e della regolazione emotiva, rendendo il sonno un momento importante per la salute mentale. Nelle persone che soffrono di insonnia o disturbi della fase REM (fase in cui le onde cerebrali evidenziano il movimento degli occhi), questa finestra può risultare “contaminata” da segnali neurofisiologici tipici della veglia. Per esempio, i livelli di noradrenalina, coinvolta nella veglia e nella risposta allo stress, dovrebbero ridursi durante la fase REM per consentire al cervello di processare i contenuti emotivi. Quando questo non avviene, si verifica un’interferenza nei meccanismi di adattamento notturno, con un impatto negativo sulla capacità del cervello di ridurre la carica emotiva dei ricordi registrati durante il giorno. Questa mancata separazione tra veglia e sonno è un’interferenza funzionale, che può contribuire alla cronicizzazione del disagio e alla vulnerabilità psicologica, soprattutto nei soggetti con un sonno agitato [4].
Diversi studi recenti hanno rivelato che una fase REM agitata interferisce con i processi di adattamento emotivo. Al contrario, un sonno profondo e continuo favorisce l’elaborazione notturna delle emozioni contribuendo a ridurre l’intensità e la carica negativa dei ricordi, che diventano più facili da gestire e meno invadenti. Quando il sonno REM risulta
©
disturbato, questi meccanismi adattivi vengono compromessi, con effetti che possono durare a lungo e lasciare tracce visibili nell’attivazione cerebrale, anche dopo decenni [5]. Questa vulnerabilità potrebbe contribuire anche allo sviluppo di altri disturbi psicopatologici, come ansia, depressione e disturbo da stress post-traumatico che condividono fattori di rischio simili che spesso si manifestano come comorbidità o in successione. È possibile, quindi, che le differenze diagnostiche tra questi disturbi risiedano soprattutto nel tipo di disagio emotivo che non viene elaborato adeguatamente durante il sonno, come paura, ansia, iperattivazione, stress, tensione o tristezza. Questa nuova ipotesi offre un quadro più completo per lo studio dell’insonnia superando l’idea che sia un disturbo puramente del sonno [1].
La genetica dell’insonnia
Circa un terzo della popolazione generale sperimenta sintomi di insonnia almeno occasionalmente. La diagnosi viene confermata quando i sintomi (difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni, risveglio al mattino presto, difficoltà di riaddormentarsi) si verificano nonostante ci siano condizioni adeguate per dormire, causando un disagio soggettivo o un impatto negativo sul funzionamento diurno, e sono presenti almeno tre volte a settimana per un periodo di almeno tre mesi. In media, circa il 10% della popolazione soddisfa questi criteri diagnostici. Uno studio recente ha monitorato persone con un sonno regolare per un anno rilevando un’incidenza del 27% di insonnia acuta, con l’1,8% di probabilità di sviluppare una forma cronica. Le stime di prevalenza possono variare in base a fattori come l’età, gli strumenti di valutazione e i criteri diagnostici applicati. In generale, l’insonnia risulta il secondo disturbo mentale più comune, con una prevalenza superiore a quella della depressione e seconda solo ai disturbi d’ansia [1,6].
Un modello psicologico dell’insonnia ha evidenziato la
necessità di affrontare i tre cosiddetti fattori “P”: personalità predisponenti a preoccuparsi (predisposing personality); eventi scatenanti, come lo stress (precipitating events); e atteggiamenti e pratiche che perpetuano il disturbo, come le concezioni errate sul sonno necessario (perpetuating attitudes).
Ma in quale momento della vita iniziano i fattori predisponenti all’insonnia? I rischi di sviluppare insonnia cronica dovrebbero essere analizzati lungo l’intero arco della vita e comprendere un’ampia gamma di fattori individuali e sociali. Per esempio, si può nascere con il rischio di sviluppare insonnia? Studi familiari suggeriscono di sì ma non chiariscono se questo dipenda da una base genetica oppure da somiglianze ambientali e comportamentali trasmesse tra generazioni. Per isolare la componente genetica servono studi sui gemelli. Le stime di ereditarietà riportate per fenotipi specifici di insonnia sembrano pari a quella dell’ansia, della depressione e del neuroticismo, i tre tratti strettamente legati all’insonnia [7].
L’insonnia è stata associata a polimorfismi presenti in geni implicati in altri disturbi psichiatrici come quelli coinvolti nel trasporto (5-HTTLPR) o nel metabolismo (MAO-A) della serotonina. È stato inoltre suggerito che l’insonnia sia associata a polimorfismi in geni coinvolti nella regolazione del ritmo circadiano, come PER2, PER3, CLOCK e BMAL1, e PGC-1α, un gene coinvolto sia nei meccanismi dell’orologio biologico che nel metabolismo. Oltre alla ricerca basata sulla selezione dei geni candidati, vi sono studi anche sulla definizione del fenotipo dell’insonnia. Ad esempio, se alcune persone sono geneticamente predisposte a faticare ad addormentarsi quando cercano di adattarsi a orari socialmente convenzionali, non necessariamente soffrono di insonnia [1,8].
I geni associati al rischio di insonnia probabilmente esercitano il loro effetto modificando il funzionamento cerebrale. Analisi specifiche per tessuto hanno mostrato un’elevata concentrazione del segnale genetico nei geni espressi nel cervello, in particolare nella corteccia cerebrale. Successive analisi su tipi cellulari più ampi hanno rivelato un’espressione significativamente più alta dei geni di rischio per l’insonnia nei neuroni spinosi medi [9].
Stimolazioni del cervello e trattamento
Oggi il sonno può essere facilmente indotto in numerose specie attraverso la stimolazione mirata di specifiche popolazioni neuronali, ma questo controllo remoto del sonno richiede tecniche di ingegneria genetica, iniezione di vettori virali e impianto di elettrodi o fibre ottiche, il che ne limita l’applicazione nell’uomo. Le tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva, invece, permettono ai clinici di modulare l’attività cerebrale in modo sicuro e reversibile. Le tecniche che modulano indirettamente l’attività cerebrale includono: la stimolazione del nervo vago auricolare transcutanea, il raffreddamento frontale, la stimolazione uditiva e la stimolazione vestibolare. La maggior parte di queste è stata testata in studi
che avevano lo scopo di comprendere i meccanismi della regolazione o manipolazione del sonno in soggetti adulti sani. La stimolazione cerebrale è quindi diventata un argomento di grande interesse, con applicazioni che spaziano dalla ricerca di base alla potenziale applicazione terapeutica [10].
L’esplorazione degli approcci di stimolazione cerebrale come potenziali trattamenti per l’insonnia sta vivendo una fase di rinascita, a seguito dei tentativi storici di migliorare elettricamente il sonno dei pazienti con insonnia. Le moderne tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva hanno effetti ben documentati sulla neurofisiologia, alimentando nuove speranze sul fatto che la stimolazione cerebrale possa finalmente dimostrarsi utile nel trattamento dell’insonnia. Al contrario, rimane un mistero come la stimolazione di diverse aree corticali, in diversi momenti del giorno o della notte e con tecniche e parametri di stimolazione diversi, possa produrre effetti terapeutici così simili e intensi. È importante notare che gli effetti positivi, però, sono stati registrati sia nei gruppi attivi che in quelli di controllo, indicando che i dispositivi di stimolazione cerebrale possono generare un importante effetto placebo. È quindi essenziale proporre studi clinici in doppio cieco per testare e valutare accuratamente i potenziali benefici terapeutici [10,11].
Altri metodi sono attualmente in fase di studio, come la stimolazione cerebrale profonda che consiste nello stimolare elettricamente aree cerebrali circoscritte dopo l’impianto neurochirurgico di un elettrodo sottile. Questa tecnica ha avuto grande successo nel trattamento dei disturbi del movimento, in particolare nei pazienti con morbo di Parkinson. Ma il suo uso nel trattamento di disturbi psichiatrici resta limitato per la grande eterogeneità con cui la patologia si presenta, per la mancanza di modelli fisiopatologici chiari e per la difficoltà nel selezionare bersagli di stimolazione efficaci. Alcuni studi hanno monitorato il sonno come parametro secondario, ma i risultati ottenuti sono stati altamente variabili. Ad oggi, nessuno studio ha studiato la possibilità che la stimolazione cerebrale profonda possa essere un possibile trattamento per l’insonnia primaria. Tuttavia, l’assenza di una regione cerebrale candidata inequivocabile, unita ai vincoli etici legati al piccolo ma serio rischio di complicazioni chirurgiche, rendono improbabile un suo prossimo uso nel trattamento dell’insonnia. Alcune evidenze scientifiche, invece, suggeriscono che la stimolazione del sistema vestibolare dell’orecchio mediante movimenti oscillatori possa influenzare l’architettura del sonno, le oscillazioni cerebrali e la consolidazione mnemonica durante il sonno, sia negli animali che nell’uomo. I risultati riportati però sono contrastanti e in assenza di un gruppo di controllo non possono essere considerati definitivi. Uno studio pilota, per esempio, ha impiegato la stimolazione del sistema vestibolare prima del sonno notturno in pazienti con insonnia riportando miglioramenti nei parametri soggettivi del sonno, ma senza confronto con un gruppo o condizione di controllo.

Circa un decennio fa è stato scoperto che applicare stimoli uditivi durante il sonno può potenziare le oscillazioni lente, i fusi del sonno e la consolidazione mnemonica legata al sonno. Da allora, sono stati dimostrati gli effetti fisiologici di diversi paradigmi di stimolazione uditiva sull’attività oscillatoria cerebrale, così come gli effetti molecolari, di rete e comportamentali conseguenti. Sebbene la maggior parte della ricerca finora si sia concentrata sullo sviluppo tecnologico per ottenere effetti robusti sulla neurofisiologia del sonno, modifiche dell’architettura del sonno sono state recentemente dimostrate. Diversi studi clinici sono attualmente in corso per esplorare il potenziale dei paradigmi di stimolazione uditiva nel migliorare i sintomi dell’insonnia [10].
Conclusioni
La ricerca dei prossimi anni dovrà concentrarsi su come ridurre la fase REM agitata del sonno e favorirne una più riposante. Questo potrebbe essere ottenuto attraverso strategie note come la restrizione del sonno, la terapia cognitivo-comportamentale o tramite l’uso di farmaci che agiscono sul sistema noradrenergico, soprattutto nelle ultime ore della notte, quando il sonno è più disturbato e si concentra la maggior parte del sonno REM. Sebbene la ricerca su animali e umani indichi che è possibile modulare il sonno attraverso stimolazione cerebrale, la traslazione clinica è ostacolata da lacune nella comprensione attuale della fisiologia del sonno e della fisiopatologia dell’insonnia. La maggior parte dei metodi agisce modulando l’attività corticale, sarà quindi essenziale comprendere come la corteccia contribuisca alla regolazione del sonno e quali pattern di attività corticale risultino alterati nei pazienti con insonnia, al fine di ottimizzare bersagli e protocolli di stimolazione.
© WesternExoticStockers/shutterstock.com
1. Van Someren EJW. Brain mechanisms of insomnia: new perspectives on causes and consequences. Physiol Rev. 2021 Jul 1;101(3):995-1046
2. Riemann D, Espie CA, Altena E, Arnardottir ES, Baglioni C, Bassetti CLA, et al. The European Insomnia Guideline: An update on the diagnosis and treatment of insomnia 2023. J Sleep Res. 2023 Dec;32(6):e14035
3. Seyffert M, Lagisetty P, Landgraf J, Chopra V, Pfeiffer PN, Conte ML,Mam R. Internet-delivered cognitive behavioral therapy to treatinsomnia: A systematic review and meta-analysis. PLoS One 11:e0149139, 2016
4. Van Someren EJW. Doing with less sleep remains a dream. ProcNatl Acad Sci U S A 107: 16003–16004, 2010. doi:10.1073/pnas.1011249107
5. Wassing R, Schalkwijk F, Kamal O, Ramautar J, Stoffers D, MutsaertsH-J, Talamini LM, Van Someren EJW. Haunted by the past: old emo-tions remain salient in insomnia disorder. Brain 142: 1783–1796,2019
6. Perlis ML, Vargas I, Ellis JG, Grandner MA, Morales KH, Gencarelli A,Khader W, Kloss JD, Gooneratne NS, Thase ME. The natural historyof insomnia: the incidence of acute insomnia and subsequent pro-gression to chronic insomnia or recovery in good sleeper subjects.Sleep 43: zsz299, 2020
7. Lind M, Gehrman P. Genetic pathways to insomnia. Brain Sci 6: 64, 2016
8. Wang CC, For-Wey L. The role of PGC-1 and Apoepsilon4 in insomnia. Psychiatr Genet 22: 82–87, 2012
9. Jansen PR, Watanabe K, Stringer S, Skene N, Bryois J, Hammerschlag AR; The 23andMe Research Team; et al. Genomewide analysis of insomnia in 1,331,010 individuals identifies new risk loci and functional pathways. Nat Genet 51: 394–403, 2019
10. Krone LB, Fehér KD, Rivero T, Omlin X. Brain stimulation techniques as novel treatment options for insomnia: A systematic review. J Sleep Res. 2023 Dec;32(6):e13927
11. Roth, T., Mayleben, D., Feldman, N., Lankford, A., Grant, T., & Nofzinger, E. (2018). A novel forehead temperature-regulating device for insomnia: A randomized clinical trial. Sleep, 41(5), zsy045
Come la terapia genetica sta rivoluzionando l’approccio al trattamento delle malattie genetiche rare e oncologiche
Negli ultimi anni, la terapia genica ha compiuto passi da gigante, trasformandosi da approccio sperimentale a concreta opzione terapeutica per molte malattie genetiche rare e, più recentemente, per alcuni tipi di tumore. Le innovazioni tecnologiche, in particolare l’editing genetico di nuova generazione, stanno ridefinendo i confini della medicina personalizzata, offrendo nuove speranze laddove le terapie convenzionali si sono rivelate inefficaci.
Le malattie genetiche rare rappresentano una sfida clinica e scientifica notevole: spesso colpiscono bambini, hanno una progressione rapida e una prognosi severa. In questo contesto, la terapia genica offre un’opportunità unica: intervenire direttamente sulla causa genetica, correggendo o compensando il difetto alla base della patologia. Un esempio emblematico è rappresentato dalle terapie approvate per l’atrofia muscolare spinale (SMA) o per alcune forme di amaurosi congenita della retina.
Un caso tutto italiano è rappresentato dalle terapie sviluppate grazie al sostegno della Fondazione Telethon. Tra queste, la terapia genica per l’ADA-SCID (una forma rara e grave di immunodeficienza congenita) è stata la prima al mondo a ottenere l’approvazione europea (con il nome commerciale Strimvelis), aprendo la strada alla cura di bambini fino ad allora condannati a una vita in isolamen -
* Professore - Università degli Studi di Napoli Federico II
** Ufficio Scientifico TIGEM - Fondazione Telethon ETS
to. Sempre nell’ambito delle malattie rare, il TIGEM di Pozzuoli ha sviluppato una terapia genica sperimentale per la mucopolisaccaridosi di tipo VI (MPS VI), una grave malattia lisosomiale pediatrica, oggi in fase clinica. Questi risultati dimostrano come la combinazione di ricerca di eccellenza, sostegno filantropico e collaborazione internazionale possano portare a trattamenti concreti per pazienti spesso dimenticati dalla ricerca industriale.
Nel campo dell’oncologia, la terapia genica ha trovato un’applicazione rivoluzionaria con l’introduzione delle CAR-T, cellule T ingegnerizzate per riconoscere e attaccare specificamente le cellule tumorali. Anche l’editing genetico viene esplorato per rendere le cellule immunitarie resistenti all’immunosoppressione indotta dal microambiente tumorale, o per silenziare oncogeni specifici.
Tra le tecnologie più promettenti c’è sicuramente CRISPR/Cas9, che consente di “tagliare e cucire” il DNA con precisione, aprendo la strada a interventi terapeutici mirati e potenzialmente definitivi. CRISPR è oggi utilizzato in studi clinici per patologie come la beta-talassemia, l’anemia falciforme e la distrofia muscolare di Duchenne. Versioni più recenti ed ancora più precisi a livello delle singole basi come il base editing e il prime editing, offrono ulteriori livelli di precisione, riducendo il rischio di effetti off-target.
Parallelamente, altre strategie di editing epigenetico stanno emergendo, permettendo di modulare l’espressione genica senza alterare direttamente la sequenza del DNA. Queste tecnologie potrebbero essere particolar-



mente utili per patologie multifattoriali o per il tratta mento del cancro, dove spesso l’alterazione dei pattern
Un aspetto fondamentale della terapia genica riguar da i vettori utilizzati per trasportare il materiale gene tico nelle cellule bersaglio. I più comuni sono i virus adeno-associati (AAV), utilizzati per la loro sicurezza e capacità di infettare cellule non in divisione. Tuttavia, restano aperte sfide significative: la risposta immunitaria ai vettori, la necessità di ottenere un’espressione stabile e controllata, e la possibilità di trattare tessuti di difficile accesso, come le cellule del sistema nervoso centrale.

lità economica e sull’accesso equo alle cure. In questo senso, programmi di sviluppo accademico e modelli “nof-1” personalizzati per pazienti ultra-rari stanno cercando di tracciare nuove strade, più flessibili e orientate al bisogno clinico.

Stanno emergendo inoltre approcci non virali, come i nanoparticellati lipidici (LNP), già impiegati nei vaccini a mRNA, e sempre più studiati per la somministrazione di RNA terapeutici e sistemi CRISPR.
L’avanzamento rapido della terapia genica solleva però questioni complesse di natura etica e regolatoria. L’editing genetico su cellule germinali è oggi proibito in quasi tutti i paesi, per evitare modifiche trasmissibili alle generazioni future. Ma anche gli interventi su cellule so -
Le nuove frontiere della terapia genica stanno trasformando la medicina, portando soluzioni innovative per malattie finora prive di cura. La combinazione di editing genetico, vettori sempre più efficienti e strategie personalizzate apre scenari di straordinario potenziale, ma richiede anche un impegno costante in termini di ricerca, etica e accessibilità. I biologi e biotecnologi, con la loro formazione interdisciplinare, sono chiamati a giocare un ruolo chiave in questo processo, contribuendo alla progettazione, alla validazione e alla comunicazione di queste terapie che cambiano la vita.
Un legame millenario tra sopravvivenza ed esplorazione
di Giuliano Russini*
Sappiamo che le piante sul pianeta Terra svolgono un ruolo indispensabile, per garantire l’evoluzione della vita animale, producendo grazie alla fotosintesi clorofilliana O2, consumando CO2 e oggi anche filtrando e quindi purificando l’aria da particolati prodotti dall’inquinamento industriale e urbano (PM 10, PM 2,5), fornendo cibo e nutrimento per gli erbivori e l’essere umano stesso e caratterizzando gli habitat attraverso i paesaggi; inoltre formano una delle biomasse più abbondanti di organismi viventi esistenti.
Nel caso dell’essere umano, hanno anche fornito da tempi remoti mezzi di cura e tessuti con cui vestirsi (piante medicinali, piante tessili), o per costruire utensili, giacigli per dormire, o tetti per le case.
Storia di un rapporto affascinate e in alcuni casi misterico, tra Uomo e Piante
Nel 1787 un vascello inglese, comandato dal tenente William Bligh, lasciò l’Inghilterra, con il compito di trasportare un migliaio di piante dell’albero del pane (Artocarpus incisa) dalla nativa Tahiti alle Indie Occidentali britanniche. I piantatori di queste regioni, conosciuta l’esistenza di questo albero, i cui frutti a livello nutrizionale potevano sostituire il pane, volevano tentare a loro volta la coltivazione.
La nave, costruita apposta per questo trasporto, dovette attendere in porto che i botanici preparassero le talee da
* Biologo
mettere a dimora in piccoli vasi riempiti della terra locale, poiché essendo endemici del luogo, i semi in altri tipi di terre e latitudini non sarebbero germinati. La destinazione finale era la Giamaica, ma dopo tre settimane dalla partenza da Tahiti, l’equipaggio si ammutinò a causa sia del trattamento duro del comandante e sia perché in quelle terre paradisiache, avevano trovato la pace, una splendida natura, cibo e creato famiglie con le donne locali. La nave era il Bounty; imbarcato con 18 uomini su una sola scialuppa, Bligh si salvò, navigando per 3.618 miglia marine sino a Timor (Indonesia).
L’ammutinamento e il processo che ne seguì resero la pianta del pane nota al mondo. È meno noto che Bligh nel 1792, ritentò l’impresa; questa volta portò a destinazione in Giamaica i preziosi alberelli, cresciuti dalle talee, che in seguito vennero moltiplicati e crebbero in molte zone tropicali. Molte sono le piante esotiche, le cui vicende sono strane e avventurose e vedono oltre che capitani di navi, anche esploratori e botanici coinvolti.
Leggere la storia del Cacao (Theobroma cacao), significa per esempio, tornare indietro nel tempo per rivivere i fasti e la storia delle corti degli Aztechi e dell’antico impero Maya (ove fu probabilmente importato dalle regioni del Messico). Presso gli Aztechi il cacao era alimento di uso quotidiano: le tasse potevano venire pagate anche con casse di semi di cacao, usate come moneta. Il cacao veniva bevuto caldo, come bevanda aromatizzata con vaniglia e altre spezie; oppure sbattuto a lungo ed energeticamente così da ottenere una sorta di “frullato” semisolido, che si consumava freddo.
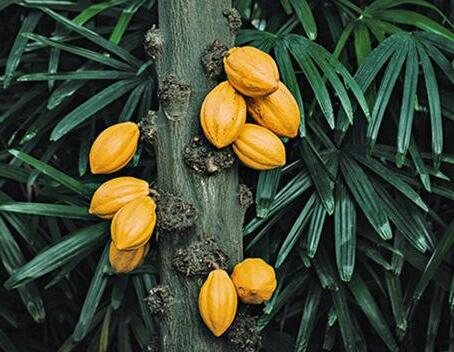
Da documenti si conosce che Montezuma consumasse da solo fino a 50 boccali di questo frullato e che nelle cucine imperiali, solo per la grande famiglia dell’imperatore se ne preparavano quotidianamente 2.000 boccali al giorno (le cronache di Cortès, Gomara, Oviedo e altri, parlano addirittura di “brocche”).
Altrettanto affascinante è la storia del Caffè (Coffea arabica), la cui origine geografica a dispetto del nome non è arabica, ma africana, in particolare degli altipiani dell’Etiopia e in Angola; l’equivoco sembrerebbe nascere dal fatto che quando il caffè arrivò in Europa nel secolo XII, proveniva dall’Arabia, poiché fu importato prima in Asia minore. Da qui l’uso del caffè come bevanda, cominciò a diffondersi tra i musulmani, da questi in Egitto e in Persia (l’attuale Iran).
Pochi anni dopo a contrabbandare i semi del Suriname, fu lo stesso governatore della Caienna: di qui il caffè si diffuse in Brasile. Alcune piante coltivate dai botanici a Parigi nel Jardin du Roi, furono richieste dalla Martinica, ove la coltivazione cominciò con una sola pianta sopravvissuta al viaggio! Furono sempre gli olandesi a introdurre la coltivazione del caffè a Ceylon (attuale Sri Lanka), mentre gli inglesi, lo potarono in Africa e in India.
“Esotiche” sono molte piante che hanno dato all’essere umano specialmente europeo, nuovi ortaggi e nuovi frutti (non solo gli avocados, gli ananas sono esotiche in senso proprio, ma anche le patate, i pomodori, le melanzane, il mais giunte a noi dal Nuovo Mondo); quelle che ci hanno dato fibre tessili, legname pregiato, sostanze medicinali, o anche solo fiori particolari e profumati, o piante ornamentali da giardino e appartamento.
Alcune di queste “esotiche”, hanno solo un interesse scientifico e non economico. Un esempio può essere quello dei Seneci: mentre le specie indigene delle nostre regioni come Senecio vulgaris e Senecio jacobeae, sono piccole piante erbacee, quelle esotiche, nel clima tropicale-montano d’Africa e Asia, si sviluppano in maniera abnorme, fino a diventare alberelli di 4-5 m d’altezza. Sul monte Kenia e sul Ruwenzori questi Seneci “giganti” o arborei ad esempio Senecio keniodendron, si spingono fino al limite montano della vegetazione sotto le cime rocciose, rappresentando l’ultimo avamposto (stazione vegetativa) della foresta tropicale.
Specie esotiche fruttifere e loro uso a scopo umano
Numerose sono le specie esotiche che danno frutti saporitissimi, utilizzati dall’essere umano. Due possono servire da esempio, la prima americana, la seconda asiatica. Tipica dell’America centrale, poiché probabilmente originaria dei Caraibi e anticamente passata in coltivazione in Messico è la Papaia (Carica papaya): detta anche «albero dei meloni» per i frutti gialli, piriformi, attaccati direttamente al fusto (esempio di caulifloria) è un albero alto dai 3-4 m, sino ai 10-12 m. La sagoma richiama vagamente quello della palma.
A maturità i frutti ricordano il melone, pesano 1-2 kg in media, fino a 8-10 kg per gli esemplari più grandi. Il frutto aperto mostra una cavità centrale, ove in una placenta mucillaginosa sono immersi i semi neri. Ha un sapore misto di melone e albicocca e da una certa varietà di papaie si estrae la «papaina» un fermento digestivo peptonizzante, simile alla pepsina. Arrivata nel Vecchio Mondo solo nel XVI secolo, in poco più di cento anni si è diffusa in India, Malesia, Indonesia, Indocina, Cina e nell’Africa orientale. Si è naturalizzata tanto bene nei paesi di coltivazione, da essere scambiata per indigena.
Il mango (Mangifera indica) specie asiatica è coltivato in India da ben 4.000 anni; albero imponente (sia per l’altezza, da 10 a 25 e più m), sia soprattutto per la chioma ampia, densa ed ombrosa. I frutti possono avere la dimensione di una albicocca, o arrivare a pesare anche 2 kg, possono essere ovali, rotondi, cuoriformi, a buccia gialla, verde o cremisi; la polpa sempre giallo-arancio. Se ne conoscono innumerevoli varietà oggi coltivate in Brasile, Indie Occidentali, Africa, Florida, Filippine.
In India è stato dato il nome di mango persino ad un uccello a un pesce e persino alle piogge che cadono nei mesi più caldi, poiché coincidono con la stagione del frutto. In Tailandia esiste una varietà chiamata «il Bramino che vende la moglie» poiché una antica legenda narra che un bramino vendette la consorte, per potersi comprare questi frutti saporiti.
1. Il Libro delle Piante, Franceso e Maria Vittoria Bianchini- Fabbri Editori
2. Scienze Biologiche “Gli esseri viventi”, AA.VV. -Istituto Geografico de Agostini Novara
3. Tropical Plants, W. Lötschert, G. Beese -Collins Guide
4. Il grande Libro delle Piante e dei Fiori- AA.VV. Reader’s Digest
5. Plagues in World History- John Aberth
6. Igiene e Medicina Sociale, Società Editrice Internazionale- Ulrico di Aichelburg
7. Abbiw, D.K., 1990, Useful Plants of Ghana. West African uses of wild and cultivated plants. Intermediate Technology Publications and the Royal Botanic Gardens, Kew. p 41
8. Anderson, E. F., 1993, Plants and people of the Golden Triangle. Dioscorides Press. p 205
9. Awasthi, A.K., 1991, Ethnobotanical studies of the Negrito Islanders of Andaman Islands, IndiaThe Great Andamanese. Economic Botany 45(2) pp274-280.
