Cosmometry Exploring the HoloFractal Nature of the Cosmos Marshall Lefferts
Visit to download the full and correct content document: https://textbookfull.com/product/cosmometry-exploring-the-holofractal-nature-of-the-c osmos-marshall-lefferts/

More products digital (pdf, epub, mobi) instant download maybe you interests ...
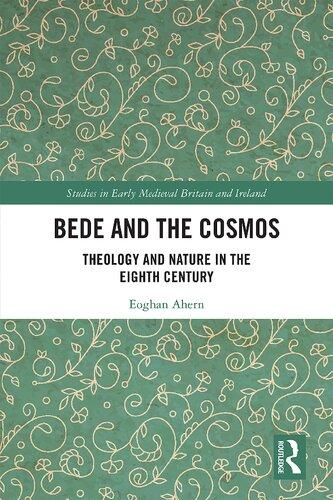
Bede and the Cosmos Theology and Nature in the Eighth Century Eoghan Ahern
https://textbookfull.com/product/bede-and-the-cosmos-theologyand-nature-in-the-eighth-century-eoghan-ahern/
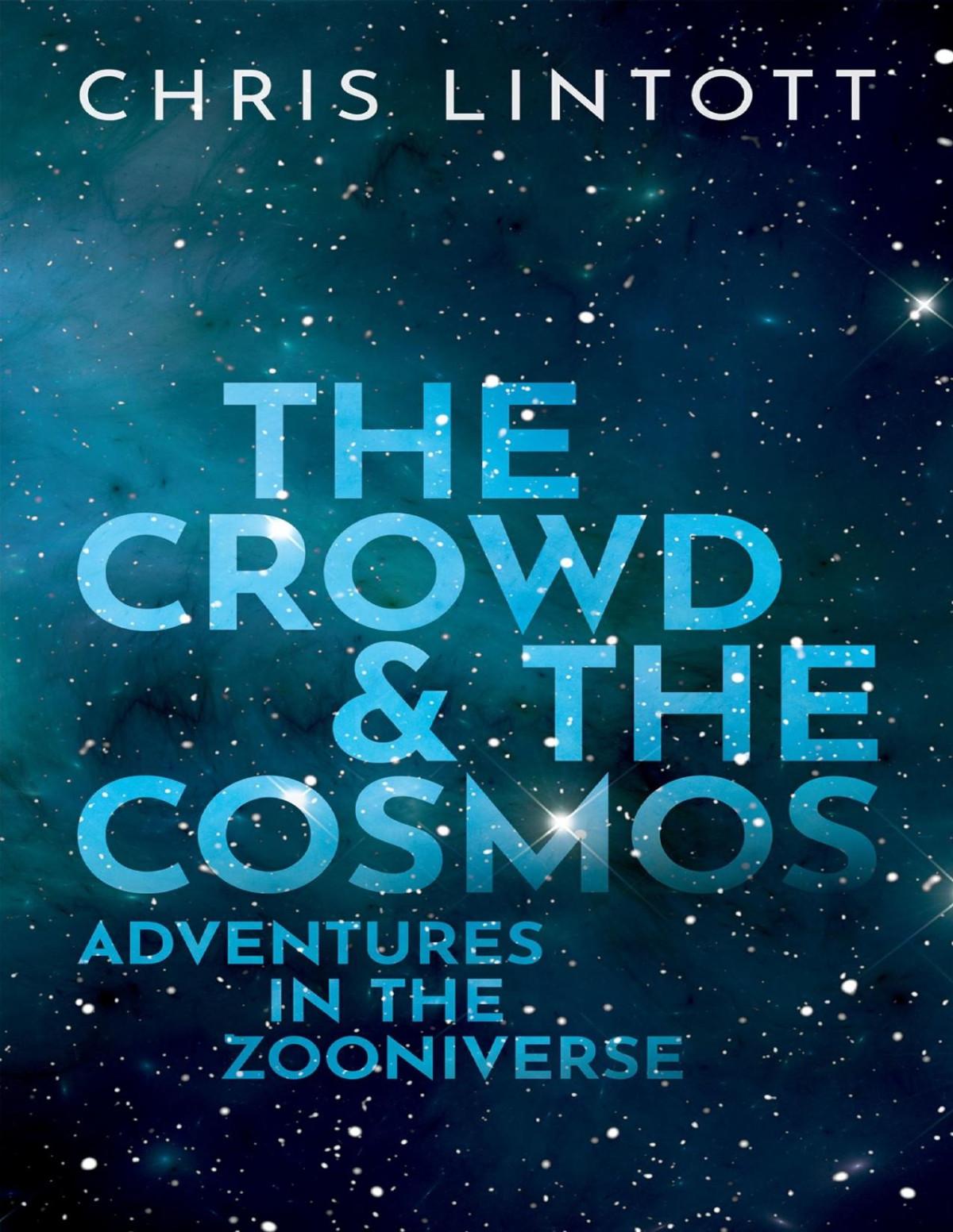
The Crowd and the Cosmos Chris Lintott
https://textbookfull.com/product/the-crowd-and-the-cosmos-chrislintott/

Secrets of the Universe How We Discovered the Cosmos Paul Murdin
https://textbookfull.com/product/secrets-of-the-universe-how-wediscovered-the-cosmos-paul-murdin/

The Rhetoric of Lincoln s Letters Marshall Myers
https://textbookfull.com/product/the-rhetoric-of-lincoln-sletters-marshall-myers/
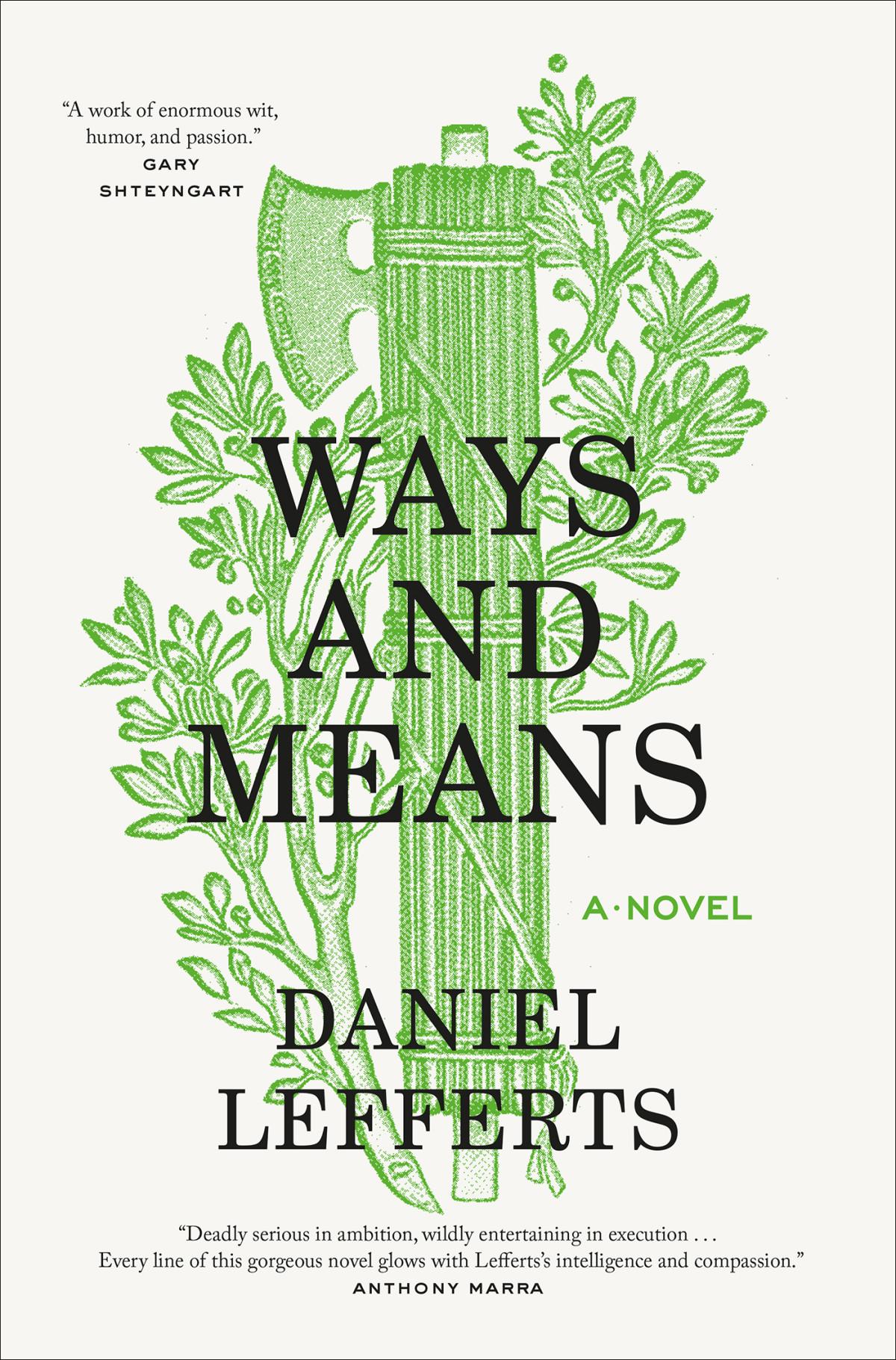
Ways and Means 1st Edition Daniel Lefferts
https://textbookfull.com/product/ways-and-means-1st-editiondaniel-lefferts/

The Cosmos Astronomy in the New Millennium Jay M. Pasachoff
https://textbookfull.com/product/the-cosmos-astronomy-in-the-newmillennium-jay-m-pasachoff/
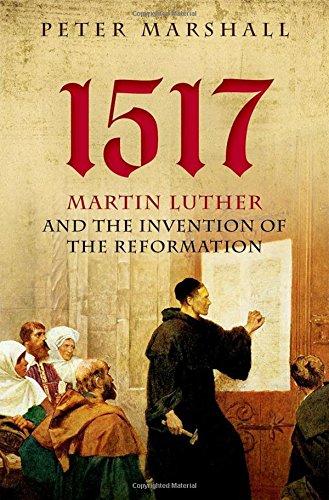
1517 : Martin Luther and the invention of the reformation Peter Marshall
https://textbookfull.com/product/1517-martin-luther-and-theinvention-of-the-reformation-peter-marshall/
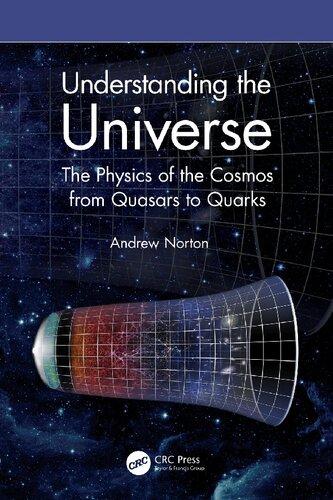
Understanding the Universe: The Physics of the Cosmos from Quasars to Quarks 1st Edition Andrew Norton
https://textbookfull.com/product/understanding-the-universe-thephysics-of-the-cosmos-from-quasars-to-quarks-1st-edition-andrewnorton/
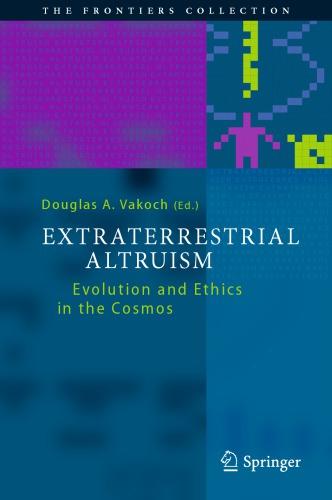
Extraterrestrial Altruism Evolution and Ethics in the Cosmos Vakoch
https://textbookfull.com/product/extraterrestrial-altruismevolution-and-ethics-in-the-cosmos-vakoch/
Another random document with no related content on Scribd:
quando di varietà. Quintiliano (�. 4) dice: Noster sermo articulos non desiderat; e Gellio (N. Atticæ, ��. 25) che il volgare differisce dal latino perchè manca di declinazioni e della varietà di desinenze; e Nonnio reca molti esempj di preposizioni adoprate per la maggior chiarezza. Ad Augusto, Svetonio appone di scrivere meno colla retta ortografia, che secondo la pronunzia, tralasciando lettere e fin sillabe, errore comune (cap. 88); e facendo prima cura l’esprimersi chiaramente, soggiungeva le preposizioni ai verbi, e iterava le congiunzioni, alla chiarezza sagrificando la grazia (cap. 86). Di fatto nel famoso suo testamento troviamo impendere in aliquam rem, invece di alicui rei; includere in carmen invece di carmine o carmini. Nè questo vezzo è raro ne’ classici:
Plauto. Filius de summo loco Hunc ad carnificem dabo.
Terenzio. Ne partis expers esset de nostris bonis Si res de amore secundae essent — Alere canes ad venandum.
Lucrezio. Portante de genere hoc.
Cicerone. Homo de schola — Declamator de ludo
Audiebam de parente nostro. E così
Efugere de manibus (Rosc. Am., 52).
Cæsar de transverso rogat ut veniam ad se (15. Att. 4).
Se gladio percussum ab uno de illis. (Milon. 24).
Ecco altri usi del de al modo nostro:
Ut jugulent homines surgunt de nocte latrones. O�����, Epist.
Una pars orationis de die dabitur mihi. P�����, Asin., ���. 1.13.
Fac ut considerate naviges de mense decembre. C��. ad Quint., 2, 5.
Vos convivia lauta de die facitis. C������, 47, 5.
De principio studuit animus occurrere magnitudini criminis. C�����, Sull., 24.
E altrove:
Atticus pecuniam numeravit de suo. C��. ad Planc.
Succus de quinquefolio. P���., 26. 4. 11.
Orazio. Cætera de genere hoc — De medio potare die Rapto de fratre dolentis.
Virgilio. Solido de marmore templa instituam, festosque dies de nomine Phœbi — Quercus de cœlo tactas.
Fedro. De credere (in un titolo).
Ovidio. Arbiter de lite jocosa — De duro est ultima ferro
Nec de plebe deus — De cespite virgo se levat.
Plinio. Genera de ulmo.
Svetonio. Partes de cœna[116].
Negli Agrimensori si ha «caput de aquila, rostrum de ave, monticelli de terra».
In Cicerone abbiamo: Ad omnes introitus, armatos opponit
— Ad meridiem spectans — Quid ad dextram, quid ad sinistram sit — Esse sapientem ad normam alicujus.
Varrone. Turdi eodem revolant ad aequinoctium vernum — Quod apparet ad auricolas.
Cesare. Magnam hæc res contemptionem ad omnes attulit.
Livio. Patrum superbiam ad plebem criminari — Incautos ad satietatem trucidabitis — Restituit ad parentes (��. 13).
— Restituti ad Romanos (����. 47).
Parimenti nei classici troviamo il pronome usato al modo italiano, e l’inde per l’onde o il ne nostro:
Plauto. Cadus erat vini; inde impievi cirneam.
Cicerone. Romani sales salsiores quam illi Atticorum.
Virgilio. Ille ego qui quondam ecc.
Ovidio. Stant calyces, minor inde faba, olus alter habebat[117].
E nel Vangelo: «Exiit Petrus et ille alius discipulus — Currebant duo simul, et ille alius præcurrit».
Da ciò era ovvio il passaggio all’articolo determinante[118]: ma neppur dell’indeterminato scarseggiano esempj.
Cicerone. Cum uno forti viro loquor — Sicut unus paterfamilias Ita nobilissima Græciæ civitas sui civis unius acutissimi monumentum ignorasset — Tamquam mihi cum M. Crasso contentio esset, non cum uno gladiatore nequissimo.
Orazio. Qui variare cupit rem prodigaliter unam.
Cesare. Inter aures unum cornu existit.
Curzio. Alexander unum animal est temerarium, vecors.
Seneca. Historici, cum unam aliquam rem nolunt spondere, adjiciunt, ecc.
Plauto. Qui est is homo? unus ne amator? Est huic unus servus violentissimus — Unum vidi mortuum efferri foras.
Plinio. Tabulam aptatam picturæ anus una custodiebat.
Plinio il giovane. Tanta gratia, tanta auctoritas in una vilissima tunica. Vedi pure Cornelio Nipote in Hannib., ����; e T�����, Ann., ��. 30. Uni libello.
Terenzio. Inter mulieres quæ ibi aderant, forte unam adspicio adolescentulam — Ad unum aliquem confugiebant.
Del qual ultimo verso vienmi a grand’uopo un commento, appostovi da Donato mentr’era ancor viva la latina lingua: Ex consuetudine dicit ����, ut dicimus ���� est adolescens. Unam ergo
dixit, vel unam pro quandam.
Si sa che in Omero non si trova l’articolo, onde Aristarco asserisce ἐλλείτει
Quando lo s’incontra, ha un valore diverso. Così
non vuol dire il decimo giorno, ma quel giorno, che era il decimo.
In ciò forse l’imitarono gli scrittori latini, tralasciando gli articoli, ma ricompajono abbondanti nella Bibbia, come i segnacasi: Et ecce una mulier fragmen molæ desuper jaciens, illisit Abimelech. Giudici, ��. 53.
Petrus sedebat foris in atrio, et accessit ad eum una ancilla. Matteo, ����. 69.
Per diem solemnem consueverat præses populo dimittere unum vinctum, quem voluissent, �����. 15.
Et videns fici arborem unam, venit ad eam. ���. 19.
Interrogabo vos et ego unum sermonem. Ivi. 24.
Interrogabo vos et ego unum verbum. Marco, ��. 29.
Unus autem quidam de circumstantibus. ���. 47.
Nella flessione dei verbi, delle sei forme organiche amo, amabam, amavi, amaveram, amavero, amabo, le sole tre prime ritenemmo: le altre si circoscrivono cogli ausiliarj. Ma già il verbo si trova conjugato al modo nostro. Invece del futuro usano il passato futuro, duravero, respiravero, il quale sincopato in duraro, respiraro, equivale all’odierno, o piuttosto potè formarsi coll’habeo: dicere habeo usavano, e il vulgo a dir ho, donde dirò; siccome i nostri dicono fu nato per nacque, ebbe trovato per trovò, fece offensione per offese, ecc. Parimente si ha in provenzale dir vos ai, in ispagnuolo hacere lo he; e nel greco moderno θελω pel futuro, εκω pel passato[119]. Di fatto quando anticamente si diceva io abbo, io aggio, usavasi pure io amarabbo, io amaraggio; ora che si declina ho, hai, ha, si dice amerò, amer-ai, amer-à. La stessa coincidenza appare nel francese e nel provenzale, nello spagnuolo, nel portoghese: anzi nel provenzale antico si ha pregarai vos, o pregar vos ai.
Già nella legge longobarda di Luitprando, tit. 108, § 1, si ha: veni et occide dominum tuum, et ego tibi facere habeo bonitatem quam volueris — Feri eum adhuc, nam si feriveris ego te ferire habeo. Il Grutero porta un’iscrizione del ��� secolo, che legge: Quod estis fui,
et quod sum essere habetis (Nº 1062). D’origine simile sarebbe il condizionale. Or ecco esempj degli ausiliarj avere e stare:
Cicerone. Satis hoc tempore dictum habeo — Clodii animum perfecte habeo cognitum, judicatum — Bellum nescio quod habet susceptum consulatus cum tribunatu — Domitas habere libidines — Si habes jam statutum quid tibi agendum putes — Aut nondum eum satis habes cognitum? Nimium sæpe exspertum habemus — Haec fere dicere habui de natura Deorum — Bellum habere indictum Diis — Habeo absolutum epos.
Cesare. Idque se prope jam effectum habere — Quorum habetis cognitam voluntatem in rempublicam — Præmisit equitatum omnem quem in omni provincia coactum habebat — Vectigalia parvo prætio redempta habere.
Terenzio. Quo pacto me habueris praepositum amori tuo
— Quae nos nostramque adolescentiam habent despicatam.
Virgilio. Quem semper honoratum habebo. Plinio. Cognitum habeo insulas.
Lucrezio dice che alcuni filosofi errarono, «amplexi quod habent perverse prima viai». A Gellio riferisce l’editto antico d’un pretore su quelli qui flumina retanda publice redempta habent.
La legge Tres tutores porta: «Cum destinatum haberet mutare testamentum. Tale è il frequentissimo compertum habere: e habere conductas. In Plauto trovo anche avere per essere, come da noi usa: «Quo nunc capessis tu te hinc advorsa via cum tanta pompa? — Huc. — Quid huc? quid isthic habet? (che ci ha?) — Amor, Voluptas, Venus, ecc.».
E Tertulliano più alla moderna: «Etiam filius Dei mori habuit — Si inimicos jubemur diligere, quem habemus odisse?» che noi diremmo ebbe a morire, abbiamo a odiare.
A Pompei vedesi scritto: Abiat Venere pompejana irada qui hoc læserit.
Nè mancano esempj di essere come ausiliario. Così Ovidio: «Quassus ab imposito corpore lectus erat» per quatiebatur: e in altri, casus esto, vinctus erit, si furtum conceptum erit, si mortuus erit.
Lucrezio. Manus et pes atque oculi partes animantis totius extant.
Orazio. Hoc miseræ plebi stabat commune sepulcrum: e in Virgilio
Dum Troja staret: nondum Ilium steterat: ubi transmissæ steterant trans æquora classe; e in altri stabat acuta silex; stant belli causæ; deserta stat domus. Del quale stare ci sopravanzò stato, verbale di essere. Anzi anche l’andare come ausiliario mostrasi in Virgilio (ite solutæ) e in Orazio (dimissus abibis).
Colla lingua dunque a terminazione variata, consueta negli scritti, viveva quella a terminazione fissa che parlavasi, e che crebbe col volgere de’ secoli, tanto che nell’italiano noi ci troviamo aver conservato le parole che escono in vocale (acqua, stella, porta...), mentre a quelle in consonante appiccicammo una vocale, o ne prendemmo l’ablativo (fronte, arbore, libro...)
Il Galvani[120] mostrò che ne’ primitivi itali c’era si e su, nominativo del sui, sibi, se, e che di là viene il nostro si in si dice, si vuole. In una iscrizione presso il Muratori[121] leggesi: ultimum illui spiritum, come chi dicesse l’ultimo di lui spirito.
L’aggiungere spesso le preposizioni intro e foris tiene del modo nostro: — Ingressus intro (Matteo, ����. 58); egressus foras (ivi, 75).
Hypocritæ, quia mundatis quod deforis est calicis; (�����. 25). Aforis quidem paretis hominibus justi (ivi, 28, dove riconosci il nostro parere, sembrare). Exeuntes foras de domo (�. 14), pleonasmo affatto italiano. Et cum intrasset in domum, prævenit eum Jesus (����. 24).
Oltre i vicecasi e i vicetempi, altra differenza grammaticale dell’italiano è il risolvere col che (siccome coll’ὄτι il greco) le proposizioni dipendenti, che il latino mette all’infinito coll’accusativo. Il basso latino, o, come noi crediamo, il parlar popolare v’adoprava il
quia e quod, e non ne mancano i classici[122]. La Bibbia ne offre molti esempj. — Ut cognovit quod accubuisset in domo Pharisæi (Luca, ���. 37). Prædicate dicentes quia appropinquavit regnum cœlorum (Matteo, �. 7). Spesso lo usa un autore che scriveva prima dell’invasione dei Barbari, ch’era maestro di retorica, e che pecca di affettazione piuttosto che di negligenza, sant’Agostino. Apriamo a caso le sue Confessioni, e al libro vii. c. 9, narrando come i libri platonici lo avviassero al cristianesimo, dice che in quelli «legi quod in principio erat verbum... quia hominis anima non est ipsa lumen... quia in hoc mundo erat... quia in sua propria venit.... Item ibi legi quia
Deus verbum non ex carne, sed ex Deo natus est. Sed quia verbum caro factum est non ibi legi... quia semetipsum exinanivit... quia Dominus Jesus in gloria est Dei patris non habent illi libri. Quod enim ante omnia tempora unigenitus filius tuus coæternus tibi, et quia de plenitudine ejus accipiunt animæ... est ibi». E così prosegue mettendo quia e quod ove i classici avrebbero messo l’infinito, e ove noi mettiamo il che[123].
Senza più dilatarci in esempj, a sovrabbondanza abbiamo veduto come la lingua latina potesse tralasciare qualche sillaba finale; facoltà conservata dalla italiana, ove tronchiamo tante voci, e diciamo ardor, furo, fero, ecc. Ascoltate un contadino toscano, e vi dice a cà, mi pa, u’ o a ì? (dove ho a ire?). Di tali mozzamenti maggior uso fanno ancora i vulghi d’altre contrade. E già il facevano i loro padri all’età romana; e con ciò invece di da mihi illum panem, compendiavano da mi il pane; e Cicerone potè udire questa frase senza meravigliare o frantendere, nè sognarsi che derivasse da imitamento di Barbari.
Le somiglianze o differenze grammaticali, di cui va tenuto maggior conto che delle lessiche, ci autorizzano ad asserire che, delle principali mutazioni nella nuova lingua, nessuna fu portata da imitazione esterna, bensì da evoluzione interna e naturale.
Perocchè, lo ripetiamo, la natura non procede di salto, e ciò ch’è oggi, nasce da quel di jeri. Potreste immaginare un giorno, nel quale gli abitanti d’Italia abbiano cessato di parlare la latina per adottare la
lingua del vincitore, o formarsene un gergo, barbarico affatto, e dal quale uscisse poi questa bellissima e organica favella nostra? Non ne aveano essi già tutte le parole dal latino, e tutte le forme dal greco?
Le diversità grammaticali indicano che l’italiano deriva dal latino parlato, anzichè dallo scritto. Questo svolgeasi in ampj periodi e trasposizioni; l’italiano no: quello ha flessioni variate, finali consonanti, mentre l’italiano termina in vocali, e ciò viepiù dove meno Barbari intervennero: segno che persisteva una lingua popolare, in cui era stato introdotto il lessico del latino colto, ma non la grammatica.
12º
Andamento consimile nelle evoluzioni di varie lingue.
Che se guardiamo ad altre favelle della famiglia indo-europea, le vedremo tutte tramutarsi da un’antica in una moderna per andamento somigliante, attesa l’identità d’inclinazione e di principj; e passare dal prisco sintetico al moderno analitico.
D’una favella possono alterarsi o l’interna struttura delle parole, o le forme grammaticali. Le parole antiquandosi tendono a surrogare alle consonanti gagliarde e dure le deboli e dolci, alle vocali sonore le sorde dapprima, poi le mute; i suoni pieni s’estinguono a poco a poco e si perdono, le finali dispajono, le parole si contraggono; in conseguenza le lingue divengono meno melodiose; parole che lusingavano l’orecchio, non offrono più che un senso mnemonico e quasi una cifra.
Le forme grammaticali, che possiamo chiamare l’anima delle lingue, di cui le parole sarebbero il corpo, col tempo si confondono fra loro, o si trascurano; s’impiegano fuor di proposito, o si smettono: onde viene un linguaggio mutilato, che, per vivere, conviene adotti organamento nuovo.
E qui rivelasi l’azione rigeneratrice; diremmo oggi, la lotta del vivere. Perita l’antica sintesi grammaticale, smesse le inflessioni, mal distinti i casi de’ nomi, i tempi de’ verbi, i rapporti che prima erano espressi dai segni grammaticali aboliti si dinotano con parole separate, per evitare la confusione; con preposizioni si supplisce alle desinenze che distinguevano i casi con ausiliarj a quelle che indicavano i tempi de’ verbi; i generi si dinotano cogli articoli, le persone coi pronomi. Di tal passo dal sanscrito nacquero il pali e i diversi dialetti pracriti; dallo zendo il persiano, dal greco classico il moderno, il tedesco odierno dall’antico, l’inglese dall’anglosassone, l’olandese dal frisone ch’è affine al sassone, il danese e svedese da quello scandinavo ch’è conservato in Islanda. Così pure dal latino derivarono le lingue neolatine, e specialmente la nostra.
È della natura umana, che una parola che ricorre frequente, la si scorci per parlare più spiccio; si sostituisca un segno semplice a uno complicato: si confondano le gradazioni, si trascurino le distinzioni delicate; e questo svolgimento delle lingue non è sospeso se non quando scrittori classici fanno legge e prefiggono un canone. Il popolo tende a contrarre, a fognare, giacchè parla per parlare, non per parlar bene; e purchè una parola renda il suo pensiero, poco gli cale l’articolarla con esattezza o trascurarne alcun elemento. I’ so per io sono; gnor sì per signor sì; vello per vedilo, Cecco, Bista, Cola, Gino, dugenvenzei sono contrazioni usitatissime; la lingua de’ trecconi è una perpetua contrazione; e così la più parte de’ dialetti. L’uso vulgare confonde le desinenze che distinguono i casi e le persone; darà il genere mascolino ad un sostantivo femminile, o il contrario; dirà voi eri, voi andavi, un poca d’acqua, una libbra e mezzo; porrà l’indicativo pel soggiuntivo, il passato definito per l’indefinito, e ciò non per solecismo ignorante, come chi parli una lingua non sua, ma con regola istintiva, tal che resta comune a tutto un paese, a tutta una classe. Come dunque lo scomporsi, così il ricomporsi delle lingue tiene all’indole dello spirito umano, essendo naturale il rendere con preposizioni od ausiliarj, vale a dire con una sorta di perifrasi, ciò che le modulazioni grammaticali del nome e dei verbi esprimono o male o non più. Se paragoni le lingue primitive
colle loro derivate, trovi dappertutto l’accorciamento delle parole. Inoltre ciascun idioma derivato è assai meno ricco di forme grammaticali che i primitivi; il numero duale, che esisteva nel sanscrito, sparve nel pali e nel pracrito; le declinazioni, sì ben distinte nel sanscrito, si confondono nel pali, ch’è suo figlio diretto, nel quale molte voci dell’ottava seguono la prima; di rado si adopera il passivo; la conjugazione offre appena i tempi indispensabili, e uno solo risponde all’imperfetto, al perfetto o all’aoristo del sanscrito.
Come l’alterazione e lo sfasciamento della lingua si manifestano per effetti quasi simili in tutti gli idiomi della famiglia indo-europea, in quasi tutti vi si oppone lo stesso rimedio. Dove i casi divennero troppo scarsi ai bisogni del pensiero, o troppo raffinati per l’uso comune, l’eguale terminazione si adottò per casi differenti, rimovendo la confusione coll’anteporre preposizioni al sostantivo. Ai modi e tempi semplici dei verbi ne furono surrogati di composti cogli ausiliarj essere, avere, volere, fare, venire, divenire. Nel bengali, derivato dal sanscrito, se ne formano quattro modi; potenziale, ottativo, inceptivo, frequentativo, e molti tempi. Nell’indostani, dialetto più alterato che il bengali per straniere influenze, si adoperano essere e dimorare come ausiliarj, il passivo formasi con raddoppiare il verbo essere, e n’è ausiliario il verbo andare All’antica declinazione zenda, che è conforme alla sanscrita, nel persiano moderno in molti casi si supplì colle preposizioni der, be, ez; sono composti il passato e il futuro, e la voce passiva formasi col verbo essere. Il greco vulgare perdette il passato perfetto; il piuccheperfetto forma mediante il verbo avere, e il futuro mediante il volere, come in inglese; avanti al soggiuntivo pone il να, come in francese il que.
Anche le germaniche sostituirono preposizioni alla terminazione dei differenti casi; tutte si valsero degli ausiliarj dovere, diventare o volere pel futuro, il quale uso degli ausiliarj fu già conosciuto, sebbene non sempre usato da Ulfila, che nel quarto secolo tradusse in gotico la Bibbia. Altrettanto nei dialetti slavi moderni. Nell’antica lingua slavona già si trova il preterito, composto con iesmi (io sono), e due altri tempi formati con ausiliarj. Fra le celtiche, l’irlandese, che
conserva i monumenti più vetusti, presenta pure forme grammaticali, mancanti a tutti gli altri dialetti, e vestigia di declinazioni, e specialmente il dativo plurale in aibh, analogo al sanscrito bhyas, e al latino abus. I dialetti bretoni e cornovalesi, più discosti dal tipo primitivo che non il gallese, hanno l’ausiliario io fo; mi a gura in cornovalese, me a gra in bretone. Il gallese esprime il passivo con terminazioni speciali; il bretone non le possiede più, e si vale del verbo essere come le lingue neolatine: il cornico sta di mezzo, conservando le forme passive del gallese, e adoperando il verbo essere come il bretone.
Anche noi nel verbo perdemmo molti tempi, e il gerundio, il supino: nei conservati si soppresse generalmente la consonante finale; gli altri si formarono cogli ausiliarj. Del passivo ci restò solo il participio passato, che serve a formare, coll’avere, i tempi dell’attivo, e coll’essere quei del passivo, contenendo però in sè la sola determinazione, mentre tutte le relazioni del soggetto, numero, persona, tempo, modo spettano all’ausiliare. Perduto è affatto il deponente. Il comparativo sparve quasi in italiano, ma già i Latini vi sostituivano il magis, come magis pius, conservato in altre lingue romanze (mas dulce spagnuolo): e talvolta il plus, come plus lubens, in Plauto, plus formosus in Nemesiano.
L’analogia degli accidenti alfabetici s’incontra dappertutto. Come lavo fa lotus, così causa fa cosa; amavit fa amò. I dittonghi si contraggono, e come seibi in sibi, jous in jus, così audio in odo. Alcune lettere si ommettono, altre si aggiungono per eufonia, o mutansi secondo l’affinità di organi; talune si traspongono sì, che da metuo viene timeo; da magro gramo; da peramare bramare, da metipsum medesimo, fa verecundia vergogna, da dum interim dommentre, poi mentre. La h non fu più aspirata, sicchè divenne superflua; la j cambiossi in g; la x in s; crebbe l’uso della z
Ognuno vede come facilmente, coi processi indicati, si venisse a fare ciò da ecce hoc, colà da ecce illuc; così da æque sic, ac si, che ne’ dialetti è ancora acsì e ixì; come e como da quo modo; da hanc horam e illam horam ancora e allora; da ad ipsum tempus adesso;
da tunc dunque; da ab ante avanti; da post dopo; da retro dietro; da per hoc quid (allungamento invece di nam) l’imperciocchè; il quale da ille qualis, come nel neogreco ὁ ὁποῖος: da ecc’ille quello; da ecc’iste cotesto, cotestui, questo; da veh vai e guai, come in guasto mutossi vasto, in guado vado. Le tre forme di affermazione sì, oil, oc sono dal latino sic est; illud est; hoc est[124].
Da per tutto ci salterà all’occhio questo studio, o dirò meglio istinto del raddolcimento, manifestato col troncare, aggiungere, trasporre: nè di più si richiede per ridurre italiane la più parte delle voci latine.
Non sono abbastanza spiegate certe ragioni eufoniche, per cui una lingua predilige un tale accento, una tale cadenza, una tale combinazione di vocali e consonanti. Quando la favella si trasforma per costituirsi in linguaggio, le parole assumono alterazioni successive piccolissime, finchè incontrano una tale combinazione di suoni che resta prevalente, e determina l’indole eufonica d’essa lingua. Così l’italiano finisce le parole o piane o sdrucciole in vocali, il francese in consonanti coll’accento sempre sull’ultima sillaba e colle nasali; lo spagnuolo ha vocali chiare ma strette, mentre il portoghese le ha cupe: nell’inglese sibilano i suoni fra i denti; nel tedesco si conserva l’accento su ciascun componente delle parole e si pronunzia per tono di voce, anzichè per accento prosodico: nelle lingue semitiche abbondano suoni gutturali e fortemente aspirati. Introducendo in quelle lingue parole forestiere, queste s’acconciano al tipo eufonico.
L’alterazione prodotta dall’uso è viepiù sensibile, quanto più la lingua alterata avanza di età, e più risente delle abitudini popolari, cioè è più parlata e meno scritta. Il vecchio latino appare aspro nel rozzo numero saturnino; e tale si conservò in gran parte nello scritto: ma favellando si temperava per sentimento di eufonìa, sin a ledere la grammatica. Quest’alterazione, già operata dal vulgo ne’ bei tempi romani, e talora accettata dagli scrittori[125] , io penso tenesse ai prischi idiomi italici, e vorrei dedurne che la nostra lingua non originò dalla conquista germanica. Il latino volgare avea forme più povere e parole differenti dalle classiche. Da una letteratura esotica, tutta
artistica, non nata col popolo nè svolta con esso, venne la lingua scritta, senza impedire che, in bocca al popolo, seguisse la legge universale del movimento, a segno che quando quella potè prodursi in iscritto, si trovò ben differente, modificata senza scrupoli filologici.
Ne segnammo le vestigia nelle iscrizioni, massime dei primi Cristiani, fatte da persone vulgari, cioè che scriveano secondo uso, non secondo grammatica; e più la coltura diminuiva, più gli scriventi s’avvicinavano alla pronunzia, piuttostochè all’uso letterario. I Padri greci continuarono a scrivere meglio de’ latini, perchè la loro lingua essendo più naturale cioè conforme alla parlata, non richiedeva molta coltura; mentre la latina, così artefatta, corrompevasi col diminuire degli studj ad essa necessarj. Oltrecchè l’uditorio de’ Greci era di persone civili, mentre quel de’ Latini componeasi spesso di schiavi o liberti o stranieri importati.
I popoli germanici importando molte voci, indirettamente ajutarono la decomposizione del latino, mentre le tradizioni e le abitudini letterarie da cui erane protetta la purezza, si corrompeano, e il negletto linguaggio delle classi incolte, di quei Casci, di cui dice Cicerone che la lingua non istudiavasi, prevaleva nell’uso all’accurato della classe forbita. Una lingua non perisce se non colla società che la parla: e qui appunto periva la società colta, e con essa il parlare accurato, e riviveva il popolare. Onde alla lingua latina si surrogarono gli idiomi neolatini in virtù di leggi intrinseche e generali, e non per particolari avvenimenti.
La filologia comparata provò che non fu sempre la lingua più organica, in conseguenza la più bella, che venne ricevuta per nazionale. L’alto tedesco è incontestabilmente inferiore al basso tedesco, eppur divenne lingua letteraria dacchè Lutero lo adoprò a tradurre la Bibbia.
§ 13º
Influenza de’ Barbari. Periodo di scomposizione.
Le cause di alteramento della lingua letteraria latina crebbero dacchè irruppero i Barbari, e scossero prima, poi annichilarono l’impero romano. È notevole che gli elementi lessicali germanici, divenuti parte dei parlari latini (contano da 300 voci comuni a tutti), s’incontrano egualmente in tutti questi nelle diverse regioni romane. Ciò è indizio che tale immissione è ben più antica dell’ultima invasione, e risale a un tempo quando il latino aveva ancora tanta vitalità, da non poterne venir modificato secondo le varie contrade. E forse si identificava coll’estendersi del latino fuori delle regioni natìe per mezzo delle colonie e degli accampamenti.
Ormai nessuno più crede che i Barbari fossero fiumi di popoli, che affogassero gli indigeni, e portassero non solo devastazione e micidio, ma sovvertimento generale. Fossero anche stati numerosissimi, sarebbe insolito il fenomeno d’un popolo conquistatore, che al conquistato impone la propria lingua. Nelle due Americhe le colonie antiche conservano la favella materna, mentre la conservano anche i prischi abitanti. Che se talvolta quella prevalse, ne fu causa la sua maggior coltura; come nelle colonie eoliche e doriche della Sicilia e della Magna Grecia. Pei Barbari in Italia il caso era l’opposto: una gente rozza sovrapponevasi ad una colta; e se a questa imponeva le leggi sue, doveva ricorrere ad essa fin per iscriverle.
Dov’è però a notare che l’esclusivo patriotismo degli antichi idolatrava la patria favella, repudiando ogni altra. Fra le servitù che Roma imponeva ai vinti, era l’obbligo di parlar latino[126]; Claudio imperatore tolse la cittadinanza ad uno di Lisia, il quale non seppe rispondergli in latino[127]; davanti al Senato contendevasi se avventurare o no un tal vocabolo di greca etimologia, e Tiberio imperatore voleva ricorrere ad una circonlocuzione, piuttosto che dire monopolio.
Da ciò alle antiche favelle l’unità, il carattere specifico, non alterato nelle derivazioni e ne’ composti, mentre le moderne sono formate dei frantumi di varie, sicchè in un solo periodo potresti incontrar voci delle origini più disparate[128]: oltrecchè più popolare essendo la
letteratura, meno squisita riesce la forma. Così avvenne del latino, introdotto in paesi, la cui gente aveva gli organi abituati ad altri suoni, e lo spirito ad altra sintassi. Se, come pretende Fauriel, la lingua latina fosse stata decomposta dalle indigene di ciascun paese, dovrebb’essere riuscita differentissima, mentre da per tutto appare simile a quella de’ paesi dell’antico Lazio. La località fu però uno de’ fattori de’ nuovi linguaggi: e per es. nell’Italia dove il latino parlavasi, le parole conservarono l’estensione; nella Gallia si raccorciarono. Ma che a generare le lingue, dette romanze perchè uscite dal romano, principal parte contribuissero i Barbari, è tutt’altro che provato. I Goti dominarono lungo tempo la Spagna, eppure a stento riscontri alcun vocabolo gotico in quell’idioma, che dall’invasione araba confinato tra le montagne delle Asturie, colla vittoria e colla croce ne discese, e s’impossessò di alcuni termini arabi, di alcuni francesi, ma in fondo rimase latino. Venezia non fu invasa da alcun Barbaro, Verona da tutti, e i loro dialetti si somigliano ben più che non il veronese col contiguo bresciano, o questo col bergamasco, o il bergamasco col milanese, separati appena da qualche fiume. E appunto un corso di acque o la cresta d’un monte frapponevasi a due linguaggi diversissimi, quant’è il toscano dal bolognese. Qui che hanno a fare i Barbari? Se l’articolo ci fosse dato dal tedesco, qualche traccia propria ne resterebbe, mentre non ve n’ha alcuno, anche de’ varj dialetti, che non si derivi e spieghi col e pel latino[129].
La lingua è tradizione, che si fa dalle madri, onde ben dicesi materna; nè gli stranieri ci hanno a vedere. Il cambiamento è neologismo, non barbarismo. Fosse anche durato l’impero, la trasformazione sarebbe avvenuta. Spagna, Portogallo, Francia hanno lingua simile all’italiana e come questa derivata dal latino, ma dal latino popolare non dallo scritto. Ora è certo che i dialetti conservaronsi fra i varj popoli, malgrado il latino; e che colà mai non fu parlato il latino proprio. Raynouard sostenne si fosse formata una lingua comune romanza, da cui derivarono le altre. Ma ciò supporrebbe che già fosse comunemente parlato il latino, val a dire che si fosse cambiata la grammatica originale di que’ paesi nel breve
tempo della dominazione romana. Provasi che ciò non fu. E ripugnerebbe pure che il latino, mescolandosi colle lingue originarie differenti, producesse una lingua simile in tutte. § 14º
Periodo di formazione dell’italiano nell’età barbara.
In somma la lingua parlata scostavasi più sempre dalla scritta, fino a riuscirne due diverse; anche i Barbari conservavano la favella nazionale, ma per ispiegarsi coi vinti adottavano un gergo fra il tedesco e il latino, bilingui anch’essi. Che se in altri paesi il vinto ingegnavasi di usare la lingua del vincitore come segno di emancipazione, l’Italiano preferiva l’antica come ricordo di gloria; e il vincitore stesso che non avea letteratura, valeasi di quella del vinto.
Nè solo i preti e i notaj erano latini, ma in latino furono scritti e l’Editto di Teodorico, e le sue lettere, e le leggi de’ Longobardi, sebbene sia dimostrato che queste non doveano servire se non pei conquistatori. In esse sovente alle parole latine s’aggiunge il sinonimo vulgare[130]: prova evidente dell’esistenza di questo, e che trapela anche dalle poche carte di quell’età. Nel feudalismo, i signori trovandosi diffusi nei castelli, in contatto cogli indigeni anzichè coi loro nazionali, smetteano più sempre il tedesco, e diventava comune anche a loro il vulgar nostro nel parlare, il latino nello scrivere.
Quando gli studj erano così scarsi, difficile dovea riuscire lo scrivere questa lingua, mentre già in un’altra si pensava e parlava; ciascuno v’inseriva gli idiotismi del proprio paese; e, come in idioma non famigliare, vacillavasi per l’ortografia, pei reggimenti, pei costrutti[131]. Laonde ne’ rozzi scrittori di carte e di cronache è a cercare l’origine dell’italiana, o dirò meglio l’inconscio mutarsi dell’antica nella nostra favella, prima che fosse adottata per libri.
Il Codice Longobardo abbonda di modi traenti agli odierni: Rotari, leg. 218. Vadat sibi ubi voluerit: riempitivo tutt’italiano, se ne vada.
299. Si quis vitem alienam de una fossa scapellaverit.
Quest’ultima voce dicesi ancora in Piemonte, come masca per strega: Striga, quod est masca. Ivi, 197.
302. Capistrum de capite caballi.
303. Pistorium per pastoje, come alla 296 sogas per soghe; alla 306 pirum aut melum; alla 345 caballicare per cavalcare; alla 382 cassinam per casa campestre; alla 387 genuculum per ginocchio.
Nelle leggi di Liutprando, alla VI, 68 occorre scemus; alla III, 4, Faciat scire per judicem; alla IV, 3, In manus de parentibus suis, et in præsentia de parentibus suis; alla V, 3, matrina aut filiastra.
Il Canciani trasse dall’archivio di Udine una Legge Romana; e sia, come a lui sembra, dei tempi carolingi, o sia piuttosto un’irrazionale accozzaglia, noi, guardandola solo filologicamente, vi troviamo: Con mandatis principum — Ipsa uxor da marito suo — Prosequat cujus essere debeat — Si hoc scusare potest (lombardismo frequentissimo) — Ancilla quam in conjugio prese — Ante per suam tema (timore). — De aliorum facultates male favellant — Si illa judiciaria per sua cupiditate prendere presumserit — Per fortia violaverit — De furtivo cavallo — Cujus causa minare voluerit — Ad unum de illos judices — Per sua culpa — Ad unum dare voluerit plusquam ad alium — Quod minus precium presisset, quam ipsa res valebat.
Nelle formole sulle Leggi Longobarde, dal Canciani stesso riportate al vol. �, pag. 85 delle Leges Barbarorum, incontrasi: Petre, te appellat Martinus, quod tu comprasti decem modios de frumento.
Tu tenes sibi unum suum bovem.
Plus valebat quando tibi dedit — Non est verum.
Tu minasti Mariam ad aliam partem.
Volo tollere eam ad uxorem.
Invenisti unum suum caballum, et minasti ad clausuram.
De torto.
Tene tuum bovem, et da michi debitum.
Ora disponiamo, secondo la loro età, alcuni testi.
Anno 715. Il prete Aufrit interrogato, risponde: Quando veniebat Angelo de Sancto Vito, faciebat ibidem officio; et quod inveniebat a Christianis, totum sibi tollebat... e termina l’interrogatorio: Sed postea quam ego presbiter factus sum, semper ego ibidem missa faciebam. Nam in isto anno Deodatus episcopus de Sena... presbiterum suum posuit uno infantulo de annos duodecim etc....
(Antiq. ital., ��. pag. 375). Orso prete disse: Vecinus sum cum istas diocias... Nam episcopus Senenses numquam habuit nulla dominatione... Iste Adeodatus episcopus fecit ibi presbitero uno infantulo, habente annos non plus duodecim, qui nec vespero sapit, nec madodinos facere, nec missa cantare. Nam consobrino ejus coetaneo ecce mecum habeo: videte si possit cognoscere presbiterum esse. Ib., p. 378.
715. Idio omnipotens. Ib., ���. 1007.
— Fortia patemus, et non presumemus favellare. Carta senese appresso B�������, �. 439.
720. Medietate de casa mea infra civitatem, cum gronda sua libera. Ant. it., ���. 1003.
— Garibaldus Tosabarba riceve a fitto un campo di santa Maria di Cremona, nei documenti del T����, n. 441.
723. Post nostrum decessum, quem ivi ipsi monaci de ea consacrationem eligere ipsum aveat ordinatum. B�������, �. 275.
730. Et Gagiolo illo prope ipsa curte, ora præsepe. Ib., 518.
— De uno latere corre via publica. Ant. it., ���. 1005; bell’idiotismo toscano, ancora vivo; e così al 760, De suptu curre fossatum, et ab alio latere curre vigna. B�������, �. 570; e al 746: Cui de uno latum decorre via publica. Doc. lucch., ��. 23.
736. Si eum Taso aut filiis ejus menare volueris, exeas. B�������, �. 491.
743. In via publica, et per ipsam viam ascendente in suso. E ivi stesso gambero, molino, capanna. Ant. ital., �. 517.
746. Da capo pedes sexaginta... di una parte terra... di alia parte... da capo vinea et da pede... di presente solutum. Carta di Chiusi ap. B�������, �, 522.
754. Mezzolombardo chiamasi un diacono cremonese nel codice del Troya, n. 683.
762. Fratellum presbiterum scribere rogavi: e nella soscrizione: Fratellus presbiter. Doc. lucch., ���.
763. In una carta pisana: Et si ego non adimpliro ita, in ipsorum sacerdotis sia dominio hæc adimplendo. Ant. ital., ���. 1009.
765. In una lucchese: Gustare eorum dava: Sua voluntate dava. Ib., 745.
766. Ita decrevimus ut per ipsum monasterium sancti Bartholomei fiant ordinata et disposita. B�������, �. 289.
767. Excepto silva qui fue de ipsa corte... Excepto forte Fosculi, qui fue barbano (barba, zio) ejus. Ant. ital., �. 748.
770. Hoc decerno, ut cum ipsis rebus quas vobis concido, vel pos meo decessu reliquero, siatis in monasterio, ut per singulos annos persolvere debeatis pro anima mea in ecclesia Sancti Salvatoris... per quam abueritis, reddatis in ipsa ecclesia vel ad ejus rectores in aureo soledo uno, aut pro auro, aut per circa, vel pro oleo, aut per quem
