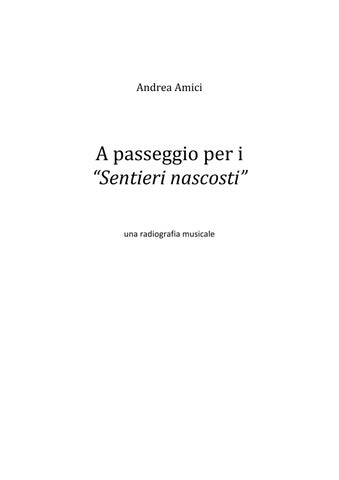Andrea'Amici A'passeggio'per'i “Sentieri(nascosti” una$radiografia$musicale
1. Un momento particolare
L’opera Sentieri nascosti è stata composta espressamente per la partecipazione alla Rassegna Nazionale di Composizione “A. Gigli” di Bologna del 1996; la scelta dell’organico e la durata complessiva, nonché una necessità di semplificazione della scrittura, atta a raggiungere la “difficoltà non superiore alla media” (come recita il bando) sono stati quindi strettamente legati alle necessità della Rassegna.
Durante quest’anno mi ero dedicato in modo particolare allo studio della scrittura novecentesca, dopo aver approfondito, negli anni passati, numerosi aspetti delle poetiche del nostro secolo, convinto profondamente della necessità di conoscere i presupposti sia tecnici che estetici della musica del passato a me più prossimo. Era naturale, quindi, che, non appena ricevuto il bando della Rassegna, mi mettessi subito all’opera per porre in pratica quanto appreso in vari mesi di studio e approfondimento, in maniera tale da inviare un’opera al passo con i tempi, cosa che, al momento dell’inizio del lavoro, mi sembrava particolarmente importante. Per ragioni pratiche avevo dapprima deciso di scrivere un pezzo per pianoforte, ma i vari progetti che intraprendevo venivano puntualmente abbandonati dopo poche ore di lavoro o confluivano in altri pezzi. Decisi allora, in seguito al contatto con le poesie di Rosalia Nigrelli, di tentare la via del pezzo per soprano e pianoforte, ritenendo che la scrittura pianistica poco si confacesse alle mie intenzioni compositive. In realtà capii, dopo aver terminato il lavoro, che ciò era vero solo in parte. Perché, allora, l’abbandono del solo pianoforte? Sono vari i motivi: formali, timbrici, storici. Sono molto scettico nei confronti della possibilità di ampliamento della letteratura pianistica, in quanto sono convinto che quanto già detto in questo campo sia ineguagliabile nelle sue varie sfaccettature ; ma anche questo è un concetto legato a particolari idee evoluzionistiche nei confronti del linguaggio musicale che avevo prima dei Sentieri nascosti e che adesso non mi sento più di condividere. Il motivo effettivamente di notevole peso per la mia scelta è senza dubbio di natura timbrica, a sua volta collegato intrinsecamente con il problema formale. Dal punto di vista timbrico non mi sento infatti vicino al pianoforte, pur riconoscendone la versatilità e soprattutto non potendone ormai fare a meno nel processo compositivo, piuttosto mi sento naturalmente portato all’ensemble strumentale e alle voci, soprattutto al coro, una mia autentica passione e mezzo di sperimentazione. Dicevo che il problema timbrico è per me legato alla ragione formale. Infatti sono convinto che una dialettica musicale che non si fondi su relazioni che in qualche modo preordinino il percorso musicale (mi riferisco evidentemente alla tonalità ed al serialismo) abbia più che mai necessità, per la propria sopravvivenza, della manipolazione del materiale attraverso differenziazioni delle risorse timbriche, cosa che mi indirizza verso le tavolozze più complete di vari ensemble strumentali.
Abbiamo messo già tanta carne al fuoco, numerosi problemi che hanno trovato adesso una (momentanea) soluzione grazie ai Sentieri nascosti e che adesso cercherò di analizzare.
Ho parlato di convinzioni evoluzionistiche sul problema del linguaggio musicale: ero profondamente convinto della necessità di inquadrare il mio linguaggio musicale in una coerente prospettiva storica, di renderlo una necessaria continuazione di quanto andavo approfondendo nei miei studi. Per questo avevo cercato delle vie di applicazione del serialismo oppure dei parametri di strutturalizzazione della forma nei suoi vari aspetti costitutivi, saltando a piè pari l’alea, che non considero personalmente degna di applicazione se non con determinati e profondi controlli che la limiterebbero così tanto da renderla pressoché inesistente. Mentre quindi la mia scrittura procedeva rigorosamente a tavolino, con l’ausilio di carte di programmazione del percorso musicale che assi-
ANDREA AMICI - A passeggio per i “Sentieri nascosti”
curassero coerenza “storica” al mio linguaggio, venni inspiegabilmente a contatto in maniera diversa dal passato con la musica di Igor Stravinski, soprattutto in connessione con l’opera di Goffredo Petrassi, compositore che stimo moltissimo. Di Petrassi avevo letto il debito nei confronti del compositore russo come modello di libertà intellettuale, a proposito della Sinfonia di Salmi. Personalmente non potei far altro che condividere questo debito e quindi trasportarlo nel mio lavoro, che mi apparve quindi, sarei tentato di dire fatalmente, sotto una luce del tutto diversa. Ciò che io facevo era solo una pedanteria, un mettere la testa sotto la terra, come uno struzzo. Si immagini quindi il mio stato d’animo. Ciò che si aprì principalmente alla mia mente fu di capitale importanza: la mia conquista strutturale non era valida di per sé, non giustificava il risultato fonico: non era un’operazione moralmente valida. Ecco quindi che l’imperativo stravinskiano di comporre a contatto con la materia sonora piuttosto che immaginarsela o, peggio - aggiungo io -, non considerandola e giustificandola in nome di un progetto, faceva sì che le mie sudate carte si spostassero definitivamente sul leggio del pianoforte, dove ogni scelta musicale diventa, per me, una scelta estetica, una scelta etica, dove ogni suono può essere veramente un mio suono. Restavano tuttavia numerosi problemi aperti, impossibili da risolvere con il semplice spostamento del lavoro dal tavolino al leggio del pianoforte. Mi riferisco all’aspetto progettuale. È una vera e propria dicotomia da risolvere: fedeltà a un progetto che preordini il discorso musicale oppure la romantica ispirazione? La soluzione che io ho trovato è aristotelicamente in medio. La giustificazione, necessaria al convincimento della mente e al suo consecutivo incanalamento sul binario lavorativo, mi venne dalla meditazione su alcune parole di Petrassi e di Massimo Mila. Del primo mi sono state di grande conforto, per procedere sulle vie che stavo intraprendendo, queste parole: «Quando mi sono proposto delle vie di condotta le ho seguite, salvo poi infrangerle quando una specie di imperativo della fantasia o altri interessi mi spingevano a contraddire, senza esitazione, ciò che avevo deciso di fare. [...] Si dirà che ho avuto un momento di follia, ma questo non m’importa affatto»1. Ecco quindi che si stabilisce un vero bilanciamento tra fantasia e progettualità che si incontrano sul terreno di quella che Massimo Mila chiama «natura inconsapevole dell’espressione artistica»2, assioma che io condivido pienamente e che mi permette non solo di prendere parte al meraviglioso miracolo della creazione artistica, che per me, comunque, seguendo Paolino da Nola, assume anche ben più profonde connotazioni religiose, ma di giungere alla comprensione di quanto è accaduto e accade non solo nella storia della musica ma anche nelle altre arti o meglio nelle altre sfaccettature dell’Arte suprema, che è opera di Dio. Ogni esperienza personale e soprattutto ogni convinzione personale, ogni dato della propria cultura confluisce inevitabilmente nel proprio atto creativo, come se il proprio patrimonio genetico culturale si trasmettesse in ogni riproduzione dell’anima. In questo modo non vi è momento della storia della musica (moralmente irreprensibile) che non possa essere spiegabile, al di là di ogni presupposto filosofico che la storia si autoimpone, quasi per giustificarsi. La storia della musica diventa, così, storia di anime che espandono la propria essenza verso una immortalità compatibile con la corporeità.
La storia della musica: una locuzione immensa, che può suscitare rifiuti netti o pedanti amori; anche qui la soluzione potrebbe sembrare aristotelicamente in medio, ma non è così semplice come può sembrare a prima vista. Il mio rapporto con la storia della musica diventa vitale nella composizione musicale, e ancora una volta qui l’illuminazione viene da Stravinski. André Boucou-
3
1 G. PETRASSI, Seminario di composizione, in «Chigiana», vol. XXXIII, n.s. n.13, 1979, p.328-9
2 cfr. M. MILA, L’esperienza musicale e l’estetica, Torino, Einaudi, 1956
ANDREA AMICI - A passeggio per i “Sentieri nascosti”
rechliev chiarisce molto bene il modo di porsi stravinskiano nei confronti della storia: «All’ossessione del procedere della storia, al determinismo dell’evoluzione musicale vissuto come necessario, Stravinski ha opposto la propria concezione della storia come permanenza [...] Per raggiungere, attraverso la totalità disponibile della storia, le radici della propria invenzione, e una tradizione concepita come viva e vissuta come inevitabile»3 . Queste parole, così vere nei confronti di Stravinski, hanno rivelato a me stesso ciò che io volevo seguire nella mia musica. Ecco quindi che i Sentieri nascosti intraprendono più un percorso musicale compatibile al testo poetico e alla mia personale revisione della storia, piuttosto che stravolgere ogni possibile contatto con una naturale musicalità in nome di un presunto evoluzionismo musicale. Allo stesso modo, la facilità di approccio a Sentieri nascosti non ha nulla a che vedere con le istanze neoromantiche oggi in voga come “reazione” alle poetiche nate attorno a Darmstadt. A ulteriore conferma della mia idea vorrei citare una frase che Arruga scrive a proposito della musica di Berio, in un contesto diversissimo dal mio, ma che comunque, per astrazione coerente, può ben adattarsi al discorso: «la storia non è un percorso obbligato e obbligante, non giustifica nulla e nulla spiega: mette a disposizione. L’esecutore e l’ascoltatore sono sollecitati a una conoscenza del passato e del presente che, se vogliono capire, devono attivare»4
Sentieri nascosti sono, per quanto mi riguarda, un punto di equilibrio che sono riuscito a realizzare tra progettualità, fantasia, istinto, etica e moralità personale e storicità, intesa, quindi, come permanenza onnicomprensiva, all’interno dell’atto creativo, di ogni momento della storia, rivissuta e ricreata, direi quasi giustificata, dalla personalità dell’atto compositivo. Ogni futura mia opera sarà debitrice ad essi e con essi si confronterà, nel tentativo di mantenere la mia personale fedeltà all’estetica che ne è alla base.
4
3 A. BOUCOURECHLIEV, Stravinsky, Milano, Rusconi, 1984, p.6
4 L. ARRUGA, Per ascoltare Berio, in AA.VV., Berio, Torino, EDT, 1995, p.33
2. Testo e musica: un percorso comune
Sentieri nascosti prende il titolo da una delle quattro poesie di Rosalia Nigrelli che ne costituiscono il materiale testuale. Nel momento in cui ho deciso di mettere in musica questi versi inediti, mi sono posto con grande rispetto nei confronti di essi, per il profondo legame che mi lega all’autrice. Anzi, ho cercato di dare il maggior risalto possibile al testo poetico, tentando di ricrearlo nella musica. Devo molto, nel rapporto con il testo, ai miei studi sulla polifonia rinascimentale, un periodo della storia musicale in cui le istanze del testo poetico erano veramente trasfuse nell’universo musicale: pur con le limitazioni imposte da un sistema musicalmente ambiguo e imperfetto, le composizioni corali del tempo prendono vita da tutti gli elementi del testo, non solo quelli ideali, ma anche e soprattutto dalla retorica del testo, dalla sua metrica.
In Sentieri nascosti il testo definisce diversi parametri musicali. Posso affermare, per la mia confidenza con l’autrice, che l’approccio compositivo del testo poetico è nettamente vicino al mio nei riguardi della musica, condividendone l’assunto etico e quello, importantissimo, chiarito dal Mila, di cui abbiamo parlato prima; la scelta quindi di queste quattro poesie e la loro trasposizione è stata, quindi, pressoché naturale.
La concentrazione dei quattro testi in una successione continua, con le piccolissime interruzioni previste scrupolosamente in partitura, non è solo dovuta alla necessità di rispetto del limite di otto minuti imposto dal bando della Rassegna bolognese; in ognuno dei quattro testi è insita una formidabile concentrazione del pensiero che quasi stenta, di conseguenza, a palesarsi di primo acchito, nascondendosi nella sensualità delle parole che raramente occupano in lunghezza i versi che si spezzano fino a confondere la struttura logica del pensiero stesso. Lo stile aforistico delle poesie e il loro costante gusto per l’allusione a una realtà che può solamente intravvedersi al di là della parola si riallacciano alla storicità dell’esperienza ermetica rivissuta in modo necessariamente personale, dettando una serie di aforismi musicali, di ascendenza weberniana esclusivamente per quel che concerne la concentrazione e la sobrietà del gesto sia vocale che strumentale, che tende all’introspezione del senso, piuttosto che alla sua estrinsecazione o, peggio, alla sua pittura. Non sono, infatti, rintracciabili all’interno della partitura segni musicali che siano imparentati alla natura semantica delle parole o al loro aspetto fonetico. Ciò che ho tentato di realizzare è stata una costante spersonalizzazione dell’elemento testo, che è stato trasferito all’elemento musica, grazie a una identica formulazione della cifra espressiva basata sull’apparenza della parola da una parte e del suono dall’altra. La diretta conseguenza di questo assunto di base, di derivazione strettamente testuale, porta la melodia del soprano su un sentiero impervio dal punto di vista discorsivo, dove l’immagine della vocalità si avvicina ai larghi spazi intervallari tipici di Webern, che implodono alla ricerca di una trasfigurazione del testo poetico al limite dell’impossibilità in cui viene relegata una certa nozione di cantabilità; Webern esiste solo in relazione a questo assunto, non esistendo, invece, alcun legame né con l’espressionismo, né con i procedimenti canonici, che sono totalmente assenti dalla mia opera. Ciò è vero soprattutto per i due pezzi centrali, mentre i due estremi effettivamente avvicinano la loro cantabilità a un parametro più tradizionale, essendo l’inizio e la conclusione non meglio definibili di un cerchio poetico. Su tutto domina quindi un certo senso ermetico, in cui si procede per impossibilità, per frammentazione allusiva Nel testo il discorso procede per frasi che, pur non facilmente caratterizzabili e distinguibili, tuttavia esistono, anche se allusivamente. La loro caratteristica principale è data dalla naturalezza con cui confluiscono l’una nell’altra, quasi senza farne capire il perché, facendo ritrovare improvvi-
ANDREA AMICI - A passeggio per i “Sentieri nascosti”
samente il lettore in dimensioni sempre nuove e trasfigurate che perdono una nozione importante alla quale siamo abituati: la consequenzialità. Ogni sequenza testuale diventa così un’immagine fissa di un modus dell’anima. Nell’espressione musicale la simbiosi avviene grazie alla melodia che si organizza anch’essa in frasi che non hanno però né sintassi definibile classicamente, come invece potrebbe apparire da certe “gradevolezze” d’ascolto (perché, poi, la musica del novecento dovrebbe abbandonarle?), né tanto meno consequenzialità. La continua ricorrenza di determinati movimenti intervallari, più o meno identici ritmicamente, nonché l’apparizione continua di elementi pianistici, che sbocciano frammentariamente a ricordare elementi passati e futuri, tende alla confusione, realizzata in termini prossimi a una nozione di ascolto più tradizionale (...di media difficoltà...), della vettorializzazione del discorso, sostituendo, quindi, alla direzionalità l’immobilità vissuta a livello di forma, per quanto questa immagine possa adattarsi alla musica che, per sua natura, procede attraverso il tempo (senso che io non abbandono mai, dando anzi sempre una certa mobilità alla scrittura). Ecco, quindi, così finalmente spiegata, o, ancora una volta, allusa, la metafora dei Sentieri nascosti, che vivono di per sé, ma nel contempo si trovano uniti in una visione globale. Nascosta è quindi, primariamente, la consequenzialità dell’idea. In realtà non vi è giustapposizione delle idee, ma una trasmigrazione di un’idea nell’altra, per mezzo di passaggi incolori. A tal proposito diventa centrale il secondo pezzo (Giochi di sottili apparenze), dove il titolo già chiarisce la ludica follia di quella figurazione pianistica che si muove sempre uguale a se stessa nella successione degli intervalli, mostrandosi apparentemente inconsapevole della linea melodica.
Il percorso comune di poesia e musica in Sentieri nascosti diventa, in ultima istanza, il percorso della mia visione della cultura, costantemente in bilico tra la necessità di vivere come unica l’esperienza dell’arte. ANDREA AMICI giugno 1996
6
ANDREA AMICI - A passeggio per i “Sentieri nascosti”
I. Di seta magici fruscii
Di seta
Magici fruscii
Morbide carezze
Di porpora
I sensi avvolgono
Di nota in nota
All’apice del suono ascendono
Rapiti.
II. Giochi di sottili apparenze
Giochi di sottili apparenze
Splendidi suoni
T’accarezzano la mente
Trema quella mano
Che ha sepolto i fiori
III. Venati di blu corrono i pensieri
Venati di blu
Corrono i pensieri
Alti si librano incontro all’oceano
Lontani
Avviluppati in morbide nuvole
Fioccano
Lacrime dal cielo
IV. Sentieri nascosti
Sentieri nascosti
S’inerpicano su
Fino al cuore, l’attraversano
Sentieri solitari
Senza nome né direzione
7