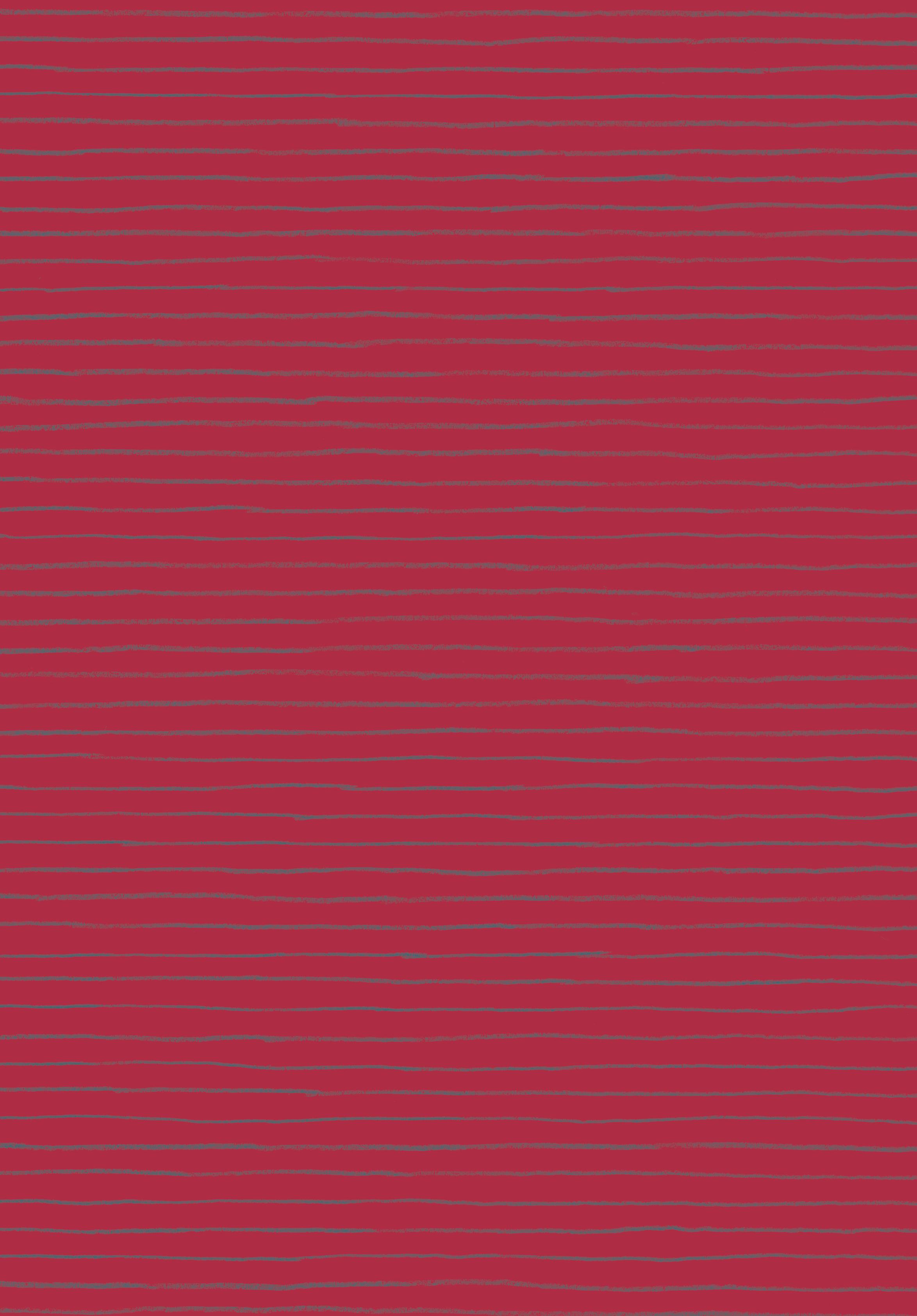
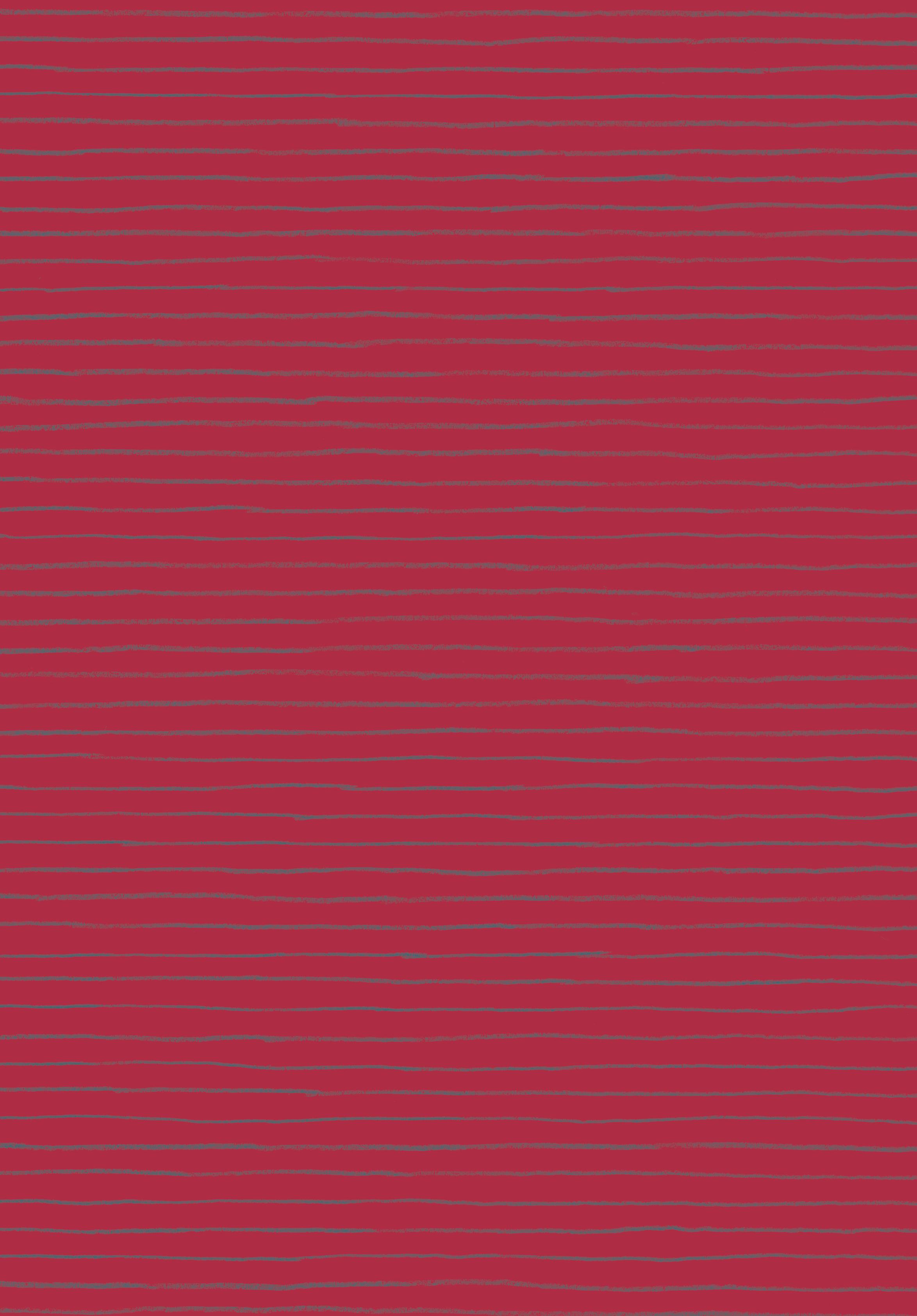
20 QdR
Didattica e letteratura
Servono per vivere
Per un’educazione all’uso della letteratura
Bruno Falcetto
QdR / Didattica e letteratura
diretta da Natascia Tonelli e Simone Giusti
Collana
La collana
La didattica della letteratura è una disciplina ancora giovane, che dagli anni Sessanta del secolo scorso ha accompagnato con riflessioni teoriche e proposte pratiche il cambiamento della società contemporanea. Oggi, di fronte agli sconvolgimenti legati alla rivoluzione digitale e alle profonde mutazioni del contesto socio-culturale, si rende necessario stipulare un nuovo patto tra scuola e università, tra insegnamento e ricerca, al fine di individuare metodi e strumenti idonei a valorizzare il ruolo degli studi letterari, della scrittura, della lettura, e dell’interpretazione delle opere letterarie.
La collana vuole essere un punto di riferimento per coloro che, nel mondo della scuola e dell’università, sono interessati ad approfondire i problemi dell’insegnamento letterario e degli apprendimenti correlati alla fruizione della letteratura.
Comitato scientifico
Michele Cometa (Università degli Studi di Palermo)
Paolo Giovannetti (IULM)
Pasquale Guaragnella (Università degli Studi di Bari)
Marielle Macé (CRAL Parigi)
Marion Sauvaire (Università Jean Jaurès di Tolosa)
Beatrice Stasi (Università del Salento)
Francesco Stella (Università degli Studi di Siena)
I volumi della collana sono sottoposti a un processo di peer review.
Volumi pubblicati
1. Jean-Marie Schaeffer, Piccola ecologia degli studi letterari. Come e perché studiare la letteratura?
2. Cinzia Ruozzi, Raccontare la scuola. Testi, autori e forme del secondo Novecento
3. Pasquale Guaragnella, Barocco e «nuova scienza». Proposte di ricerca didattica per il docente di italiano
4. Marielle Macé, La lettura nella vita. Modi di leggere, modi di essere
5. Le competenze dell’italiano, a cura di Natascia Tonelli
6. Per leggere i classici del Novecento, a cura di Francesca Latini e Simone Giusti
7. Letterature e letteratura delle origini: lo spazio culturale europeo. Prospettive didattiche per la Scuola secondaria e per l’Università, a cura di Giuseppe Noto
8. Simone Giusti, Tradurre le opere, leggere le traduzioni
9. Insegnare letteratura. Teorie e pratiche di una disciplina, a cura di Ambra Carta
10. Ariosto tra gli specchi del Novecento, a cura di Clara Allasia e Carla Sclarandis
11. Sulle spalle di Atlante. Un altro Novecento, a cura di Carlo Albarello e Simonetta Teucci
12. Simone Giusti, Natascia Tonelli, Comunità di pratiche letterarie. Il valore d’uso della letteratura e il suo insegnamento
13. La felice impresa. Letture e commenti delle opere di Gianni Rodari, a cura di Benedetta Aldinucci e Vanessa Roghi
14. Paolo Jedlowski, Nicola H. Cosentino, Fantascienza e modernità. Una breve guida alla fantascienza sociale
15. Nancie Atwell, Anne Atwell Merkel, La zona di lettura. Come aiutare i ragazzi e le ragazze a diventare lettori abili, appassionati, abituali, critici
16. Elisa Golinelli, Sabina Minuto, Meraviglia da sfogliare. Quando l’albo illustrato incontra il laboratorio di lettura e scrittura
17. Le risorse della letteratura per la scuola democratica, a cura di Simone Giusti e Natascia Tonelli
18. Simone Marsi, Il racconto del passato. La formazione del canone letterario italiano tra programmi ministeriali, manuali scolastici e storiografia letteraria (1861-1945)
19. Manzoni a fumetti. Tra educazione letteraria e educazione linguistica, a cura di Giuseppe Noto e Manuela Roccia
Didattica e letteratura
Servono per vivere
Per un’educazione all’uso della letteratura
Bruno Falcetto
Sede operativa Via Vittorio Amedeo II, 18 - 10121 Torino www.loescher.it
Diritti riservati
I diritti di pubblicazione, riproduzione, comunicazione, distribuzione, trascrizione, traduzione, noleggio, prestito, esecuzione, elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale e di adattamento totale o parziale su supporti di qualsiasi tipo e con qualsiasi mezzo (comprese le copie digitali e fotostatiche), sono riservati per tutti i paesi. L’acquisto della presente copia dell’opera non implica il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce.
Fotocopie e permessi di riproduzione
Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti di uso collettivo) possono essere effettuate, nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla S.I.A.E. del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali convenzionati S.I.A.E. o con altre modalità indicate da S.I.A.E.
Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico, commerciale, strumenti di studio collettivi, come dispense e simili) l’editore potrà concedere a pagamento l’autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume. Le richieste vanno inoltrate a
Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (CLEARedi)
Corso di Porta Romana, n. 108 - 20122 Milano e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org
L’editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale. La loro fotocopia per i soli esemplari esistenti nelle biblioteche è consentita, anche oltre il limite del 15%, non essendo concorrenziale all’opera. Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell’editore, una successiva edizione, né le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche. Nei contratti di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, musei e archivi, la facoltà di cui all’art. 71 - ter legge diritto d’autore. Per permessi di riproduzione diversi dalle fotocopie rivolgersi a diritti@loescher.it
Licenze per riassunto, citazione e riproduzione parziale a uso didattico con mezzi digitali La citazione, la riproduzione e il riassunto, se fatti con mezzi digitali, sono consentiti (art. 70 bis legge sul diritto d’autore), limitatamente a brani o parti di opera, a) esclusivamente per finalità illustrative a uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. (La finalità illustrativa si consegue con esempi, chiarimenti, commenti, spiegazioni, domande, nel corso di una lezione); b) sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le parti di opere sono utilizzate; c) a condizione che, per i materiali educativi, non siano disponibili sul mercato licenze volontarie che autorizzano tali usi.
Loescher offre al mercato due tipi di licenze di durata limitata all’anno scolastico in cui le licenze sono concesse: A) licenze gratuite per la riproduzione, citazione o riassunto di una parte di opera non superiore al 5%. Non è consentito superare tale limite del 5% attraverso una pluralità di licenze gratuite, B) licenze a pagamento per la riproduzione, citazione, riassunto parziale ma superiore al 5% e comunque inferiore al 40% dell’opera.
Per usufruire di tali licenze occorre seguire le istruzioni su www.loescher.it/licenzeeducative L’autorizzazione è strettamente riservata all’istituto educativo licenziatario e non è trasferibile in alcun modo e a qualsiasi titolo.
Ristampe 6 5 4 3 2 1 N 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026
ISBN 9788820138981
In alcune immagini di questo volume potrebbero essere visibili i nomi di prodotti commerciali e dei relativi marchi delle case produttrici. La presenza di tali illustrazioni risponde a un’esigenza didattica e non è, in nessun caso, da interpretarsi come una scelta di merito della Casa editrice né, tantomeno, come un invito al consumo di determinati prodotti. I marchi registrati in copertina sono segni distintivi registrati, anche quando non sono seguiti dal simbolo ® Nonostante la passione e la competenza delle persone coinvolte nella realizzazione di quest’opera, è possibile che in essa siano riscontrabili errori o imprecisioni. Ce ne scusiamo fin d’ora con i lettori e ringraziamo coloro che, contribuendo al miglioramento dell’opera stessa, vorranno segnalarceli all’indirizzo clienti@loescher.it
Loescher Editore Divisione di Zanichelli editore S.p.A. opera con Sistema Qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001. Per i riferimenti consultare www.loescher.it
Il contenuto di questo libro non è stato approvato dalle Nazioni Unite e quindi potrebbe non riflettere la posizione ufficiale di questa organizzazione. © Loescher Editore - 2025
Diritto di TDM
L’estrazione di dati da questa opera o da parti di essa e le attività connesse non sono consentite, salvi i casi di utilizzazioni libere ammessi dalla legge. L’editore può concedere una licenza. La richiesta va indirizzata a tdm@loescher.it
Direzione della collana: Natascia Tonelli e Simone Giusti
Coordinamento editoriale: Alessandra Nesti - Php srl - Grosseto
Realizzazione editoriale e tecnica: Franco Cesati Editore - Firenze
Progetto grafico: Fregi e Majuscole - Torino; Leftloft – Milano/New York
Copertina: Leftloft – Milano/New York; Visualgrafika - Torino
Stampa: Gravinese Industrie Grafiche S.r.l., via Lombardore 276/F – 10040 Leinì (TO)
Referenze fotografiche p. 85: August Sander © Die Photographische Sammlung/SK-Stiftung Kultur – August Sander Archiv, Koln; © Michael Somoroff.
L’Editore ha cercato di reperire tutte le fonti delle illustrazioni e porrà rimedio, in caso di segnalazione, alle involontarie omissioni o errori nei riferimenti.
1.
per vivere. Per un’educazione all’uso della letteratura
Un bisogno costitutivo
1.2. Accorgersi del metabolismo verbale
1.3. Vedere l’ambiente. Saper leggere in situazione
Una capacità di usare
1.5. Stare in mezzo, guardare dal basso
1.6. Le virtù della letteratura. La vitalità delle opere
4. Allenare all’esperienza testuale. Per una didattica delle azioni e degli effetti di lettura
4.1. Eugenio Montale e Alberto Garutti
4.2. Misurarsi con i contesti
5. Ecchisiamonòi. Letteratura e identità. Per una didattica per confronto .
5.1. Al tempo della didattica a distanza
5.2. Agilulfo e Angeleri Giuseppe
6. Via delle soglie. Passeggiata breve nel Novecento letterario
6.1. Una vetrina di libraio
6.2. Perché “insegnare con l’editoria”?
6.3. Scansare gli stereotipi
6.4. Un lessico minimo. Il soggetto che pubblica: catalogo, collana, identità editoriale .
6.5. I paratesti. Definizioni, forme, funzioni
6.6. Segnalatori di posizione. Per uno sguardo panoramico
6.7. Novecento plurale. Una passeggiata
6.7.1. Dove pubblicare nel nuovo secolo: Marinetti e Corazzini, Slataper e Saba. Tempi grami per il romanzo
6.7.2. Una prefazione siglata, un’introduzione firmata e due pseudonimi (più due frontespizi). Le diverse rotte del romanzo . . . . 98
6.7.3. Copertine e un incipit. Narrativa di genere
6.7.4. La stagione del neorealismo. Una prefazione senza titolo, un volantino, una lettera. Bisogno di testimonianza ed egemonia del romanzo
6.7.5. Risvolti e quarte di collana, e una pagina pubblicitaria. Anni Cinquanta, Sessanta, Settanta
7. Aperture
7.1. Libri per far leggere? Vite di lettori, piccole biblioteche, vademecum-manifesto
7.2. Insegnare la letteratura che cambia
7.3. Connettere e distinguere
7.4. Storie, formati, piattaforme, lettori
Premessa
La scuola è uno spazio vitale per la letteratura. Innanzi tutto per le potenzialità eccezionali di interazione fra parola letteraria e mondo sociale che la caratterizzano: l’ampiezza del numero di giovani coinvolti, l’estensione nel tempo del rapporto fra lettori e testi – tutti i giorni nei tanti mesi scolastici, per parecchi anni –, la fondamentale mediazione orientante e incentivante che chi insegna può svolgere.
Certo quelle potenzialità si realizzano solo in parte: il contatto fra gli studenti e il leggere letterario non dà nessuna sicura garanzia di successo. Lo spazio della lettura a scuola è esposto ai rischi dell’astrattezza che insidia gli ambienti didattici, è gravato dall’intercapedine allontanante di un obbligo che sovente resta poco compreso e condiviso. Ed è, come le attività dell’apprendere e insegnare nel loro insieme, costretto in un orario di frequente troppo affollato di discipline, sempre più in questi ultimi anni insidiato e corroso da attività scolastiche extradisciplinari imposte dalle normative ministeriali. Ancora, le condizioni di lavoro dei docenti (status economico sempre troppo modesto, immagine sociale ormai da tempo indebolita, politiche scolastiche inadeguate, purtroppo costituzionalmente mutevoli se non dannose) non paiono affatto in grado di generare un clima di slancio d’impegno, di entusiasmo operativo, in chi va la mattina in aula.
In questo ambiente si dovrebbero realizzare imprese difficili come la delicata, complessa, sintonizzazione fra qualità delle opere e sensibilità e interessi dei giovani lettori, fronteggiando creativamente la mutazione nelle pratiche del leggere che si è aperta dopo l’ingresso nel mondo della rete. Un nuovo quadro che va ridisegnando il sistema culturale e letterario, i modi della produzione, della mediazione editoriale e critica, della ricezione della letteratura. Un contesto in cui i rischi di indebolimento di un leggere profondo si accompagnano a nuove maniere di partecipazione all’esperienza della lettura, al sorgere di nuove forme di testualità, di nuovi supporti, formati, attori della messa in pubblico delle opere; un contesto nel quale le ragioni di inquietudine non possono non accompagnarsi a una vigilante apertura di fiducia; nella consapevolezza che quello in cui stiamo imparando a
muoverci è uno spazio di condizionamenti, ma altrettanto di potenzialità. Come hanno dimostrato altri decisivi momenti di svolta nella vita della lettura e dei “libri”, il segno più vero della trasformazione sta in un arricchimento del ventaglio di possibilità offerte dalle pratiche dello scrivere, leggere, pubblicare.
Nella «sfera letteraria digitale»1 la capacità di leggere in situazione, di cui si dice nelle pagine che seguono, di percepire ambienti e cornici dei messaggi, è sempre più decisiva, per non esserne semplici bersagli passivi; si tratta di acquisire piena consapevolezza di come la connessione di quei messaggi con soggetti e forme della mediazione editoriale, delle varie interfacce di pubblicazione, sia terreno tutt’altro che secondario nella costruzione – assestamento, arricchimento, distorsione – dei significati.
Nonostante le difficoltà, lo spazio della letteratura a scuola è vitale perché anche, ancora, vivace e produttivo. Grazie all’opera silenziosa e notevole di tanti docenti, alla loro capacità di ascolto e alla spinta delle loro proposte, grazie alle energie intellettuali e alla disponibilità a mettersi in gioco e applicarsi con intensità di tanti ragazzi, l’incontro con le scritture letterarie in più occasioni continua a incidere.
Perché questo incontro si attivi e si stabilizzi in modo diffuso l’insegnamento della letteratura deve riuscire di più, prima e più sistematicamente, a far percepire agli studenti perché la letteratura conta, quali sono le sue “virtù”, per impiegare un termine meneghelliano. È fatta con i libri ma non è solo una disciplina di studio; è un sapere che risponde a bisogni essenziali, primari, che serve per vivere; è un ambito testuale di confronto e contaminazione di saperi diversi; ci aiuta a padroneggiare a fondo lo strumento più importante di cui disponiamo per interagire con gli altri e rappresentarci, la lingua, raffigurando con ricchezza peculiare e problematica le disparate cose che gli uomini possono fare con le parole. Si tratta di riuscire a mostrare ai giovani lettori la vividezza, la potenza, la plasticità della parola artistica, la sua materialità povera (a darle vita bastano segni neri su pagine bianche o il suono di una voce) dalla quale scaturiscono immagini di mondo di densità fascinosa, di incisività suggestiva. Si tratta di mettere in primo piano nel lavoro didattico il discorso sugli effetti della scrittura, di far “intendere per prova” la forza di ampliamento e arricchimento della visione che le opere letterarie possono produrre in chi legge.
A presentare sinteticamente in atto questa forza può aiutarci, per esempio, un certo tipo di sequenze, si potrebbe dirle dello scarto di scala.
1. S. Murray, The Digital Literary Sphere. Reading, Writing, and Selling Books in the Internet Era, Baltimore, John Hopkins University Press, 2018.
Riconfigurano in velocità la scena, ci conducono in un improvviso dischiudersi di tempi e spazi, ci obbligano a uno scatto dimensionale, a modificare il nostro sguardo in estensione, a ripensare il mondo e il posto che vi occupiamo. Come avviene in questo folgorante passo da Pomo pero di Luigi Meneghello:
Mio nonno è nato proprio nell’anno che il Veneto diventò Italia, dunque non ci sono altri italiani che lui e mio padre tra me e il tempo antico quando qui non ce n’erano ancora. Ci si sta comodi in tre in un secolo; una sessantina di persone da rintracciare tra me e i romani, qualche centinaio fino alle caverne, alcune migliaia tra me e i pitecantropi. E curioso che a metterli tutti insieme si farebbe all’incirca un paese come il mio e si potrebbe venirci a conoscere tutti; è molto probabile che dell’intera serie sarebbero alfabeti solo gli ultimi tre, nonno, papà e in un certo senso io; tutti invece, per la natura stessa della linea divisoria, saprebbero parlare. Non so se sarebbe probabile, ma vorrei sperare che le lingue facessero una catena, almeno in fatto di comprensibilità: in fondo dev’essere ben raro che il figlio non s’intenda affatto col padre, a parole. Si potrebbe dunque dirci qualunque cosa e aspettare che ciascuno la racconti all’altro, e alla fine veder ridere in fondo alla fila lo scimmiotto Meneghello, o noi minacciarlo col pugno.
Questo volume raccoglie le testimonianze scritte di un percorso di ragionamenti ed esperienze attorno ai temi della letteratura a scuola. Un itinerario che trova le sue premesse e radici nella convinzione profonda dell’importanza capitale – culturale, civile, politica – del mestiere di insegnare e in un’idea della letteratura, di tipo funzionalistico-relazionale, che si è formata nel confronto essenziale con le riflessioni di Vittorio Spinazzola e Franco Brioschi.
I saggi provano a delineare un modo di guardare e presentare la letteratura a scuola, formulando alcuni principi di metodo e operativi, offrendo qualche proposta, qualche spunto di progettazione didattica. La titolazione degli scritti dà evidenza al ricorrere di alcuni termini e espressioni, di alcune parole chiave, che ne costituiscono l’ossatura concettuale (uso, ambiente/ contesto, cornice, identità, effetti, leggere in situazione, didattica reattiva).
Qui in nota riporto le sedi di pubblicazione dei diversi interventi, che ho conservato perlopiù nella stesura originaria 2; Via delle soglie. Una passeggiata
2. 1) Servono per vivere. Per un’educazione all’uso della letteratura, in La didattica della letteratura nella scuola delle competenze, a cura di G. Langella, Pisa, ETS, 2014, pp. 39-63; 2) I saperi essenziali della letteratura a scuola. Per un’educazione al libro, in Il Novecento a scuola, a cura di G. Langella, Pisa, ETS, 2011, pp. 37-46, e Il manuale e l’esperienza della lettura, ivi, pp. 119-132; 3) Conoscere le cornici. Per una didattica reattiva della letteratura, in Le risorse della letteratura per la scuola democratica, a cura di S. Giusti e N. Tonelli, QdR / Didattica e letteratura #17, Torino, Loescher, 2024, pp. 15-27; 4) Allenare all’esperienza testuale. Per una didattica delle azioni e degli effetti di lettura, in La letteratura in cui viviamo. Saggi e interventi sulle competenze letterarie, a cura di P. Giovannetti, I Quaderni della Ricerca #26, Torino, Loescher, 2015, pp. 15-21;
nel Novecento letterario è inedito. La sezione conclusiva Aperture riunisce alcuni testi che estendono un poco il raggio del discorso: verso l’ambito della riflessione sulla didattica universitaria della letteratura italiana contemporanea, verso quello della promozione della lettura (con osservazioni su un tipo di testo, il “libro per far leggere”, che, in morfologie differenziate, ha acquisito una presenza significativa nell’offerta editoriale d’oggi), verso alcuni nuclei d’attenzione per le attività di chi insegna Letteratura italiana contemporanea non solo all’università.
Questo volume ha cominciato a prendere forma nel doppio contesto delle lezioni di Letteratura italiana contemporanea per l’indirizzo linguistico-letterario della SILSIS-MI e poi per i corsi TFA e PAS, da un lato, e, dall’altro, della partecipazione (con colleghi dell’Università degli Studi di Milano e della scuola secondaria) al progetto Finvali 2005 Obiettivi cognitivi, saperi minimi e linguaggi nelle prove nazionali di fine ciclo. L’area umanistica, l’area matematica e l’area delle scienze sperimentali. E si è sviluppato, negli ultimi anni, in parallelo alle attività condotte nel gruppo di ricerca Servono per vivere. Didattica dei saperi letterarie e linguistici3 con gli amici del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici.
L’arco temporale di pubblicazione degli scritti presentati ha visto il progressivo irrobustirsi di un “campo di lavoro” plurale per una didattica disciplinare della letteratura italiana, sollecitato in primo luogo dall’esistenza e dalle diverse esperienze dei differenti percorsi di formazione all’insegnamento, nonostante i segnali istituzionali contradditori e intermittenti dei governi che si sono succeduti, l’esitazione fra percorsi di specializzazione post laurea (SSIS 1999-2009, TFA e PAS 2012-2015) e inclusione di 24 crediti per insegnamenti specifici nei corsi di laurea (PF24 2017-2022), una tempistica di programmazione e realizzazione più che discutibile. A testimonianza di questo consolidamento e della sua recente accelerazione può valere come indicatore di rilievo, per quanto parziale, un gruppo cospicuo di monografie apparse in questo decennio. Volumi collettivi o individuali pensati come quadri d’insieme, con impianto più panoramico e sistematico oppure come itinerari attorno a questioni o casi nodali per l’insegnamento della letteratura: sono i libri curati/scritti da Gino Ruozzi e Gino Tellini, Andrea Manganaro,
5) Ecchisiamonòi. Letteratura e identità. Per la didattica disciplinare ai tempi della didattica a distanza, in «OBLIO», X (2020), 38-39, pp. 248-254; 6) Via delle soglie. Una passeggiata nel Novecento letterario (inedito); 7.1) Libri per far leggere? Vite di lettori, piccole biblioteche, vademecum-manifesto, in Tirature ‘19, a cura di V. Spinazzola, Milano, il Saggiatore-Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2019, pp. 173-180; 7.2) Insegnare la letteratura che cambia, in Lector in aula. Didattica universitaria della letteratura italiana contemporanea, a cura di B. Falcetto, Pisa, ETS, 2020; 7.3-7.4) Connettere e distinguere, in «La modernità letteraria», XIII (2020), pp. 11-17.
3. Cfr. studilefiliascuola.unimi.it/i-gruppi-di-ricerca/servono-per-vivere-3/.
Roberto Carnero, Matteo Giancotti, Emanuele Zinato, Simone Giusti, Massimiliano Tortora4.
A far vivere e crescere questo campo plurale è stata l’azione convergente di insegnanti di scuola, anche nei loro ruoli di tutor nei percorsi di formazione appena ricordati, e docenti universitari, alimentata dalle iniziative delle associazioni disciplinari che si sono dotate di sezioni didattiche (MOD per la scuola, ADI-sd, Compalit per la scuola, SIFR-scuola), così come ne ha favorito la crescita l’affermarsi di vari contesti editoriali specifici: blog, collane, serie di volumi, riviste5. Un campo di lavoro che è serbatoio di risorse, riflessioni, strumenti, esempi di attività e ricerche possibili o realizzate, condotte secondo prospettive di metodo, baricentri disciplinari, linee di interesse differenziate.
Simone Giusti ha usato l’immagine del «ponte», di un «collegamento che il mondo accademico ha cercato e cerca ancora di realizzare con il mondo della scuola da quando si è cominciato a non dare per scontato l’insegnamento della letteratura per insegnarla»6, uno spazio di interazione su più piani ancora in via di allestimento, che va assumendo anche i caratteri di un «campo di ricerca scientifica», in analogia con quel che è accaduto in altri Paesi in un arco temporale analogo, dagli anni Settanta in poi. Per rendere più produttivo questo complesso, eterogeneo, di risorse serve tenerlo presente nella sua varia articolazione (cercando di guardarlo nell’insieme, con sensibilità al suo divenire storico, come ha provato a fare Giusti nel libro appena citato) e tener vivo il confronto fra punti di vista e collocazioni professionalidisciplinari, anche vivacemente critico, ma con costante disponibilità a leggere e ragionare a partire da prospettive ed esperienze che non sono le nostre.
4. Didattica della letteratura italiana. Riflessioni e proposte applicative, a cura di G. Ruozzi e G. Tellini, Milano, Le Monnier, 2020; A. Manganaro, Per la didattica della letteratura italiana, Roma, Bonanno, 2020; R. Carnero, Il bel viaggio. Insegnare letteratura alla Generazione Z, Firenze-Milano, Giunti-Bompiani, 2020; M. Giancotti, Educare al testo letterario. Appunti e spunti per la scuola primaria, Milano, Mondadori, 2022; Insegnare letteratura. Teorie e pratiche per una didattica indocile, a cura di E. Zinato, con S. Giroletti, A. Grandelis, F. Grendene, M. Marsilio, Roma-Bari, Laterza, 2022; S. Giusti, Didattica della letteratura italiana. La storia, la ricerca, le pratiche, Roma, Carocci, 2023; M. Tortora, Il lavoro culturale dell’insegnante. La letteratura in classe, Palermo, Palumbo, 2023.
5. Mi limito a ricordare soltanto «La letteratura e noi», la collana in cui esce questo volume e la recente rivista online «La MODernità della SCUOLA», www.modernitadellascuola.it
6. Giusti, Didattica della letteratura italiana. La storia, la ricerca, le pratiche, cit., p. 95.
QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO.
QdR / Didattica e letteratura
Servono per vivere
I saggi riuniti in questo volume muovono da una doppia convinzione: l’importanza capitale della scuola per la vita della letteratura e lo straordinario serbatoio di potenzialità conoscitive, etiche, emotive che i testi ci offrono. La proposta è quella di un’educazione all’uso della letteratura che metta in primo piano gli effetti della scrittura, per far cogliere agli studenti la forza con cui le opere letterarie sanno rappresentare la vita verbale e ci aiutano – come nessun altro oggetto culturale – a capire e sentire in quante diverse maniere gli uomini sanno far cose (e fanno sé stessi) con le parole. Una didattica del saper leggere in situazione, in cui l’esperienza della lettura sia pensata nel mondo extrascolastico del libro (biblioteche, librerie, rete), che guidi a mettere a fuoco ambienti e cornici dei messaggi, valori e funzioni delle vesti testuali, insegnando anche con l’editoria.
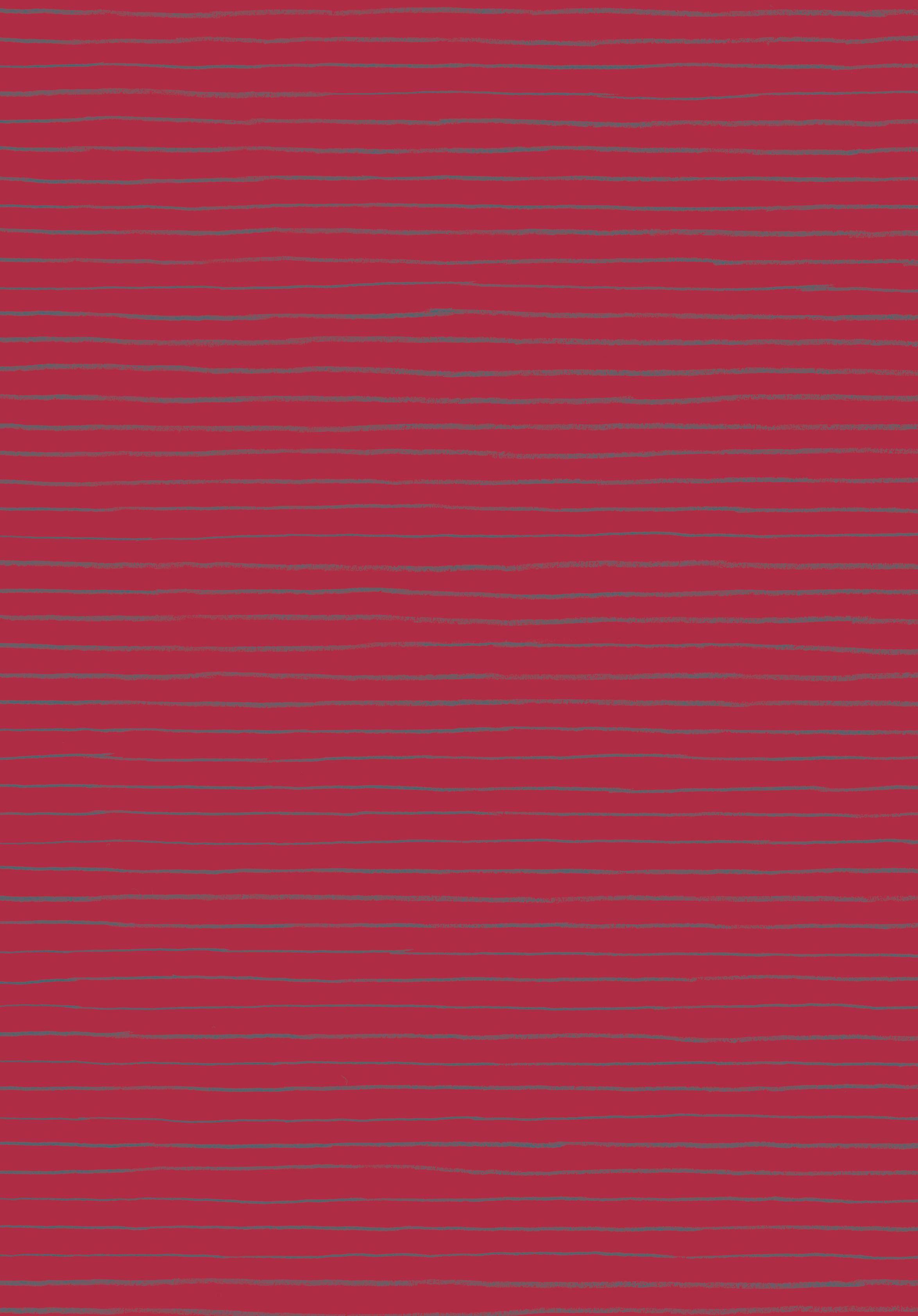
Bruno Falcetto è docente di Letteratura italiana contemporanea presso il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dell’Università degli Studi di Milano. Oltre che di didattica della letteratura, si è occupato di forme della narrativa realista, in particolare studiando l’opera di Italo Calvino, Ippolito Nievo, Ignazio Silone e Mario Soldati.
