La lettura, che av ventura!
SUSSIDIARIO DEI LINGUAGG I PER LA QUINTA CLASSE
a cura di Renata Rava
La lettura, che av ventura!
SUSSIDIARIO DEI LINGUAGG I PER LA QUINTA CLASSE ALLA SCOPERTA DEL MONDO
a cura di Renata Rava
L’edizione di questo sussidiario dei linguaggi dà compiutezza e visibilità al lavoro di un gruppo di insegnanti che in questi anni ha individuato, selezionato e composto testi ed esercitazioni. La loro personale e collegiale ricerca è espressione della consapevole scelta di una proposta di lettura, scrittura e riflessione grammaticale essenziale e significativa nel percorso elementare. Per scoprirne di più, sulla pagina del libro sul sito www.itacascuola.it è disponibile la guida per l’insegnante.
Hanno collaborato: Mirella Amadori, Manuela Callaioli, Maria Teresa Carabelli, Barbara Righetti, Francesca Simonazzi, Giulia Zonca, Carlotta Piatti.
Consulenti: Raffaela Paggi per la riflessione grammaticale, Francesco Grava per la musica, Denise Marchiori per l’arte.
Sul sito www.itacascuola.it sono disponibili materiali integrativi per docenti e alunni. Inquadra il QR Code per:
registrarti e accedere ai materiali digitali del tuo libro
Alla scoperta del mondo 5.
Sussidiario dei linguaggi. Classe 5 www.itacaedizioni.it/scoperta-mondo-5
Prima edizione: marzo 2018
Sesta ristampa: maggio 2025
© 2018 Itaca srl, Castel Bolognese Tutti i diritti riservati
ISBN 978-88-526-0548-2
accedere alla pagina del tuo libro
Progetto grafico e impaginazione: Andrea Cimatti
Coordinamento di redazione: Cristina Zoli
Cura editoriale e ricerca iconografica: Isabel Tozzi
Illustrazioni: Luciano Mereghetti
Stampato in Italia da Lito Terrazzi, Prato (PO)
Col nostro lavoro cerchiamo di rispettare l’ambiente in tutte le fasi di realizzazione, dalla produzione alla distribuzione. Questo prodotto è composto da materiale che proviene da foreste ben gestite certificate FSC®, da materiali riciclati e da altre fonti controllate.
Utilizziamo inchiostri vegetali senza componenti derivati dal petrolio e stampiamo esclusivamente in Italia con fornitori di fiducia, riducendo così le distanze di trasporto.
Oltre alla versione digitale dei libri sul sito www.itacascuola.it, i nostri testi possono essere richiesti a:
Grazie alla collaborazione con Seleggo, la versione digitale ottimizzata di questo libro per studenti dislessici può essere ottenuta in download gratuito registrandosi al sito www.seleggo.org ®
Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” www.bibliotecaciechi.it
Biblioteca digitale dell’Associazione Italiana Dislessia www.aiditalia.org
Per esigenze didattiche alcuni brani sono stati ridotti e/o adattati.
L’Editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, nonché per eventuali involontarie omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti. La realizzazione di un libro comporta aspetti complessi, che richiedono particolare cura in ogni sua parte e nei controlli finali.
Ciononostante è molto difficile evitare completamente refusi o imprecisioni.
L’Editore ringrazia chi vorrà inviare segnalazioni alla redazione, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: itaca@itacalibri.it
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Referenze fotografiche
The Metropolitan Museum of Art, New York: Bequest of Miss Adelaide Milton de Groot (1876–1967), 1967, 21; Gift of Charles F. Iklé, 1960, 150 · Nasa 75 · National Gallery of Art, Washington, DC/Andrew W. Mellon Collection 89 · PxHere · Wikimedia Commons: Paologiorcelli 55, Thesupermat 105, Arild Vågen 112 · Shutterstock.com
QUESTO LIBRO APPARTIENE A:
SONO I N CLASSE:
Sommario
Pronti per l’avventura
Ogni uomo al suo lavoro T.S. Eliot 6
Viaggiatori Cantiamo insieme P. Amelio 6
Lo stretto di Magellano S. Zweig 8
La conquista della penna d’aquila A. Panont 10
Scelti per vivere un’avventura J.R.R. Tolkien 13
Il compito di Peter C.S. Lewis 17
In fondo al tunnel E. Franceschini 19
Il piccolo mietitore G. Pascoli 21
Il piccolo aratore G. Pascoli 21
Tra casa e scuola
Rima rimani B. Tognolini 22
Pick a Bale of Cotton
Cantiamo insieme Canto spiritual 22
Chissà come si divertivano I. Asimov 24
Io e la mia cartella Martino, classe V 27
Stai per cominciare I. Calvino 28
Volete un consiglio? Giacomo, classe V 29
Leggi! D. Pennac 30
Leggo per legittima difesa Maddalena, II media 32
Il tema M. Corradi 34
Giochi con la palla V. Pratolini 35
Giocavo a nascondino M. Serao 36
Il gioco E.H. Porter 37
Le clic-clac M. Schiani 40
Calciatori in gabbia N. Lanotte, S. Lem 41
Citius, Altius, Fortius M. Sulis 42
Una nuova amica S. de Beauvoir 44
Un pranzo movimentato G. Durrell 46
Parlatemi di vostra madre C. Manzoni 49
Pomeriggi con la mamma G. Papini 49
Questa storia A. Baricco 50
Un’avventura finita bene M.F. Moro 51
Nonno Tino Tommaso, III media 52
Nonno usa WhatsApp Lorenzo, classe V 53
La casa dei suoni C. Abbado 54
Il mio universo M. Labaky 56
Verso il cielo
Sereno G. Ungaretti 58
Notturno op. 9 no. 1
ascoltiamo insieme F. Chopin 58
Il cielo azzurro R. Filippetti 60
Vidi il cielo J.A. Gagarin 62
Cielo stellato G. Fanciulli 63
L’alba E. Corti 66
Notte stellata Mettiamoci all’opera 67
Il mostro dalle ali di pipistrello 68
Il ritorno della cometa M. Bersanelli 70
Stella mia C. Rebora 72
Mare G. Pascoli 72
Più in alto il Papa dialoga con l’equipaggio della
Stagioni e ricorrenze
Cantico di frate Sole San Francesco 76
Nuvole M. Corradi 78
L’autunno gioca D. Rebucci 79
Imitazione G. Leopardi 79
Le foglie Mettiamoci all’opera 80
Il Natale di Martin L. Tolstoj 81
La notte misteriosa scintillante J. Dobraczynski 84
La luce del mondo Benedetto XVI (J. Ratzinger) 88
La notte di Natale V.S. Solov’ëv 89
In oriente G. Pascoli 90
Jingle bells Cantiamo insieme 90
Una città diversa I. Calvino 91
Neve A. Negri 92
Fior di neve U. Saba 92
Primavera E. De Amicis 93
Pasqua A. Negri 94
Tu mi guardi dalla croce Cantiamo insieme 94
Inno alla Vergine D. Alighieri 95
Progetti per le vacanze M. Quoist 96
Una mattina d’estate L. Tolstoj 97
Scoperte
Perlaparola C. Carminati 98
Pata, Pata ascoltiamo insieme M. Makeba 98
Miriam Makeba F. Cavallo, E. Favilli 100
Il cannocchiale di Galileo C. Rando 101
L’invenzione di Marconi P. Caccialupi 103
La macchina per lavare M. Calabresi 105
Un caso straordinario:
Alessandro Fleming R. Truax
Gli sci dei primordi N. Lanotte, S. Lem
Il successo è nei dettagli J. Elliot, W. L. Simon
Tra grotte e foreste
Torri che scompaiono
Fisica da spiaggia
Senza paura
Gabbiani V. Cardarelli
Inno alla gioia, dalla Sinfonia n. 9
ascoltiamo insieme L. van Beethoven
Il soprannome P. Voranc
Superbia E. De Amicis
Non appartieni più al male V. Hugo
Lacrime come perle A. Leonardi
La signora Carla Carlotta, classe V
Il fazzoletto bianco V. Boldis, A. Toffolo
L’altalena di Kito M. Serra
La gita di prima media R.J. Palacio
Amici nonostante la guerra M. Labaky
Partenza per la Turchia F. Geda
Descrivere la persona
Autoritratto A. Manzoni
Pedro Pedreiro
ascoltiamo insieme C. Barque de Hollanda
Giuseppe E. Morante 144
I miei compagni E. De Amicis 145
Il mio amico Garrone E. De Amicis 147
Margaret L.M. Alcott 149
Il ritratto del compagno
Mettiamoci all’opera 150
Incontro con padre Gemelli E. Franceschini 151
Lucia A. Manzoni 152
Auda J. Verne 153
Pablo Picasso R. Grenci, D. Zanoni 154
Il ritratto della mia bambina U. Saba 156
Viola G. Papini 156
Il mio bambino E. De Amicis 157
Fiabe e racconti
La tartaruga Trilussa 158
Aria di Papageno, da “Il flauto magico” ascoltiamo insieme W.A. Mozart 158
Moby-Dick H. Melville 160
Il cappello C. Manzoni 162
L’operazione Tono (A. de Lara) 163
Ernestino L. Doninelli 165
Giufà e la statua di gesso I. Calvino 170
Gli occhialini d’oro A.C. Doyle 171
Tonino l’invisibile G. Rodari 172
La vera libertà Lauretta 174
Il brutto anatroccolo H.C. Andersen 177
Bellinda e il mostro I. Calvino 185
Il lino H.C. Andersen 191
Il principe Giovanni e gli omini neri
C. Romagnoni 194
Racconti storici
Profezia della gloria di Roma Virgilio 200
Storia di due bimbi appena nati L. Orvieto 202
Perché febbraio ha 28 giorni? 205
Il ponte 205
Esempi di eroismo
Il vessillifero della decima legione
C.G. Cesare 207
Acilio Plutarco 207
Cassio Sceva Plutarco 207
Un soldato Plutarco 207
Granio Petrone Plutarco 208
La visione di Costantino L. De Wohl 208
Come i Romani: la pavimentazione
a mosaico Mettiamoci all’opera 210
Scrittori antichi 211
I difetti Fedro 212
I nostri antenati Sallustio 212
Le lodi d’Italia Virgilio 213
Cause del terremoto il motivo del nostro timore Seneca
Eccomi alla fine della quinta! Matteo, classe V 215
Testi di narrativa per la lettura integrale in classe
La nascita di Roma L. Orvieto
Il viaggio di Elisabeth J. Gaarder
PRONTI PER L’AVVENTURA
Ogni uomo al suo lavoro
Nei luoghi deserti
noi costruiremo con nuovi mattoni.
Ci sono macchine e mani, e calce per nuovo cemento.
Dove i mattoni sono crollati noi costruiremo con nuove pietre.
Dove le travi sono spezzate noi costruiremo con nuovo legno.
Dove la parola non è pronunciata noi costruiremo con nuovo linguaggio.
C’è un lavoro comune, e c’è una fede per tutti, un compito per ognuno.
Ogni uomo al suo lavoro.
T.S. Eliot
Cantiamo insieme
Viaggiatori
Questa canzone di Paolo Amelio racconta di un viaggio fatto con compagni inaspettati, con guide di cui si impara a fidarsi, di errori e ripartenze, proprio come l’anno di scuola.
Siamo tutti di passaggio sempre in viaggio, su, coraggio come un gran pellegrinaggio non dimenticarlo mai: È chiarissimo il messaggio che ci arriva da chi è saggio: proseguendo scoprirai che felice arriverai.


Lo stretto di Magellano
Quelle giornate devono essere state le più cupe nell’esistenza di Magellano, forse le sole in cui egli, uomo di saldissima fede, ha perduto dentro di sé il coraggio. Si presenta per la prima volta nella sua mente la possibilità della ritirata. Una battaglia solitaria combatte dentro il suo animo finché non decide: avanti! Poche settimane dopo arriva la svolta. Le navi si avvicinano ad una strana insenatura dalle acque nerastre. Che paesaggio strano, singolare e austero! Colline a strapiombo, dalle linee irregolari e tormentate e ben lontane alte cime incoronate di neve. Magellano decide di entrarvi ed esplorarle. Deve essere stato uno spettacolo singolare e fantastico vedere per la prima volta le prime quattro navi dell’umanità scivolare lievi e silenziose su quella taciturna e fosca via mai solcata da creatura terrena.
Li attende un infinito silenzio. Il cielo sempre rannuvolato grava fosco sulle acque, come la nave di Caronte sulla palude stigia, i quattro velieri silenziosi procedono, ombre tra ombre, per questo mondo infernale. L’equipaggio della
Sant’Antonio, logorato da tanta desolazione, una notte si ammutina e fugge verso casa. Magellano non si arrende e continua l’esplorazione…
Non un essere umano si mostra, ma misteriosi fuochi fiammeggiano giorno e notte; per questo Magellano chiamerà questa regione Terra del fuoco.
Più volte viene mandata una spedizione ad investigare, ma i marinai non trovano né case né tracce di vita, non giunge una voce, non appare una figura.
Quel viaggio non è soltanto faticoso, ma anche pericoloso.
La via scoperta non è un canale dritto e comodo, come potremmo nei nostri sogni immaginare. È in realtà un labirinto, un groviglio di svolte, di insenature, di baie, di fiordi, di banchi di sabbia, di scogli.
Bisogna girare intorno alle rocce, mentre il vento ostile con improvvisi vortici agita le acque e lacera le vele.
Si può comprendere, da questa breve descrizione, perché nei secoli successivi lo Stretto di Magellano abbia rappresentato il terrore della gente di mare.
Nelle spedizioni successive, decine di navi naufragano in quello stretto terribile. E nulla dà migliore testimonianza dell’incomparabile maestria nautica di Magellano del fatto che proprio lui, primo esploratore di quel pericoloso percorso, fu anche per anni e anni l’unico a cui sia riuscito superare lo stretto senza perdere una nave.
Dopo un mese di navigazione in quel labirinto, una mattina si alza un grido: «Mare! Mare!».
Davanti a loro si apre finalmente il nuovo Oceano. Il grido di gioia si innalza verso un cielo che non ha mai sentito l’inno giubilante della voce umana.
Ed ecco accadere ciò che nessuno avrebbe osato supporre in un uomo così duro. D’un tratto la fiamma interiore prende il dominio sul rigido soldato.
La passione gli trabocca dagli occhi, lacrime calde, lacrime brucianti gli scendono per le guance. Per la prima, per l’unica volta in vita sua, quest’uomo di ferro piange di felicità.
«Il capitano generale lacrimò per allegrezza», così annota nel suo diario Pigafetta.
Stefan Zweig, Magellano, Bur
• Cosa decide di fare Magellano, quando si presenta nella sua mente per la prima volta la possibilità della ritirata?
• Perché lo Stretto di Magellano rappresentava «il terrore della gente di mare»?
• Dopo le grida «Mare! Mare!», cosa si apre alla vista di Magellano e cosa gli succede di inaspettato?
La conquista della penna d’aquila
In riva a un lago sorgeva un tranquillo villaggio indiano. Una sera d’estate gli uomini della tribù si raccolsero tutti nella tenda di Bisonte Nero, il grande capo, per consiglio dei saggi e degli anziani.
I giovani indiani se ne stavano seduti non molto lontano, in atteggiamento di attesa: i saggi e gli anziani infatti erano riuniti per una questione che li riguardava da vicino. Dovevano cioè decidere quale sarebbe stata la prova di forza e coraggio che alcuni di loro avrebbero dovuto superare per essere accettati a pieno titolo come membri della tribù.
I giovani «che avevano visto cadere dieci nevi» – come dicevano loro –, cioè che avevano compiuto i dieci anni, sapevano bene che durante l’estate sarebbe giunto il giorno della prova anche per loro: non potevano prevedere, però, quale prova sarebbe stata decisa quest’anno per l’ingresso fra i grandi.
Era ormai calato il sole quando dalla tenda uscirono i saggi, gli anziani e, infine, il grande capo. I giovani si avvicinarono, creando in un attimo un cerchio silenzioso intorno a Bisonte Nero.
Ascoltarono la voce del capo, solenne e profonda, che pur conoscevano bene, con un’attenzione tutta nuova: «La prova di forza e di coraggio sarà questa: domani all’alba, quando apparirà il primo raggio di sole, partirete con le vostre canoe. Sull’altra riva del lago, in un posto segreto, sarà nascosta una penna d’aquila dorata. Chi la troverà avrà vinto e dimostrato di avere forza, coraggio e saggezza».
Quella notte i giovani non fecero altro che pensare a penne d’aquila nascoste sulle cime di picchi rocciosi, in profondi burroni, sotto enormi massi di pietra; pensarono soprattutto di tornare al villaggio con la penna d’aquila dorata, guardati con ammirazione e orgoglio dai loro genitori.
Appena un primo chiarore apparve da dietro le montagne i giovani indiani portarono le loro canoe verso la riva del lago. Mentre erano tutti indaffarati a preparare i remi e le provviste videro arrivare Falco Bruno, un indiano anziano che abitava dall’altra parte del lago. Il vecchio si avvicinò e disse: «Questa notte sono stato ospite del vostro villaggio, ma ora devo tornare dalla mia tribù, sull’altra riva. Sono anziano e non ho forze: se dovessi percorrere a piedi tutta la riva non arriverei che a notte inoltrata. Qualcuno di voi mi potrebbe portare sulla sua canoa?».
Il giovane Piuma Rossa prese la parola: «Ma noi proprio oggi dobbiamo fare la prova di forza e coraggio…».
Castoro Grigio aggiunse: «No, non è possibile; fosse un altro giorno, magari, ma ora dobbiamo correre…».
In poche parole pensavano che chi avesse preso sulla sua canoa Falco Bruno sarebbe rimasto indietro e non avrebbe conquistato la penna d’aquila. Ma che
fatica per questo povero vecchio compiere a piedi il giro del lago! Dopo alcuni istanti di silenzio e imbarazzo Nuvola Rossa si avvicinò a Falco Bruno e disse: «Vieni, ti porto io».
Gli altri giovani indiani, sorpresi, lo guardarono e pensarono: «Un concorrente in meno per la penna d’aquila».
Ma ecco in quel momento spuntò da dietro le montagne il primo raggio di sole. Era il segnale della partenza: con un grido tutti balzarono sulle loro canoe, afferrarono i remi e… via veloci sul lago: era iniziata la grande prova.
Nuvola Rossa faticava di più perché doveva remare per due.
Rimase sempre più indietro. Gli altri mentre lo vedevano faticare si convincevano sempre più che fosse stato poco furbo, che avesse perso la sua occasione: proprio lui, Nuvola Rossa, tra i più abili e coraggiosi della giovane compagnia.
Da parte sua Nuvola Rossa vedeva i suoi amici molto più avanti, ormai lontani e cominciava a temere di avere sbagliato. Sarebbe arrivato sull’altra riva così tardi che sicuramente qualcuno avrebbe già trovato la penna d’aquila. Per rassicurarsi ogni tanto voltava lo sguardo verso Falco Bruno, la cui faccia soddisfatta e riposata sembrava suggerire: «Hai fatto bene, Nuvola Rossa, hai fatto bene». I giovani raggiunsero la riva opposta quando il sole era già molto alto sul lago: uno dopo l’altro saltarono a terra, tirarono in secco le canoe, corsero a inerpicarsi sulle rocce o si inoltrarono nei boschi. Ognuno scelse la sua strada: chi si mise a scalare un picco roccioso per avere una vista più ampia dall’alto; chi si cacciò coraggiosamente in una grotta buia, sperando di trovare la penna nascosta in qualche fessura della roccia; chi si arrampicò su un vecchio albero cavo, per calarvisi poi dentro, perché il trofeo poteva essere proprio lì…
Era ormai mezzogiorno quando arrivò la canoa di Nuvola Rossa. Il giovane indiano era tutto sudato per la faticosa traversata e pensava di trovare i suoi amici che già festeggiavano il vincitore. Ma, a quanto pare, nessuno aveva ancora trovato la penna d’aquila. Nuvola Rossa riprese allora forza: forse poteva ancora farcela. Salutò in fretta Falco Bruno e via di corsa anche lui alla ricerca. Ma l’indiano anziano lo chiamò: «Aspetta, Nuvola Rossa, vieni qui! Ti devo dire una cosa».
Un po’ a malincuore il bambino si fermò e si voltò verso Falco Bruno: ma era teso, come un arco pronto a scattare. «Ieri sera il grande capo Bisonte Nero mi ha convocato nella tenda e mi ha detto: “Domani all’alba, quando vorrai tornare al tuo villaggio, recati sulla riva del lago e aspetta; vedrai arrivare alcuni giovani della nostra tribù. Chiedi loro di portarti sulla riva opposta. A chi lo farà, quando sarete arrivati a destinazione, consegnerai questa”». Falco Bruno tirò fuori da sotto il suo poncho una penna d’aquila dorata. Nuvola Rossa non credeva ai suoi occhi: «Correte, correte: ho trovato la penna d’aquila!».
I giovani indiani cominciarono a passarsi la voce.
Dopo poco erano tutti raccolti intorno al vincitore. «Sì – disse Falco Bruno – ha vinto la prova di forza e coraggio, con la forza che ha dimostrato prendendomi sulla canoa e con il coraggio che ha avuto nel fare quello che nessun altro voleva fare».
«Che cosa ho fatto, dunque?» riprese sorpreso Nuvola Rossa.
E Falco Bruno: «Hai guardato chi ti si è presentato di fronte; hai accettato la sfida di un’occasione imprevista».
Gli altri giovani si guardarono l’un l’altro in silenzio.
Solo Castoro Grigio se la sentì di prendere la parola: «Questa volta, ragazzi, ci è mancato qualcosa».
Il silenzio di tensione si sciolse ben presto: quella volta era mancato qualcosa, ma per l’avvenire c’era la speranza di nuove occasioni per fare come il loro giovane amico Nuvola Rossa.
Padre Andrea Panont, L’alfabeto di Dio, Mimep-Docete
• In cosa consisteva la “prova di forza” che avrebbero dovuto affrontare i giovani indiani?
• Quale richiesta fece Falco Bruno ai giovani indiani, mentre erano tutti indaffarati a preparare i remi e le provviste, per poter affrontare la prova di forza?
• Chi accettò la proposta di Falco Bruno?
• Chi vinse tra i giovani indiani la gara di forza? In quale modo?
• Cosa era mancato ai giovani indiani rispetto a Nuvola Rossa?
Scelti per vivere un’avventura
Un mattino di molto tempo fa, nella quiete del mondo, quando c’era meno rumore e più verde, e gli hobbit erano ancora numerosi e prosperi, e Bilbo Baggins stava sulla porta dopo colazione fumando un’enorme pipa di legno che gli arrivava fin quasi alle pelose dita dei piedi (accuratamente spazzolate), ecco arrivare Gandalf.
Gandalf!
Se di lui aveste sentito solo un quarto di quello che ho sentito io, e anch’io ho sentito ben poco di tutto quello che c’è da sentire, vi aspettereste subito una qualche storia fuor del comune. Storie e avventure spuntavano fuori da ogni parte, dovunque egli andasse, e del tipo più straordinario. Non era più sceso sotto la Collina da un sacco di tempo, per l’esattezza da quando era morto il suo amico, il Vecchio Tuc, e gli hobbit avevano quasi dimenticato il suo aspetto. Era stato via oltre la Collina e di là dall’Acqua per certi suoi affari sin da quando erano tutti piccoli hobbit.
Tutto quello che l’ignaro Bilbo vide quel mattino era un vecchio con un bastone. Aveva un alto cappello blu a punta, un lungo mantello grigio, una sciarpa argentea sulla quale la lunga barba bianca ricadeva fin sotto la vita, e immensi stivali neri.
«Buon giorno!» disse Bilbo; e lo pensava veramente.
Il sole brillava e l’erba era verdissima.
Ma Gandalf lo guardò da sotto le lunghe sopracciglia irsute ancora più sporgenti della tesa del suo cappello.
«Che vuoi dire?» disse. «Mi auguri un buon giorno o vuoi dire che è un buon giorno che mi piaccia o no; o che ti senti buono, quest’oggi; o che è un giorno in cui si deve essere buoni?».
«Tutto quanto» disse Bilbo. «È un bellissimo giorno per una pipata all’aperto, per di più. Se avete una pipa con voi, sedetevi e prendete un po’ del mio tabacco! Non c’è fretta, abbiamo tutto il giorno davanti a noi!».
E Bilbo si sedette su un sedile accanto alla porta, incrociò le gambe e fece un bell’anello grigio di fumo che salì in aria senza rompersi e si librò sopra la Collina.
«Graziosissimo!» disse Gandalf. «Ma stamattina non ho tempo di fare anelli di fumo. Cerco qualcuno con cui condividere un’avventura che sto organizzando ed è molto difficile trovarlo».
«Lo credo bene, da queste parti! Siamo gente tranquilla e alla buona e non sappiamo che farcene delle avventure. Brutte fastidiose scomode cose! Fanno far tardi a cena! Non riesco a capire cosa ci si trovi di bello!» disse il nostro signor Baggins, e infilati i pollici sotto le bretelle fece un anello di fumo ancora più
grande. Poi tirò fuori la posta del mattino e cominciò a leggerla, ostentando d’ignorare completamente il vecchio. Aveva deciso che non era proprio il suo tipo e voleva che se ne andasse.
Ma il vecchio non si mosse. Stava fermo, appoggiato al suo bastone, fissando lo hobbit senza dire niente, finché Bilbo si sentì a disagio e anche un po’ seccato.
«Buon giorno!» disse alla fine. «Non vogliamo nessuna avventura qui, grazie tante! Potete tentare sopra la Collina o di là dall’Acqua».
Con ciò voleva dire che la conversazione era conclusa.
«Però, quante cose sai dire col tuo Buon giorno!» disse Gandalf. «Adesso vuoi dire che ti vuoi sbarazzare di me e che il giorno non sarà buono finché non me ne sarò andato».
«Niente affatto, niente affatto, caro signore! Vediamo un po’, non credo di conoscere il vostro nome…».
«Sì, sì, mio caro signore! E io conosco benissimo il tuo, signor Bilbo Baggins. E tu conosci benissimo il mio, anche se non ricordi che sono io a portarlo. Io sono Gandalf e Gandalf vuol dire me! E pensare che dovevo vivere per essere congedato con un ‘Buon giorno’ dal figlio di Belladonna Tuc, come se fossi un venditore ambulante di bottoni!».
«Gandalf, Gandalf! Figurarsi un po’! Quello stregone vagabondo che diede al Vecchio Tuc un paio di magici gemelli di diamanti che si attaccavano da sé e non si riusciva più a staccarli fino a che non glielo si ordinava? Quel tipo che alle feste raccontava splendide storie di draghi e orchi e giganti e la liberazione di principesse e la fortuna inaspettata di figli di vedove? L’uomo che sapeva fabbricare quei fantastici fuochi d’artificio? Quelli sì che me li ricordo! Il Vecchio Tuc li faceva a Ferragosto. Splendidi! Salivano come enormi gigli, bocche di leone e ginestre di fuoco, e rimanevano sospesi nel crepuscolo per tutta la sera!».
Vi sarete accorti che il signor Baggins non era proprio così prosaico come amava credere, e inoltre che era molto amante dei fiori.
«Povero me!» continuò. «Proprio il Gandalf che spinse tanti bravi ragazzi e ragazze a partire per l’Ignoto in cerca di pazze avventure: arrampicarsi sugli alberi, visitare elfi o andare per nave e far vela per altri lidi! Che il cielo mi perdoni, la vita era proprio interess… voglio dire, un tempo avevate l’abitudine di metter tutto sottosopra da queste parti! Vi chiedo scusa, ma non avevo idea che foste ancora in affari!».
«Che altro dovrei fare?» disse lo stregone. «Ma sono contento lo stesso di vedere che ricordi qualcosa di me. Sei gentile a ricordare almeno i miei fuochi d’artificio, e questo mi fa sperare bene. Sì, certo! Per amore del tuo vecchio nonno Tuc e per amore della povera Belladonna, ti darò quello che mi hai chiesto!».
«Vi chiedo scusa, ma io non ho chiesto niente!».
«E invece sì, e per ben due volte. Sei scusato. Te lo darò. Anzi, farò di più: ti darò una bella parte in quest’avventura, molto divertente per me, ottima per te, e anche proficua, probabilmente, se riesci a venirne fuori».
«Scusate! Io non voglio nessuna avventura, grazie! Non oggi! Buongiorno! Ma venite a prendere il tè, per piacere, quando vi pare! Perché non domani? Venite domani! arrivederci!».
Detto questo lo hobbit si girò, svignandosela per la verde porta rotonda, e la chiuse, appena osò farlo senza apparire maleducato. Dopo tutto, gli stregoni sono sempre stregoni. «Perché mai l’ho invitato a prendere il tè?» disse tra sé e sé andando in dispensa.
J.R.R. Tolkien, Lo hobbit o la riconquista del tesoro, Adelphi
• Cosa stava facendo Bilbo quando Gandalf si presentò a casa sua?
• Perché Gandalf era andato a trovare Bilbo? Chi stava cercando?
• Come reagisce Bilbo di fronte alla proposta di Gandalf? Perché?
• Perché, secondo te, Bilbo pensa «Perché mai l’ho invitato a prendere il tè?», riferendosi a Gandalf?
• Ti è mai capitato che qualcuno ti abbia invitato a vivere un’avventura? Come hai reagito all’invito? Cosa è accaduto poi? Racconta.
Il compito di Peter
In lontananza, si vedeva il mare azzurro dove erano sospese piccole nuvole che il tramonto colorava di rosa. Ma, là, dove il paese di Narnia era lambito dal mare, esattamente alla foce del Grande Fiume, si ergeva qualcosa che sembrava una montagna sfolgorante. Non era una collina di luce, ma un grande castello. Lo scintillio meraviglioso era dovuto al riflesso del tramonto che faceva brillare i vetri delle finestre, ma a Peter sembrò ugualmente che il castello fosse una stella splendente posata in riva al mare.
«Eccolo, uomo» disse Aslan. «Laggiù c’è Cair Paravel con i suoi quattro troni. Su uno di essi siederai tu, come re: sei il primogenito e dominerai sugli altri».
Peter rimase in silenzio, poi il suo orecchio fu raggiunto da uno squillo curioso: sembrava una tromba, ma era più cupo.
«È tua sorella che soffia nel piccolo corno» spiegò Aslan in un sussurro così basso che, se non temessi di mancargli di rispetto, direi che assomigliava al ron ron di un placido gatto.
Finalmente, Peter capì il significato di quelle parole e si lanciò di corsa verso la grande tenda di seta gialla, dove si trovava la sorella. Lucy correva verso di lui con tutta la velocità che le permettevano le sue gambette, pallida come un cencio lavato. Susan scattò verso un albero e cominciò ad arrampicarsi; la inseguiva una grossa bestiaccia grigia, che Peter scambiò prima per un orso, poi per un cane: ma era troppo grande, doveva essere un lupo. Era infatti un lupaccio ringhioso che si era alzato sulle zampe posteriori e, appoggiando quelle anteriori al tronco dell’albero, tentava di azzannare Susan.
Il lupo aveva i peli della schiena ritti come una cresta di fili di ferro. Susan era arrivata al secondo, grosso ramo e una delle gambe penzolava nell’aria, a pochi centimetri dai denti del lupo. Peter si chiese, stupito, perché la sorella non cercasse di salire più su o almeno di aggrapparsi saldamente: poi si accorse che stava per svenire e che sarebbe caduta immancabilmente nelle fauci della belva. Peter si lanciò impetuosamente verso il lupaccio e vibrò un colpo di spada, mirando al fianco. Il colpo non arrivò a segno perché il lupo, rapido come il lampo, si voltò verso il ragazzo, gli occhi fiammeggianti e la bocca spalancata, latrando furiosamente; era troppo furioso e il ragazzo ebbe il tempo di fare un balzo indietro. Peter tornò all’attacco e con tutte le forze, affondò la spada nel petto della bestiaccia, proprio in mezzo alle zampe anteriori, dritto al cuore.
Poi il nemico stramazzò al suolo e lui estrasse la spada senza fatica. Tremante da capo a piedi, aveva la fronte imperlata di sudore e si sentiva stanchissimo. Ansante, si volse a guardare Aslan.
«Hai dimenticato di ripulire la spada» disse il leone, severo.
Era vero e Peter arrossì di emozione vedendo la bella lama lucente ancora im-

piastricciata del sangue del lupo. Si chinò e strofinò la lama sull’erba: quando fu pulita del tutto, finì di asciugarla passandola sul vestito. «Ora dammela e inginocchiati, figlio di Adamo» ordinò Aslan. Peter obbedì e il grande leone gli battè sulla spalla con la spada messa di piatto, dicendo: «Alzati, ora sei un vero cavaliere e ti chiamerai Peter Flagello dei Lupi. Ma non dimenticare mai più di ripulire la spada».
C.S. Lewis, Il leone, la strega e l’armadio. Le cronache di Narnia, vol.2, Mondadori
In fondo al tunnel
Camminavo da ore. Respiravo. Non sentivo stanchezza. L’aria fresca mi fasciava tutto e pareva mi volesse portare. Sulle spalle, come sempre, un piccolo sacco. D’un tratto, il rumore di un volo deciso e fermo: davanti a me stava, calma, la cedrona. Una gioia incredibile mi prese. L’accarezzai. Non si mosse. La fissai negli occhi. Poi, come per indicarmi la strada, partì decisa fra i mughi e le sterpaglie volgendosi, di tanto in tanto, per vedere se la seguissi. Certo che la seguivo, certo. Avevo capito che aveva bisogno di aiuto ed ero pronto a darglielo, come potevo.
Dopo circa mezz’ora, fummo davanti ad una parete a picco.
«Qua passi tu sola» dissi, guardando desolatamente la parete nera «io no, sono senza ali».
L’animale fece cenno che la seguissi; e la vidi, subito dopo, scomparire. Stupito, cercai e trovai, assolutamente nascosto e invisibile ai piedi della parete, l’imbocco di una caverna, ma così stretta che ci passavo appena. M’introdussi… e dopo pochi metri fu notte fonda. Continuai come un cieco, appoggiandomi con le mani alle pareti umide e scivolose; andavo a tentoni nel buio. Quanto durò quell’andare a tentoni? Non lo so. So solo che a un certo punto quel tunnel nero finì.
Mi stropicciai gli occhi. Li aprii… e mi trovai davanti alla valle più bella del mondo. Non grande. Una cascata precipitava garrula in basso, formando un limpidissimo lago, cinto da prati verdi e difeso da quattro enormi abeti secolari; scoiattoli e uccelli di ogni genere, dappertutto. Ginepri con bacche mature, mirtilli neri e rossi. Ma ciò che mi colpì, più di ogni altra cosa, furono i galli cedroni di ogni età: ma erano stranamente fermi, davanti a me… stranamente fermi.
«Dev’essere il paradiso» dissi fra me «il paradiso dei cedroni».
Cercai con lo sguardo la guida. La vidi, s’incamminò. La seguii.
Mi condusse davanti ad un grosso ramo sul quale stava appollaiato il più grosso gallo cedrone che esistesse – credo – sulla terra: maestoso, immenso, regale.
Mi guardò, senza stupore, con gli occhi acuti ma velati. Lo toccai. Scottava. «Ma sei malato» dissi «sei malato!».
Guardai un’ala: nulla. L’altra: nulla. Ma intorno al collo vidi una vena infiammata. La seguii delicatamente con la mano. Soffiai fra il pelame. E capii. Un grosso pallino di piombo, sparato da un cacciatore, l’aveva raggiunto al collo e si era fermato vicino alla spina dorsale, senza romperla, fortunatamente: ma bisognava toglierlo, e subito, perché si era formata un’infiammazione che aumentava, e la cui fine sarebbe stata inevitabilmente la morte. Accarezzai l’animale.
«Ora ci penso io» dissi «ma ti chiedo di star fermo, anche se sentirai male, molto male: ma poi guarirai, vedrai, guarirai… te lo garantisco. Guarirai perché ti voglio bene».
Trassi dal sacchetto un pacchetto di sanità, che sempre porto con me durante le gite, e un grosso coltello da montagna. Intanto altri galli cedroni erano venuti, in silenzio, a vedere ciò che facevo al loro re. Anch’essi non dimostravano alcuna paura verso di me: mi parvero, curiosamente, degli assistenti intorno al chirurgo. Mi avvicinai al cedrone fino a toccargli il becco poderoso.
«È il momento» dissi «cerca di stare fermo, molto fermo».
E mentre disinfettavo con l’alcool la lama grande del coltello, pregavo: «Signore, dirigi la mia mano: è una tua creatura, fa’ che ancora per molti anni possa lodarti per i liberi cieli…».
Soffiai sulla fitta piuma. Scoprii il rigonfiamento, ormai paonazzo, del grosso pallino. Lo cosparsi di alcool. Poi, con un colpo rapidissimo, lo incisi. Spruzzò sangue e pus: e finalmente, premendo forte con le dita, uscì il micidiale pallino. Il cedrone era stato immobile: solo al colpo rapido di coltello la sua pelle rabbrividì.
«Bravo» gli dissi mostrandogli il pallino estratto «sei stato bravissimo. Ora disinfetto e chiudo la ferita. Ancora un po’ di pazienza».
Disinfettai tutto il solco della ferita; lo ripulii, schiacciai ancora dove c’erano piccole sacche di pus; quando tutto fu chiaro e lavato con alcool, vi misi sopra, dolcemente, un cerotto di finissimo tessuto, lo stirai e rimisi a posto le piume. «Eccoti» dissi «rimesso a nuovo. Ancora un po’ di riposo. Poi sarai di nuovo padrone dei cieli».
Il cedrone scosse le grandi ali. Le richiuse. Poi mise il suo poderoso collo sul mio petto. Lo guardai negli occhi. Quel velo che li offuscava era passato; essi stavano tornando a poco a poco lucidi e potentissimi.
Ezio Franceschini, La valle più bella del mondo, Vita e Pensiero
garrula: rumorosa, vivace.
Il piccolo mietitore
Legge… (la nonna ammira): ecco il campetto bianco di grano nero in lunghe righe: esso, tutt’occhi, con il suo falcetto a una a una miete quelle spighe; miete, e le spighe restano pur quelle; miete e lega coi denti le mannelle;
e le mannelle di tra i denti suoi parlano… come noi, meglio di noi.
Giovanni Pascoli


Il piccolo aratore
Scrive… (la nonna ammira): ara bel bello, guida l’aratro con la mano lenta; semina col suo piccolo marrello; il campo è bianco, nera la sementa.
D’inverno egli ara: la sementa nera d’inverno spunta, sfronza a primavera;
fiorisce, ed ecco il primo tuon di Marzo rotola in aria, e il serpe esce dal balzo.
Giovanni Pascoli
Due poesie molto simili tra loro come si vede dal primo verso:
Scrive… (la nonna ammira), Legge… (la nonna ammira): la nonna ammira il nipotino che impara a leggere e a scrivere.
Scrive, legge: questi due verbi all’inizio della poesia cosa c’entrano con il lavoro del piccolo aratore e mietitore? Cosa c’entrano con il lavoro della terra?
Eppure una somiglianza tra l’attività del contadino e quella del bambino c’è: imparare a scrivere e a leggere costa fatica come arare, seminare e mietere, ma dopo tanto lavoro si raccoglie qualcosa che serve a vivere. Chi meglio di un bambino di quinta può riconoscere questa evidenza mentre ammira e aiuta i bambini della prima classe chini sul loro quadernino all’inizio di settembre e poi, guardando sé, vede e riconosce il frutto di tanto lavoro?
TRA CASA E SCUOLA
Rima rimani
Apro la bocca e dico la rima
Ride il silenzio che c’era prima
Tutte le cose mi siedono intorno
Per aspettare la fine del giorno
Io le saluto, una per una
So le parole per sole e per luna
So quelle rime che tengono insieme
Fiore con fiume, sole con seme
Fiume di figli, inzuppati d’amore
Che solo il nome fa già buon odore
Che con il grido di uccelli felici
Danzano intorno a queste radici
Anche le cose ora danzano in tondo
La filastrocca che ha dentro il mondo
Sole tramonta, torna domani
Rima, rimani
Pick a Bale of Cotton
Canto spiritual che col ritmo e i movimenti
ripropone il lavoro nelle piantagioni di cotone.
You got to jump down, turn around and pick a bale of cotton
You got to jump down and turn around and pick a bale a day.


Chissà
come si divertivano
Margie lo scrisse perfino nel suo diario, quella sera. Sulla pagina che portava la data 17 maggio 2157, scrisse: «Oggi Tommy ha trovato un vero libro!».
Era un libro antichissimo. Il nonno di Margie aveva detto una volta che, quand’era bambino lui, suo nonno gli aveva detto che c’era stata un’epoca in cui tutte le storie e i racconti erano stampati su carta. Si voltavano le pagine, che erano gialle e fruscianti, ed era buffissimo leggere parole che se ne stavano ferme invece di muoversi, com’era previsto che facessero: su uno schermo, è logico. E poi, quando si tornava alla pagina precedente, sopra c’erano le stesse parole che loro avevano già letto la prima volta.
«Mamma mia, che spreco» disse Tommy. «Quand’uno è arrivato in fondo al libro, che cosa fa? Lo butta via, immagino. Il nostro schermo televisivo deve avere avuto un milione di libri, sopra, ed è ancora buono per chissà quanti altri. Chi si sognerebbe di buttarlo via?».
«Lo stesso vale per il mio» disse Margie.
Aveva undici anni, lei, e non aveva visto tanti telelibri quanti ne aveva visti Tommy. Lui di anni ne aveva tredici.
«Dove l’hai trovato?» gli domandò.
«In casa». Indicò senza guardare, perché era occupatissimo a leggere. «In solaio».
«Di che cosa parla?».
«Di scuola».
«Di scuola?» Il tono di Margie era sprezzante. «Cosa c’è da scrivere sulla scuola? Io, la scuola la odio».
Margie aveva sempre odiato la scuola, ma ora la odiava più che mai. L’insegnante meccanico le aveva assegnato un test dopo l’altro di geografia, e lei aveva risposto sempre peggio finché la madre aveva scosso la testa, avvilita, e aveva mandato a chiamare l’Ispettore della Contea.
Era un omino tondo tondo, l’Ispettore, con una faccia rossa e uno scatolone di arnesi con fili e con quadranti. Aveva sorriso a Margie e le aveva offerto una mela. Poi aveva smontato l’insegnante in tanti pezzi. Margie aveva sperato che poi non sapesse più come rimetterli insieme, ma lui lo sapeva e, in poco più di un’ora, l’insegnante era di nuovo tutto intero, largo, nero e brutto, con un grosso schermo sul quale erano illustrate tutte le lezioni e venivano scritte tutte le domande.
Ma non era quello il peggio. La cosa che Margie odiava soprattutto era la fessura dove lei doveva infilare i testi compilati. Le toccava scriverli in un codice perforato che le avevano fatto imparare quando aveva sei anni e il maestro meccanico calcolava i voti con una velocità spaventosa.
L’Ispettore aveva sorriso, una volta finito il lavoro, e aveva accarezzato la testa di Margie.
Alla mamma aveva detto: «Non è colpa della bambina, signora Jones. Secondo me, il settore geografia era regolato male. Sa, sono inconvenienti che capitano, a volte. L’ho rallentato. Ora è su un livello medio per alunni di dieci anni. Anzi, direi che l’andamento generale dei progressi della scolara sia piuttosto soddisfacente». E aveva fatto un’altra carezza sulla testa di Margie.
Margie era delusa. Aveva sperato che si portassero via l’insegnante per ripararlo in officina. Una volta s’erano tenuti quello di Tommy per circa un mese. Perché il settore storia era andato completamente a pallino.
Così, disse a Tommy: «Ma come gli viene in mente, a uno, di scrivere un libro sulla scuola?».
Tommy la squadrò con aria di superiorità. «Ma non è una scuola come la nostra, stupida! Questo è un tipo di scuola molto antico, come l’avevano centinaia e centinaia di anni fa».
Poi aggiunse altezzosamente, pronunciando la parola con cura. «Secoli fa».
Margie era offesa. «Beh, io non so che specie di scuola avessero, tutto quel tempo fa».
Per un po’ continuò a sbirciare il libro, china sopra la spalla di lui, poi disse: «In ogni modo, avevano un maestro».
«Certo che avevano un maestro, ma non era un maestro regolare. Era un uomo».
«Un uomo? Come faceva un uomo a fare il maestro?».
«Beh, spiegava le cose ai ragazzi e alle ragazze, dava da fare dei compiti a casa e faceva delle domande».
«Un uomo non è abbastanza in gamba».
«Sì che lo è. Mio papà ne sa quanto il mio maestro».
«Ma va’! Un uomo non può saperne quanto un maestro».
«Ne sa quasi quanto il maestro, ci scommetto».
Margie non era preparata a mettere in dubbio quell’affermazione. Disse: «Io non ce lo vorrei un estraneo in casa, a insegnarmi».
Tommy rise a più non posso. «Non sai proprio niente, Margie. Gli insegnanti non vivevano in casa. Avevano un edificio speciale e tutti i ragazzi andavano là».
«E imparavano tutti la stessa cosa?».
«Certo. Se avevano la stessa età».
«Ma la mia mamma dice che un insegnante deve essere regolato perché si adatti alla mente di uno scolaro o di una scolara, e che ogni bambino deve essere istruito in modo diverso».
«Sì. Però loro a quei tempi non facevano così. Se non ti va, fai a meno di leggere il libro».
«Non ho detto che non mi va, io» si affrettò a precisare Margie.
Certo che voleva leggere di quelle buffe scuole.
Non erano nemmeno a metà del libro quando la signora Jones chiamò:
«Margie! A scuola!».
Margie guardò in su. «Non ancora, mamma».
«Subito!» disse la signora Jones. «E sarà ora di scuola anche per Tommy, probabilmente».
Margie disse a Tommy: «Posso leggere ancora un po’ il libro con te, dopo la scuola?».
«Vedremo» rispose lui con noncuranza. Si allontanò fischiettando, il vecchio libro polveroso stretto sotto il braccio.
Margie se ne andò in classe.
L’aula era proprio accanto alla cameretta, e l’insegnante meccanico, già in funzione, la stava aspettando. Era in funzione sempre alla stessa ora, tutti i giorni tranne il sabato e la domenica, perché la mamma diceva che le bambine imparavano meglio se imparavano a orari regolari.
Lo schermo era illuminato e diceva: «Oggi la lezione di aritmetica è sull’addizione delle frazioni proprie. Prego inserire il compito di ieri nell’apposita fessura».
Margie obbedì con un sospiro. Stava pensando alle vecchie scuole che c’erano quando il nonno di suo nonno era bambino.
Ci andavano i ragazzi di tutto il vicinato, ridevano e vociavano nel cortile, sedevano insieme in classe, tornavano a casa insieme alla fine della giornata. Imparavano le stesse cose, così potevano darsi una mano a fare i compiti e parlare di quello che avevano da studiare.
I maestri erano persone…
L’insegnante meccanico faceva lampeggiare sullo schermo: «Quando addizioniamo le frazioni 1/2 + 1/4…».
Margie stava pensando ai bambini di quei tempi, e a come dovevano amare la scuola.
Chissà, stava pensando, come si divertivano!
Isaac Asimov, in B. Panebianco, P. Pullega, Il lettore consapevole. Manuale di analisi del testo narrativo, Clio
Io e la mia cartella
La mia cartella è grande, rossa e fatta a mano. Me l’hanno regalata quando frequentavo la prima elementare ed io vorrei che mi durasse fino alla quinta perché le sono affezionato e poi le ho appiccicato sopra una collezione di autoadesivi invidiata da tutti i miei compagni.
Io credo che anche lei mi voglia bene, eppure l’altro giorno ho sognato che si lamentava un po’ di me.
«Non mi tratti mica bene» mi diceva. «Io non ho la mania dell’ordine, ma qualche volta potresti darmi una pulitina e liberarmi da tutti quei pasticci che mi infili nella pancia: cartacce, gomme, gommine, penne rosicchiate, merende secche e strasecche…».
«Ma non sono pasticci» le rispondevo io, sempre nel sogno «sono cose a cui io tengo e che mi piace ritrovare nei tuoi scomparti…».
«Anche le merende secche?».
«No, quelle no, ma insomma…».
Ma le lamentele della mia cartella non erano ancora finite: «E poi, ragazzo mio, non capisco perché tu mi debba trattare come una ciabatta! Ieri mi hai fatto scivolare sul pavimento tanto forte che stavo rompendo il vetro della porta e l’altro giorno mi hai appoggiato sopra l’ombrello bagnato facendomi venire il raffreddore! Guarda un po’ il tuo amico Piero: ha sempre delle cartelle pulite e in ordine che sono l’ammirazione della scuola e sono sicura che dentro ha tutti i quaderni ordinati e senza “orecchie” e che i fogli grandi per i compiti in classe non hanno neanche una macchiolina così!».
«Beh, hai ragione, ma Piero è uno di quelli che cambiano cartella ad ogni anno scolastico e poi io non sono un pignolo come lui e…» stavo per mettermi a piangere ed allora la mia cartella si è impietosita ed ha cominciato a consolarmi: «Ma no, non te la prendere, io dicevo così per dire! Ti voglio bene come sei e spero di rimanere ancora con te, dividendo le tue ore di scuola, i tuoi nervi quando devi fare i compiti e, povera me, le corse e gli sballottamenti all’uscita di scuola!».
Quando mi sono svegliato ho guardato con simpatia ancora più grande la mia scassatissima cartella: era per terra, aperta, e da lei spuntavano fuori quaderni, pennarelli, del pongo e un puffo.
Chissà perché mi è sembrato che ridesse!
Se la tua cartella potesse parlare, cosa racconterebbe di te?
Martino, classe V
Stai per cominciare
Stai per cominciare a leggere un nuovo libro.
Prendi la posizione più comoda: seduto, sdraiato, raggomitolato, coricato. Coricato sulla schiena, su un fianco, sulla pancia. In poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul pouf. Sull’amaca, se hai un’amaca. Sul letto, naturalmente, o dentro il letto. Puoi anche metterti a testa in giù, in posizione yoga. Col libro capovolto, si capisce.
Certo, la posizione ideale per leggere non si riesce a trovarla. Bene, cosa aspetti? Distendi le gambe, allunga pure i piedi su un cuscino o su due. Togliti le scarpe, prima.
Regola la luce in modo che non ti stanchi la vista. Fallo adesso, perché appena sarai sprofondato nella lettura non ci sarà più verso di smuoverti.
C’è qualcosa di particolare che ti aspetti da questo libro? Ci sono ragazzi che vivono in attesa di esperienze straordinarie: dalle persone, dai viaggi, dagli avvenimenti, da quello che succederà domani, dai libri.
Che cosa aspetti tu da questo libro?
Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Mondadori
• «Caro amico, ti consiglio di leggere questo libro, perché…». Scrivi una lettera ad un tuo amico, per consigliargli un libro che valga la pena leggere e che a te è particolarmente piaciuto.
• Parla di un personaggio che hai conosciuto leggendo un libro e che ti ha particolarmente colpito.
Descrivilo nelle sue caratteristiche, nelle sue azioni e spiega che cosa ti affascina di tale personaggio.
Volete un consiglio?
Volete un consiglio su cosa leggere quest’estate? Io vi suggerisco un libro di Salgari. I libri che ho letto di questo autore mi sono piaciuti molto.
Voglio raccontarvene uno, “I pirati della Malesia”, un romanzo di avventure e missioni impossibili a tutti, ma non al temerario pirata Sandokan, soprannominato “La tigre della Malesia”.
La storia è ambientata nel Sud-Est asiatico, dove predomina la giungla con piante esotiche di ogni genere, anche velenose.
Pensate che Salgari abbia visitato realmente questi luoghi? Assolutamente no. Il suo desiderio era quello di visitare luoghi lontani, ma nella sua vita lo poté soddisfare solo attraverso i suoi libri.
In questa avventura Tremal-Naik, il cacciatore di serpenti della Giungla Nera, viene incarcerato dagli Inglesi perché è stato accusato ingiustamente dai Thugs, una setta di fanatici fedeli alla dea Kalì e spietati nemici di Tremal-Naik. Però il fedele Kammamuri decide di andare a liberare il suo padrone e porta con sé Ada Corisant, la fidanzata di Tremal-Naik, impazzita per il dolore.
La moglie di Sandokan, la defunta Marianna, è parente di Ada Corisant, perciò Sandokan partecipa a questa impresa. Questo è solo l’inizio di una serie di meravigliose avventure che vedono Sandokan con i suoi tigrotti e Tremal-Naik combattere contro gli Inglesi, guidati dal terribile sterminatore di pirati, James Brooke.
Non vi anticipo la fine… non voglio privarvi del gusto della lettura!
Giacomo, classe V
Leggi!
«Leggi! Ma insomma, leggi! Diamine, ti ordino di leggere! Sali in camera tua e leggi!».
Risultato? Niente. Il verbo leggere non sopporta l’imperativo.
All’improvviso la finestra gli è apparsa spalancata su qualcosa di desiderabile, e da lì è volato via, per sfuggire al libro. E ora eccolo, di fronte a un libro che non legge. Tutta la voglia di essere altrove forma tra lui e le pagine aperte uno schermo che confonde le righe. Se almeno ci fossero dei dialoghi. Figurati! Pagine zeppe di righe strettissime, neri paragrafi ammassati gli uni sugli altri, e, qua e là, l’elemosina di un dialogo, due virgolette, come un’oasi, a indicare che un personaggio parla a un altro personaggio. Ma l’altro non gli risponde. Segue un blocco compatto di dodici pagine! Dodici pagine di inchiostro nero! Manca l’aria! Uh, se manca l’aria! All’inizio dell’anno, il ragazzo è approdato qui, in questa scuola, insieme a molti altri. Naturalmente non amano leggere. Almeno, questo è ciò che si desume dalla selva di mani alzate quando l’insegnante chiede:
«A chi non piace leggere?».
«Bene,» dice l’insegnante «visto che non vi piace leggere… sarò io a leggervi dei libri».
Apre la cartella tira fuori un libro: «Mettetevi comodi, rilassatevi».
«Ma… ci leggerà quel libro… a voce alta?».
«Non vedo come potreste sentire se leggessi a voce bassa».
«Abbiamo passato l’età…» pregiudizio abbastanza diffuso, soprattutto fra coloro che non hanno mai ricevuto il vero dono di una lettura. Gli altri sanno che non c’è età per questo genere di regali.
«Se fra dieci minuti sarai ancora dell’idea di aver passato l’età, alzi la mano e facciamo qualcos’altro. D’accordo?». Passano i giorni. Un’insegnante legge alcune pagine ogni settimana. Ma perché rimandare alla settimana prossima un piacere che ci si può concedere in una serata?
«Chi l’ha scritto questo libro?».
«Dove posso comprarlo?».
«Cos’altro ha scritto?». Non uno, tra gli alunni, aspetta che l’insegnante arrivi alla fine del libro: terminano prima di lui. Cos’è successo di tanto straordinario? Il merito dell’insegnante è nullo in tutta la vicenda. Il fatto è che il piacere di leggere era vicinissimo, imprigionato da una paura segreta: la paura di annoiarsi.
Quei ragazzi avevano semplicemente dimenticato che cos’era un libro, cos’aveva da offrire. Avevano dimenticato, per esempio, che un romanzo racconta prima di tutto una storia. Non sapevano che un romanzo deve essere letto come un romanzo: placare prima di tutto la nostra sete di racconto.
Scoprire che l’autore si rivolge a me, racconta la sua storia per me.
Daniel Pennac, Come un romanzo, Feltrinelli
Leggo per legittima difesa
Ricordo il primo libro che lessi all’età di circa sei anni. Era un libretto piccolo, sulla cui copertina era stampata un’oca bianca con un fiocco al collo e un cappellino arancione in testa. Non ricordo bene di cosa parlasse, ricordo però che più spesso del dovuto lo prendevo e lo leggevo attentamente. Non ricordo se la storia parlasse di un’oca avventuriera o se fosse semplicemente un libro di filastrocche con coniglietti di Pasqua e topolini; quello che ricordo bene era la totale concentrazione che mi prendeva quando avevo in mano quel libretto bianco. Era probabilmente la mia cosa preferita. Me ne stavo seduta nel mio letto, piccolo anche lui come me, come quel libretto, e me lo leggevo una, due, tre volte e anche di più. Non mi stancava mai, anche se le lettere, le frasi, erano sempre le stesse. Di tanto in tanto veniva mia madre in camera e me lo leggeva prima di andare a dormire; la sua voce dava alla storia qualcosa in più: dal tono con cui accentuava le lettere, dai gesti che faceva, la storia prendeva vita e tutto d’un tratto i personaggi uscivano, così io li vedevo parlare e agire davanti ai miei occhi. Di questo non mi stancavo mai.
Finito il periodo nel quale la mia conoscenza in fatto di libri si limitava a quell’oca dal cappello strano, cominciai a leggere libri un po’ più lunghi e articolati; stavolta si trattava di storie meravigliose, di principesse e draghi, polpi e campanari, di eroi e streghe dai lunghi artigli. Erano libri che ci davano a scuola, libri che rendevano migliore la mia convivenza tra articoli e somme, tra rimproveri e note di comportamento. A casa li leggevo sul mio letto che era stato spostato sotto la finestra: d’estate entrava tanta luce nella stanza e potevo leggere senza difficoltà; mia madre mi ripeteva continuamente di non leggere al buio, cosa che accadeva molto spesso.
Ai miei amici e a mia sorella non piaceva leggere: «Che noia!» esclamavano, e in quei momenti avrei voluto vederli sommersi di libri, senza poter fare nulla. Era quello che si sarebbero meritati per aver disdegnato la cosa che più amavo. Ciò che leggevo instaurava in me la voglia di scrivere a mia volta, ma, come mi succede sempre, scrivevo un inizio, lo rileggevo il giorno dopo, lo cancellavo e iniziavo una storia completamente diversa. Il mio computer strabordava di inizi di storie senza alcuno sviluppo; mi chiedevo come facessero gli autori delle storie che leggevo a immaginarsi una introduzione, uno svolgimento e una fine senza scrivere stupidaggini. Quelle persone scrivevano divinamente e non potevo fare a meno di desiderare di essere come loro, avrei voluto incantare la gente come loro incantavano me. Cosa aveva di così speciale leggere? Era davvero difficile intenderlo e lo è tuttora.
Il passaggio dalle elementari alle medie cambiò radicalmente il mio modo di vedere la lettura. Leggere non era considerata una grande cosa: se leggevi eri
un “secchione”, ed io non potevo mancare al mio perfetto alibi da sconsiderata e svogliata studentessa. Leggevo quasi di nascosto, e in ogni caso non era una cosa di cui mi vantavo troppo. Fu un periodo abbastanza povero in quanto a lettura, non ricordo nemmeno quali tipi di libri leggevo e soprattutto se li leggevo. Ripresi ad interessarmi verso la terza media quando mi capitò tra le mani la trilogia di Italo Calvino: Il barone rampante, Il visconte dimezzato e Il cavaliere inesistente. Quello che preferii in assoluto fu il primo, Il barone rampante, pensai che avrei potuto fare come lui: nascondermi tra gli alberi con una buona scorta di libri e non scendere mai più.
Da questo punto di vista i libri erano anche abbastanza pericolosi, mi suggerivano cose che probabilmente non sarebbero state del tutto sagge. Non m’importava, ovviamente. Non avrei rinunciato a leggere per nulla al mondo. Neanche se i miei genitori ogni giorno mi ripetevano di uscire perché c’era il sole, neanche se rischiavo di essere investita camminando con un libro in mano per strada, neanche se mi veniva un terribile mal di testa in macchina. Io dovevo sapere cosa sarebbe successo dopo, immaginare delle scene nella mia testa, tifare per il mio personaggio preferito. Non avrei mai sopportato di essere interrotta.
Al momento non potrei amare i libri più di così. Li adoro, sono cose preziosissime. Non sopporto chi pensa che leggere sia tremendo, ammiro invece chi, come me, lo trova fantastico. Di solito rispetto le opinioni altrui in una discussione, ma se qualcuno inizia con «Non mi piace leggere…» perde il mio rispetto e la mia considerazione in poco tempo. Alla gente non piace leggere perché la gente è pigra, non perché i libri non sono belli, questo è ciò che penso e magari è sbagliato ma per me è inconcepibile non amare i libri. Penso però che tutti dovrebbero leggere un libro almeno una volta. È qualcosa di inspiegabile, ti avvolge completamente e tutto d’un tratto sei fisicamente nel salotto di casa tua ma mentalmente in un posto di gran lunga migliore ad avventurarti tra personaggi favolosi.
C’è una frase che ho letto su una delle borse ammucchiate che mia madre tiene nel sottoscala: «Leggo per legittima difesa». Ho pensato subito che fosse una bellissima frase. Leggo per difendermi, difendermi dalle superficialità, dalle cose fredde e vuote, anche un po’ dalle persone e dal mondo.
Leggere è come sognare, essere trascinati in avventure meravigliose o nella vita di qualcuno. Una volta finito un libro senti che hai capito qualcosa di più del mondo in cui vivi.
Spiegare la lettura è qualcosa a me davvero difficile, ce la sto mettendo tutta per dare l’idea di cosa accade realmente quando si apre un libro. L’unica cosa da fare è prenderne uno in mano e cominciare a leggere, cominciare ad entrare in quelle fantastiche storie di gente, di posti, di castelli o di piccole oche dai buffi cappelli. Maddalena, II media
Il tema
Succedeva sempre alle nove di sera, quando si era già cenato, ed era ora che io andassi a dormire. Ma il tema, il tema per il giorno dopo era ancora lì da fare, come una spada di Damocle, angoscioso. Con il suo titolo su un quaderno a righe, e, sotto, la pagina completamente bianca. Andava sempre così: avevo otto anni, mi piaceva andare a scuola e, molto, leggere; ma quel titolo appeso nel nulla mi opprimeva, e per tutto il pomeriggio avevo lasciato il quaderno chiuso.
«E il tema?», chiedeva infine mia madre. Io, occhi bassi, ancora seduta a tavola: «Non so cosa scrivere». Com’è il titolo? chiedeva allora lei. E io, con una smorfia: «“Sta arrivando l’autunno”. E che cosa vuoi che dica dell’autunno? Non c’è niente da dire, sull’autunno», esclamavo indispettita. Mia madre sorrideva, del sorriso che aveva quando ancora mia sorella era viva. «Senti, domani il tema lo devi portare a scuola. Coraggio, proviamo». E andavamo nello studio di mio padre, e ci sedevamo al suo grande tavolo ingombro di carte.
«Dunque, l’autunno», cominciava mia madre. Io con la biro, china sul foglio di brutta copia, tracciavo degli scarabocchi, imbronciata. Che stupidissima cosa i temi, pensavo. Chissà perché i grandi devono affliggere i bambini con degli inutili temi. A me piacevano le fiabe, ne leggevo senza mai stancarmi. Ma, nelle fiabe succedeva qualcosa, e c’era un buono, e un cattivo. Nei temi, invece.
Mia madre: «Ti ricordi ieri mattina, quando siamo uscite e c’era quel vento forte che sollevava le gonne, e tu ridevi?».
«Mi ricordo», replicavo, accigliata. «Beh, quello era l’autunno. L’autunno è uscire di casa una mattina pensando che faccia ancora caldo, e invece una folata di vento freddo ti coglie e ti fa rabbrividire, e fa correre i mulinelli delle foglie come se scappassero via, rincorse da un nemico».
Detta così, la cosa sembrava più interessante. Mi piaceva, l’idea del nemico che inseguiva la foglie rinsecchite. «Facevano un rumore secco», dicevo allora timidamente, «sembravano voci di vecchie che si lamentano». Mia madre: «È vero, scrivilo questo: le voci secche delle foglie morte che scappano. E poi, non ti piaceva anche quella pioggia a raffiche? Hai detto che sembrava arrabbiata».
Già, e c’era, mi veniva in mente, anche quel cielo fosco, come caduto in basso su Milano. E l’odore, fuori da scuola, da un banchetto, delle prime caldarroste.
«Ecco, devi scrivere tutto questo, liberamente, e anche le cose che ti sembrano strane», spiegava mia madre.
E finalmente la mia biro correva. Mi pareva di avere scoperto, in quel foglio bianco, una libertà che non conoscevo. Sono grata a mia madre, per quelle sere nello studio, noi due da sole. Per avermi svelato quell’angolo in cui potevo dire ciò che avevo nel cuore: le lettere tonde della mia grafia infantile che adesso si lasciavano andare, come acqua liberata, in quello che ora mi sembrava un grande, bel gioco.
Giochi con la palla
Il campo di gioco per il calcio occupava metà della piazza; la “porta” estrema era segnata da uno dei quattro lampioni che inquadravano la cancellata del monumento e da un tombino; l’altra, vicina alle panchine, veniva delimitata da due strisce sulla ghiaia.
Si cominciò con una palla di cencio da pochi soldi; un giorno Dino, ch’era uno dei primi ad arrivare, e uno dei più appassionati al gioco, ed anche uno dei più capaci, apparve con una grossa palla fatta di giornali, più ottagonale che sferica, legata stretta con uno spago: durò alcuni giorni, stracciandosi via via.
Fu poi la volta di una palla di gomma multicolore che Rossini aveva trafugata a qualche ragazzo del Giardino Pubblico, ma balzava troppo e finì col bucarsi rimanendo infissa nella cancellata del monumento; finché mi riuscì di comperare un pallone numero tre, una camera d’aria, che solo io so come l’ottenni. Ma il pallone complicò le cose, attirò alcuni giovanotti che lavoravano in una tipografia vicina, i quali fino ad allora avevano aspettato la sirena bivaccando sulle panchine, cosicché giocavano loro soltanto, di prepotenza.
Tornammo alla palla fatta di giornali che Dino rinnovava meravigliosamente.
All’una dopo mezzogiorno si cominciava la partita, dividendoci in due squadre; come altri sopraggiungevano «tu con loro, tu con noi», le file si ingrossavano. Suonate le due, chi in fabbrica, chi a bottega, chi chissà dove, le file si assottigliavano di nuovo. Erano partite furiose, frammezzate da litigi e calci negli stinchi di ragazzi di dodici, di quattordici, di sedici anni.
Vasco Pratolini, Diario sentimentale, Bur cencio: straccio, pezza.
Giocavo a nascondino
Con molta serietà ci mettevamo in cerchio per la stanza da pranzo e tiravamo a sorte quello che doveva star sotto.
Se capitava a una bambina, faceva il muso e se ne andava borbottando a mettersi in un angolo, col viso rivolto al muro, con gli occhi chiusi per non vedere; se era un maschio, faceva il disinvolto e il sicuro di sé.
Dopo esserci assicurati che quello sotto non poteva vederci, partivamo in punta di piedi, in gruppi di due, di tre, per nasconderci: ed era una ricerca muta e nervosa di un nascondiglio impossibile.
Bisognava trovar presto e bene; avere astuzia e fantasia.
C’era il giocatore egoista che, trovato il nascondiglio per sé, ne cacciava gli altri, col pretesto che facevano rumore e che, altrimenti, l’avrebbero scoperto subito; c’era il giocatore immaginoso, che si ficcava negli armadi, fra i materassi, senza respirare, sorridendo; c’era il giocatore incerto che girava tutta la casa, senza trovare un cantuccio soddisfacente e c’era quello sciocco che si ficcava stupidamente sotto il letto. Quando tutti erano nascosti, si sentiva un grido di lontano: «Vieni!».
Allora quello di sotto si muoveva con precauzione, non allontanandosi troppo dal suo posto, guardando a destra e a sinistra, camminando a piccoli passi.
I nostri cuori palpitavano nei nascondigli; dove eravamo nascosti in due, l’uno diceva all’altro:
«No, non ci trova; è troppo scemo».

Che tipo di giocatore sei tu? Egoista, immaginoso o incerto?
Ti piace giocare a nascondino?
Quando ti capita di fare questo gioco? Racconta.
Il gioco
«Perché mi hai fatto tanto spaventare, signorina Pollyanna?» chiese Nancy ansimando, dopo che era arrivata ai piedi dello sperone di roccia dove la bimba era appena ridiscesa con evidente rincrescimento.
«Ti ho fatto spaventare? Oh, mi dispiace; ma non devi mai preoccuparti per me, Nancy. Anche papà e le signore dell’Assistenza si preoccupavano, finché si sono rassegnati. Tanto finivo per tornare sempre a casa senza un graffio».
«Ma non sapevo nemmeno che fossi uscita» disse Nancy, prendendo la ragazzina sottobraccio e correndo giù per il pendio. «Non ti ho visto uscire. Nessuno ti ha vista. Scommetto che te ne sei andata per il tetto».
Pollyanna saltellò soddisfatta. «È proprio quello che ho fatto. Solo che invece di salire sopra il tetto, sono scesa dall’albero».
Nancy s’arrestò di colpo. «Che cosa hai fatto?».
«Sono uscita dalla finestra e poi mi sono lasciata scivolare lungo i rami dell’albero».
«Benedetti numi!» disse Narcy quasi senza fiato, riprendendo la corsa. «Vorrei sapere quello che tua zia avrà da dire su questo!».
«Davvero? Bene, allora glielo dirò, così lo saprai» rispose Pollyanna con allegro candore.
«Per amor del cielo!» disse Narcy terrorizzata. «No, no!».
«Vuoi dire che si arrabbierebbe?» domandò Pollyanna chiaramente preoccupata.
«No… anzi, sì… beh, lasciamo perdere. Non m’importa sapere che cosa direbbe» disse Narcy borbottando, decisa a evitare a Pollyanna una sgridata, se non di peggio. «Ma è meglio che ci sbrighiamo; ho ancora tutti i piatti da lavare!».
«Ti aiuterò io» le promise immediatamente Pollyanna.
«Oh, signorina Pollyanna!» esclamò Nancy esitante.
Per un po’ procedettero in silenzio; il cielo si stava oscurando rapidamente e Pollyanna strinse più forte il braccio della sua amica. «Sono contenta, dopo tutto, di averti fatto stare in pensiero; perché così sei venuta a cercarmi» disse con un brivido.
«Povero uccellino! Devi anche aver fame; io… io temo che dovrai mangiare pane e latte in cucina con me. Tua zia vuole così perché non sei stata puntuale per la cena, capisci?».
«Ma non potevo. Ero lassù».
«Sì, d’accordo, ma lei non lo sapeva» disse Nancy. «E mi dispiace per il pane e latte, proprio davvero».
«Ma a me non dispiace per niente, sono contenta».
«Contenta? E perché?».
«Perché il pane e il latte mi piacciono, e perché così potrò mangiare con te, in cucina».
«Sembra che tu non faccia fatica a essere contenta di tutto» disse Narcy con una certa ironia, ancora scossa al ricordo del coraggioso sforzo di Pollyanna nell’accettare di buon grado la squallida stanza nel sottotetto.
Pollyanna abbozzò un sorriso. «Beh, comunque fa parte del gioco».
«Del… gioco?».
«Sì, il gioco del “sii sempre contento”».
«Di che cosa diavolo stai parlando?».
«Ma è un gioco! Me l’ha insegnato papà ed è molto carino» aggiunse Pollyanna. «L’abbiamo sempre giocato insieme, fin da quando ero piccola piccola. L’ho anche insegnato alle signore dell’Assistenza e qualcuna di loro ha persino provato a giocarlo».
«Com’è questo gioco? Non me ne intendo molto di giochi, io».
Pollyanna rise ancora, ma poi sospirò. Alla ormai tenue luce del crepuscolo il suo piccolo viso apparve affilato e pensieroso. «Beh, abbiamo cominciato quella volta che alla missione sono arrivate un mucchio di stampelle».
«Stampelle?».
«Sì. Vedi, io desideravo tanto una bambola e papà l’aveva anche scritto, ma quando le signore dell’Assistenza inviarono un po’ di roba alla missione, risposero che non avevano ricevuto nessuna bambola, ma diverse stampelle. Aggiunsero che ce le mandavano perché potevano sempre riuscire utili, prima o poi. Ed è stato allora che abbiamo iniziato per la prima volta a far questo gioco».
«Non vedo che cosa ci sia di divertente» disse Nancy quasi irritata.
«Ma sì, il gioco consiste proprio nel trovare in qualsiasi situazione qualcosa di cui potersi rallegrare; non importa che cosa» soggiunse candidamente Pollyanna. «E noi cominciammo proprio dalle stampelle».
«Ma benedetto il cielo! Non vedo come si possa essere contenti di ricevere un paio di stampelle quando si desidera una bambola!».
«E invece, una ragione c’è» disse Pollyanna. «Anch’io in principio non riuscivo a capirlo» aggiunse in uno slancio di sincerità. «Papà me l’ha dovuto spiegare».
«Bé, allora potresti spiegarlo anche a me» disse Nancy un po’ sarcastica.
«Ma è semplice! Tanto per cominciare puoi essere contenta di non aver bisogno delle stampelle» spiegò Pollyanna trionfante. «Come vedi, è molto facile, una volta che hai capito il meccanismo».
«Sì, sì, fra le tante cose strane ci sarà anche questa» ammise Nancy con scarsa convinzione.
«Non è strano, è bello» insistette Pollyanna con fervore. «Da allora, abbiamo sempre continuato a far questo gioco. E più era difficile, più era divertente!
Solo… solo… che qualche volta è troppo difficile, come quando papà se ne va in cielo e non ti restano che le signore dell’Assistenza».
«O come quando sei cacciata in un buco di stanza, con niente dentro, in cima alla casa» disse Narcy con rabbia.
Pollyanna sospirò. «Sì, anche in quel momento è stato difficile» ammise. «Soprattutto perché mi sentivo così sola e non avevo nessuna voglia di fare il gioco: desideravo proprio essere circondata da molte belle cose! Ma poi mi è venuto in mente quando odio guardarmi allo specchio e vedere tutte le lentiggini che ho, e mi sono sentita contenta che non ce ne fosse neanche uno. E per finire ho visto lo splendido panorama fuori dalla finestra, e ho capito che c’era proprio di che essere contenti. Vedi, quando ti capita qualcosa che ti fa dispiacere, come trovarti un paio di stampelle al posto di una bambola, pensi subito a cosa servono le stampelle, e allora ti ricordi che hai due gambe sane e robuste che ti permettono di correre e di salire sugli alberi: così dimentichi il resto».
«Uff!» sbottò Nancy, cercando di mandar giù il groppo che aveva in gola.
Eleanor H. Porter, Pollyanna, De Agostini
fervore: passione, entusiasmo.
Le clic-clac
Quell’estate aveva poi portato una voga che aveva contagiato tutti i ragazzi dai sette ai quattordici anni: quella delle Palline clic-clac. Si trattava di due sfere in plastica dura (disponibili in tutti i colori) congiunte da una cordicella attraverso una linguetta di plastica. Afferrata la linguetta tra pollice e indice, con un movimento del polso si incominciava a far sbattere tra loro le palline sopra e sotto la mano tesa con una serie di colpi che producevano una raffica di suoni, motivo di disperazione per chiunque ne fosse raggiunto nell’ora della siesta. I ragazzi ne erano invece orgogliosi: più lunga la raffica, più alto l’onore. In questa attività Chicco, è quasi superfluo dirlo, non aveva rivali. Dal porto e dalla collina, i ragazzi del paese convergevano alle Quattro Strade dove lui, magnanimo, volentieri dava prova della sua abilità. Nella sua mano le clic-clac ballavano e si scatenavano in raffiche frenetiche e incomparabili. Oltre che re, Chicco era dunque un campione.
Anzi, il campione.
Forse la sua abilità era tutta nella mano, forse nel polso: nessuno lo sapeva. Chicco aveva custodito il segreto alla perfezione.
L’unico, a dir la verità, che fosse mai riuscito a custodire in vita sua.
Mario Schiani, La banda delle quattro strade, Salani

Calciatori in gabbia
Alcuni fuoriclasse del calcio sono atleti naturali: possiedono forza, velocità, resistenza a livelli così elevati da far immaginare che, se invece che al calcio si fossero dedicati per esempio al decathlon o ai 400 ostacoli, avrebbero comunque primeggiato. Cristiano Ronaldo o Gareth Bale fanno parte di questa categoria.
Altri campioni non hanno doti atletiche così evidenti. Messi e Maradona, assieme a Pelé i più forti calciatori di sempre, non raggiungono il metro e settanta di statura e certo avrebbero difficoltà a far parte di una staffetta olimpica.
Ciò che fa di loro dei calciatori unici è la tecnica, la capacità di immaginare in pochi centesimi di secondo la sequenza di movimenti più adatta per ogni situazione, e di eseguirla con precisione assoluta a una velocità tale da prevenire la reazione dell’avversario (nelle parole di Andrés Iniesta: «Io e Messi facciamo le stesse cose, ma lui le fa al doppio della mia velocità»).
Si tratta di doti in gran parte innate, che l’allenamento può soltanto affinare, ma non creare da zero. Tuttavia esistono metodi che aiutano i calciatori a migliorare, entro certi limiti, le loro qualità tecniche.
Alcuni club di alto livello posseggono per esempio una speciale gabbia, al cui interno si piazza l’atleta. Lungo il perimetro della gabbia ci sono cannoni che sparano il pallone verso il centro. Nello stesso istante in cui il pallone viene sparato, uno dei 64 riquadri che formano la gabbia si illumina.
Il giocatore non sa da quale parte e a quale altezza, arriverà il pallone. Quando sente il rumore del cannone deve girarsi, controllarlo e calciarlo nel minore tempo possibile verso il riquadro illuminato.
I cannoni e i riquadri sono controllati da un software che cronometra anche i tempi di esecuzione e trasmette i risultati a uno smartphone.
La gabbia costituisce un simulatore di una tipica situazione di gioco: l’atleta riceve il pallone, lo controlla, individua il compagno libero (o la porta) e tira.
Il vantaggio del simulatore è che la situazione viene ripetuta decine di volte di seguito, in condizioni studiate appositamente per migliorare la velocità di reazione e di esecuzione del giocatore.
Nunzio Lanotte, Sophie Lem, Sportivi ad alta tecnologia. La scienza che aiuta a costruire i campioni, Zanichelli
Citius, Altius, Fortius
Arrivò stremato sull’Acropoli il povero Filippide: aveva percorso correndo la strada che separava Atene dalla città di Maratona per annunciare ai suoi concittadini che l’esercito ateniese aveva battuto quello persiano. Era il 490 a.C. e le notizie arrivavano “a piedi”. Si narra che il povero soldato ebbe appena il tempo di dire «Ateniesi, abbiamo vinto!» e poi si accasciò al suolo, sconfitto dalla fatica. Nel 1960 le Olimpiadi si svolgono nella cornice suggestiva della Città Eterna: Roma. I maratoneti partono dal Campidoglio, e sfiorano i monumenti più importanti. Sono tanti.
La folla, assiepata ai bordi delle strade, incita e applaude tutti, russi, cinesi, inglesi. Fra tutti i partecipanti ce n’è uno che attira più degli altri l’attenzione, non perché sia famoso; anzi, quando si è iscritto alla corsa in pochi hanno notato il suo tempo di gara e quasi nessuno lo dà tra i favoriti.
È un etiope di 28 anni, è sposato, ha due figli, ha la pelle lucida e gli occhi profondi ed è scalzo. Abebe Bikila è figlio di un pastore e nel suo paese fa il poliziotto per mantenere la famiglia. Qualche giorno prima della partenza per Roma, alla squadra etiope viene a mancare per un infortunio uno dei suoi atleti Wami Biratu e Abebe si rirova a far parte della nazionale olimpica in sostituzione di Wami.
Poche ore prima della gara, Bikila decide in accordo con il suo allenatore, lo svedese Niskanen, di gareggiare scalzo, le scarpe fornite dallo sponsor sono scomode, meglio senza. Con indosso il numero 11 cerca l’avversario da battere, il 26, il marocchino Rhadi, che invece è partito con un altro numero. Anche Rhadi fa il poliziotto al suo paese, anche lui è di umili origini, crede di avere 30 anni, ma non ne è sicuro; quando lo raccolsero orfano e in fasce dopo che il suo villaggio era andato distrutto, nessuno sapeva che età avesse. I due si confrontano per le vie di Roma dopo aver sfiorato in gruppo con altri atleti il Colosseo, il Circo Massimo… Un corpo a corpo non violento, scandito dal ritmo dei passi sempre uguali dei maratoneti che attraversano la città, passano per l’Appia antica e, solo quando ormai è sera, si dirigono verso il traguardo sotto l’arco di Costantino. Al ventesimo chilometro sono rimasti in due, Rhadi e Abebe, entrambi africani, entrambi soldati. Al trentesimo, Rhadi si arrende ad Abebe che sorpassa l’avversario e si mette in testa alla gara, anche se staccato di poco, ma è difficile sostenere quel ritmo sempre uguale; Abebe non ha mai cambiato passo, non ha mai ceduto né cede. A un chilometro dal traguardo, Rhadi cede definitivamente il primo posto all’etiope, che si avvia a vincere la medaglia d’oro. La straordinaria forza d’animo di quest’uomo si manifesta ancora quattro anni dopo, quando si presenta alle Olimpiadi di Tokyo dopo un’operazione chirurgica che gli ha impedito di allenarsi come dovuto, ma non gli impedisce di vincere
ancora, di essere il primo campione olimpico a fregiarsi del titolo di vincitore per due volte consecutive e di stabilire il record mondiale sulla distanza. Durante la sua carriera partecipò a 14 gare vincendone 12, fino al 1969, quando un incidente lo paralizzò dal torace in giù.
Non smise mai comunque di praticare sport e di allenarsi e gareggiare in altre discipline, dal tiro con l’arco al ping pong, alle paraolimpiadi.
Muore a 41 anni per emorragia cerebrale, e lo stadio di Addis Abeba gli viene intitolato. A pochi come a lui calzano le parole che sono il motto Olimpico: Citius, Altius, Fortius. Più veloce, più alto, più forte.
Una nuova amica
Il giorno in cui entrai in quarta – ero ormai sui dieci anni – il posto accanto al mio era occupato da una bambina nuova: una brunetta dai capelli corti. Aspettando la signorina, e alla fine della lezione, parlammo. Si chiamava Elizabeth Mabille, e aveva la mia età. I suoi studi, cominciati in famiglia, erano stati interrotti da un grave incidente: in campagna, mentre stavano cuocendo delle patate, le si era appiccato il fuoco all’abito; aveva riportato un’ustione di terzo grado alla coscia che l’aveva fatta urlare per notti e notti. Era dovuta restare a letto per un anno intero; sotto la gonna pieghettata, la carne era ancora tutta raggrinzita. A me non era mai accaduto nulla di così importante. La mia nuova compagna mi parve subito un personaggio. Il suo modo di parlare con le insegnanti mi sbalordì; la sua naturalezza contrastava con la voce stereotipata delle altre compagne. Nella settimana che seguì mi conquistò totalmente: scimmiottava in modo meraviglioso la signorina Bodet, e tutto quello che diceva era interessante o strano. Nonostante le lacune dovute al suo ozio forzato, Elizabeth si piazzò ben pre -
sto tra le prime della classe; in componimento io la battevo di misura. L’emulazione che sorse tra noi piacque alle insegnanti, che incoraggiarono la nostra amicizia. Al saggio ricreativo che aveva luogo ogni anno verso Natale, ci fecero recitare insieme un dialogo. Con un vestito rosa, il viso incorniciato di riccioli, io impersonavo Madame de Sévigné bambina; Elizabeth faceva la parte di un suo giovane e irrequieto cugino; il costume da ragazzo le si addiceva, e il pubblico rimase incantato dalla sua vivacità e disinvoltura. Il lavoro delle prove, e il nostro colloquio sotto le luci della ribalta, rinsaldarono ancor di più i nostri legami; ormai ci chiamavano “le due inseparabili”.
Elizabeth ed io fummo autorizzate ad andare a giocare l’una in casa dell’altra. La prima volta che andai in rue de Varennes mia sorella mi accompagnò, e restammo tutt’e due sgomente. Elizabeth – che nell’intimità era chiamata Zazà – aveva una sorella e un fratello più grandi, e sei tra fratelli e sorelle, più piccoli di lei, oltre una moltitudine di cugini e di piccoli amici. Correvano, saltavano, si picchiavano, si arrampicavano sui tavoli, rovesciavano i mobili, gridando.
Alla fine del pomeriggio, la signora Mabille entrava nel salotto, rimetteva in piedi una sedia, asciugava sorridendo una fronte sudata; io mi stupivo della sua indifferenza ai bernoccoli, alle macchie, ai piatti rotti: non si arrabbiava mai. Non mi piacevano molto quei giochi forsennati, e spesso anche Zazà se ne stancava.
Andavamo a rifugiarci nello studio del signor Mabille, e, lontane dal tumulto, ci mettevamo a parlare. Era un piacere tutto nuovo. I miei genitori mi parlavano, e io parlavo loro, ma non conversavamo; tra la mia sorella e me non c’era la distanza necessaria per una scambio. Con Zazà facevo vere conversazioni, come papà con la mamma, la sera. Parlavamo dei nostri studi, delle letture, delle compagne, dei professori, di ciò che sapevamo del mondo: mai di noi stesse. A Zazà piacevano i libri al pari di me; in più, essa era dotata di una quantità di capacità che a me mancavano. Un anno, durante un saggio di pianoforte, si permise un’audacia che rasentò lo scandalo. La sala era gremita. Nelle prime file, le allieve agghindate nei loro più bei vestiti, arricciate, ondulate, con nastri nei capelli, aspettavano il momento di esibirsi. Dietro di loro erano sedute le professoresse e le sorveglianti, in blusa di seta e in guanti bianchi. Più indietro sedevano i genitori e i loro invitati. Zazà, vestita di taffetà azzurro, suonò un pezzo che sua madre giudicava troppo difficile per lei, che di solito ne massacrava qualche parte; questa volta lo eseguì senza sbagli, dopodiché, gettando alla madre un’occhiata trionfante, le mostrò la lingua. Le bambine fremettero sotto i loro boccoli, e la faccia di quelle signorine si irrigidì di riprovazione; ma quando Zazà scese dal palco, la mamma la baciò con tanta gaiezza che nessuno osò rimproverarla. Ai miei occhi quest’episodio la circonfuse di gloria.
Simone de Beauvoir, Memorie di una ragazza perbene, Einaudi
Un pranzo movimentato
Un giorno trovai nel muro un grasso scorpione femmina, con indosso quello che a prima vista sembrava un mantello di pelliccia color fulvo pallido. A un esame più attento mi accorsi che quello strano manto era formato da una massa di minuscoli piccoli aggrappati al dorso della madre. Estasiato da questa famiglia, decisi di portarmeli tutti a casa di nascosto e di tenerli in camera mia per vederli crescere. Con cura infinita riuscii a introdurre madre e figliolanza in una scatola di fiammiferi, e poi corsi a casa. Disgraziatamente, proprio mentre varcavo la soglia, fu portato il pranzo in tavola; sicché posai con grande cura la scatolina sulla mensola del camino nel salotto,in modo che gli scorpioni avessero tutta l’aria che volevano, e me ne andai in sala da pranzo a raggiungere gli altri. Giocherellando con la roba che avevo nel piatto, allungando di nascosto bocconcini a Roger sotto il tavolo e ascoltando i discorsi degli altri, mi dimenticai completamente dei miei nuovi ed eccitanti prigionieri. Infine Larry, finito di mangiare, andò in salotto a prendere le sigarette e abbandonandosi rilassato sulla poltrona se ne mise una tra le labbra e si accinse ad aprire la scatola dei fiammiferi che aveva presa di là. Immemore del funesto destino che mi sovrastava, io lo guardavo tutto interessato mentre lui, continuando a parlare in tono disinvolto, apriva la scatola.
Sostengo ancora oggi che lo scorpione femmina non aveva cattive intenzioni. Era agitata e un po’ seccata di stare richiusa da tanto tempo in una scatola di fiammiferi, e così colse la prima occasione per darsi alla fuga. Scavalcò rapi-
damente il bordo della scatola, con i suoi piccoli aggrappati forte su di lei, e sgambettò sul dorso della mano di Larry. Qui, non molto sicura della prossima mossa, si fermò, col pungiglione ricurvo all’insù in posizione di allerta. Larry, sentendo il movimento delle sue chele, abbassò gli occhi, e da quel momento le cose precipitarono in un gran bailamme. Lui ruggì di terrore, al che Lugaretzia si lasciò scappare un piatto dalle mani e Roger uscì di sotto il tavolo, abbaiando come un forsennato. Con uno scatto della mano, Larry fece volare lo sventurato scorpione sul tavolo, e quello cadde a mezza strada tra Lessie e Margo, disseminando bambini come coriandoli mentre atterrava sulla tovaglia. Addirittura furiosa per questo trattamento, la bestiola si diresse veloce verso Leslie, la nostra ospite, col pungiglione tremante di sdegno. Leslie balzò in piedi, rovesciando la sedia, e sventolò disperatamente il tovagliolo, facendo rotolare lo scorpione lungo la tovaglia verso Margo, che immediatamente gettò un urlo che qualunque locomotiva sarebbe stata orgogliosa di saper imitare. Mamma, completamente sconcertata da questo improvviso e rapido passaggio dalla pace al caos, si mise gli occhiali e scrutò il tavolo per vedere che cosa avesse suscitato quel pandemonio, e in quel momento Margo, in un vano tentativo di fermare l’avanzata dello scorpione, gli scagliò addosso un bicchiere d’acqua. La doccia fallì l’obiettivo, ma prese in pieno mamma, che non potendo soffrire l’acqua fredda perse subito il fiato e se ne rimase ansimante in fondo al tavolo, incapace persino di protestare. A colpi di piatto Leslie aveva scaraventato lo scorpione sul pavimento, mentre i piccoli sciamavano freneticamente sulla tovaglia. Roger, disorientato dal panico ma deciso a parteciparvi, correva torno torno la stanza, abbaiando come un matto.
«È sempre quella peste di ragazzo…» ruggiva Larry.
«Ci vuole un libro!» urlava Leslie. «Non spaventarti, colpisci con un libro!».
«Ma si può sapere che diavolo vi prende a tutti quanti?» continuava a implorare mamma, asciugandosi gli occhiali.
«È quella peste di ragazzo… ci ammazzerà tutti… Guarda il tavolo… formicola di scorpioni…».
«Presto… presto… fa’ qualcosa. Attento! Attento!».
«Santo cielo, smettila di strillare e prendi un libro… Sei peggio del cane… Zitto, Roger…».
«È un miracolo che non mi abbia punto…».
«Attento… ce n’è un altro… presto… presto…».
«Oh, piantala di gridare e dammi un libro o qualche cosa».
«Ma come hanno fatto gli scorpioni ad arrivare sul tavolo, caro?».
«Quella peste di ragazzo… In questa casa ogni scatola di fiammiferi è un’insidia mortale…».
«Attento, sta venendo verso di me… presto, presto, fa’ qualcosa».
«Colpiscilo col coltello… col coltello… forza, colpiscilo…».
Poiché nessuno si era preso la briga di spiegargli la situazione, Roger era erroneamente convinto che la famiglia fosse stata aggredita e che lui aveva il dovere di difenderla. Visto che nella stanza l’unica persona estranea era Lugaretzia, lui arrivò alla logica conclusione che la responsabile doveva essere lei, e le morse una caviglia. Questo non migliorò molto le cose. Intanto si era ristabilito un certo ordine, tutti i piccoli scorpioni si erano nascosti sotto i vari piatti e stoviglie. Finalmente, dopo le mie suppliche veementi, sostenute da mamma, la proposta di Leslie che bisognava massacrarli tutti fu bocciata. Mentre tutti quanti, ancora frementi di sdegno e di paura, si ritiravano in salotto, io passai mezz’ora a radunare i piccoli, a raccoglierli con un cucchiaino da tè e a rimetterli sul dorso della madre. Poi li portai fuori in un piattino e con immensa riluttanza li lasciai liberi sul muro del giardino. Roger e io andammo a passare il pomeriggio sulla collina, perché mi parve prudente lasciare che la famiglia si riposasse un po’ prima di rivedermi.
Gerard Durrell, La mia famiglia e altri animali, Adelphi bailamme: confusione di gente che va e che viene, frastuono di voci.
• Racconta di quella volta in cui tu o un membro della tua famiglia l’ha combinata proprio grossa.
• Sottolinea tutti i vocaboli e le espressioni che evidenziano suoni e rumori.
Parlatemi di vostra madre
Parlatemi di vostra madre. Vi ascolto.
Parlatemi soltanto delle cose più semplici, quelle che fa ogni madre, come rimboccarvi le lenzuola, per esempio, e darvi l’ultimo bacio della sera.
Parlatemi di quando vi rimproverava, severa, per un vostro capriccio.
Di quando vi riempiva le orecchie e gli occhi di sapone.
Di certo ricordate un mucchio di cose.
Ricordate la sua voce dolce, morbida, calda.
Parlatemi di vostra madre quando vi dava uno scapaccione ogni tanto.
Una tirata d’orecchie.
Quando vi vestiva. Quando vi diceva: – Non bere, non correre, non prender freddo, non sudare.
Di tutte queste cose potete parlare. Io vi ascolto.
Carlo Manzoni, Per favore, regalatemi un ricordo, «Annabella» 20 (1967)
Pomeriggi con la mamma
Mi rivedo accanto alla mamma nei pomeriggi d’inverno, quando calava presto la notte; eravamo seduti a una stessa tavola, sotto la luce quieta del globo di vetro appeso al soffitto. Lei, tutta rinvoltolata in uno scialle di lana, cuciva con l’ago; io appiccicavo sopra un foglio grandi farfalle azzurre, piccoli cammelli colar sabbia o strane bambine danzanti con la gonna rossa. In casa non c’era nessuno al di fuori di noi due, soli soli, vicini vicini, al riparo dal freddo, dal vento e dal buio. Io mi sentivo calmo e sicuro sotto la protezione della luce calma e discreta della lampada e degli occhi lucenti e potenti della mamma.
Giovanni Papini, La felicità dell’infelice, Vallecchi
«Parlami di tua madre». Descrivi le sue caratteristiche fisiche, i suoi interessi, le azioni che è solita compiere, soffermandoti su ciò che ti colpisce di lei.
Questa storia
Per infinite volte, da grande, avrebbe rivisto quella immagine, proprio quella: la sagoma massiccia del padre che cammina a grandi passi davanti a lui, contro il volo della nebbia mattutina, senza mai voltarsi, né per aspettarlo né per controllare che ci fosse ancora. In quella severità, e in quella assenza totale di dubbi, vi era quanto suo padre gli aveva insegnato dell’essere padri: che è saper camminare, senza mai voltarsi. Camminare il passo lungo degli adulti, senza pietà, ma un passo limpido e regolare, perché tuo figlio possa capirlo e starci attaccato, nonostante il suo passo bambino. E farlo senza mai voltarsi, se ne avrai la forza: perché lui sappia che non si perderà, e che camminare insieme è un destino di cui non bisogna mai dubitare, giacché è scritto nella terra.
Alessandro Baricco, Questa storia, Feltrinelli

Un’avventura finita bene
Mi piacevano i giochi rischiosi.
Una mattina mi ero arrampicata come una scimmia in cima a un albero da frutto di quelli che erano sparsi qua e là sul “greppo”, una specie di pendio che fronteggiava la casa.
Avrò avuto dieci anni.
Mi ero spinta talmente in alto che si ruppe un ramo ed io, miracolosamente, restai appesa per le braccia e scivolai fino a un ramo più basso; poi però mi venne il panico con relativa tremarella. Non sapevo più scendere.
Venne l’ora del pranzo e qualcuno dei miei fratelli mi chiamò a tavola. Ma come avrei potuto fare ad andarci?
Quand’ecco arrivare lemme lemme papà. Io mi sentii morire; era proprio l’ultima persona che desideravo come soccorritore, perché a me bambina sembrava talmente incapace di risolvere un problema di ordine pratico.
Papà fece finta di niente e instaurò una conversazione generica, come se fossimo stati due vecchi amici intenti a prendere il tè in un salotto.
Dovette capire che qualcosa non andava per il suo verso e si offrì di aiutarmi. Io rifiutai protestando che non avevo bisogno di aiuto.
A questo punto assistetti alla più comica scenetta che ho avuto la fortuna di ammirare nel corso della mia vita. Perché papà si mise a raccontarmi, mimandone la varie fasi, la sua vita militare per dimostrarmi con i fatti che aveva delle doti atletiche nascoste.
Mi fece ridere talmente che mi decisi a scendere di un paio di rami. Così arrivai all’altezza delle sue braccia alzate e so che mi tenne ferma per una caviglia mentre io mi sporgevo con l’altro piede, ancora un po’ titubante, alla ricerca di un ramo più basso. Ridendo fino alle lacrime, e piuttosto rinfrancata, scesi finalmente dall’albero traditore.
Da quel giorno mio padre salì nella mia stima a dismisura anche perché, senza il suo intervento, sarei ancora lassù.
Maria
Racconta di quella volta in cui hai avuto bisogno di un adulto: dove ti trovavi?
Che cosa era successo? Qual era l’ostacolo che ti metteva in difficoltà? Chi è giunto in tuo aiuto?
Nonno Tino
Eccomi qui: sono mezzo intontito e un po’ affamato. Dopo due ore di macchina, normalmente mi sdraierei sul divano, ma non ora. Scendo dalla macchina, entro in casa e… ed ecco mio nonno. Mi viene incontro strafelice di vedermi, ed anche io lo sono: dopo un paio di settimane o addirittura un mese, rivedo quell’energico contadino. Non sono a casa mia, a Milano, ma nel mantovano, a casa di mio nonno. Appena arrivato, vengo abbracciato da quelle enormi mani, spesso con qualche taglio o livido. Mio nonno è l’uomo più energico che conosca: lavora, zappa, semina come un allegro giovanotto, ma ha appena compiuto ottant’anni. Da quel che ho scritto si dovrebbe già capire che di lavoro fa il contadino. Il nonno Tino è un uomo non troppo alto, ma molto robusto e forte. Ha il fisico del lavoratore. Ma la sua forza non è solo fisica: vive la vita più bella e più brutta che si possa vivere. Vive in mezzo alla campagna, in una fattoria meravigliosa, ma ha un peso durissimo da sostenere, un peso, un peso che io non potrei sopportare. La nonna Mary, sua moglie, è malata di Parkinson e parzialmente di Alzheimer. Per questo la sua non è solo una forza fisica: è lui che deve restare sveglio fino a tardi, finché la nonna non finisce le sue “scenate”. Addirittura, molte volte la nonna lo tratta malissimo, ovviamente senza volerlo, e lui è sempre lì, ad aiutarla e a prendersi cura di lei. Non l’ho mai sentito lamentarsi. Certo, è struggente che la persona a cui tieni di più sia ridotta in questo stato, ed è un tormento vivere in questa situazione, ma lui non si è mai tirato indietro. Lui, e con lui anche io, viviamo tra due fuochi a Mantova: la bellezza di un posto così, della fattoria e della campagna, e la tristezza per la nonna. Con me, il nonno Tino è sempre gentile e buono, ma non come i nonni che viziano i loro nipoti, più come una persona che vuole la tua felicità, ma davvero. Come me, sa cosa vuol dire sopportare un fratello più grande e una sorella più piccola, perché anche lui è il secondo di tre figli. Una cosa che mi ha sempre colpito di lui è il fatto che sa insegnarti cose bellissime su tutto quello che riguarda la fattoria e la campagna. Credo che nessun professore di agraria conosca più cose di mio nonno, che ha fatto solo le elementari. A dieci anni già lavorava. Se potessi scegliere farei anche io quella vita; l’ho sempre desiderato fin da bambino. La campagna è tutta la vita di mio nonno, e la mia passione: lì non ti annoi mai. Pescare, dare da mangiare agli animali, seminare i campi e zappare l’orto sono solo alcune delle infinite cose che si possono fare. Due sono le cose che identificano ai miei occhi mio nonno: le sue mani, come ho già scritto, e il suo sguardo. Le sue enormi mani secondo me non sentono il dolore. Quando gli domando cosa ha fatto per procurarsi quei tagli o quei lividi, lui risponde tutto tranquillo che si è tirato una martellata per sbaglio o che si è tagliato con qualche strano arnese. Il suo sguardo invece è straordinario. Il modo con cui ti guarda, con quegli occhi
meravigliosi che passano dal marrone all’azzurro verso l’esterno, ti svuota da qualsiasi preoccupazione. Ha uno sguardo sereno e felice, ma allo stesso tempo profondo e pensieroso. E poi è bellissimo sentirlo ridere. Ha una risata un po’ pastosa, ma genuina come quella di un bambino. Già, mio nonno ha l’energia e la serenità di un bambino, e la tenacia e la conoscenza del più saggio degli adulti. Lo si può definire un arzillo vecchietto. In realtà, le uniche cose che denotano la sua età sono le rughe e i capelli, perché il corpo robusto e l’indole energica tradiscono e mascherano i suoi anni. Sono sicuro che Agostino, da me comunemente chiamato nonno Tino, sia il miglior nonno che mi potesse capitare, perché non esiste un altro uomo che mi faccia sentire così, veramente felice.
Descrivi una persona cara: parla del rapporto che hai con lei, racconta un episodio vissuto insieme.
Nonno usa WhatsApp
Questo brano contiene un’espressione che si ripete. Cercala e leggi il brano a voce alta dando l’intonazione adeguata rispetto al senso.
In onore dei settant’anni del nonno, in famiglia si decide di regalargli uno smarthphone.
I nipotini, appena scartato il regalo, gli dicono: «Nonno, usa WhatsApp, è una cosa stupenda!».
E lui risponde: «Nonno, usa WhatsApp… ma cusa l’è WhatsApp?».
I ragazzi cercano di spiegarglielo ma niente, il nonno sembra non riesca proprio a capire.
Passano i giorni e la vita famigliare procede tranquilla.
La nonna, però, sembra essere preoccupata di qualcosa: il nonno passa sempre più tempo da solo con il suo nuovo cellulare in mano.
Un giorno al nipote più giovane arriva un messaggino WhatsApp che dice: «Finalmente ci sono anch’io. Il nonno!».
Lui, pieno di stupore, corre a tavola, dove è radunata la famiglia, e urla: «È arrivato un messaggio dal nonno da WhatsApp! Il nonno usa WhatsApp!».
La sorella più grande, allibita e quasi sdegnata, dice: «Nonno usa WhatsApp???
Ma è una cosa da giovani!!!».
Tutta la famiglia ride divertita, ma non immagina cosa l’aspetti. Il nonno, infatti, inizia a creare gruppi su gruppi e chat su chat.
Tutte le volte che arriva un messaggino, tutti si guardano e, rassegnati, pensano: «Nonno usa WhatsApp».
Allora i familiari provano in tutti i modi a disinstallare l’applicazione al nonno, ma ne escono a testa bassa e non possono far altro che dire: «Nonno usa WhatsApp!».
La casa dei suoni
La nostra casa era piena di strumenti (c’erano perfino due pianoforti!), di allievi della mamma, che insegnava il pianoforte, e di amici del papà che suonavano con lui.
Avevo sette anni quando andai per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano. Quando mi sono affacciato al parapetto del loggione, che è la fila di posti più vicina al soffitto, ho visto, dall’alto, piccolissimi e lontani, tanti musicisti come nel sogno, ed un uomo che, agitando il suo ditino, scatenava suoni meravigliosi. Si trattava dei «Notturni» di Debussy, un musicista nato nella seconda metà dell’Ottocento, che sembra quasi dipingere luci e colori con la sua musica, ed in particolare mi colpì la musica del secondo notturno, Feste, con un suono di trombe che arriva in crescendo da lontanissimo come una magia.
Arrivato a casa, ho chiesto chi fosse quel piccolo omino che stava su una pedana rossa, e sembrava onnipotente: era un grande direttore d’orchestra, Antonio Guarnieri. Ho subito scritto nel mio diario che un giorno anch’io avrei diretto quella musica. Quando, molti anni dopo, ho avuto un figlio, ho provato a fargli ascoltare i Notturni che mi avevano impressionato quando avevo la sua età: il mio bambino ha spalancato gli occhi, come per il racconto di una favola, e il miracolo si è ripetuto, esattamente nello stesso momento musicale.
Quella serata fu per me importantissima; ero rimasto ammaliato dalla possibilità di suonare in tanti, insieme, e dalla importanza di quell’omino che li dirigeva come un filo conduttore. ll giorno dopo iniziai a studiare il pianoforte, per potere un giorno anche io fare musica insieme ad altri. Intanto, con rinnovata attenzione, ascoltavo le prove di mio padre, quando suonava con la mamma: era
una forma familiare di duo, speravo un giorno di essere in grado di sostituire la mamma al pianoforte, e di accompagnare io il papà. Una volta la mamma si ammalò, e il papà mi chiese di sedermi al pianoforte, e di provare a suonare insieme a lui. Ero emozionatissimo, e non mi sentivo affatto preparato. Cominciai a suonare, sentendomi orgoglioso di questo nuovo ruolo, ma le cose non andarono come avevo sperato: fu un vero disastro, perché era difficile seguire il violino del papà, e il papà era durissimo. Gridava, mi faceva suonare troppo in fretta, non mi lasciava smettere mai.
In realtà, suonare col papà è sempre stato così, per me, anche quando sono diventato più bravo: diventava giustamente esigentissimo, quando si trattava di musica, e la sua proverbiale pazienza lasciava posto a critiche impietose. La maggiore sorpresa, e il segreto più importante che mi ha lasciato, fu questa: fare musica con qualcuno non vuol dire tanto saper suonare quanto saper ascoltare. Egli mi ha insegnato che accompagnare un discorso musicale significa saperlo sentire attentamente, accettarlo, comprenderlo fin nei suoi angoli più misteriosi. Nella vita, come nella musica, è indispensabile sapere ascoltare gli altri, per poterli seguire. Ancora oggi, quando devo accompagnare un cantante o un solista con l’orchestra, mi ricordo di quel prezioso insegnamento. A volte due amici dei miei genitori venivano ad aggiungersi al violino del papà: Vidusso al pianoforte e Crepax al violoncello: così ho ascoltato per la prima volta un trio e ho capito che se si vuole suonare in tanti, bisogna sapersi ascoltare e cercare di “accordarsi” con gli altri.

Claudio Abbado è stato uno dei più importanti direttori d’orchestra. È nato a Milano nel 1933, da genitori anch’essi musicisti: suo padre era insegnante di violino al Conservatorio Giuseppe Verdi, sua madre era pianista. Ha diretto le più prestigiose orchestre del mondo, tra le quali la Scala di Milano, l’Orchestra Sinfonica di Londra, l’Orchestra Filarmonica di Vienna e l’Orchestra Filarmonica di Berlino.

Il mio universo
Quand’ero bambino, dalla mia montagna si vedeva il mare, in fondo in fondo, a ovest, bello, immenso, misterioso, con quelle sue mattine d’estate color blu di seta, i suoi mezzogiorni splendenti di luce e le sue notti screziate di stelle e di luna. Io pensavo che finisse all’orizzonte, là dove il sole calava in un trionfo di porpora e d’oro o si offuscava in un cumulo di nuvole che erano presagi di pioggia. Sotto di noi il mare bagnava una sottile striscia di costa distesa tra i lunghi agrumeti il cui profumo inebriante al momento della fioritura saliva fino a noi portato dalla brezza.
In realtà, noi eravamo troppo in alto per ricevere i profumi della pianura; ma dall’istante in cui mia madre iniziava a percepirli (e una felice emozione brillava nei suoi occhi) io non potevo che imitarla, annusando convinto, nella sua scia ai limiti della mia personale percezione.
Mia madre era mia madre ed io ero convinto che lei cogliesse, sentisse e vedesse una quantità di cose che per gli altri erano impercettibili. Per esempio, quando d’estate, alla sera, ci gustavamo lo splendore del cielo stellato, ero convinto che lei vedesse davvero l’interno del paradiso che mi descriveva. E mentre le ero rannicchiato accanto, lei faceva penetrare nel mio animo la presenza misteriosa ma così intensa di Dio, certo più con la dolcezza della sua voce che non con le sue parole.
Fu più tardi che seppi che gli aranci in fiore potevano dare profumo a certi ricordi particolarmente felici di mia mamma. Ed ancora molto più tardi compresi che si poteva davvero “sentire” mediante il ricordo. Il nostro lido (una parvenza di lido…), che era verde e castano in tutte le stagioni e cosparso di tetti rossi, di quando in quando si chiazzava di bianco sulle cime, dove le case (e questo lo imparai ancora più tardi) si ammassavano come greggi di pecore per formare delle città.
Appena oltre i frutteti si ergevano le montagne, ondulate in lontananza, verso il sud, e ancora più lontano, a nord; ma, ad Oriente, vedevo soltanto la curva boscosa della collina a strapiombo sul nostro villaggio ed ero convinto che lì finisse la terra.
Un giorno, appollaiato sulle spalle del mio geddo (nonno), mi arrampicai con lui fino alla sommità di questa collina e… con che sorpresa scoprii altre vallate e altre montagne, molto più profonde e impressionanti di quanto nessun mare potesse delimitare! Rimasi a lungo in loro contemplazione, rendendomi conto a poco a poco che – più in là di quel che i nostri occhi possono vedere – esistono altri mondi, mondi che sembrano raggiungere il cielo, a meno che non siano senza fine. Ma, allora, dove finisce la terra?
«Cos’è questo, cos’è tutto questo?» chiesi al mio geddo.
«Tutto questo è il nostro paese» mi rispose divertito dalla mia meraviglia. «Tutto questo è il Libano».
«Ma tutto quello che è là, dalla parte del mare, fa parte del nostro villaggio, no?».
«No – rispose il geddo – è Libano anche quello. Il nostro villaggio è soltanto là dove sono riunite le nostre case, la tua e quelle delle persone che conosci bene e che puoi incontrare tutti i giorni. Il nostro villaggio è solo una piccola briciola del nostro paese».
«E quelle case, laggiù e laggiù… e là in alto… e in basso, non sono dunque il nostro villaggio?» domandai puntando l’indice in tutte le direzioni.
«No» mi rispose il geddo. «Sono altri villaggi: ognuno ha un suo nome e tutti si trovano nel Libano».
«E il mare? Anche lui è il nostro paese?».
«No» disse il geddo. «Solo una sua piccola parte, quella vicino alla costa. Il mare ti porta in altri paesi e in altri mari; e, oltre le nostre montagne, ci sono altri paesi e altri mari».
«Ah!» feci io, ammirato per la grandezza e la diversità di un mondo che cominciavo appena a intravedere.
«Allora il nostro villaggio non è tutta la terra?»
«No, – disse il geddo – ma, nel nostro Paese, il nostro villaggio è terra di nostra proprietà».
«E cosa c’è oltre gli altri paesi e gli altri mari? È lì che comincia il cielo? Oppure è lì che finisce la terra? E, da qui, si può vedere un altro paese? E…».
Feci mille domande e il geddo mi spiegò tali e tante cose meravigliose che io finii col fare una gran confusione fra cielo e terra.
Ma quella sera, al momento di prender sonno, sentii che il mio villaggio mi abbracciava come faceva la mamma; per me, esso non era più qualcosa di impreciso, fluttuante tra l’orizzonte e le cime delle nostre montagne, i miei due confini del mondo. Si era singolarmente rimpicciolito mentre il mio universo era diventato infinito, ma aveva assunto forma e consistenza.
Io non ero che un piccolo ragazzo tra tanti altri e lui non era che un piccolo villaggio tra tanti altri. Ma anche lui, come me, aveva un nome, aveva, come me, il suo posto nell’universo, era amato, come me, e, come me, era vivo.
Ecco quello che il mio geddo mi fece capire lassù, sulla collina, nello stesso momento in cui mi insegnò che l’orizzonte non era mai la fine di qualcosa ma sempre l’inizio di «qualche altro luogo».
Mansour Labaky, Amici nonostante la guerra, Edizioni Paoline
VERSO IL CIELO
Sereno
Dopo tanta nebbia a una a una si svelano le stelle
Respiro il fresco che mi lascia il colore del cielo
Mi riconosco immagine passeggera
Presa in un giro immortale
Giuseppe Ungaretti
Ascoltiamo insieme
Notturno op. 9 n. 1 di Chopin
Questo brano di Chopin descrive la tranquillità e l’oscurità di un ambiente notturno.


Il cielo azzurro
Un giorno, quand’ero bambino, mi hanno portato a vedere il mare. Era la prima volta. Il cielo terso si specchiava nell’acqua profonda: azzurro sopra, azzurro sotto. Sarei rimasto a contemplare questo spettacolo per ore. Forse è quel giorno che sono diventato pittore.
Poi quell’azzurro l’ho rivisto nelle volte di tante chiese: ad Assisi, a Roma, nel mausoleo di Galla Placidia a Ravenna, nel Duomo di Padova. Io però l’ho voluto rendere ancora più intenso, facendo spendere tanti soldi allo sponsor Enrico Scrovegni, perché è un colore che si ottiene coi lapislazzuli, che sono pietre preziose. Ma io volevo che tutti coloro che sarebbero entrati in questa chiesetta di Padova, per prima cosa arrestassero lo sguardo e restassero senza respiro! Se uno non alza lo sguardo, è come un bicchiere girato in giù: è inutile versare da bere, perché scivola via tutto e io volevo versare questa storia, l’unica storia che placa la sete del cuore, in bicchieri pronti a farsene riempire fino all’orlo. Nel nostro cuore c’è un grande desiderio, e de-siderio vuol proprio dire sete di stelle (sidera in latino).
Per questo ho dipinto in un grande manto azzurro circa settecento stelle d’oro a otto punte. Poi, più grandi, più luminosi, altri otto astri: gli otto pianeti, che hanno il volto di otto profeti (mi sa proprio che anche il numero otto nasconde un segreto… sveliamolo subito: è il numero che indica la resurrezione di Gesù, come ho imparato da sant’Ambrogio). Dio ci ha messo nel cuore il desiderio della felicità, e i profeti hanno annunciato che un giorno quel cielo così bello e così lontano, sarebbe venuto giù a portarci la felicità. “Padre nostro che sei nei cieli” sarebbe venuto giù sulla terra! Infine, grandissimi, ho dipinto in comune corpi celesti più luminosi: la luna, cioè la Madonna con in braccio Gesù bambino, per
illuminare la notte; e il sole, cioè Cristo Signore del cielo e della terra, a riscaldare il giorno. Se lo guardate bene, è proprio un sole: gli ho fatto anche i raggi attorno! Cristo l’ho dipinto con la mano benedicente, ove tre dita sono unite (la Trinità), mentre l’indice e medio sono intrecciati, per indicare che è insieme Dio e uomo. Anche i due colori dei suoi abiti hanno questo significato: rosso-Dio, celeste-uomo.
Da san Francesco ho imparato a dire ogni giorno «Laudato sii o mi’ Signore» per il sole, la luna e le stelle, per questo azzurro firmamento così bello e grandioso, regalato ai nostri occhi per farci capire quanto più bello e grande è il Creatore di tutte queste cose.
L’intensissimo azzurro del cielo poi l’ho fatto scivolare giù dalla volta sopra tutti, ma proprio tutti i trentasei (dodici per tre, vi ricordate?) affreschi, cioè sopra le tappe di questa lunga storia, anche sopra le tappe dolorose: perché tutto quello che succede sulla terra è sotto il gran manto del cielo, cioè accade sotto il celeste abbraccio del Padre buono e misericordioso.
Roberto Filippetti, Il Vangelo secondo Giotto. La vita di Gesù raccontata ai ragazzi attraverso gli affreschi della Cappella degli Scrovegni, Itaca
• Cosa significa l’espressione «Se uno non alza lo sguardo, è come un bicchiere girato in giù»?
• Cosa significa la parola «de-siderio»?
• Di quali colori sono gli abiti di Cristo? Perché?
• Perché «l’intensissimo azzurro del cielo» scivola «giù dalla volta sopra tutti, ma proprio tutti i trentasei (dodici per tre, vi ricordate?) affreschi»?
Vidi il cielo
Sulla lontana e cara Terra si riflettevano le ombre leggere delle nuvole. Poi vidi il cielo, e in me si risvegliò il figlio del colcosiano che ero, abituato nell’infanzia a vivere sotto “la grande cupola”. Il cielo era nero, pieno di stelle, come un campo arato di fresco; e le stesse, brillanti, ferme e pure, mi facevano pensare a chicchi di grano. Anche il sole aveva uno straordinario splendore e non si poteva guardarlo a occhio nudo, nemmeno socchiudendo appena le palpebre. Lo vedevo splendere con un’intensità decine e forse centinaia di volte maggiore che sulla Terra. Naturalmente, non guardavo soltanto il cielo, ma anche giù. La distesa delle acque appariva come una massa scura dai riflessi cangianti. Guardando verso l’orizzonte ero colpito dal violento contrasto tra la superficie chiara della terra e il nero assoluto del cielo. È bellissima, la Terra: la vedevo circondata da un’aureola azzurra, e facendo scorrere lo sguardo da essa al cielo passavo dall’azzurro al blu, dal blu al turchese, al violetto, fino ad incontrare la notte profonda.
Jurij A. Gagarin, La via del cosmo. Sputnik, Lunik, Vostok: l’assalto sovietico al cielo, Pgreco colcosiano: contadino.
• Sottolinea tutti gli aggettivi qualificativi e indica con una freccia il nome a cui si riferiscono.
• Il cielo nero e pieno di stelle a cosa viene paragonato? E le stelle? Riscrivi il confronto sul quaderno e rappresentala col disegno.
Cielo stellato
Tutto il cielo è popolato di stelle.
Sono le stelle piccolissime e immense.
Sono punti di un ricamo luminoso che scintillano su un velluto cupo, che tremano su un velo diafano, che impallidiscono su una seta cilestrina.
Sono lucciole erranti per prati infinitamente vasti, con un palpito continuo, mai stanco.
Sono gli innumerevoli fanalini di una lussuosa illuminazione: disegnano nell’a ria figure di animali e di fiori, fontane di luce, archi di trionfo.
Alcuni ardono rossi e solitari su una strada per la quale nessuno passerà, alcuni di momento in momento sembrano prossimi a spegnersi, per mancanza d’umore, prossimi a mandare l’ultimo guizzo verdognolo.
Sono occhi aperti sulla terra, in essi trema l’anima del cielo; guardano, ridono, confidano un segreto e tanti silenziosamente ne scrutano.
Sono finestrelle aperte sul regno della eterna luce, attraverso risplendono
i bagliori del purissimo oro fuso; lievemente si oscurano quando dietro ad esse rapida passa l’ala di un angelo.
Sono fiori di fuoco penduli sullo stelo invisibile; un petalo si stacca e di fuoco riga il cielo nero.
Sono i brillanti vivi di un signore che è passato tenendo aperto il suo cofano favoloso per far più bella la notte e più lieti gli occhi degli uomini.
Si accendono le stelle ad una ad una, come per taciti richiami. Passa una mano e segna il punto luminoso, e spinge la lucciola e accende il fanale, e sveglia gli occhi e apre le finestrelle, e sboccia i fiori, e trae i brillanti dallo scrigno.
Tutte sorelle hanno le stelle i più diversi colori; ve ne sono di quelle rosse come la lanterna di un vascello all’ancora di una notte, o come tizzi che vegliano in focolari deserti, o come gli occhi sanguigni di fantastici animali.
Altre hanno il pallore della perla o della goccia d’acqua che racchiude un riflesso di luna.
Altre hanno un cilestrino cenerino, quasi fossero tanti “non ti scordar di me” appena aperti lungo il corso di un rio fresco e cupo.
Né mancano quelle che di momento in momento cambiano veste, e son rosse e gaggiate, e verdoline e pazzerelle.
Alcune si tengono per mano, in giro tondo, le mani non si vedono, tuffate nel buio. Alcune hanno d’intorno un lago nero, o un prato cinto da una siepe di tenebre.
Tante, tante, infinite si stringono lungo una via luminosa; fiume che scorre silenzioso nella pianura del cielo; processione di folla che si avvia ad una festa ignota.
Impallidisce tutto il cielo, passa la mano onnipotente e stacca il punto luminoso, abbatte la lucciola, spegne il fanale, cala le palpebre sugli occhi, serra le finestrelle, recide i fiori, e rinchiude i brillanti nello scrigno.
Una sola stella, alta, grande, la stel-


la del mattino, rimane ancora nel cielo e guarda il sole, purissima come uno squillo d’argento.
Sono le stelle piccolissime e immense. Lassù traboccano in una immane cascata di fuoco; e ognuna era un mondo. Divise, distinte presero la corsa nel cielo infinito, e ognuna trovò segnata la sua via.
Ruotano i mondi da secoli e da secoli intorno a perni, che pur girano attorno ad altri mobili mondi lontani.
Miriadi corrono là dove l’occhio meglio armato mai li arriva, nel puro silenzio senza confine. Il moto è sempre uguale; passandosi contro le stelle si guardano in uno specchio di fiamma, roghi di un incendio portentoso.
Da quella danza solenne piove un diffuso chiarore, come l’eco di una musica, fino ai più remoti angoli del cielo: è quel chiarore che anche nelle notti senza lumi e senza luna fa bianche le strade e pallidi i giardini degli uomini.
Giuseppe Fanciulli, Creature. Quadri di vita per la gioventù, Società Editrice Internazionale
• «Immerso nel buio e nel silenzio della sera, ho osservato il cielo stellato».
Racconta una tua esperienza in cui hai potuto osservare il cielo di sera.
Dov’eri? Cosa hai visto? Cosa hai pensato o provato?
• «Sono una stella e sto osservando il mondo che dorme…».
Immagina di essere una stella di una precisa costellazione che osserva il nostro mondo dall’alto e si chiede che cosa esso sia, cosa siano gli uomini e tutto ciò che vede.
• Sottolinea in blu quelle parole o espressioni che parlano del cielo.
• Sottolinea in giallo quelle parole o espressioni che parlano delle stelle.
L’alba
Verso le quattro cominciò a schiarire.
A levante si formò nelle tenebre un barlume verde scuro, che tracciò poco alla volta un segmento d’orizzonte, come a dire un principio di separazione tra il cielo e il mare, entrambi ancora neri. Poi la luce crebbe, si diffuse, le stelle andarono attenuandosi, mentre la macchia verdastra si espandeva sempre più, trasmutando in rosso, in oro, in altri colori. Sospesa nel cielo sopra il mare sterminato rimase un’unica stella, goccia di luce tremula: era Espero, la prima che si accende la sera, l’ultima che si spegne al mattino. Dal piano del mare emerse infine un punto straordinariamente luminoso, che crebbe fino a trasformarsi in un principio di disco: il sole.
I dieci uomini, avvolti nelle loro umide coperte, osservarono quasi senza parlare lo spettacolo, mentre la barca seguitava a correre bravamente, spinta dal suo inestetico motore.
Eugenio Corti, Il cavallo rosso, Ares

Mettiamoci all’opera
Notte stellata
Osserva il quadro «La notte stellata» ponendo molta attenzione al modo di dipingere di Van Gogh e alle pennellate con cui realizza le stelle. Scegli un paesaggio che possa sostituire il villaggio e le montagne dipinte da Van Gogh, in cui siano ben riconoscibili le sagome degli oggetti. Disegnalo con la matita grafite, poi dipingi sopra di esso il cielo della «Notte stellata» usando i colori brillanti e chiari di Van Gogh. Ricorda di utilizzare un pennello sottile per realizzare tratti stretti e armoniosi. Infine completa dipingendo di nero il paesaggio sottostante.


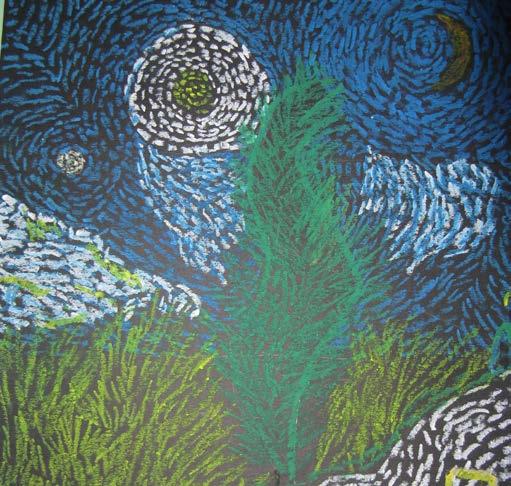
Il mostro dalle ali di pipistrello
Cassiopea, la splendida moglie del re di Etiopia, si era vantata un giorno di non temere confronti in fatto di bellezza neppure con le graziose Nereidi.
Le Nereidi, allora, punte nel proprio orgoglio, avevano chiesto al dio dei mari, Nettuno, di vendicare l’oltraggio fatto loro, e Nettuno aveva mandato sulle coste d’Etiopia un mostro marino dalle ali di pipistrello.
Questo mostro si era lanciato per il paese e aveva distrutto uomini e greggi. Inoltre, per accrescere il castigo, Nettuno aveva ordinato alle acque di straripare oltre gli argini e di inondare alcune regioni d’Etiopia.
La regina Cassiopea e il re Cefeo, suo sposo, erano desolati di questi flagelli e, non sapendo come placare l’ira del dio infuriato, chiesero all’oracolo di Giove come dovevano regolarsi.
«La mareggiata e la voracità del mostro inviato dal Nettuno saranno scongiurate se esporrete vostra figlia su di una roccia in cospetto del mare, e le acque si ritireranno entro le sponde, non c’è altro mezzo».
La povera Cassiopea pianse a lungo a queste parole: il suo cuore di madre si rifiutava di compiere un sacrificio così inumano.
Ma il popolo urlava di spavento e di fame ed esigeva un riparo al flagello immenso.
Fu deciso dunque, come lo strazio più atroce, di incatenare la bella principessa Andromeda agli scogli e di lasciarla lì, finché non fosse giunto il mostro a divorarla.
Quando Perseo, durante il suo viaggio di ritorno dai Paesi della Notte, arrivò in Etiopia, vide Andromeda legata ad un’enorme roccia, in attesa che l’animale infuriato venisse a dilaniarle le carni.
Un lieve soffio di vento che veniva dal mare le agitava i capelli biondi sparsi sulle spalle, lacrime silenziose le scendevano dagli occhi semichiusi: questi erano i soli segni di vita di quella fanciulla vicina a morire.
Col corpo perfetto riverso sulla roccia, col volto immobile, pallido di terrore, con le bianche braccia abbandonate, la principessa pareva la statua del dolore.
Perseo, rapito da tanta bellezza, si fermò davanti a lei e le chiese:
«Perché, meravigliosa fanciulla, dai tuoi occhi scendono tante lacrime e perché ti hanno incatenata a questa scogliera selvaggia?».
Quando udì che dopo pochi minuti un grande mostro dagli occhi sanguigni sarebbe balzato dal mare per divorarla viva, Perseo non ebbe un attimo di esitazione:
«Attenderò il mostro e ti libererò, Andromeda. – disse – Il feroce animale inviato da Nettuno per punire le vanterie di una madre sacrilega non deve toccare te che sei innocente».
Non aveva finito di dire queste parole che il terribile mostro marino agitò con grandi ondate la superficie delle acque e apparve.
Si avvicinava rapido, gettando fiamme dagli occhi, mentre la gola spalancata arrivava già a gustare il dolce bocconcino che lo aspettava. Perseo, nascosto dietro una roccia, appena il mostro fu vicino, si alzò e volò sull’acqua, passò sul dorso della bestia e gli conficcò nel corpo la lunga acuminata spada donatagli da Minerva. Il viscido corpo del drago sprizzò fiotti di sangue nerastro, la coda squamosa batté furiosamente sull’acqua, i lugubri anelli si attorsero per lo spasimo della ferita, poi il mostro si sprofondò negli abissi del mare, sollevando schiume rosseggianti, e i marosi si chiusero sopra di lui. Andromeda era salva e l’Etiopia liberata dal flagello!
Per ricompensare l’eroe, il re Cefeo gli concesse in moglie la principessa. Torce di festa furono accese in tutto il regno, profumi e incensi furono gettati a piene mani nei bracieri, e ghirlande di fiori e trofei di frutta turgida furono appesi alle colonne dei palazzi e dei templi. In un festino magnifico furono riuniti i magnati del regno e innumerevoli furono i canti e le melodie: tutto il popolo voleva inneggiare al generoso Perseo che aveva liberato la principessa e il paese e, prima che con la sua bella sposa partisse verso l’isola di Serifo per rivedere sua madre, voleva dimostrargli in tutti i modi la sua riconoscenza.
Finite le feste di nozze, Perseo si congedò dalla corte di Etiopia e partì con Andromeda verso la sua patria adottiva, ove aveva promesso di tornare portando la testa di Medusa.
Prima però volle generosamente chiedere ai Numi il perdono per la regina Cassiopea che, col suo vano egoismo, aveva fatto accadere tante disgrazie. E Cassiopea, anziché venir gettata nel livido Tartaro, venne da Giove tramutata in costellazione.
marosi: grandi onde di mare agitato.
• Qual è la causa originaria che ha scatenato flagelli e gravi sciagure in Etiopia?
• Spiega il motivo per cui «il popolo urlava di fame».
• Che soluzione viene ideata per porre fine a tali sciagure?
• Che caratteristiche ha il personaggio di Perseo?
• Come il popolo etiope dimostra la propria riconoscenza?
• Il fatto che la regina Cassiopea venga trasformata in costellazione è una sorte positiva?
Il ritorno della cometa
Arriva Natale e nelle nostre case è ritornata la cometa, l’astro che campeggia in ogni presepe a ricordo del cammino dei Magi verso Betlemme. Ma quest’anno la parola “cometa” forse rievoca in noi anche un’altra immagine, quella che ci ha lasciato Rosetta, la sonda dell’Agenzia Spaziale Europea che poco più di un mese fa ha emozionato il mondo posandosi proprio sulla superficie di una cometa, a una distanza di oltre cinquecento milioni di chilometri dalla Terra. Mai prima d’ora un oggetto costruito da mano d’uomo era sbarcato su un mondo tanto lontano. Le comete interessano molto gli scienziati perché sono testimoni speciali delle nostre origini cosmiche. Questi corpi simili ad asteroidi ghiacciati, grandi qualche chilometro, sono rimasti pressoché immutati per quasi cinque miliardi di anni e hanno custodito i segreti della nebulosa che diede origine al sistema solare. Avvicinandosi al Sole queste “palle di neve interplanetarie” si fanno belle. Il calore solare genera una chioma gassosa intorno al nucleo che, sospinta dal vento solare, forma la famosa “coda”.
Anticamente l’improvvisa comparsa di una cometa era considerata presagio di eventi eccezionali, sia infausti che fortunati.
Fu dunque una cometa ad ispirare il cammino dei Magi? Va detto subito che il racconto dell’evangelista Matteo, l’unico che lo riporta, non parla mai di “cometa” ma di “stella”. Anzi, usa la parola greca aster, che indica genericamente un astro o un evento astronomico, aprendo così il campo a molte interpretazioni. Come mai allora tutti diamo per scontato che si trattasse di una cometa? La tradizione risale all’inizio del XIV secolo quando Giotto, dipingendo la sua meravigliosa Adorazione dei Magi nella Cappella degli Scrovegni a Padova, decise di rappresentare la stella di Betlemme come una cometa. Il motivo è chiaro: pochi anni prima, nel 1301, Giotto aveva visto di persona lo spettacolo della cometa di Halley incombere in cielo e ne fu tanto impressionato da rappresentarla nel suo affresco. Da allora non c’è quadro della Natività o presepe al mondo nel quale non appaia la tradizionale cometa. A lungo si è pensato che una cometa potesse essere la stella dei Magi, ma oggi questa ipotesi è caduta: la meccanica celeste ci assicura che la cometa di Halley fu visibile nel 12 avanti Cristo. Che cosa fu dunque l’astrum che spinse i Magi a mettersi in cammino? La pista più promettente è un’altra. Talvolta accade che due pianeti, che percorrono le loro orbite a velocità diverse, appaiano in cielo allineati in modo tale da formare ai nostri occhi quasi un’unica luminosissima stella. Nel 1604 il grande Johannes Kepler poté ammirare un evento di questo tipo, una congiunzione tra Giove e Saturno. Ebbe un’intuizione e si gettò in un lungo calcolo: ebbene sì, proprio lo stesso fenomeno doveva essere accaduto in prossimità della nascita di Gesù. Oggi, grazie alla precisione della meccanica celeste e al potere di calcolo raggiunto, possiamo confermare con certezza che
nell’anno 7 avanti Cristo per ben 3 volte (29 maggio, 3 ottobre, 4 dicembre) Giove e Saturno si sfiorarono sulla volta celeste, sullo sfondo della costellazione dei Pesci. Anche Marte si avvicinò, rendendo la scena ancor più ricca e insolita. Un evento astronomico non appariscente, ma che non poteva certo sfuggire ai Magi, presumibilmente astronomi persiani o caldei, attenti osservatori del cielo. Questa configurazione celeste avrebbe avuto per loro anche un forte significato astrologico e potrebbe così dare conto dell’intuizione che li avrebbe mossi al cammino. Nella simbologia del tempo infatti Giove rappresentava la “regalità” e la “divinità”, Saturno la “giustizia”, e la costellazione dei Pesci veniva associata al popolo ebraico. È quindi possibile che i Magi abbiano tradotto quel segno celeste nel concetto che «un grande re di giustizia sta per nascere in Israele». Ecco allora che si dirigono verso la Palestina e si recano nella reggia di re Erode chiedendo: «Dov’è il re dei Giudei che è nato?».
Gli astri che per millenni erano stati concepiti come dei o potenze superiori, capaci di determinare la vita degli uomini e il corso della storia, sono stati in quel momento demitizzati.
Così oggi possiamo ammirare i corpi celesti – dalle comete alle supernove, dalle stelle alle galassie – e anche tentare di conoscerli attraverso la scienza proprio perché non sono realtà soprannaturali ma creature provvisorie, segni di una Bellezza più grande.
E così la cometa nel nostro presepe continuerà a essere segno della nascita di quel Bambino, tutt’altro che appariscente, ma decisiva per la storia di ogni uomo e della realtà tutta.
Marco Bersanelli, Il ritorno della cometa, «Avvenire», 23 dicembre 2014
demitizzati: slegati dalle divinità immaginate dall’uomo.
Stella mia
Leggiadro vien nell’onda della sera un solitario pàlpito di stella: a poco a poco una nube leggera le chiude sorridendo la pupilla;
e mentre passa con veli e con piume, nel grande azzurro tremule faville nascono a sciami, nascono a ghirlande, son nate in cento, sono nate in mille:
ma più io non ti vedo, stella mia.
Mare
M’affaccio alla finestra, e vedo il mare: vanno le stelle, tremolano l’onde. Vedo stelle passare, onde passare: un guizzo chiama, un palpito risponde.
Ecco sospira l’acqua, alita il vento: sul mare è apparso un bel ponte d’argento.
Ponte gettato sui laghi sereni, per chi dunque sei fatto e dove meni?
Giovanni Pascoli
Più in alto
Dialogo del Santo Padre Francesco con l’equipaggio della stazione spaziale internazionale, 26 ottobre 2017.
Santo Padre: Good morning you all!
Paolo Nespoli: Sua Santità, buongiorno. Benvenuto sulla stazione spaziale internazionale, tra di noi, tra l’equipaggio della spedizione 52 e 53.
Santo Padre: Buongiorno!... o buonasera… perché, quando si è nello spazio, mai si sa! Caro dottor Nespoli, cari astronauti, penso che lì nella stazione spaziale le giornate scorrono in modo diverso, vero? Comincio subito con la prima domanda. (Domanda 1) L’astronomia ci fa contemplare gli orizzonti sconfinati dell’universo, e suscita in noi le domande: da dove veniamo? dove andiamo?
Chiedo a Lei, dottor Nespoli: alla luce delle Sue esperienze nello spazio, qual è il Suo pensiero sul posto dell’uomo nell’universo?
Nespoli: Santo Padre, questa è una domanda complessa. Penso che il nostro obiettivo qua sia quello di conoscere il nostro essere, per riempire la conoscenza, capire quello che ci sta intorno. E tra l’altro è una cosa interessante, perché più conosciamo più ci rendiamo conto di conoscere poco. Mi piacerebbe tanto che non solo ingegneri, non solo fisici, ma persone come Lei possano venire qui nello spazio, qua per esplorare che cosa vuol dire avere un essere umano nello spazio.
Santo Padre: (Domanda 2) Vi chiedo: che senso ha per voi, che siete tutti ingegneri e astronauti, chiamare “amore” la forza che muove l’universo?
Nespoli: Santo Padre, vorrei lasciare la parola al mio collega russo Aleksandr Misurkin.
[Misurkin parla in russo, Nespoli traduce]: Il collega Aleksandr ha fatto una risposta molto bella. Fa riferimento a un libro che sta leggendo in questi giorni qua sopra, per riflettere, Il Piccolo Principe di Saint-Exupéry. Fa riferimento alla storia che dà volentieri – o darebbe volentieri – la propria vita per tornare e salvare piante e animali sulla terra. E, sostanzialmente, l’amore è quella forza che ti dà la capacità di dare la tua vita per qualcun altro.
Santo Padre: Mi piace questa risposta. È vero, senza amore, non è possibile dare la propria vita per qualcun altro. Questo è vero. Si vede che Lei ha capito il messaggio che tanto poeticamente spiega Saint-Exupéry . È bello, questo. Grazie. (Domanda 3) Che cosa maggiormente vi dà gioia nel tempo che passate nella stazione spaziale?
Nespoli: Santo Padre, lascerei il microfono a due colleghi: il collega russo Sergei Ryazansky e il collega americano Randy Bresnik.
[Ryazansky parla in inglese, Nespoli traduce]: Sergei ha detto che la sua ispirazione è stato suo nonno: suo nonno è stato uno dei primi pionieri dello spazio; ha lavorato al satellite Sputnik, il primo satellite volato sulla Terra; era uno dei
responsabili della costruzione del satellite, e lui ha preso ispirazione da suo nonno, ha voluto seguire le sue tracce, perché secondo lui lo spazio è interessante e bello, ma anche molto importante per noi, come esseri umani.
[Bresnik parla in inglese, Nespoli traduce]: Quella che io vedo da qui è una prospettiva incredibile: è la possibilità di vedere la Terra un po’ con gli occhi di Dio, e vedere la bellezza e l’incredibilità di questo pianeta. Nella nostra velocità orbitale di 10 km al secondo, noi vediamo la Terra con occhi diversi: vediamo una Terra senza confini, vediamo una Terra dove l’atmosfera è estremamente fine e labile, e guardare questa Terra in questo modo ci permette di pensare come esseri umani, di come tutti dovremmo lavorare assieme e collaborare per un futuro migliore.
Santo Padre: In questa risposta mi è piaciuto tanto quello che voi due avete detto. Lei, il primo, è andato alle proprie radici per spiegare questo: è andato al nonno. E Lei, che viene dall’America, è riuscito a capire che la Terra è troppo fragile, sottile l’atmosfera, tanto da poter distruggersi. E Lei è andato proprio a guardare con gli occhi di Dio. Il nonno e Dio: le radici e la nostra speranza, la nostra forza. Mai dimenticare le radici: a me fa bene sentire questo, e sentirlo da voi! Grazie. (Domanda 4) Vi domando: c’è qualcosa in particolare che vivendo nella stazione spaziale vi ha sorpreso? E c’è al contrario qualcosa che vi ha colpito proprio perché ha trovato conferma anche lì, in un contesto così diverso?
Nespoli: Grazie, Santo Padre, per questa domanda. Lascerei la parola al collega americano Mark Vande Hei.
[Vande Hei parla in inglese, Nespoli traduce]: Mark dice che quello che l’ha sorpreso è che nello spazio trovi cose completamente diverse che sembrano le stesse ma non riconoscibili. Ogni tanto mi avvicino a qualcosa da un angolo completamente diverso e all’inizio rimango un po’ sconcertato, perché non riesco a capire dove sono, a capire che cos’è. Quello che non è cambiato, invece, è che anche qui dove non c’è più il “su” e il “giù”, per riuscire a capire dove sono e trovarmi in questa situazione devo decidere io dov’è il “su” e dove il “giù”. E quindi stabilire il mio micro-cosmo, il mio micro-universo con i miei sensi e i miei sistemi di riferimento. Santo Padre: E questa è una cosa propriamente umana: la capacità di decidere, di decisione. (Domanda 5 ) La nostra società è molto individualista, e invece nella vita è essenziale la collaborazione. Penso a tutto il lavoro che c’è dietro un’impresa come la vostra. Potete darmi qualche esempio significativo di collaborazione vostra nella stazione spaziale?
Nespoli: Santo Padre, un’ottima domanda. Lascerei la domanda al collega americano Joe Acaba che è di discendenza portoricana.
[Acaba parla in inglese, Nespoli traduce]: Joe ha ricordato che per questa stazione c’è una cooperazione tra diverse Nazioni del mondo: ci sono gli Stati Uniti, c’è la Russia, il Giappone, il Canada, nove Nazioni europee... E ha ricordato come queste Nazioni lavorano insieme per ottenere qualcosa che è al di sopra di ognuno di loro.


Ma una delle cose importanti e interessanti che ha detto è il fatto che ognuno di noi porta una diversità e queste diversità messe assieme fanno un insieme molto più grande di quello che sarebbe la persona singola; e lavorando così insieme, in questo spirito collaborativo per andare oltre, questo è il modo per noi, come esseri umani, di uscire fuori dal mondo e continuare questo viaggio nella conoscenza.
Santo Padre: Voi siete un piccolo “Palazzo di Vetro”! La totalità è più grande della somma delle parti, e questo è l’esempio che voi ci date. Grazie tante, cari amici, vorrei dire: cari fratelli, perché vi sentiamo come rappresentanti di tutta la famiglia umana nel grande progetto di ricerca che è la stazione spaziale. Vi ringrazio di cuore per questo colloquio, che mi ha molto arricchito. Il Signore benedica voi, il vostro lavoro e le vostre famiglie. Vi assicuro: pregherò per voi; e voi, per favore, pregate per me. Grazie!
Nespoli: Santo Padre, a nome di tutti voglio ringraziarLa di essere stato con noi oggi, sulla stazione spaziale internazionale. Questo è un posto dove facciamo tanta ricerca, dove andiamo a cercare le cose di tutti i giorni. La ringrazio per essere stato con noi e averci portati più in alto e averci tirato fuori da questa meccanicità quotidiana, di averci fatto pensare a cose più grandi di noi. Grazie ancora!
Santo Padre: Grazie a voi!
Palazzo di Vetro: riferimento alla sede delle Nazioni Unite.
• Leggi con i tuoi compagni questo dialogo interpretando i diversi personaggi.
• Sottolinea le cinque domande del Papa con un colore e le risposte degli astronauti con un altro colore (non sottolineare tutta la risposta, ma la frase più significativa per te).
• Perché l’astronauta Nespoli dice al Santo Padre che li ha portati più in alto?
STAGIONI E RICORRENZE
Cantico di frate Sole
Altissimo, onnipotente, buon Signore tue sono le lodi, la gloria e l’onore ed ogni benedizione.
A te solo, Altissimo, si confanno, e nessun uomo è degno di te.
Laudato sii, o mio Signore, per tutte le creature, specialmente per messer frate Sole, il quale porta il giorno che ci illumina ed esso è bello e raggiante con grande splendore: di te, Altissimo, porta significazione.
Laudato sii, o mio Signore, per sora Luna e le Stelle: in cielo le hai formate limpide, belle e preziose.
Laudato sii, o mio Signore, per frate Vento e per l’Aria, le Nuvole, il Cielo sereno ed ogni tempo per il quale alle tue creature dai sostentamento.
Laudato sii, o mio Signore, per sora Acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta.
Laudato sii, o mio Signore, per frate Fuoco, con il quale ci illumini la notte: ed esso è robusto, bello, forte e giocondo.
Laudato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra, la quale ci sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba.
San Francesco


Nuvole
Al mattino, quando spalanco le finestre sulle Tofane, mi si para davanti agli occhi una giornata splendida. Più bella delle altre: uno di quei cieli di smalto di estate piena, nemmeno all’orizzonte la traccia di una piccola nuvola.
Poi, cos’è stato? All’inizio un niente. Un refolo di vento sottile e improvviso nell’aria ferma. Scompone per un istante gli ombrelloni nei giardini e le tende di pizzo alle finestre lasciate spalancate.
Poi tutto torna ardente e immobile.
Guarda: ora c’è una nuvola. Che strana: molto piccola, gonfia e nera. Sembra arrabbiata. Nel cielo terso si muove con una singolare velocità. Io la seguo con gli occhi, incuriosita da quella sua strana andatura furtiva. Mi piacciono, le nuvole, e soprattutto quelle nere. La mia nuvola, mi accorgo ora, è l’avanguardia di una schiera che rapida, spuntata come dal nulla, velocemente si ammassa all’orizzonte. Da dove vengono?
Nuvole nere, come chiamate all’appello da un oscuro generale, falangi che sorgono e si allineano l’una dopo l’altra minacciose, disponendosi alla battaglia. C’è ancora il sole in paese. Ma lassù si sta allestendo un sabba, un gonfiore rancoroso, un’ iradiddio di spifferi maligni e moli plumbee. Finalmente una nuvola grassa, con la portanza da nave maestra, lambisce il sole e lo oscura. La luce cambia in un attimo: trasfigura la giornata ridente in un’aura livida.
Larghe ombre percorrono ora le rocce chiare delle Tofane: passano sopra le cime, le incupiscono in un grigio plumbeo e di nuovo le liberano; altre, più gonfie, ne arrivano. Un esercito ha occupato il cielo.
Sul tetto sopra di me, finalmente un tocco solitario, come di un piccolo sasso gettato. È il segnale: comincia.
L’autunno gioca
L’autunno comincia il suo gioco: dipinge le foglie di croco, le indora: se sbaglia, le strappa, le dona al vento che scappa. Accende l’ultimo lampo, saluta chi semina il campo, la rondine che trasvola, i bimbi che tornano a scuola.
Ma ad un tratto… dov’è la sua gioia?
Ottobre fa il broncio, s’annoia, piagnucola… pioggerellina monotona, fina fina.
Dina Rebucci
Imitazione
Lungi dal proprio ramo, povera foglia frale, dove vai tu? – Dal faggio là dov’io nacqui, mi divise il vento. Esso, tornando, a volo dal bosco alla campagna, dalla valle mi porta alla montagna. Seco perpetuamente vo pellegrina, e tutto l’altro ignoro. Vo dove ogni altra cosa, dove naturalmente va la foglia di rosa, e la foglia d’alloro.
Giacomo Leopardi
Mettiamoci all’opera
Le foglie
È sempre affascinante ammirare le foglie nella stagione autunnale: colori accesi e caldi, forme differenti per alberi di diversa specie, tappeti morbidi e fruscianti sotto i piedi.
Puoi scegliere il tuo albero preferito e osservare la pagina della foglia con il margine e le nervature che la caratterizzano. Prendi un panetto di Das terracotta, stendi uno strato sottile e ampio quanto la foglia che hai scelto. Appoggia sopra la foglia e premi bene con il palmo della mano o un mattarello affinché rimanga impressa con decisione. Con l’aiuto di un attrezzo appuntito, premi lungo il margine per tagliare e poi stacca il Das di contorno.
Otterrai la tua foglia a cui puoi anche piegare le punte per dare l’idea della foglia autunnale, un po’ avvizzita e sgualcita. Se ti metti all’opera con tutti i compagni di classe, puoi realizzare un grande quadro con un albero autunnale. Con le foglie formerete la chioma. Per il tronco e le radici, modellate il Das formando dei rettangoli di proporzione adeguata, anche diversi fra loro per lunghezza e larghezza; con una forchetta tirate delle righe per rendere l’idea della corteccia rugosa. Distribuite del lucido da scarpe marrone su tutti i pezzi prodotti per la corteccia e strofinateli con una piccola spazzola per dare luminosità e colore. Infine, le foglie e le parti di tronco si appoggiano su un pannello di legno, studiando attentamente la disposizione. Quando siete convinti dell’esito, le foglie e la corteccia vanno fissate con colla Vinavil e lasciate asciugare. Il pannello con l’albero autunnale è pronto per abbellire un ambiente comune.

Il Natale di Martin
In una certa città viveva un ciabattino, di nome Martin Avdeic. Lavorava in una stanzetta in un seminterrato, con una finestra che guardava sulla strada. Da questa poteva vedere soltanto i piedi delle persone che passavano, ma ne riconosceva molte dalle scarpe, che aveva riparato lui stesso. Aveva sempre molto da fare, perché lavorava bene, usava materiali di buona qualità e per di più non si faceva pagare troppo.
Anni prima, gli erano morti la moglie e i figli e Martin si era disperato al punto di rimproverare Dio. Poi un giorno, un vecchio del suo villaggio natale, che era diventato un pellegrino e aveva fama di santo, andò a trovarlo. E Martin gli aprì il suo cuore.
«Non ho più desiderio di vivere» gli confessò. «Non ho più speranza».
Il vegliardo rispose: «La tua disperazione è dovuta al fatto che vuoi vivere solo per la tua felicità. Leggi il Vangelo e saprai come il Signore vorrebbe che tu vivessi».
Martin si comprò una Bibbia. In un primo tempo aveva deciso di leggerla soltanto nei giorni di festa ma, una volta cominciata la lettura, se ne sentì talmente rincuorato che la lesse ogni giorno.
E così accadde che una sera, nel Vangelo di Luca, Martin arrivò al brano in cui un ricco fariseo invitò il Signore in casa sua. Una donna, che pure era una peccatrice, venne a ungere i piedi del Signore e a lavarli con le sue lacrime. Il Signore disse al fariseo: «Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e non mi hai dato acqua per i piedi. Questa invece con le lacrime ha lavato i miei piedi e con i suoi capelli li ha asciugati… Non hai unto con olio il mio capo, questa invece, con unguento profumato ha unto i miei piedi».
Martin rifletté. Doveva essere come me quel fariseo. Se il Signore venisse da me, dovrei comportarmi cosi? Poi posò il capo sulle braccia e si addormentò.
All’improvviso udì una voce e si svegliò di soprassalto. Non c’era nessuno. Ma sentì distintamente queste parole: «Martin! Guarda fuori in strada domani, perché io verrò».
L’indomani mattina Martin si alzò prima dell’alba, accese il fuoco e preparò la zuppa di cavoli e la farinata di avena. Poi si mise il grembiule e si sedette a lavorare accanto alla finestra. Ma ripensava alla voce udita la notte precedente e così, più che lavorare, continuava a guardare in strada. Ogni volta che vedeva passare qualcuno con scarpe che non conosceva, sollevava lo sguardo per vedergli il viso.
Passò un facchino, poi un acquaiolo. E poi un vecchio di nome Stepanic, che lavorava per un commerciante del quartiere, cominciò a spalare la neve davanti alla finestra di Martin che lo vide e continuò il suo lavoro.
Dopo aver dato una dozzina di punti, guardò fuori di nuovo. Stepanic aveva appoggiato la pala al muro e stava o riposando o tentando di riscaldarsi. Martin uscì sulla soglia e gli fece un cenno.
«Entra» disse «vieni a scaldarti. Devi avere un gran freddo».
«Che Dio ti benedica!» rispose Stepanic. Entrò, scuotendosi di dosso la neve e si strofinò ben bene le scarpe al punto che barcollò e per poco non cadde.
«Non è niente» gli disse Martin. «Siediti e prendi un po’ di tè».
Riempì due boccali e ne porse uno all’ospite. Stepanic bevve d’un fiato. Era chiaro che ne avrebbe gradito un altro po’. Martin gli riempì di nuovo il bicchiere. Mentre bevevano, Martin continuava a guardar fuori della finestra.
«Stai aspettando qualcuno?» gli chiese il visitatore.
«Ieri sera» rispose Martin. «stavo leggendo di quando Cristo andò in casa di un fariseo che non lo accolse coi dovuti onori. Supponi che mi succeda qualcosa di simile. Cosa non farei per accoglierlo! Poi, mentre sonnecchiavo, ho udito qualcuno mormorare: “Guarda in strada domani, perché io verrò”».
Mentre Stepanic ascoltava, le lacrime gli rigavano le guance. «Grazie, Martin Avdeic. Mi hai dato conforto per l’anima e per il corpo».
Stepanic se ne andò e Martin si sedette a cucire uno stivale. Mentre guardava fuori della finestra, una donna con scarpe da contadina passò di lì e si fermò accanto al muro. Martin vide che era vestita miseramente e aveva un bambino fra le braccia. Volgendo la schiena al vento, tentava di riparare il piccolo coi propri indumenti, pur avendo indosso solo una logora veste estiva. Martin uscì e la invitò a entrare. Una volta in casa, le offrì un po’ di pane e della zuppa.
«Mangia, mia cara, e riscaldati» le disse.
Mangiando, la donna gli disse chi era: «Sono la moglie di un soldato. Hanno mandato mio marito lontano otto mesi fa e non ne ho saputo più nulla. Non sono riuscita a trovare lavoro e ho dovuto vendere tutto quel che avevo per mangiare. Ieri ho portato al monte dei pegni il mio ultimo scialle».
Martin andò a prendere un vecchio mantello. «Ecco» disse. «È un po’ liso ma basterà per avvolgere il piccolo».
La donna, prendendolo, scoppiò in lacrime. «Che il Signore ti benedica».
«Prendi» disse Martin porgendole del denaro per disimpegnare lo scialle. Poi l’accompagnò alla porta.
Martin tornò a sedersi e a lavorare. Ogni volta che un’ombra cadeva sulla finestra, sollevava lo sguardo per vedere chi passava.
Dopo un po’, vide una donna che vendeva mele da un paniere. Sulla schiena portava un sacco pesante che voleva spostare da una spalla all’altra. Mentre posava il paniere su un paracarro, un ragazzo con un berretto sdrucito passò di corsa, prese una mela e cercò di svignarsela. Ma la vecchia lo afferrò per i capelli. Il ragazzo si mise a strillare e la donna a sgridarlo aspramente.
Martin corse fuori. La donna minacciava di portare il ragazzo alla polizia. «Lascialo andare, nonnina» disse Martin. «Perdonalo, per amor di Cristo».
La vecchia lasciò il ragazzo. «Chiedi perdono alla nonnina» gli ingiunse allora Martin.
Il ragazzo si mise a piangere e a scusarsi. Martin prese una mela dal paniere e la diede al ragazzo dicendo: «Te la pagherò io, nonnina».
«Questo mascalzoncello meriterebbe di essere frustato» disse la vecchia.
«Oh, nonnina – fece Martin – se lui dovesse essere frustato per aver rubato una mela, cosa si dovrebbe fare a noi per tutti i nostri peccati? Dio ci comanda di perdonare, altrimenti non saremo perdonati. E dobbiamo perdonare soprattutto a un giovane sconsiderato».
«Sarà anche vero – disse la vecchia – ma stanno diventando terribilmente viziati».
Mentre stava per rimettersi il sacco sulla schiena, il ragazzo sì fece avanti. «Lascia che te lo porti io, nonna. Faccio la tua stessa strada».
La donna allora mise il sacco sulle spalle del ragazzo e si allontanarono insieme. Martin tornò a lavorare. Ma si era fatto buio e non riusciva più a infilare l’ago nei buchi del cuoio. Raccolse i suoi arnesi, spazzò via i ritagli di pelle dal pavimento e posò una lampada sul tavolo. Poi prese la Bibbia dallo scaffale.
Voleva aprire il libro alla pagina che aveva segnato, ma si aprì invece in un altro punto. Poi, udendo dei passi, Martin si voltò. Una voce gli sussurrò all’orecchio: «Martin, non mi riconosci?».
«Chi sei?» chiese Martin.
«Sono io» disse la voce. E da un angolo buio della stanza uscì Stepanic, che sorrise e poi svanì come una nuvola.
«Sono io» disse di nuovo la voce. E apparve la donna col bambino in braccio. Sorrise. Anche il piccolo rise. Poi scomparvero.
«Sono io» ancora una volta la voce. La vecchia e il ragazzo con la mela apparvero a loro volta, sorrisero e poi svanirono.
Martin si sentiva leggero e felice. Prese a leggere il Vangelo là dove si era aperto il libro. In cima alla pagina lesse: «Ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi dissetaste, fui forestiero e mi accoglieste». In fondo alla pagina lesse: «Quanto avete fatto a uno dei più piccoli dei miei fratelli, l’avete fatto a me».
Così Martin comprese che il Salvatore era davvero venuto da lui quel giorno e che lui aveva saputo accoglierlo.
Lev Tolstoj, La casa di Martin, Paoline editoriale libri
La notte misteriosa scintillante
La misteriosa notte scintillante continuava. Il cielo addirittura avvampava di stelle, tanto numerose che sembrava formassero un largo fiume di splendore, il quale scorresse da un’estremità all’altra dell’orizzonte e cadesse in una cascata argentea dietro la parete dei monti. Ma anche la terra pareva riflettere quello splendore, come se fosse un grande lago in cui si specchiasse il cielo.
Il gruppo di persone si era fermato qualche passo davanti alla grotta. Ata con le braccia conserte pareva volesse trattenerle dal fare irruzione all’interno. Diceva qualcosa – ora con tono di preghiera, ora con voce disperata. Giuseppe si fermò accanto a lei. La donna si volse verso di lui, disse: «Ascolta, Giuseppe, loro vogliono assolutamente entrare. Dicono che vogliono vedere. Spiego, li prego… non so che cosa vogliano…».
Lo sguardo si era abituato al chiarore e adesso li vedeva del tutto nitidamente. Si trattava dei pastori a cui gli abitanti di Betlemme affidavano le loro greggi. Il loro aspetto era selvaggio. Avevano i visi non rasati, tenevano in mano dei bastoni e coltelli e asce ficcati nella cintura. Erano vestiti con pelli di animali. In mezzo ai peli ispidi spuntavano le loro mani nerborute, grandi e forti. Il loro aspetto suscitava apprensione. Giuseppe sentì un brivido di paura, ma con mossa tanto più decisa si pose davanti ad Ata. Chiese:

Non risposero. Che li avesse stupiti l’apparizione di Giuseppe? Parlavano tra loro, come se si consultassero. Non comprendeva che cosa dicessero. Avevano una propria lingua, semplice, piena di parole straniere. Certamente nella loro vita non osservavano né la purezza né le norme della Legge. Vivevano in continuo vagabondaggio, conducendo con sé donne e bambini. Per quasi l’intero arco dell’anno si trovavano sui pascoli. A Betlemme comparivano due, tre volte l’anno: vi conducevano le greggi, per mostrarle ai proprietari, consegnavano i capi da ingrasso destinati al macello. In quell’occasione i proprietari delle greggi facevano i conti con loro. Ma nessuno li invitava in casa propria. Incutevano paura. Quando entravano nel villaggio, tutte le porte si chiudevano al loro passaggio. Si prendevano buona cura delle greggi, ma tutti erano convinti che, oltre alla pastorizia, si occupassero di ruberie. Inoltre parecchi erano meticci. Il lavoro li aveva resi duri, avvezzi alla lotta con gli animali selvaggi, che assalivano le greggi.
«Che volete?» ripeté. L’apprensione non lo aveva lasciato, ma al contempo sentiva di essere pronto a difendere i suoi anche se gli fosse toccato di lottare con tutto il gruppo dei nuovi venuti.
Quegli altri continuavano a parlare tra loro. Pareva che discutessero qualcosa. All’improvviso incominciarono a chiamare qualcuno e a spingerlo avanti. L’uomo che si fermò davanti a Giuseppe non era più giovane. Aveva i capelli ispidi, una incipiente calvizie sulla fronte. Il viso scuro, bruciato dal sole e dai venti,

«Di’» incominciò l’uomo «Qui nella grotta è forse nato un Bambino?».
Giuseppe si stupì a questa domanda.
«Perché me lo chiedi?».
«Voglio saperlo. Anche loro – indicò il gruppo – vogliono saperlo. Per questo siamo venuti».
«Per sapere della nascita di un bambino?».
«Sì».
«A mia moglie è veramente nato un Bambino…».
«E lo avete deposto nella mangiatoia?».
«Non capisco perché me lo chiedi. È così come hai detto. Siamo giunti oggi da lontano. Non si è trovato un posto per noi nella locanda. Nessuno ha voluto accoglierci…».
«E per questo è nato qui?».
«Sì».
«E lo avete deposto nella mangiatoia?».
L’uomo ripeté la domanda col tono di chi voglia accertare qualcosa di estremamente importante.
«Non avendo una culla…».
Il vecchio si rivolse verso i suoi. Disse loro qualcosa in una lingua gutturale, incomprensibile per Giuseppe. Quando finì si levò un grande vocìo. Giuseppe non riusciva a indovinare che cosa significassero le grida: ira, stupore o ammirazione. C’era qualcosa di strano nel fatto che quelli chiedessero notizie su cose tanto usuali.
L’altro si rivolse di nuovo a Giuseppe:
«Quando è nato questo tuo Bambino? Proprio quando si è accesa quella grande luce e quando si sono fatte sentire le voci?».
«La notte è piena di luci… E non so di quali voci parli. Io non ne ho sentita nessuna».
«Non le hai sentite?» adesso nella voce dell’uomo risuonava stupore.
«No… Che voci erano? Che cosa dicevano?».
L’uomo sembrava riflettere.
«Sì, erano delle voci…» affermò infine. «Le abbiamo sentite tutti. Non poteva essere un sogno. Il sogno viene a uno solo. Non ci sono due sogni uguali…».
«E che cosa dicevano quelle voci?» mentre chiedeva sentì un brivido percorrergli le braccia e scivolargli giù per la spina dorsale.
Il vecchio parve esitare. Diede un’occhiata ai suoi, si passò le mani sul petto irsuto. Infine borbottò:
«Dicevano cose strane… Che andassimo a cercare il Bambino che è nato nella notte nel campo di Davide ed è stato deposto in una mangiatoia di animali…».
«E a che scopo quelle voci vi hanno ordinato di cercare il Bambino?».
«Hanno ordinato di cercarlo e di guardarlo» affermò evasivo. Improvvisamente chiese: «Come è questo tuo Bambino?».
«Come gli altri bambini».
Scosse il capo, come se non potesse comprendere qualcosa.
«Dici così… Ma le voci hanno ordinato di andare, cercarlo, trovarlo e porgergli omaggio… Non so perché… Ognuno di noi ha preso con sé quello che poteva… Per offrirlo… E tu dici: un bambino qualsiasi? Ogni notte nascono dei bambini. Perché di questo Bambino hanno parlato le voci? Dobbiamo vederlo. Dobbiamo convincerci».
Disse questo e si mosse verso Giuseppe. Dietro di lui si mosse l’intera turba. Ma Giuseppe ancora una volta impedì loro il passaggio.
«Fermatevi! Trattenetevi!» esclamò.
«È vero quel che hai detto delle voci?».
Quello che aveva detto l’uomo suonava bello come un prodigio, eppure poteva celare un pericolo. La turba dei pastori, da cui emanava un sentore di pelle, di sangue e di grasso animale, non ispirava fiducia. Li avevano davvero condotti qui delle voci del cielo? – pensava. Se erano davvero voci celesti, perché non si erano rivolte ai sacerdoti? Perché non avevano parlato ai suoi fratelli? Proprio loro avrebbero dovuto comprendere e giungere per primi. Che cosa avrebbero capito da quel che avrebbero visto queste persone selvagge? Un Bambino avvolto nel lembi stracciati da una tunica… E che fosse un tranello? Che i suoi fratelli avessero macchinato qualcosa? Che volessero rapire il Piccino?
«Pensi» disse il vecchio, come indovinando i pensieri di Giuseppe «Che le voci misteriose non potevano parlare con noi? Le abbiamo sentite davvero. E abbiamo deciso subito di venire. Non ci trattenere…».
«Bene – disse – andate a vederlo. Non ve lo impedirò. Ma voglio avvertirvi: non vedrete nulla di straordinario. Non so che cosa vi abbiano detto le voci. Ma mia moglie ed io siamo povera gente…».
«Quando quello che ha parlato con noi ha detto che il Bambino sarebbe stato in una mangiatoia, sapevamo che avrebbe avuto bisogno del nostro aiuto… Per questo ciascuno ha portato qualcosa…».
«Che cosa vi aspettate dunque da Lui?».
L’uomo fece passare la mano nella chioma ispida.
«Lui ha detto – affermò – che questo Bimbo porterà la pace…».
«La pace?!» esclamò, indietreggiando istintivamente di un passo. «Vi ha detto così?».
«Ha detto così. Te ne stupisci?» da sotto le ciglia irsute adesso guardò con attenzione Giuseppe.
«Mi stupisce che voi cerchiate la pace» era in preda all’incertezza. «Avete l’aspetto di gente che ama la lotta».
Il vecchio pastore si strinse nelle spalle.
«Che ne sai tu di noi, uomo?» disse. «Dobbiamo lottare. Ma ognuno di noi vorrebbe lasciare a suo figlio una vita diversa. Facci passare».
Giuseppe abbassò le braccia che teneva levate davanti a sé.
«Entrate» affermò. «Vi prego solo di non fare rumore, di non gridare… Il Bimbo è piccino, e sua madre stanca…».
Entrarono l’uno dopo l’altro con cautela, sulle punte dei piedi, con strana umiltà. Il loro aspetto minaccioso, bellicoso era scomparso. Miriam non dormiva più, guardava i pastori che entravano nella grotta, e sul suo viso non scorse sgomento. Il Bimbo non pianse. Il cane non abbaiò. Insieme alle persone che vi entravano, si spandeva nella grotta il misterioso splendore di cui era inondata la notte.
nerborute: piene di vigore.
La luce del mondo
«E Dio che disse: Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo». 2 Cor 4,6
Molte delle luci che adesso a Natale illuminano strade e case non hanno quasi nulla a che fare con questa luce. Sono luci abbaglianti che servono agli affari e che internamente non riescono a scaldare. Esse mi ricordano spesso che oggi gli osservatori astronomici devono ritirarsi dall’Europa, perché le luci delle nostre città sono diventate così abbaglianti da coprire la luce che viene dall’alto, la luce delle stelle.
Molte delle moderne luci natalizie sono mere luci umane, che ci nascondono la luce di Dio più di quanto non ce la mostrino. Ma non dovremmo essere così pessimisti, non restare fermi alle accuse contro il consumo natalizio, non lasciarci rendere amaro il cuore.
Sempre di nuovo, dalla grotta della Natività s’irraggia nei cuori degli uomini un’umida e calda luce e risveglia la bontà nascosta che è la fiamma di Dio nella nostra anima.
Benedetto XVI (Joseph Ratzinger), Ciò che rende bello il mondo, Marietti
La notte di Natale
Dileguata nei secoli è la notte quando di mali stanca e di dolori la terra in braccio al ciel trovò la pace e nel silenzio nacque Dio con noi.
Passata è quella notte e non ritorna: non scrutan più il cielo attenti i Magi e di pastori non odo nel deserto lieti di Dio, gli angeli parlare.
Ma eterno è ciò che in quella notte apparve! Il tempo ormai distruggerlo non vale. È il Verbo, nato allora nel Presepio, nell’alma tua oggi ancor rinasce. Dio con noi.
Non nell’azzurro avvolto, non al di là degli infiniti mondi, non nel fuoco violento ed in tempesta, non nell’oblio dei trascorsi tempi.
Egli è ora qui. Fra i vani e tristi casi, nel fiume che la vita ansiosa turba, di gioia teco ognor porti un segreto: senza potere è il male, noi siamo eterni: Dio è con noi!

In Oriente
Si vegliava sui monti. Erano pochi pastori che vegliavano sui monti di Giuda. Quasi spenti erano i fuochi. Ognun guardava ai cieli, come stanco, stanco nel cuore; ognuno avea vicino il dolce uguale ruminar del branco. E un canto invase allora i cieli: Pace sopra la terra! E i fuochi quasi spenti arsero, e desta scintillò la brace. Erano in alto nubi, pari a steli di giglio, sopra Betlehem; già pronti erano, in piedi, attoniti ed aneli, i pastori guardando di sui monti.
E un angelo era, con le braccia stese, tra loro, come un’alta esile croce bianca e diceva: «Gioia con voi! Scese Dio sulla terra». Ed a ciascuno il cuore sobbalzò verso il bianco angelo. Mossero: e Betlehem, sotto l’osanna de’ cieli ed il fiorir dell’infinito, dormiva. E videro, ecco, una capanna. Ed ai pastori l’accennò col dito un angelo: una stalla umile e nera, donde gemeva un filo di vagito.
Jingle bells
Questa canzone è una carola, cioè un canto natalizio della tradizione inglese.
Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way!
O what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh
Din don dan, din don dan
Che felicità!
Oggi è nato il buon Gesù
Con la neve che vien giù.
Una città diversa
La neve! Gridò Marcovaldo alla moglie, ossia fece per gridare, ma la voce gli uscì attutita. Come sulle linee e sui colori e sulle prospettive, la neve era caduta sui rumori, anzi sulla possibilità stessa di far rumore; i suoni, in uno spazio imbottito, non vibravano. Andò al lavoro a piedi; i tram erano fermi per la neve. Per strada, aprendosi lui stesso la sua pista, si sentì libero come non s’era mai sentito.
Nelle vie cittadine ogni differenza tra marciapiedi e carreggiata era scomparsa, veicoli non ne potevano passare, e Marcovaldo, anche se affondava fino a mezza gamba ad ogni passo e si sentiva infiltrare la neve nelle calze, era diventato padrone di camminare in mezzo alla strada, di calpestare le aiuole, d’attraversare fuori delle linee prescritte, di avanzare a zig-zag.
Le vie e i corsi s’aprivano sterminati e deserti come candide gole tra rocce di montagne.
La città nascosta sotto quel mantello chissà se era sempre la stessa o se nella notte l’avevano cambiata con un’altra?
Chissà se sotto quei monticelli bianchi c’erano ancora le pompe della benzina, le edicole, le fermate dei tram o se non c’erano che sacchi e sacchi di neve? Marcovaldo camminando sognava di perdersi in una città diversa: invece i suoi passi lo riportavano proprio al suo posto di lavoro di tutti i giorni, il solito magazzino, e, varcata la soglia, il manovale stupì di ritrovarsi tra quelle mura sempre uguali, come se il cambiamento che aveva annullato il mondo di fuori avesse risparmiato solo la sua ditta.
• «La mia città è coperta da un camice di neve… Osservo il paesaggio che mi circonda». Descrivi il paesaggio che ti circonda utilizzando delle belle similitudini e delle metafore; soffermati su qualche particolare che ti colpisce e descrivi il paesaggio innevato.
• «In questi giorni di neve ho trascorso una giornata particolarmente bella… Ecco cosa ho fatto…». Racconta.
Neve
Sui campi e sulle strade, silenziosa e lieve, volteggiando, la neve cade.
Danza la falda bianca nell’ampio ciel scherzosa, poi sul terren si posa, stanca.
In mille immote forme, sui tetti e sui camini, sui cippi e sui giardini dorme.
Tutto dintorno è pace; chiuso in oblio profondo, indifferente il mondo tace.
Ada Negri
Dal cielo tutti gli Angeli videro i campi brulli senza fronde né fiori e lessero nel cuore dei fanciulli che amano le cose bianche. Scossero le ali stanche di volare e allora discese lieve lieve la fiorita neve.
Umberto Saba

• Sottolinea le azioni che fa la neve.
• Dizionario: cerca i significati delle parole “cippi”, “immote”, “oblio”, e riscrivili sul quaderno.
Primavera
E poi era una bella mattinata di primavera. Dalle finestre della scuola si vedeva il cielo azzurro, gli alberi del giardino tutti coperti di germogli, e le finestre delle case spalancate, colle cassette e i vasi già verdeggianti. Il maestro non rideva, perché non ride mai, ma era di buon umore, tanto che non gli appariva quasi più quella ruga diritta in mezzo alla fronte; e spiegava un problema sulla lavagna, celiando. E si vedeva che provava piacere a respirar l’aria del giardino che veniva per le finestre aperte, piena d’un buon odor fresco di terra e di foglie, che faceva pensare alle passeggiate in campagna. Mentre egli spiegava, si sentiva in una strada vicina un fabbro ferraio che batteva sull’incudine, e nella casa di faccia una donna che cantava per addormentare il bambino: lontano, nella caserma della Cernaia, suonavano le trombe. Tutti parevano contenti, persino Stardi.
A un certo momento il fabbro si mise a picchiar più forte, la donna a cantar più alto. Il maestro s’interruppe e prestò l’orecchio. Poi disse lentamente guardando per la finestra: «Il cielo che sorride, una madre che canta, un galantuomo che lavora, dei ragazzi che studiano… ecco delle cose belle». Quando uscimmo dalla classe, vedemmo che anche tutti gli altri erano allegri; tutti camminavano in fila pestando i piedi forte e canticchiando, come alla vigilia d’una vacanza di quattro giorni; le maestre scherzavano; quella della penna rossa saltellava dietro i suoi bimbi come una scolaretta; i parenti dei ragazzi discorrevano fra loro ridendo, e la madre di Crossi, l’erbaiola, ci aveva nelle ceste tanti mazzi di violette, che empivano di profumo tutto il camerone. Io non sentii mai tanta contentezza come questa mattina a veder mia madre che mi aspettava nella strada. E glielo dissi andandole incontro: «Sono contento: cos’è mai che mi fa così contento questa mattina?». E mia madre mi rispose sorridendo che era la bella stagione e la buona coscienza.
Pasqua
Io canto la canzon di primavera, andando come libera gitana, in patria terra ed in terra lontana, con ciuffi d’erba ne la treccia nera. E con un ramo di mandorlo in fiore a le finestre batto e dico: Aprite, Cristo è risorto e germinan le vite nove e ritorna con l’April l’amore! Amatevi fra voi, pei dolci e belli sogni ch’oggi fioriscon su la terra, uomini della penna e de la guerra uomini de le vanghe e dei martelli. Schiudete i cuori: in essi erompa intera di questo dì l’eterna giovinezza; io passo e canto che vita è bellezza, passa e canta con me la primavera.
Ada Negri
Cantiamo insieme
Tu mi guardi dalla croce
Questo canto è attribuito a Mozart.
Tu mi guardi dalla croce
Questa sera mio Signor, Ed intanto la Tua voce
Mi sussurra: “Dammi il cuor!”.


Inno alla Vergine
Vergine madre, figlia del tuo Figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d’eterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura nobilitasti sì, che il suo Fattore non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore per lo cui caldo nell’eterna pace così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridïana face di caritate; e giuso, intra i mortali se’ di speranza fontana vivace.
Donna, se’ tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia, e a te non ricorre, sua disïanza vuol volar senz’ali.
La tua benignità non pur soccorre a chi dimanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s’aduna quantunque in creatura è di bontate.
Dante Alighieri, Paradiso XXXIII, 1-21
Progetti per le vacanze
3 luglio
Formidabile, insperato, straordinario: vado al campeggio!
Sì, vado al campeggio! E non sono stata neppure io a parlarne per prima. Ero accanto al letto di papà, che era sdraiato. Ad un certo punto, mi ha detto:
– E quel famoso campeggio? Non ce ne parli più: ti piacerebbe davvero andarci?
Ero talmente commossa da non saper più che dire. Papà mi ha richiesto alcuni chiarimenti. Sono poi andata di corsa a cercare il modulo di iscrizione e me lo ha firmato.
Sono irritata con me stessa perché non gli ho espresso a sufficienza la mia riconoscenza. Ero davanti a lui, un po’ impacciata; e succede così ogni volta che i miei sentimenti sono troppo violenti. Mi paralizzo letteralmente, e resto incapace di dire due semplici parole in croce.
Mi sembra che questo campeggio sarà molto diverso dagli altri. Prima di tutto, perché è in Spagna, inoltre perché ormai sono più grande.
Michel Quoist, Donare. Il diario di Anna Maria, Borla

impacciata: confusa, imbarazzata.
Una mattina d’estate
Uscite in una mattina d’estate quando il sole è appena spuntato; recatevi nei campi o nei boschi: vedrete scintillare nell’erba miriadi di diamanti, che riflettono i raggi del sole in mille barbagli di ogni colore, dal giallo al rosso, all’azzurro; e se vi avvicinate, se vi chinate su queste fonti di luce, scoprirete tante piccole gocce di rugiada, raccolte sulle foglie e sui fili d’erba.
Molte foglie sono vellutate, ricoperte di una specie di peluria: le goccioline vi scorrono sopra senza bagnarle. Se, con ogni precauzione ne raccogliete una sulla quale si è deposta la goccia di rugiada, il piccolo globo luminoso rotola via così in fretta, che l’occhio quasi non lo vede scivolare, e cadere al suolo.
Quante volte ho portato alle labbra una di queste foglie per bere la rugiada! E questa mi è sembrata la più dolce delle bevande.

SCOPERTE
Perlaparola
Le parole sono perle luminosa chiccheria per chi prova ad assaggiarle in collane di poesia
Le parole sono perle tra le dita dei poeti che s’incantano a girarle come piccoli pianeti
Le parole sono perle chiuse in cuori di conchiglie quando parli schiudi e sciogli le collane meraviglie
Viaggia verso. Poesie nelle tasche dei jeans,
Ascoltiamo insieme
Pata, Pata
La canzone di Miriam Makeba è una danza molto vivace e invita a ballare chiunque ascolti la canzone.


Miriam Makeba

Un tempo gli abitanti del Sudafrica venivano trattati in modi molto diversi a seconda del colore della pelle.
I bianchi e i neri non potevano trascorrere del tempo insieme e non potevano nemmeno innamorarsi e avere figli tra loro: era illegale.
Questo sistema crudele si chiamava “apartheid”.
Fu in questo mondo che nacque Miriam, una bambina che amava cantare. Ogni domenica, Miriam andava in chiesa con sua madre. Desiderava così ardentemente cantare nel coro che si intrufolava nel retro della chiesa ogni volta che c’erano le prove.
Quando Miriam crebbe, registrò più di cento canzoni con il suo gruppo femminile, le Skylarks.
Cantava della vita in Sudafrica: cosa le dava gioia, cosa la rendeva triste, cosa la faceva arrabbiare. Cantava della gioia di ballare e cantava dell’apartheid.
La gente amava le sue canzoni, soprattutto una, intitolata «Pata Pata», che era il suo più grande successo. Ma al governo non piaceva il messaggio anti-apartheid della musica di Miriam. Voleva mettere a tacere la sua voce di protesta. E quando Miriam lasciò il Paese per andare in tour, le tolsero il passaporto e non le permisero di tornare.
Miriam cantò in tutto il mondo e divenne un simbolo della fiera battaglia africana per la libertà e la giustizia. La gente cominciò a chiamarla “Mama Africa”. Passarono trentun anni e alla fine le permisero di tornare a casa. Poco tempo dopo, l’apartheid fu finalmente sconfitto.
Francesca Cavallo, Elena Favilli, Storie della buonanotte per bambine ribelli, Mondadori
Il cannocchiale di Galileo
Passiamo ora al cannocchiale, che mi ha permesso di arrivare a straordinarie scoperte astronomiche. L’idea di costruirne uno per osservare e studiare più da vicino i pianeti e le stelle mi venne quando, nel 1609, seppi che in Olanda già da tempo circolavano dei semplici e rudimentali tubi muniti di lenti capaci di ingrandire di due o tre volte gli oggetti lontani.
La notizia mi affascinò a tal punto che mi misi subito al lavoro per perfezionarlo e in poco tempo riuscii a potenziare la capacità d’ingrandimento delle lenti fino a venti o trenta volte. Con il mio nuovo cannocchiale o telescopio fui in grado di scrutare gli astri con occhi diversi, e il cielo mi svelò così sorprendenti
novità, che mi consentirono di confermare le rivoluzionarie teorie di Niccolò Copernico: la Terra non è immobile al centro dell’Universo, ma ruota su se stessa e orbita intorno al Sole. Scoprii che esistono montagne e crateri sulla Luna, che nel cielo brillano miriadi di stelle, la maggior parte delle quali sono invisibili a occhio nudo e che la stessa Via Lattea «non è che un ammasso di innumerevoli stelle disseminate a mucchi». Osservai inoltre che Venere presenta fasi simili a quelle della Luna e che il movimento del pianeta avviene intorno al Sole. Scoprii anche i quattro maggiori satelliti di Giove e le macchie scure che rendono imperfetta la superficie solare e dal movimento di tali macchie intuii che il Sole ruota sul proprio asse.
• Da chi Galileo prese spunto per costruire il cannocchiale e perché?
• Che risultati ottenne grazie alla sua invenzione?
• Quali teorie si sentì di confermate?
• Quante cose nuove riuscì a scoprire? Fai l’elenco senza dimenticare nulla.
II cannocchiale di Galileo è il risultato della combinazione di due lenti all’interno di un tubo, una piano-concava e l’altra pianoconvessa. Le lenti sono posizionate una in prossimità dell’occhio (oculare), l’altra all’estremità opposta del tubo (obiettivo). Questa combinazione di lenti permette di vedere un’immagine dritta, anche se il limite del cannocchiale galileiano è quello di avere un campo visivo molto ristretto. Negli anni che seguirono furono ideati altri modelli di telescopio, tra cui quello dell’astronomo Giovanni Keplero, nel 1611, dotato di due lenti convesse (anziché di una lente convessa combinata a una concava). La combinazione di queste lenti dà come risultato un’immagine rovesciata, ma ha il vantaggio di aumentare il campo visivo.

L’invenzione di Marconi
Per le condizioni di salute di Guglielmo fu deciso di andare a trascorrere l’estate del 1894 fra le montagne del biellese, nella superba visione delle Alpi. Paesaggio grandioso e suggestivo, aria fresca e salutare, possibilità di appartarsi, dopo lunghe passeggiate, solitudine per pensare, studiare, meditare.
Nel gennaio di quello stesso anno, era morto il fisico Hertz appena trentasettenne, ma gli studi sulle onde elettromagnetiche proseguivano intensi qua e là nel mondo per opera di molti scienziati.
Al giovane Marconi che era al corrente di questi studi e di questi esperimenti, sembrava strano che ancora nessuno di quegli scienziati avesse pensato a quello che pensava lui, benché solo ventenne.
Confidò alla mamma il suo segreto, con parole semplici, ma calde di convinzione: padroneggiare le onde elettromagnetiche scoperte da Hertz, piegarle alle necessità della vita umana trasformandole in segnali: ricevere, registrare, leggere – sì leggere – a distanza questi segnali.
Ecco l’idea sovrana che nessuno aveva ancora avuto. E bisognava fare presto e intanto tacere!
Impegno e attività senza sosta
Quando finita l’estate ritornarono alla villa del Grifone, Guglielmo Marconi scelse il solaio come suo laboratorio e chiese al padre il denaro occorrente per poter acquistare il materiale necessario agli esperimenti che questa volta dovevano essere definitivi.
Il padre brontolò. Il “signorino” (così lo chiamavano i coloni) non si contentava più di poco; era una lista interminabile di materiale assai costoso quella che aveva presentato: campanelli elettrici, accumulatori, pile elettriche, filo di rame e perfino tasti telegrafici.
Con l’intercessione affettuosa della mamma che sapeva dove voleva giungere il figlio ed aveva fiducia nella sua riuscita, il padre finì per sborsare il denaro occorrente. Diffidava, è vero, ma se poi Guglielmo fosse riuscito a combinare qualche cosa di serio?
Il giovane cominciò il suo lavoro di montaggio, con l’aiuto del falegname Vornelli e del colono Mignani, inconsapevoli di quanto si andava preparando nel solaio ma pronti ad eseguire gli ordini e fedeli alla consegna del più assoluto silenzio.
Passarono nel lavoro febbrile l’autunno e l’inverno. Il solaio era gelido… La mamma lo sollecitava a restare di più al caldo della stufa… Il papà brontolava specialmente quando lo sentiva salire di notte su nel solaio… Ma egli rassicurava ambedue, dicendo che ormai tutto era pronto e tutto sarebbe andato bene.
Tenacia e fede nella vittoria
Si giunse così alla primavera del 1895: la preparazione del grande esperimento era durata cinque mesi; le prove e le riprove si erano susseguite con ansia crescente, spesso anche con risultati poco incoraggianti. Ma la tenacia del giovane, la serietà dei suoi studi e soprattutto la fede nella vittoria, avevano superato tutte le difficoltà.
A ridosso della villa c’era una collinetta distante circa ottocento metri, visibilissima dunque dalla finestra della soffitta. Guglielmo Marconi scelse quella località per il suo primo esperimento e andò a piantarvi il ricevitore; poi chiamò il fedele Mignani e lo incaricò di restare lì accanto, bene attento. Egli sarebbe tornato nel solaio e avrebbe premuto tre colpi sul tasto del suo apparecchio. Se tutto fosse andato secondo la previsione, al triplice colpo di tasto dal davanzale della finestra (rispondente al segnale della lettera “S” dell’alfabeto Morse) Mignani avrebbe potuto udire i tre colpi ripetuti dal ricevitore; se questo fosse avvenuto, avrebbe dovuto sventolare un fazzoletto.
Rapido, nell’ansia del momento lungamente atteso, Guglielmo Marconi attraversò il giardino, salì in fretta le scale e raggiunse il solaio. Il cuore del giovane sperimentatore batteva forte.
La prima vittoria
Il giovane alla finestra della soffitta posò la mano, che non tremava, sul tasto: uno, due, tre! Un attimo e dall’alto della collinetta di fronte rispose uno sventolio che sembrava avere in sé il fremito dell’allegrezza, della gioia del saluto, il grido della vittoria.
Guglielmo Marconi aveva vinto; era nato in Italia, a Pontecchio, vicino a Bologna, il telegrafo senza fili.
Pietro Caccialupi, Il dominatore dell’infinito (Guglielmo Marconi), La Prora
La macchina per lavare
Una sera di novembre del 1955 mia nonna, che aveva quarant’anni, riconquistò la sua libertà e si sentì felice: aveva preso in mano un libro ed era riuscita a leggere qualche pagina prima di addormentarsi. Non le capitava più da quattordici anni, da quando, in mezzo alla guerra, era nato il suo primo figlio: Carlo. Da allora, di bambini ne erano arrivati altri cinque; la più piccola, Graziella, non aveva ancora nove mesi.
Ogni sera, da quattordici anni, mia nonna andava a dormire esausta solo quando aveva finito di lavare a mano montagne di lenzuola e pannolini. Lo aveva fatto migliaia di volte: prima a Torino, interrompendosi solo quando le sirene avvisavano che stavano per piovere le bombe, poi a Cavour, dov’era sfollata perché la sua casa era stata centrata e distrutta, infine a Milano, dove si era trasferita al termine della guerra. La società di compravendita di lane e sete che aveva aperto con il nonno aveva avuto successo, avevano raggiunto il benessere e comprato un appartamento con un grande terrazzo in zona Garibaldi; ma anche se si poteva permettere di avere una persona in casa che l’aiutava con i bambini e in cucina, la lavanderia notturna era rimasta un compito tutto suo.
Due giorni prima il nonno era arrivato a casa con un regalo che pensava fosse la giusta celebrazione del loro successo: un dépliant della nuova Fiat Seicento, uscita da pochi mesi.
«Micia» così la chiamò per tutti i quarantasette anni di vita che passarono

insieme «questo è per te». E le allungò il pieghevole in cui era nascosta la chiave dell’auto che sarebbero andati a ritirare la mattina dopo.
«Potrai andare in giro per la città, accompagnare i bambini a scuola, caricarci la spesa. Sarai libera di muoverti come vuoi».
La nonna non lo interruppe e rimase un momento in silenzio. La libertà che aveva in mente lei era completamente diversa, aveva un altro aspetto, e l’aveva vista giusto quella mattina nella vetrina di un negozio poco lontano da piazza Duomo. Si era fermata a guardarla a lungo, facendo un sacco di sogni e fantasie. Così spiazzò il nonno con un paio di domande strane: «Ma è davvero mia? Nel senso che è intestata a me?».
«Certo che è tua, è un regalo. Potrai usarla quando vuoi».
«Posso farne quello che voglio?»
«Ti ho detto di sì, quello che vuoi».
Il giorno dopo, quando andarono dal concessionario, lei restituì le chiavi, recuperò i soldi dell’acconto e, prima dell’ora di pranzo, aveva coronato il suo sogno di libertà: si era comprata quella gigantesca lavatrice americana appena arrivata in Italia di cui si era innamorata. Tornando a casa passò anche in libreria. Le bastò muoversi tra gli scaffali per sentirsi felice all’idea di scegliere cosa avrebbe letto quella sera. Cinquant’anni dopo, quando me lo raccontò, si era dimenticata il titolo del volume: «Non aveva nessuna importanza, qualunque libro sarebbe andato bene. Era il gesto di tornare a leggere che faceva la differenza, era l’idea di aver riconquistato un po’ di tempo per me».
Il nonno ci rimase un po’ male, ma cercò di non darlo a vedere tanta era la gioia che mostrava sua moglie.
Per settimane, ogni pomeriggio, ci fu una processione di signore che salivano la scaletta verso il bagno vicino al terrazzo per ammirare quel prodigio della tecnica. Dal piano di sotto si sentivano distintamente le risate e gli “oh!” di stupore delle amiche mentre la voce squillante della nonna illustrava ogni caratteristica e ogni dettaglio: dalla bilancia per pesare esattamente la quantità di biancheria da inserire fino alla centrifuga verde a forma di doppio cono. Mia madre, che allora aveva nove anni, ricorda ancora tutti i passaggi di quel teatrino in cui la nonna mimava con cura ogni gesto: sollevava la scatola del detersivo, fingeva di versarlo nella vaschetta, indicava l’ingresso dell’acqua calda e poi la tinozza in cui scaricava i panni inzuppati prima di infilarli nella strizzatrice. Ogni presentazione si concludeva con le stesse parole: «E così io posso andare di là a leggere, capite che libertà?».
Quando, mezzo secolo dopo chiesi a mia nonna qual era stata la più grande invenzione che aveva cambiato la sua vita, prima di raccontarmi questa storia rispose senza esitare: «La lavatrice!».
Mario Calabresi , Cosa tiene accese le stelle. Storie di italiani che non hanno mai smesso di credere nel futuro, Mondadori
Un caso straordinario: Alessandro Fleming
I microbi (nome che deriva dalle parole greche piccolo e vita) erano una vista abbastanza comune per tutti gli studiosi che si servivano del microscopio, ma di solito, dopo averli visti, gli studiosi non ci pensavano più, perché erano organismi troppo piccoli.
Nessun prodotto chimico era stato sino a quel tempo trovato, che potesse uccidere i batteri senza nuocere ai tessuti del corpo e specialmente a quei leucociti (i globuli bianchi del sangue) che sono nell’organismo umano i combattenti più valorosi contro le infezioni.
Fra i molti studiosi che stavano ricercando il modo di uccidere questi microbi infettivi, c’era Alessandro Fleming, che oltre ad essere medico era anche batteriologo. Durante la prima guerra mondiale gli era stato assegnato il compito di perfezionare un rimedio antisettico per le ferite prodotte da eventi bellici.
Nell’autunno del 1928 Fleming si dedicava in modo particolare allo studio dei batteri più pericolosi, gli stafilococchi, che sono quelli che producono il pus degli ascessi e altre infezioni del sangue. Ne aveva raggruppate diverse colture, ciascuna delle quali richiedeva particolari condizioni ambientali, riguardanti la temperatura, la qualità dell’ossigeno e la sostanza speciale sulla quale si sviluppavano. Gli studi erano già a buon punto, però egli non era ancora in grado di precisare quale fosse la particolare caratteristica di ognuna, cioè la loro potenza mortale.
Un giorno mentre egli stava per togliere la campana di vetro che ricopriva un piattino nel quale teneva alcune colonie d’un colore lattiginoso di stafi (gli stafilococchi crescono in gruppi o colonie propriamente dette) si accorse che quella coltura era stata contaminata da batteri di un genere diverso.
Fleming si comportò in questa occasione come tutti gli altri batteriologi prima di lui. Aggrottò le sopracciglia, ebbe un moto d’impazienza, quasi di rabbia per il lavoro perduto e, con l’intenzione di gettarlo via, prese in mano il piattino di vetro che conteneva quella data coltura contaminata purtroppo da una macchia di muffa che egli attribuì al genere Penicillium notatum. E fu, in questo momento, che esitò. Nessuno, nemmeno lui, seppe poi dire perché in quel momento avesse esitato.
Fleming osservò la piastra che aveva in mano. Attorno alla macchia di muffa egli vide un alone di liquido chiaro, e non il solito colore lattiginoso delle colonie degli stafilococchi.
«Era una cosa straordinaria – scrisse più tardi, – che intorno alla muffa la colonia degli stafilococchi si fosse dissolta. E anche quel colore così diverso… Tutto ciò era più che sufficiente per farmi capire che qualcosa di nuovo era accaduto».
Aveva capito che qualcosa di nuovo era accaduto e quindi avrebbe riflettuto su quel caso straordinario. Infatti riscontrò che dove cresceva la muffa del Penicillium notatum, non c’erano stafilococchi. Dove invece essi si erano già sviluppati in colonie, la muffa ben presto prendeva il sopravvento e impediva che crescessero e si moltiplicassero, finché poi morivano.
Che cosa era questa muffa alla quale gli stafilococchi non potevano resistere? Fleming prese un po’ di quel liquido nel quale la muffa si era sviluppata e ne lasciò cadere qualche goccia in mezzo a una fiorente colonia di stafilococchi. Bastò, perché dopo qualche ora essi fossero completamente vinti.
Ad ogni modo Fleming chiamò il liquido che aveva ottenuto da quella muffa speciale penicillina.
E i risultati? Anche gli altri medici dovettero ammettere che era una scoperta interessante, anzi molto interessante, ma dichiararono pure che, all’atto pratico, valeva poco. In questo senso, che per ottenere solo un poco di penicillina sufficiente per fare gli esperimenti nelle provette ci voleva moltissimo tempo, e figuriamoci poi quando occorrevano litri e litri di penicillina, quanti cioè erano necessari per una cura efficace. E a parte le difficoltà per ottenerla, la penicillina facilmente si guastava col calore o per effetto degli acidi o degli alcali.
Rimaneva quindi il problema della produzione di penicillina su vasta scala. Finché, esattamente quattordici anni dopo la scoperta di Fleming, nel 1942, la penicillina entrò a far parte della medicina generale.
E poi venendo sino ai nostri giorni, non più la penicillina soltanto fece di questi miracoli. Furono continuate le ricerche e furono trovate altre muffe che diedero gli antibiotici. E questi antibiotici uccisero anche quei batteri che resistevano invece alla penicillina.
Era insomma incominciata una nuova era per la medicina, tutto perché Alessandro Fleming, un giorno, non aveva gettato via un piattino di stafilococchi «che aveva preso la muffa».
Gli sci dei primordi
Per secoli l’uomo ha costruito sci di legno: oltre a essere facilmente reperibile, il legno ha ottime caratteristiche di robustezza, leggerezza e flessibilità. I legni più usati erano in passato la betulla, l’acero e il noce americano.
Nell’Ottocento gli sci erano fabbricati soprattutto in Norvegia, un Paese con montagne basse e poco scoscese, e per questo si adattavano piuttosto male alla neve ghiacciata e alle discese ripide delle Alpi. Poi nella prima metà del Novecento gli sci di legno massiccio furono progressivamente rimpiazzati da sci laminati, cioè costituiti da due tipi diversi di legno incollati insieme. La base, che si trova a contatto con la neve ed è quindi sottoposta ad abrasione, era una lamina di legno duro come il noce americano, mentre la parte superiore era di legni leggeri, come abete o tiglio. Grazie a questa innovazione gli sci divennero più maneggevoli e anche meno costosi. In seguito la tecnica della laminazione ha subìto molte modifiche, soprattutto nei materiali utilizzati.
Nel 1960 Jean Vuarnet conquistò la medaglia d’oro nella discesa libera olimpica di Squaw Valley, calzando gli Allais 60, sci laminati in cui la faccia superiore e quella inferiore erano di alluminio. Ben presto tuttavia anche l’alluminio fu rimpiazzato da nuovi materiali, la fibra di vetro, i polimeri e le schiume.
Lo sci «millefoglie»
Un moderno sci da competizione ha una struttura a sandwich ottenuta assemblando numerosi materiali, ma il nucleo è tuttora quasi sempre in legno; questa è una singolarità rispetto a ciò che vediamo in altri sport, dal tennis alla vela, dove il legno è stato completamente soppiantato dai materiali compositi.
Nello sci la leggerezza e la flessibilità del legno non hanno ancora trovato un valido sostituto. Soltanto negli ultimi anni alcuni costruttori hanno cominciato a rimpiazzarlo, in alcuni modelli di alta gamma, con schiume polimeriche.
Negli sci di fondo e da salto, dove la leggerezza è particolarmente importante, può comparire anche la fibra di carbonio e nel nucleo il legno può essere affiancato da una struttura a nido d’ape di materiali come il kevlar.
La grande complessità della struttura dello sci, che ha pochi riscontri nelle attrezzature di altri sport, si può comprendere facendo per esempio un paragone con una mountain bike: lo sci deve svolgere da solo la funzione del pneumatico, del telaio, dello sterzo e dell’ammortizzatore. Perciò deve combinare elasticità, maneggevolezza, tenuta, leggerezza, resistenza alla torsione, resistenza all’abrasione e agli urti.
Nunzio Lanotte, Sophie Lem, Sportivi ad alta tecnologia. La scienza che aiuta a costruire i campioni, Zanichelli
Il successo è nei dettagli
Steve Jobs aveva capito come raggiungere un risultato cui tante altre aziende tendono invano: col passare del tempo, i suoi prodotti diventavano sempre più semplici. In alcuni casi, la questione riguarda più l’utente che il prodotto; ogni utente vuole riuscire bene in quello che fa. Come ti senti quando riesci a far funzionare un apparecchio a meraviglia? Più il cliente è soddisfatto, più clienti arriveranno.
Per Steve, nulla va sprecato e non dev’esserci nulla di superfluo. Il segreto è nell’inseguire la perfezione tramite la creatività e l’innovazione, significa concentrarsi su ogni dettaglio, puntando a renderlo di facile comprensione. Il paradosso è che per ottenere questo risultato ci vuole più impegno, una pianificazione più orientata ai dettagli. Certo, a tutti noi capita di concentrarci su qualcosa, di tanto in tanto; ma Steve dedica a ogni dettaglio la stessa profondità di analisi. Visualizza l’obiettivo e poi visualizza il prodotto: come funzionerà, in che modo verrà usato, come si inserirà nel ritmo naturale della vita. Steve voleva vivere l’esperienza in ogni dettaglio. Quando arrivi a casa o in ufficio con il tuo nuovo computer e apri lo scatolone, cosa vedrai? Quanti pezzi di polistirolo devi rimuovere prima di tirare fuori il computer, e quanto è facile rimuoverli?
Steve diceva al team di sviluppo: «D’accordo, io sono il prodotto. Cosa mi succede quando il cliente cerca di tirarmi fuori dalla scatola e accendermi?». Non faceva che scoprire imperfezioni in ogni cosa, dalla progettazione alle strategie pubblicitarie e di vendita.
Rimanevo stregato da quelle esibizioni. Quella sì che era vera passione per i dettagli: una passione unita al coraggio di credere nelle proprie idee e alla certezza di essere il consumatore ideale.
Il mouse sarebbe stato una novità assoluta per gli utenti: come si poteva progettare l’imballaggio in modo che il cliente potesse prendere in mano il mouse fin dal primo momento in cui usciva dalla scatola?
Come possiamo progettare un computer esteticamente piacevole, che il cliente sarà fiero di esibire sulla scrivania? Non dev’essere un brutto parallelepipedo squadrato.
L’utente potrà iniziare subito a usare il computer, senza dover leggere il manuale di istruzioni?
Durante una riunione con i suoi collaboratori, qualcuno ribadì un luogo comune: che il manuale d’istruzioni doveva essere scritto in un linguaggio adatto ad un ragazzo dell’ultimo anno delle superiori. Steve non la prese bene. «No,» ribatté «dev’essere al livello della prima elementare».
Era uno dei suoi sogni, ci disse che il suo computer dovrebbe diventare così intuitivo da non richiedere un manuale di istruzioni.
E poi soggiunse: «Forse dovremmo farlo scrivere a un bambino di prima elementare!».
Sapeva che alcune funzioni non si potevano rendere intuitive; si era arreso all’idea che solo gli apparecchi più semplici potevano essere completamente intuitivi. Ma sapeva anche che se i progettisti e i programmatori si fossero impegnati abbastanza, avrebbero migliorato moltissimo l’usabilità del Mac (e di tutti i prodotti successivi).
Per Steve, il successo risiede nei dettagli.
Steve era affascinato dalla straordinaria anatomia della mano umana, dalla duttilità e agilità con cui si muove insieme al braccio.
A volte, durante una riunione, lo vedevo alzare una mano davanti al viso e ruotarla lentamente: sembrava intento a riflettere su cosa la mano umana è capace di fare. Per dieci o quindici secondi sembrava completamente immerso in quell’esercizio. Ti bastava assistere a quella scena un paio di volte per capire il pensiero che c’era dietro: le dita potevano impartire istruzioni al computer in modo molto più sofisticato che con una semplice tastiera.
Tornava spesso a meditare sulla mano e diceva cose del tipo: «La mano è la parte del corpo che più di ogni altra risponde ai comandi del cervello». Oppure: «Se potessimo replicare la mano, avremmo un prodotto da urlo».
Steve chiese al team di collaudare una serie di periferiche con cui controllare il cursore: c’era una specie di penna, e mi pare che fosse anche una sorta di tablet. Ci mise un po’ a convincersi che niente funzionava bene quanto il mouse.
Jay Elliot, William L. Simon , Steve Jobs. L’uomo che ha inventato il futuro, Hoepli

Tra grotte e foreste
In molte città europee esistono stazioni della metropolitana rese pressoché uniche dagli interventi di architetti e artisti. Fotografie, dipinti e mosaici riescono a caratterizzare gli spazi dando vita, insieme a decorazioni e arredi non di serie, ad ambienti ricchi di colore e di fantasia, capaci di proiettare i viaggiatori in una dimensione diversa rispetto alla quotidianità. Scendere per esempio nella T-Centralen della Tunnelbana, il sistema metropolitano di Stoccolma, significa penetrare in un’immensa caverna dalle sfumature azzurre e decorata con motivi floreali. La fermata di Olaias, a Lisbona, si presenta come una foresta di vetrate variopinte e di colonne metalliche. Anche la stazione Candidplatz di Monaco di Baviera è intonata ai colori dell’arcobaleno, mentre l’ingresso della fermata di Bockenheimer Warte (si legge bochenaimer varte), a Francoforte, sembra una vecchia carrozza del metrò sbucata come per incanto dal terreno. A Barcellona, la stazione di Drassanes si presenta bianca e dalle linee perfette, tale e quale un’astronave. Ma è una stazione italiana, quella di Toledo a Napoli inaugurata nel 2012, che ha conquistato il titolo di “più bella d’Europa”. Merito sia del suo interno, dove prevale il blu marino, che della bassa emissione di anidride carbonica e dell’uso innovativo degli spazi.

Torri che scompaiono
Torri che scompaiono, pareti ricoperte di alghe, tetti a forma di barca. La competizione tra le megalopoli non si limita a costruire il grattacielo più alto del mondo, ma anche a inventare quello più innovativo.
Se prima infatti i grattacieli venivano eretti per ottimizzare lo spazio, oggi rappresentano anche il progresso di una nazione.
Tanti sono ancora in costruzione, ma promettono di essere spettacolari, come la Cheongna City Tower o Tower Infinity a Incheon, nella Corea del Sud. Più che infinita, però, quando nel 2017 verrà completata risulterà invisibile, nonostante i 110 piani e i 450 metri di altezza. Questa torre infatti sarà in grado di “scomparire” grazie a un effetto ottico tecnologico: una serie di telecamere posizionate sulle pareti a tre diverse altezze riprenderà il paesaggio circostante, che verrà proiettato in tempo reale sulle pareti dalla parte opposta dell’edificio, ciascuna ricoperta con 500 file di schermi a Led. In pratica tutto ciò che sta dietro la torre verrà proiettato sulle pareti davanti, dando così l’illusione dell’invisibilità.
I grattacieli moderni, però, sono simbolo di progresso anche nel rispetto della natura: vengono infatti progettati per avere strutture ecosostenibili, per esempio grazie a materiali sensibili alla luce o a terrazzi da cui prendere aria e luce naturali. Ma soprattutto sono studiati per ricreare sistemi autosufficienti di riciclo dell’acqua e di pulizia dell’aria grazie alle piante, come per esempio le fattorie verticali o gli edifici ricoperti di alghe, da erigere nelle zone inquinate. Funzionano come camini: l’aria umida e sporca viene catturata dai materiali-spugna e ossigenata dalle alghe. L’acqua che ne deriva viene poi nebulizzata all’esterno, ripulita dallo smog.
La fissazione con la natura da parte degli architetti a volte genera grattacieli dalle forme zoomorfe: elefanti, koala, bisonti, pesci. Il 30 St. Mary Axe di Londra, per esempio, è più conosciuto con il nome “The Gherkin”, il cetriolo (anche se sembra un missile): gli architetti si sono ispirati al cetriolo di mare per progettarne la forma che, priva di spigoli, non oppone resistenza alle correnti, generando così un sistema di ventilazione naturale che fa passare l’aria da sotto fino al tetto; allo stesso modo l’acqua del mare filtra nel corpo dell’animale e lo ossigena.
In generale un grattacielo è una struttura che vince in altezza rispetto ai palazzi vicini, così come in origine il termine in inglese skyscraper indicava la vela più alta sull’albero di una barca. Quindi si potrebbe definire grattacielo anche la casa in legno alta 43 metri eretta a Arkhangelsk, in Russia.
Il proprietario, Nicolai Sutyagin, ha iniziato a costruirla nel 1992 facendo solo due piani, ma nei quindici anni successivi… si è fatto prendere la mano arrivando a tredici.
Cinquant’anni prima, a Los Angeles, anche Simon Rodia, piastrellista emigrato dall’Italia, aveva realizzato, da solo, un complesso di torri alto 30 metri, su un lotto comprato da un messicano.
«Volevo fare qualcosa di grande» diceva. E ci è riuscito: le torri sono diventate patrimonio nazionale e il suo ritratto compare sulla copertina di “Sgt. Pepper’s lonely heart club band”, un famoso album dei Beatles, accanto ai più grandi personaggi dell’epoca.
«Focus Junior», novembre 2014
Fisica da spiaggia
1. Perché i castelli di sabbia asciutta crollano?
La sabbia asciutta è composta da miliardi di granelli divisi tra loro. In quella bagnata, invece, minuscole goccioline d’acqua di mare legano i granelli gli uni agli altri, che formano così un insieme compatto e modellabile. A mano a mano che il vento e il calore del sole fanno evaporare l’acqua, la sabbia di asciuga e i granelli tornano a separarsi: il castello faticosamente costruito si disgrega!
2. Perché le barche stanno a galla?
Quando fai colazione e la tazza di latte è piena, devi fare attenzione a non inzuppare troppo il pane perché altrimenti trabocca. Questo accade perché la fetta ha preso il posto del latte, che è uscito dalla tazza. Allo stesso modo una barca in mare sposta una quantità di acqua uguale al volume della sua “opera viva” (termine marino che indica la parte della barca che sta sott’acqua). Se raccogliessimo in un serbatoio quest’acqua e la pesassimo, scopriremmo che è uguale al peso dell’intera barca. Questo accade per il “principio di Archimede”, legge della fisica che prende i nome dal suo scopritore, lo scienziato Archimede, che la verificò nel 300 a.C. circa: un corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso verso l’alto uguale al peso del volume di liquido spostato. L’acqua pesa circa 1 kg per litro, quindi la spinta galleggiante sarà più o meno 1 kg per ogni litro d’acqua spostata. Perciò una barca, anche se di ferro, resterà a galla finché il suo peso, con tutto il carico, non supererà il peso del volume dell’acqua che sposta. L’acqua salata, poi, è più densa di quella dolce, quindi a parità di volume pesa di più. Dunque, la sua spinta verso l’alto è maggiore rispetto a quella dell’acqua dolce: per questo al mare si galleggia di più che in piscina!
3. Perché avvicinando le conchiglie all’orecchio si sente il rumore del mare?
Il mare non c’entra, è un effetto fisico e accade anche in montagna. In pratica, alcune parti di un’onda sonora (cioè alcune frequenze) rimbalzano nella cavità della conchiglia e vengono amplificate, dando origine a quel particolare suono, simile a quello che senti se avvicini all’orecchio una mano messa a coppa anziché una conchiglia.
4. Perché al sole ci si abbronza?
La pelle ha delle cellule speciali, i melanociti, che producono una sostanza che assorbe la luce: la melanina (chiamata anche “pigmento scuro dell’epidermide”).
Serve a proteggere il nucleo cellulare dalle radiazioni solari ultraviolette Uva e Uvb, che possono causare arrossamenti, scottature e malattie anche gravi, come

lo. Quindi, per non bruciarci, dobbiamo usare le creme solari, anche se stiamo sotto l’ombrellone (dato che gli Uv riflessi dalla sabbia ci scottano quanto quelli ricevuti direttamente) e nelle giornate nuvolose (il 90% degli Uv attraversa le nuvole). Le popolazioni di pelle chiara hanno lo stesso numero di melanociti di quelle con la pelle scura. La differenza di colore dipende solo dalla minore capacità delle cellule di produrre melanina: insomma, se avessimo melanociti più efficienti, anche noi europei saremmo di pelle scura.
5. Perché la maschera da sub si pulisce con lo sputo?
La nostra saliva contiene sostanze dette enzimi (per esempio la ptialina) che funzionano come una sorta di detersivo e puliscono la parte trasparente della maschera meglio dell’acqua dolce e dell’acqua di mare. In questo modo si evita la formazione di condensa, che la appannerebbe.

6. Perché, se non uso la maschera da sub, sott’acqua vedo sfocato? Semplificando molto possiamo dire che il nostro occhio è regolato per mettere a fuoco nell’aria. Nell’acqua invece, che possiede un diverso indice di rifrazione della luce, l’occhio non riesce a mettere a fuoco le immagini sulla retina bensì più indietro, dunque vediamo sfocato. Indossando la maschera, l’occhio si trova di nuovo a contatto con l’aria, ossia nel suo ambiente naturale, e la sfocatura viene annullata. Il rovescio della medaglia è che pesci e conchiglie appaiono più grandi di circa un terzo e più vicini a noi di quanto siano in realtà. Perciò, se vedi un granchio gigante, non spaventarti: non è un mostro marino ma solo un effetto ottico!
«Focus Junior», settembre 2013
SENZA PAURA
Gabbiani
Non so dove i gabbiani abbiano il nido, ove trovino pace. Io son come loro, in perpetuo volo. La vita la sfioro com’essi l’acqua ad acciuffare il cibo. E come forse anch’essi amo la quiete, la gran quiete marina, ma il mio destino è vivere balenando in burrasca.
Vincenzo Cardarelli
Cantiamo insieme
Inno alla gioia
dalla Sinfonia n. 9 di Beethoven
Questo canto esprime il desiderio di pace e gioia di ogni uomo. È l’inno dell’Unione Europea.
Gioia figlia della luce, Dea dei carmi, Dea dei fior! Il tuo genio te conduce per sentieri di splendor. Il tuo raggio asciuga il pianto, sperde l’ira e fuga il duol!
Vien! Sorridi a noi d’accanto primogenita del sol. Ma da noi ritocca il viso chi la gioia in cuor non ha l’uom che mai non ha sorriso certo in ciel non salirà.


Il soprannome
Al mio paese c’è la brutta usanza di dare soprannomi, spesso stupidi, ingiuriosi e senza senso. Ricordo un ragazzo, per molti anni mio compagno di scuola. Era un orfano, piccolo di statura, tarchiato, e indossava quasi sempre vestiti molto chiari. Chissà per quale motivo, noi cominciammo a chiamarlo: «Caramacco».
Sebbene senza significato, quel nome racchiudeva in sé qualcosa di umiliante e di offensivo; e il mio compagno, udendolo, reagiva sempre con violenza.
In quei momenti, benché fosse piccolo, diventava terribile.
Le cose si complicavano quando giocavamo a «pollo e avvoltoio».
Una volta, facendo questo gioco, ebbi con lui il mio primo ed ultimo scontro. Lui faceva l’avvoltoio, io il pollo. Egli si sforzava di raggiungermi a tutti i costi e, correndo lungo la riva di un torrente, ci allontanammo parecchio dai compagni. Lo feci avvicinare e, quando stava per raggiungermi, con un balzo, saltai sulla riva opposta. Io avevo le gambe lunghe e la manovra fu facile per me. Anche lui tentò di saltare al di là del torrente, ma scivolò e, pataciac, giù nell’acqua, lungo e disteso.
«Ben ti sta. Caramacco!» gli gridai sogghignando.
Infuriato, riprese a correre. Io però riuscii a spiccare un nuovo salto e a ripassare il torrente. E qui lo aspettai. Non vedendolo apparire gli gridai: «Caramacco, e quando arrivi? Sono qua, non mi vedi?».
La mia era vera e propria cattiveria. E l’altro se ne rese conto.
Amareggiato, non si lasciò vedere. Nascosto dietro un arbusto non dava segni di vita. Allora mi preoccupai.
«Che ti succede, amico?» domandai tra giocoso e serio.
Non ricevetti nessuna risposta. Allora m’impensierii veramente.
Ripassai il torrente e mi diressi verso il luogo dove mi sembrava che dovesse trovarsi l’amico. Chiamandolo col suo vero nome gli dissi: «Vincenzo, che hai?».
Alzò la testa e mi guardò. Amare lacrime gli solcavano le guance. Con voce rotta da singhiozzi mi disse: «Perché anche tu mi offendi sempre?».
Fui preso da una grande compassione. Il mio sguardo si posò su un rammendo che aveva sulla giacca e mi venne in mente che quella pezza non era stata la mamma a cucirgliela, perché la mamma non l’aveva più.
Istintivamente gli tesi la mano e gli dissi: «Vincenzo, non lo farò più; ti giuro che non lo farò più».
Egli mi guardò un po’ incredulo, ma leggendo nei miei occhi la sincerità con cui parlavo, mi strinse la mano dicendo: «Lo dici davvero?».
«Te lo prometto, Vincenzo! E non permetterò neanche che te lo dicano gli altri».
Mantenni la promessa e da quel giorno Vincenzo diventò il mio amico più caro.
Prezihov Voranc, I mughetti, La Scuola
Ti è mai capitato di ricevere un soprannome o di usarne uno? Ne sei stato contento o ti sei sentito a disagio? Secondo te, come nasce un soprannome?
Superbia
E dire che Carlo Nobis si pulisce la manica con affettazione quando Precossi lo tocca, passando! Costui è la superbia incarnata perché suo padre è un riccone. Ma anche il padre di Derossi è ricco! Egli vorrebbe avere un banco per sé solo, ha paura che tutti lo insudicino, guarda tutti dall’alto al basso, ha sempre un sorriso sprezzante sulle labbra: guai a urtargli un piede quando s’esce in fila a due a due! Per un nulla butta in viso una parola ingiuriosa o minaccia di far venire alla scuola suo padre. E sì che suo padre gli ha dato la sua brava polpetta quando trattò da straccione il figliuolo del carbonaio! Io non ho mai visto una muffa compagna! Nessuno gli parla, nessuno gli dice addio quando s’esce, non c’è un cane che gli suggerisce quando non sa la lezione. E lui non può patir nessuno, e finge di disprezzar sopra tutti Derossi, perché è il primo, e Garrone perché tutti gli voglion bene. Ma Derossi non lo guarda neppure quant’è lungo, e Garrone, quando gli riportarono che Nobis sparlava di lui, rispose: «Ha una superbia così stupida che non merita nemmeno i miei scapaccioni».
Coretti pure, un giorno ch’egli sorrideva con disprezzo del suo berretto di pel di gatto, gli disse: «Va’ un poco da Derossi a imparare a far il signore!».
Ieri si lamentò col maestro perché il calabrese gli toccò una gamba col piede.
Il maestro domandò al calabrese: «L’hai fatto apposta?».
«No, signore», rispose franco.
E il maestro: «Siete troppo permaloso, Nobis».
E Nobis, con quella sua aria: «Lo dirò a mio padre».
Allora il maestro andò in collera: «Vostro padre vi darà torto, come fece altre volte. E poi non c’è che il maestro, in iscuola, che giudichi e punisca».
Poi soggiunse con dolcezza: «Andiamo, Nobis, cambiate modi, siate buono e cortese coi vostri compagni. Vedete, ci sono dei figliuoli d’operai e di signori, dei ricchi e dei poveri, e tutti si voglion bene, si trattan da fratelli, come sono. Perché non fate anche voi come gli altri? Vi costerebbe così poco farvi benvolere da tutti, e sareste tanto più contento voi pure!… Ebbene, non avete nulla da rispondermi?».
Nobis, ch’era stato a sentire col suo solito sorriso sprezzante, rispose freddamente: «No, signore».
«Sedete», gli disse il maestro. «Vi compiango. Siete un ragazzo senza cuore». Tutto pareva finito così; ma il muratorino, che è nel primo banco, voltò la sua faccia tonda verso Nobis, che è nell’ultimo, e gli fece un muso di lepre così bello e così buffo, che tutta la classe diede in una sonora risata.
Il maestro lo sgridò; ma fu costretto a mettersi una mano sulla bocca per nascondere il riso. E Nobis pure fece un riso; ma di quello che non si cuoce.
Edmondo De Amicis , Cuore, Mondadori
Non appartieni più al male
L’indomani, al sorger del sole, monsignor Bienvenu passeggiava in giardino, quando la signora Magloire accorse, tutta sconvolta.
«Monsignore, monsignore,» gridò. «Sa vostra grandezza dove sia il cesto dell’argenteria?».
«Sì,» disse il vescovo. «Gesù sia benedetto!» ella riprese. «Non sapevo più che ne fosse».
Il vescovo aveva raccattato allora allora il cesto in un’aiuola e lo presentò alla signora Magloire.
«Eccolo».
«Ma come!» ella fece. «Non c’è dentro nulla! E l’argenteria?».
«Ah!» ribatté il vescovo. «Allora è l’argenteria che vi preoccupa. Non ne so nulla».
«Oh, grande e buon Dio! L’hanno rubata! L’ha certo rubata l’uomo di ieri sera!».
E in un batter d’occhio, con tutta la vivacità di vecchietta svelta, la signora Magloire corse all’oratorio, entrò nell’alcova e tornò dal vescovo, che s’era chinato e stava osservando, con un sospiro, una pianta di coclearia dei Guillons che il paniere aveva rotta, cadendo attraverso l’aiuola. Si rialzò al grido della signora Magloire.
«Monsignore! L’uomo è partito e l’argenteria è sparita!».
E, mentre gettava questa esclamazione, i suoi occhi si fissavano sopra un angolo del giardino dove si scorgevan le tracce d’una scalata; la sommità del muro era sgretolata.
«Guardate: se n’è andato di là! È saltato nel vicolo Cochefilet! Che vergogna! Ed ha rubato la nostra argenteria!».
Il vescovo restò un momento silenzioso, poi alzò gli occhi seri e disse con dolcezza alla signora Magloire: «Prima di tutto, era nostra quell’argenteria?».
La signora Magloire rimase stupefatta. Vi fu una pausa ancora, poi il vescovo continuò: «Signora Magloire, da troppo tempo, ed a torto, io mi tenevo quell’argenteria. Essa era dei poveri. Ora, chi era quell’uomo? Evidentemente un povero».
«Oh mio Gesù!» replicò la signora Magloire. «Non parlo per me e per la signorina. A noi fa lo stesso; ma è per monsignore. Con che cosa mangerà monsignore, adesso?».
Il vescovo la guardò con aria stupita. «O bella! Non ci son forse posate di stagno?».
La signora Magloire alzò le spalle. «Lo stagno ha un certo odore…».
«E allora, posate di ferro».
La signora Magloire fece una smorfia significativa. «E il ferro ha un certo sapore!».
«E sia!» disse il vescovo. «Posate di legno».
Poco dopo, egli faceva la colazione mattutina a quella stessa tavola dove Valjean s’era seduto la sera prima. Mentre mangiava, monsignor Bienvenu faceva allegramente notare alla sorella, che non diceva nulla, ed alla signora Magloire, che brontolava fra i denti, che non v’è alcun bisogno di cucchiaio o forchetta, neppur di legno, per intingere un pezzo di pane in una tazza di latte.
«Ma si può immaginare una cosa simile?» diceva fra sé la signora Magloire mentre andava e veniva. «Ricevere un uomo come quello! Dargli alloggio vicino a sé! E meno male che non ha fatto che rubare! Oh, mio Dio, c’è da tremare solo a pensarci!».
Mentre il fratello e la sorella stavano per alzarsi da tavola, bussarono alla porta. «Entrate,» disse il vescovo.
La porta s’aperse con violenza ed un gruppo strano apparve sulla soglia. Tre uomini ne tenevano un quarto per il bavero; tre erano gendarmi, il quarto Jean Valjean. Un brigadiere, che pareva guidasse il gruppo, stava presso alla porta; entrò e s’avanzò verso il vescovo, facendo il saluto militare.
«Monsignore…» disse.
A quella parola, Valjean, ch’era cupo e pareva abbattuto, rialzò il capo con aria stupita.
«Monsignore?» mormorò. «Non è dunque il curato?».
«Silenzio!» disse un gendarme. «È monsignor vescovo».
Intanto monsignor Bienvenu s’era avvicinato con tutta la vivacità concessagli dalla sua tarda età.
«Oh, eccovi!» esclamò, guardando Valjean. «Sono lieto di vedervi. Ma come? V’avevo regalato anche i candelieri che sono d’argento come il resto e dai quali potrete ben ricavare duecento franchi; perché non li avete portati con voi, insieme alle vostre posate?».
Jean Valjean alzò gli occhi e fissò il venerabile vescovo con un’espressione che nessuna lingua umana potrebbe esprimere.
«Allora, monsignore,» disse il brigadiere «sarebbe vero quello che ci ha detto quest’uomo? L’abbiamo incontrato mentre se ne andava come uno che ha molta fretta e l’abbiamo fermato per vedere. Aveva questa argenteria…».
«E v’avrà detto,» interruppe il vescovo sorridendo «che gliel’aveva regalata un vecchio prete dabbene presso il quale aveva passato la notte. Vedo come stanno le cose. E voi l’avete ricondotto qui? È un equivoco».
«Se la cosa sta così,» riprese il brigadiere «possiamo lasciarlo andare?».
«Ma certo,» rispose il vescovo.
I gendarmi lasciarono libero Valjean, che indietreggiò.
«È proprio vero che mi lasciano andare?» disse con voce quasi inarticolata, come se parlasse nel sonno.
«Sì, ti lasciamo in libertà: non hai sentito?» disse un gendarme.
«Amico mio,» rispose il vescovo «prima d’andarvene, ecco i vostri candelieri: prendeteli».
Andò verso il camino, prese i due candelieri d’argento e li portò a Valjean. Le due donne lo guardavano fare senza una parola, un gesto, uno sguardo che potesse disturbare il vescovo. Jean Valjean tremava tutto; prese macchinalmente i due candelieri, con aria smarrita.
«Ed ora,» disse il vescovo «andatevene in pace. A proposito: quando tornerete, amico mio, sarà inutile che passiate dal giardino. Potrete sempre entrare ed uscire dalla porta della strada, che è chiusa giorno e notte solo col saliscendi».
Poi, volgendosi verso i gendarmi, disse loro: «Signori gendarmi, potete andare».
Jean Valjean pareva stesse per svenire. Il vescovo gli si avvicinò e gli disse a bassa voce: «Non dimenticate, non dimenticate mai che m’avete promesso di impiegare questo denaro per diventare un uomo onesto».
Valjean, che non si ricordava d’aver promesso, rimase stupefatto; il vescovo aveva accentuato quelle parole in particolar modo, mentre le pronunciava, e riprese poi con una specie di solennità: «Jean Valjean fratello mio, voi non appartenete più al male, ma al bene. Acquisto la vostr’anima, la tolgo ai cupi pensieri ed allo spirito di perdizione e la do a Dio».
• Chi è Jean Valjean e cosa ha compiuto all’inizio del racconto?
• Perché secondo te il monsignor vescovo finge di avergli regalato tutta l’argenteria, compresi i candelieri?
• Ti è piaciuta la conclusione del racconto?
Lacrime come perle
In sella alla sua lambretta, don Gnocchi fa la spola tra un collegio e l’altro per visitare i suoi “figli”. A Parma incontra Marco che, sfigurato da un ordigno bellico, era stato sottoposto all’amputazione di entrambe le gambe e all’estrazione del bulbo oculare.
Attende la fine delle medicazioni quotidiane, poi, avvicinandosi al lettino, gli chiede: «Quando soffri e ti fanno piangere, a chi pensi?».
«A nessuno» risponde il bambino meravigliato per la stranezza della domanda. A questa risposta il cuore di don Carlo è trapassato come da una ferita mortale. Non si poteva vivere il dolore in una tale solitudine.
Quella miseria andava consegnata a qualcuno. E così va avanti: «Ma tu non credi che ci sia qualcuno al quale poter offrire il tuo dolore, per amore del quale tu potresti inghiottire le lacrime e che potrebbe aiutarti a sentir meno la tua sofferenza?».
Più che per tutto il resto don Carlo desiderava che la sofferenza dei suoi piccini avesse senso.
Così ad un incontro li provoca: «Le vostre lacrime devono diventare perle».
I bambini lo ascoltano incuriositi, chiedendosi come ciò sia possibile. «Prepareremo una cassettina» continua don Carlo. «Quando uno di voi deve, per il suo bene, subire un’operazione chirurgica o un intervento doloroso, soffre. Ebbene, questa sofferenza fisica non deve andare perduta, buttata via come una cosa che non conta niente: bisogna offrirla al Signore, senza piangere, senza gridare. Quando uno di voi sarà riuscito a pensare a Gesù crocifisso che ha sofferto più di qualsiasi uomo, a sopportare senza lamenti la sua operazione, egli avrà diritto di mettere nella cassettina una perla preziosa».
«E poi?» chiedono i bambini sbalorditi.
«Tra un anno conteremo le perline (so che ce ne saranno tante!) e le porteremo da un orefice: egli le userà per foggiare il nostro distintivo, poi lo porteremo al Papa come simbolo della vostra coraggiosa sofferenza».
E l’udienza da Pio XII c’è veramente. Emozionati, i bambini offrono la spilla al Papa mentre don Carlo spiega il significato di quel gioiello, e conclude: «I miei piccoli hanno offerto il loro dolore per lei, Santo Padre, per la Chiesa, per la salvezza di tutte le anime». Pio XII si fa pensoso e si commuove pieno di riconoscenza al pensiero di quanto bene la Provvidenza abbia saputo suscitare attraverso quei bambini.
Anna Leonardi , Padre di una moltitudine di genti, «Tracce», maggio 2000
La signora Carla
Ieri sono stata all’Istituto don Gnocchi e ho fatto compagnia ad un gruppo di anziani e ne ho conosciuti alcuni molto simpatici.
Una signora che mi ha colpito è stata la signora Carla.
Era una signora molto affaticata nel respirare, ma era raggiante quando sono arrivata da lei.
Quello che mi ha colpito di più è stato quando mi ha detto questa cosa: «Sono felice perché ho una nipotina!».
E io: «Come si chiama?».
«Come ti chiami tu?», mi ha chiesto. «Carlotta».
«Bene, allora la mia nipotina si chiama Carlotta!».
Io l’ho guardata un po’ stranamente. Poi lei mi ha spiegato che non aveva nipoti e io ero la prima bambina che conosceva, da anziana.
La cosa più bella è che lei mi ha detto: «Chiamami nonna per cinque minuti!».
A me veniva un po’ da ridere, ma questa frase mi ha fatto capire come questa signora prende in considerazione le cose che il Signore le manda.
Lei non ha nipoti, quindi si muove per averli. Lei non sa cantare ma ha apprezzato molto i nostri canti e ha cercato di cantarli. Insomma: è una signora che non spreca la vita!
classe V
Il fazzoletto bianco
Avevamo una casa bellissima, con muri di mattoni blu scuro come il cielo prima di una tempesta autunnale, e le finestre abbastanza piccole, molto comuni nelle case dei contadini, che si affacciavano sul bosco e le dolci colline che circondavano il villaggio.
Era un villaggio come tanti altri, da quelle parti, con le case tutte in fila lungo le sponde di un ruscello dalle acque limpide che attraversava le colline della
Transilvania, nella regione chiamata Ardeal, là, dove pian piano le cime dei Carpazi si fanno più dolci, lasciando spazio, verso ovest, alla puszta magiara.
Transilvania! Terra misteriosa, fatta di leggende e miti, draghi e vampiri, streghe e malocchi. E foreste: immense e meravigliose foreste.
Io sono nato in quella terra, in quel mondo dimenticato dal tempo, prigioniero dei sogni dei nostri antenati, e, purtroppo, anche degli incubi di qualche dittatore.
Il mio villaggio è un pezzo di storia antica, al riparo dal caos e dalla tecnologia, con gente semplice che si saluta e si fa gli auguri tutte le volte che si incontra per strada, anche se magari non si conosce.
Ma bisogna dire che là tutti si conoscono.
«Che Dio ti aiuti! Che Dio ti benedica!».
Saluto e risposta, semplicità d’anima e di cuore.
Lavorare la terra era la principale attività della gente e nessuno si lamentava: se alla vita si chiede soltanto quel poco che basta e niente di più, non ci sono motivi per lamentarsi, giusto?
Io ho imparato a tagliare l’erba con la falce quando avevo appena sei, sette anni. Mi ricordo bene: la falce era più alta di me, e qualche volta anche l’erba era più alta di me! Dio buono, quant’era faticoso, ma quanto mi piaceva!
Portavo a pascolare le capre, poi le mucche e i bufali, andavo a scuola e prendevo dei buoni voti e i miei erano contenti. La vita da quelle parti e a quei tempi era così: semplice e dura, ma bella da morire!
Non era la necessità a spingere i genitori a far imparare ai figli, fin da piccoli, i lavori dei campi, erano le tradizioni tramandate da padre a figlio, da quasi duemila anni: da quando il mio popolo, il popolo romeno, venne alla luce, saldamente ancorato alle sue radici dacie e romane.
Fare il contadino in Transilvania, a quei tempi, sicuramente non era facile, come non è facile oggi, ma la vita in campagna era straordinaria. Mio papà era un uomo duro, un “generale”, con se stesso e con tutti. Senza ombra di dubbio mi voleva bene; però, quando combinavo qualche ragazzata, e ne combinavo tante, mi dava delle botte tremende. In quei casi, scappavo dagli amici e rimanevo da loro finché le acque non si calmavano.
Il segnale che mi indicava quando potevo rientrare era un piccolo fazzoletto bianco alla finestra, appeso dalla mamma naturalmente all’insaputa del “generale”! In realtà, io credo che lui abbia sempre saputo di questo piccolo stratagemma, ma ha sempre fatto finta di niente.
Il giorno in cui dissi a mio padre che volevo andar via, in cerca di fortuna, chissà dove, la prese male, anche perché ero figlio unico.
«Se vuoi andare, vattene, ma non guardare indietro, non avere rimorsi. Vattene per sempre» mi disse, sopraffatto dalla rabbia e dalla tristezza.
E io, figlio suo, testardo come lui, sono andato. Ogni tanto, voltandomi indietro, ma sono andato.
Nei primi tempi mandai delle lettere, ma i miei genitori non rispondevano mai. Poi, l’orgoglio mi spinse a fare una delle cose più brutte della mia vita: per quasi due anni non mi sono più fatto vivo. Alla fine, però, il contadino che c’era in me, che per fortuna ancora non si era perso del tutto nella fitta nebbia padana, uscì allo scoperto, e gridò tutta la sua rabbia, tutta la tristezza e la malinconia che aveva dentro. Così, decisi di ritornare: come il figliol prodigo, come la pecorella smarrita.
Gli anni vissuti in questo freddo mondo occidentale, mi spinsero però a prendere delle stupide precauzioni. Mandai loro un’altra lettera:
«Voglio tornare! Se mi volete ancora, mamma, nel giorno di Natale, appendi alla finestra un fazzoletto bianco, come facevi quando ero piccolo: mamma, ti ricordi? Se arriverò e non vedrò il fazzoletto alla finestra, vorrà dire che ce l’avete ancora con me, e allora tornerò sui miei passi e non mi vedrete mai più!» Detto e fatto. Il giorno di Natale arrivai al villaggio. Erano passati due anni dalla mia fuga.
Decisi di fare a piedi i due, tre chilometri che mancavano alla nostra casa. Man mano che mi avvicinavo, il cuore mi batteva sempre più forte. Speravo con tutta l’anima di trovare il fazzoletto bianco appeso alla finestra. Mancava poco, dovevo girare l’angolo e la nostra casa si sarebbe vista in lontananza. Girai l’angolo e… la casa non c’era più: la nostra casa di mattoni blu come il cielo prima della tempesta autunnale era sparita. Al suo posto c’era un’altra casa, con muri bianchi e senza finestre. Il cuore mi si fermò e mille domande mi franarono addosso come pesanti pietre: «Forse l’hanno ristrutturata o magari ne hanno costruita un’altra, o forse l’hanno venduta, o forse… oh Dio, no, questo no!». Decisi di andare avanti comunque, per vedere, per capire… Mi misi a correre con il cuore in gola e quando finalmente arrivai vicino, capii tutto. Non era un’altra casa e non era nemmeno bianca: era sempre la nostra casa di mattoni blu come il cielo prima della tempesta, ma i miei – la mia povera mamma e il mio duro “generale”–, temendo che un fazzoletto fosse troppo piccolo per essere visto da lontano, avevano tirato fuori tutte le lenzuola e tutti i panni bianchi che avevano, stendendoli dappertutto, sui muri, sulle finestre, sul tetto.
Viorel Boldis, Antonella Toffolo, Il fazzoletto bianco, Topipittori
Riassumi il testo.
L’altalena di Kito
Avevo otto anni e guardavo la mia altalena rossa lasciata sul retro della capanna. Potevo leggere ancora il mio nome scritto dalla mamma sul copertone nero: Kito. Ero diventato grande e non la usavo più. Ricordai quando papà, tornato dal lavoro con un bel gruzzoletto, era corso a comprare la ruota e la corda alla rivendita del mercato del villaggio. Dipinse la ruota di rosso e la legò con la corda all’albero sul retro. Saltavo di gioia e dondolavo con il mio fratellino Otieno, seduto sulle mie gambe. La mamma ci seguiva col fiatone per tenere in equilibrio il piccolo Otieno che rideva come un matto.
Poi un giorno scoppiò la guerra, mamma e papà volarono in cielo e noi non abbiamo più giocato con l’altalena rossa. Otieno ed io siamo stati sempre fortunati: non avevamo bisogno di lavorare nelle piantagioni di tè, come facevano tanti bambini del quartiere. Andavamo a scuola e la mamma era sempre stata fiera di noi. Quando però mi sono ammalato, mi vergognavo un po’ ad andarci perché non volevo che gli altri bambini vedessero le piaghe che la malattia mi lasciava sulla pelle. Così ogni tanto saltavo le lezioni e le pagelle andavano sempre peggio.
Quel giorno a scuola non c’ero andato. L’altalena era coperta di polvere e penzolava raschiando la terra. Provai a raddrizzare la ruota e soffiai via la terra. Poteva andare bene per Otieno… avrei dovuto pulirla, sistemarla e regalarla a lui, perché ricominciasse a giocare nel cortile. Bussarono alla porta. Era la signora Rita, preoccupata perché da tre giorni non mi vedeva in classe. Mi portava le medicine settimanali e un chilo di riso. Quella volta, però, aveva una notizia speciale: una coppia italiana voleva occuparsi di me e mi avrebbe sostenuto per l’intero anno scolastico. Si chiamavano Pietro e Angela. Proprio dei bei nomi! Ero contento e ringraziavo, mentre leggevo la lettera e guardavo la loro foto. Sorridevano e mi scrivevano che, anche se non mi avevano mai visto, mi volevano già bene come se fossi stato figlio loro. La scuola mi piaceva e poter continuare a studiare mi riempiva di speranza. Poi ripensai per un attimo alla vergogna di stare in mezzo agli altri bambini… e Rita si accorse che ero tanto triste. Mi lasciò con una promessa:
«Tornerò presto, Kito, e porterò con me buone notizie!».
Una novità, in effetti, arrivò in poche settimane.
Una nuova maestra si sarebbe curata di me soltanto, tutto il giorno, anche a casa dopo le lezioni. Mi avrebbe aiutato con i compiti e seguito in ogni passo della scuola. Mi sembrava una bella notizia, ma ancora non capivo bene se esserne davvero felice… Finché la conobbi! Entrò in casa mia e la feci accomodare vicino al letto dove avevo preparato i quaderni e i libri, pronto per studiare.
«Ma che bravo! Allora studiare ti piace davvero!» mi disse dolcemente.
«In matematica me la cavo, ma con geografia mi confondo un pochetto», dissi sospirando.
«Dove si trova il Ruanda?» mi chiese.
«Ehm, nell’Africa… orientale!» risposi con mia sorpresa.
«E l’Africa dove si trova?».
«Beh… sulla Terra, direi».
«Bravo, Kito. Vedi che non sei poi così tanto confuso?».
Si chiamava Angelique! Lo stesso nome di Angela, la mamma italiana.
Non mi sembrò una coincidenza e subito quella nuova maestra mi piacque parecchio. Poi, quando mi diede una carezza sul viso, prima di andare via, mi piacque ancora di più. Nessuno lo faceva più da tempo e, anche se all’inizio mi vergognai un po’, presto mi lanciai in una lunga stretta tra le sue braccia. Pensai che quel nome le stesse a meraviglia.
Da quel giorno io, Otieno e Angelique diventammo inseparabili: ci aiutava con i compiti e ci metteva a studiare duramente, ma ci insegnava anche a riordinare la casa e a farla più accogliente. Un giorno arrivò alla capanna con due morbidi materassi nuovi di zecca. Altro che paglia!
Ci spiegava come prepararci da mangiare e come cucinare piatti sani, mi portava con lei al mercato, dove imparavo a fare la spesa, e mi diede una crema che mi toglieva i segni dalla pelle.
Ero al settimo cielo, finalmente correvo a scuola tutti i giorni e giocavo con gli altri bambini, andavo spesso a casa di Angelique e stavo con i suoi figli che avevano la mia età. Quando ci invitava a pranzo la domenica, per me e Otieno era come stare in una seconda meravigliosa famiglia.
La mia vita all’improvviso era cambiata: ripulii l’altalena, ripassai la vernice rossa sul copertone e comprai una nuova corda più forte.
Il giorno del compleanno di Otieno ci fu una grande festa e gliela mostrai ben infiocchettata. Era felicissimo e lo ero anche io.
Dondola ancora senza sosta nel cortile sul retro sulla sua magnifica altalena rossa.
Maria Serra, Un sorriso per sempre. Storie di incontri che cambiano la vita, Piccola Casa Editrice
La gita di prima media
Auggie è un ragazzo normale, ma con una faccia… straordinaria! Nato con il volto deforme, protetto dalla sua meravigliosa famiglia per i primi dieci anni della sua vita, adesso, per la prima volta, deve affrontare la scuola. Chi gli siederà vicino? Chi lo guarderà dritto negli occhi? Auggie è sfortunato, ma tenace e sa vedere il lato buffo delle cose. Riuscirà a convincere i suoi compagni che lui è proprio come loro, nonostante le apparenze?
Ogni anno in primavera gli alunni di prima media della Beecher Prep vanno via per tre giorni e due notti, in un posto che si chiama Broarwood Nature Reserve in Pennsylvania. Il viaggio in pullman dura quattro ore. I ragazzi dormono in piccole casette – tipo bungalow – con tanti letti a castello. Fuochi di bivacco, marshmallow arrostiti sul fuoco e lunghe passeggiate nei boschi.
I prof ci hanno preparati a questo per tutto l’anno, per cui tutti i ragazzi di prima non stanno più nella pelle… eccetto me. Non è che io non sia entusiasta, perché in un certo senso lo sono; è solo che non ho mai dormito prima fuori di casa e sono un tantino preoccupato.
La maggior parte dei miei compagni ha già fatto dei pigiama party a casa degli amici. Molti sono stati in campeggio, o sono rimasti a dormire dai nonni o che so io. Ma non io. A meno che non si tenga conto dei miei numerosi soggiorni in ospedale, ma anche in quel caso la mamma e il papà sono sempre rimasti con me la notte.
La sera prima del grande viaggio la mamma mi ha aiutato a preparare la valigia. Abbiamo appoggiato sul letto tutti i vestiti che volevo portare e lei ha ripiegato tutto per bene e lo ha infilato nel borsone mentre io stavo a guardare. Era di stoffa blu, per inciso: né scritte né disegni.
«E se la sera non riesco ad addormentarmi?» ho chiesto.
«Portati un libro. Se non riesci a dormire puoi tirare fuori la torcia e leggere un pochino, finché non ti viene sonno» mi ha risposto la mamma.
Ho annuito: «E se faccio un incubo?».
«Ci saranno gli insegnanti, tesoro» ha ribattuto lei. «E Jack e i tuoi amici».
«Potrei portare Baboo» ho buttato lì. Era il mio animale di peluche preferito quando ero piccolo. Un orsetto nero con un morbido naso nero.
«Però non ci dormi più con lui, giusto?» ha obiettato la mamma.
«No, però lo tengo nell’armadio casomai mi svegliassi nel cuore della notte e non riuscissi a riaddormentarmi» ho detto. «Potrei nasconderlo in valigia. Non lo saprebbe nessuno».
«Allora facciamo così» la mamma ha annuito, togliendo Baboo dall’armadio.
«Quanto vorrei che si potessero portare i cellulari» ho detto poi.
«Lo so, anch’io!» ha detto la mamma. «Anche se so che ti divertirai un sacco Auggie. Sicuro che vuoi che metta nella borsa anche Baboo?».

«Sì, ma ben in fondo dove nessuno lo possa vedere» ho detto.
La mamma ha ficcato Baboo in fondissimo e poi ci ha messo sopra l’ultima maglietta. «Un bel po’ di vestiti, per appena due giorni».
La mamma si è seduta sul letto.
«In ogni caso tesoro, devi promettermi che non ti dimenticherai di mettere lo spray antizanzare, d’accordo? Sulle gambe soprattutto quando farete le passeggiate nei boschi. È proprio qui nella tasca anteriore».
«Uh, uh».
«E mettiti anche la crema da sole. Non vorrai scottarti. E, te lo ripeto, non dimenticare di toglierti gli apparecchi acustici se andrete a nuotare».
«Resterei fulminato?».
«No, ma ti fulminerebbe tuo padre perché quegli affari costano una fortuna!» ha risposto lei ridendo.
«E se mi fa schifo, là?».
«Ti divertirai, Auggie».
Ho annuito. La mamma si è alzata e mi ha stampato un rapido bacio sulla fronte. «Bene, ma adesso dico che ora di andare a letto».
Il giorno dopo mi sono svegliato davvero presto. Era ancora buio in camera mia e persino più buio fuori anche se sapevo che presto sarebbe stato mattino.
A poco a poco la stanza ha cominciato a rischiararsi. Ho allungato la mano per prendere la cuffia con gli auricolari e me la sono messa, e adesso sì che il mondo

era davvero sveglio. Mi sono alzato dal letto, e sono andato alla scrivania e ho scritto un bigliettino per la mamma. Poi sono andato in soggiorno dove il mio borsone era posato vicino alla porta; l’ho aperto e ci ho frugato dentro, finché non ho trovato quello che cercavo.
Ho riportato Baboo in camera mia, l’ho appoggiato sul letto e gli ho attaccato sul petto il bigliettino per la mamma con un pezzetto di scotch. Quindi ho tirato su le coperte, di modo che la mamma lo trovasse solo più tardi. Sul bigliettino c’era scritto:
Cara mamma, non avrò bisogno di Baboo, ma se sentirai la mia mancanza puoi tenertelo vicino tu.
xo Auggie
Il pullman sfrecciava via velocissimo. Mi sono seduto accanto al finestrino e Jack era seduto vicino a me, sul sedile del corridoio. Summer e Maya erano davanti a noi. Tutti erano di ottimo umore. Gran confusione, un sacco di risate.
Siamo arrivati alla riserva naturale intorno a mezzogiorno. La prima cosa che abbiamo fatto è stata mettere le nostre cose nei bungalow. C’erano tre letti a castello in ogni stanza, così abbiamo fatto sasso, carta, forbici per la cuccetta più in alto e ho vinto io. Yuppi!
I nostri compagni di stanza erano Reid e Tristan, Pablo e Nino.
Dopo aver pranzato nell’edificio principale, siamo andati tutti a fare un giro
guidato nel bosco per due ore. Ma non era un bosco tipo quello del Central Park: era un bosco vero. Alberi giganteschi che bloccavano quasi completamente la luce del sole. Grovigli di foglie e tronchi caduti. Ululati e cinguettii e canti di uccello a squarciagola. C’era anche una specie di nebbiolina, come un fumo azzurro chiaro, che ci avvolgeva. Forte.
La guida ci indicava e spiegava tutto. I diversi tipi di albero accanto a cui passavamo, gli insetti rintanati nei tronchi sul sentiero, le tracce del passaggio di cervi e orsi, quali tipi di uccelli stavano fischiando e dove cercarli.
Mi sono reso conto che i miei auricolari da robot mi permettevano di sentire davvero molto meglio della maggior parte degli altri, perché il più delle volte ero proprio io il primo a individuare il canto di un nuovo uccello.
Quando ci siamo di nuovo incamminati verso la base, ha cominciato a piovere. Ho tirato fuori il poncho e mi sono tirato su il cappuccio così gli apparecchi acustici non si sarebbero bagnati, ma quando abbiamo raggiunto il bungalow jeans e scarpe si erano inzuppati completamente. È stato divertente però. E una volta in camera abbiamo fatto una battaglia tirandoci le calze bagnate.
Dato che ha continuato a piovere per il resto della giornata abbiamo trascorso la maggior parte del pomeriggio a fare gli stupidi nella stanza dei giochi. C’erano un tavolo da ping-pong e vecchi videogiochi con cui ci siamo divertiti fino all’ora di cena. Per fortuna a quel punto aveva smesso di piovere perciò abbiamo potuto far da mangiare su un vero fuoco da campo. I tronchi per sedersi erano ancora un po’ bagnati, ma ci abbiamo messo sopra le giacche e siamo stati lì vicino al fuoco, ad arrostire marshmallow e a mangiare i migliori hot-dog abbrustoliti che avessi mai assaggiato in vita mia.
Mi è piaciuto un sacco stare lì intorno al fuoco dopo che aveva fatto buio. Mi piaceva il modo in cui le scintille infuocate volteggiavano verso il cielo e sparivano nell’area della notte. E come il fuoco illuminava le facce delle persone. Mi piaceva anche rumore che faceva, il fuoco. E come gli alberi fossero talmente scuri che intorno a te non potevi vedere niente, e se guardavi in su, vedevi invece un trilione di stelle. Il cielo non sembra lo stesso di North River Height. Ne ho visto uno simile a Mountauk, però: come se qualcuno avesse cosparso di sale una lucida tavola nera.
Quando siamo rientrati ero così stanco che non ho avuto bisogno di tirar fuori il libro per leggere. In pratica mi sono addormentato nell’attimo stesso in cui la mia testa ha toccato il cuscino.
E forse mi sono sognato delle stelle, non so.
R.J. Palacio, Wonder, Giunti
Amici nonostante la guerra
In un orfanotrofio libanese due ragazzini stringono amicizia: Nassim ha perso la famiglia durante un bombardamento, Jad, che ha ancora il padre, prende sotto la sua protezione il compagno “doppiamente orfano”. Jad offrirà al suo amico un’amicizia piena e sincera, fino a condividere con lui il suo bene più grande: il suo papà.
L’urlo della guerra
Per quanto a lungo io possa vivere, la guerra rimarrà per me l’incarnazione dell’inferno; è stata lei a farmi conoscere la morte quando cominciavo appena a rendermi conto di esistere.
Lei mi ha fatto conoscere il baratro del “mai più” quando la presenza dei miei cari mi sembrava eterna come l’amore.
Lei mi ha rubato il mio villaggio, la mia casa, la mia famiglia.
Lei mi ha gettato – me come tanti altri – sulle vie che non portano in alcun luogo, avendo come unico bagaglio il gelo di una brutale amputazione e dei ricordi minati dalla sofferenza, dalla distanza e dal silenzio, la sete di una presenza fisica, di quei gesti che danno vita e forma alla tenerezza, di quelle parole che l’adornano come un diadema.
Non sapevo che un villaggio fosse così fragile. Non sapevo che si potessero distruggere case e persone così facilmente come se fossero birilli.
Dov’era la mia casa? Dov’era mio padre? I miei fratelli e le mie sorelle? Dov’erano i miei nonni? Inghiottiti anche loro dal silenzio della morte?
Perché non mi rispondevano, loro, la cui voce bastava da sola a farmi palpitare di tenerezza? Perché mi lasciavano solo, me, il più piccolo, il loro piccolo? Perché mi lasciavano solo?
Solo!
Il loro silenzio mi sommerse come una marea di morte. Fu allora che urlai contro la morte. Urlai. Fino a che la mia voce non raggiunse il suo silenzio.
Da un giorno all’altro mi trovai in un orfanotrofio. Come ci sono arrivato? Chi mi ci ha condotto? Non me lo ricordo. E ricordo soltanto la grande porta che si richiude alle spalle di due figure grigie.
Jad
Jad, è a te e per te che scrivo.
Perché, dopo la scomparsa dei miei, sei stato il solo ad avermi voluto bene col cuore di una madre.
Sì Jad, proprio con il cuore di una madre.
Eppure avevi soltanto sette anni. Come me. Ed eri orfano. Come me.
Solo che tu avevi ancora tuo padre: profugo, disoccupato, povero, ferito… Ma vivo!
Tu eri dolce e vivo come uno scoiattolo.
E chiacchierone.
Lo sa Allah se tu eri chiacchierone!
Mi avresti detto, un giorno: «Bisognava pure che parlassi per due!».
Non hai aggiunto: «E che amassi per due e vivessi per due!».
Ed è proprio quello che hai fatto: ecco perché dico che mi hai amato con cuore di una madre.
Quando un ragazzino si alza di notte perché un altro bambino piange, l’abbraccia e gli dice semplicemente: «Piangi, Nassim, ma io ti sorrido…» a sette anni, Jad, questo è il massimo della comprensione, della partecipazione… dell’amore.
E sorridevi, Jad. Avevi le lacrime agli occhi e nella voce, ma sorridevi. Coraggiosamente, con calore, in modo meraviglioso.
Mi avevano messo vicino a te in classe, nel refettorio e nella cappella; nel dormitorio occupavi il letto vicino al mio, a destra.
Ma chi avrebbe mai potuto fermare le tue chiacchiere? Tu, anche se fossi stato solo su un’isola deserta, avresti parlato alle onde, alle nuvole, al vento, a te stesso.
Fu forse per compensare il fatto che io ero muto che le suore ci avevano sistemato fianco a fianco? O fu per la tua dolcezza e per la tua gentilezza tanto evidenti, tanto vere da poter intaccare – loro sole – il mio silenzio?
Fratelli per sempre
«Sto per dirti una cosa per la quale smetterai di piangere, sai? Ascoltami Nassim: papà ci porta con sé tutti e due, per sempre».
«Tutt’e due, per sempre?».
Impiegai un’eternità per capire.
Il mio cuore si apriva. Il cielo si apriva. La terra si apriva. Tutto l’universo era un scampanìo di Pasqua, un cantico di Natale e sole… sole…
Papà, mamma! Ora finalmente ritrovavo i vostri volti vivi e l’amore che voi avevate installato in me riprendeva vita. Allah! Che voglia di vivere… Per sempre. Anche se la guerra mi aveva insegnato che “sempre” poteva sparire in un attimo.
Ma sempre non aveva più importanza, quando ogni secondo pieno d’amore portava in sé l’eternità.
Tutto ciò lo avvertivo in modo confuso. Tuttavia, per mezzo di questa felicità favolosa che mi arrivava mentre fuori tuonava la guerra, io seppi, in modo profondo e definitivo, quello che volevo nella vita: volevo essere vivo… vivo… vivo… e disponibile per gli altri, come mio padre e mia madre, come il mio villaggio, come Jad e il suo meraviglioso papà… mano che semina, miete e dissolve… sì, anche la guerra.
Guardai Jad. Sembrava deluso e triste:
«Ma come, è tutto qui? Invece di saltare di gioia, continui a piangere? Non è giusto! Non hai capito che siamo diventati due veri fratelli per sempre?».
Oh Jad, Jad! Mio vero, mio meraviglioso fratellino, la mia gioia era troppo forte perché la si potesse esprimere con le parole; ci voleva ancora un po’ di tempo per finire di sgelare il mio cuore. Ma se tu avessi saputo come avevo bisogno di te, della tua dolcezza e della tua gentilezza così vere e spontanee, delle tue chiacchiere, dei tuoi gesti di insofferenza, dei tuoi Yalla!, dei tuoi «Ya Mar Elias, ma cosa ti ho mai fatto perché mi rifilassi un simile idiota!».
Sì, piangevo. Lacrime brillanti e serene come un sorriso. Lacrime come preghiere. Lacrime dedicate ai miei genitori, a Dio, a tuo padre (“mio” padre su questa terra, che Allah lo conservi sempre su di noi e lo colmi di pace d’amore!) e a te, Jad, ragazzino dal cuore di madre, che mi hai dato tanto.
Piangevo e balbettavo:
«Jad, sei mio fratello davvero?».
E tu, di nuovo insofferente, di nuovo a te stesso, piccolo scoiattolo dispensatore di tenerezze, sei balzato in piedi e mi hai tirato per un braccio:
«Se te lo dico! Ya Mar Elias, cosa ti ho mai fatto perché tu mi rifilassi un simile idiota? Yalla, ma sbrigati!… Ci aspetta!».
Mansour Labaky, Amici nonostante la guerra, Edizioni Paoline
Partenza per la Turchia
Un pomeriggio, di venerdì, che come ho già detto, era il nostro giorno per fare quello che ci pareva e che io passavo in un eterno e incommensurabile – si dice così? – campionato di calcio contro le squadre delle fabbriche vicine, ecco, un venerdì questo mio amico con cui avevo parlato a cena dei trafficanti, si è avvicinato alla pietra dov’ero sdraiato per riprendere il fiato, con una mano sulla pancia, e mi ha detto se avevo voglia di ascoltarlo un secondo.
Mi sono tirato su. Non era solo. C’erano altri afghani assieme a lui.
Mi ha detto: «Senti, Enaiat. Abbiamo parlato. Vogliamo partire per la Turchia, e abbiamo messo da parte abbastanza soldi per pagare il viaggio e per pagarlo anche a te, se ti fa piacere. E non lo facciamo solo per la fratellanza eccetera», ha detto, «ma anche perché quando si parte insieme a degli amici le possibilità che tutto vada bene sono maggiori di quando si parte da soli, senza nessuno cui chiedere aiuto in caso di pericolo».
Poi ha fatto una pausa, mentre la squadra che era scesa in campo dopo di noi ha segnato e tutti hanno urlato per la gioia. «Che ne dici?».
«Che ne dico?».
«Sì».
«Che vi ringrazio e accetto. Cos’altro posso dire?».
«È un viaggio pericoloso, lo sai?».
«Lo so».
«Molto più pericoloso degli altri».
La palla è rimbalzata contro la pietra e si è fermata contro i miei piedi. L’ho rispedita indietro con un calcio, con la punta della scarpa.
Il sole aveva afferrato ogni angolo del cielo, l’azzurro non era azzurro, ma giallo, le nuvole dorate e sanguinanti per le ferite inferte dai monti. Dove i massi stritolano. Dove la neve taglia e soffoca.
Ancora non lo sapevo che la montagna uccide.
Ho strappato un filo d’erba secca e ho cominciato a succhiarlo.
«Non ho mai visto il mare», ho detto. «Ci sono un sacco di cose che non ho ancora visto nella mia vita e che vorrei vedere, e se a questo aggiungiamo che anche a Qom, anche qui, ogni volta che metto piede fuori dalla fabbrica, anche qui è pericoloso. Beh, sapete cosa vi dico? Sono pronto a tutto».

La voce era ferma. Ma per la mia inconsapevolezza. Avessi saputo cosa mi attendeva, non sarei partito.
O forse sì.
Non lo so.
Di certo lo avrei detto in un altro modo.
Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah

• Hai sentito parlare dei “viaggi della speranza” con i quali migliaia di persone fuggono da guerre, carestie e povertà per cercare un luogo dove poter ricominciare una nuova vita?
• Secondo te quali sacrifici e dolori dovranno sopportare lasciando la loro terra e i loro affetti?
• Porta a scuola un articolo di giornale che racconti un fatto di cronaca su questo argomento.
DESCRIVERE LA PERSONA
Autoritratto
Capel bruno, alta fronte, occhio loquace, naso non grande e non soverchio umile, tonda la gota e di color vivace, stretto labbro e vermiglio, e bocca esile. Lingua or spedita or tarda, e non mai vile, che il ver favella apertamente, o tace; giovin d’anni e di senno, non audace; duro di modi, ma di cuor gentile. La gloria amo e le selve e il biondo Iddio; spregio, non odio mai; m’attristo spesso; buono al buon, buono al tristo, a me sol rio.
A l’ira presto, e più presto al perdono; poco noto ad altrui, poco a me stesso: gli uomini e gli anni mi diran chi sono.
Alessandro Manzoni
Ascoltiamo insieme
Pedro Pedreiro di Chico Barque de Hollanda
La canzone racconta la vita di Pedro, che attende sempre qualcosa: il tram, una vincita, un figlio... Alla fine qualcosa inizia ad arrivare. È un samba, una musica che con il suo ritmo riecheggia il ritmo del cuore.


Giuseppe
Giuseppe aveva presto imparato a camminare per la casa sulle ginocchia e sulle mani, a imitazione di Blitz, che forse fu il suo maestro.
L’uscio dell’ingresso, per lui, era lo sbarramento estremo dell’universo, come le Colonne d’Ercole per gli antichi esploratori.
Era infagottato, per ripararsi dal freddo, in vari cenci di lana che lo facevano sembrare un poco più tondo, come i cuccioli nel loro pelo.
Il disegno del suo viso ormai si precisava con evidenza. La forma del nasino cominciava a profilarsi, diritta e delicata; e i tratti, puri nella loro minuzia, ricordavano certe piccole sculture.
Non s’era mai vista una creatura più allegra di lui. Tutto ciò che vedeva intorno lo interessava e lo animava gioiosamente. Mirava esilarato i fili della pioggia fuori della finestra, come fossero coriandoli e stelle filanti multicolori. E se, come accade, la luce solare, arrivando indiretta al soffitto, vi portava, riflesso in ombre, il movimento mattiniero della strada, lui ci si appassionava senza stancarsene: come assistesse a uno spettacolo straordinario di giocolieri cinesi che si dava apposta per lui.
Una delle prime parole che imparò fu ttelle (stelle).
Però chiamava ttelle anche le lampadine di casa, i derelitti fiori che Ida portava da scuola, i mazzi di cipolle appesi, perfino le maniglie delle porte, e in seguito anche le rondini.
Poi quando imparò la parola dondini (rondini) chiamava dondini pure i suoi calzettoni stesi ad asciugare su uno spago.
E a riconoscere una nuova ttella (che magari era una mosca sulla parete) o una nuova dondine, partiva ogni volta in una gloria di risatine, piene di contentezza e di accoglienza, come se incontrasse una persona della famiglia.
Elsa Morante, La Storia, Einaudi
• Sottolinea nel testo con colori diversi la descrizione fisica, gli aspetti del carattere e il linguaggio usato da Giuseppe.
• Quali sono gli oggetti che Giuseppe chiama “ttelle”?
• Quali sono gli oggetti che Giuseppe chiama “dondine”?
I miei compagni
Il ragazzo che mandò il francobollo al calabrese è quello che mi piace più di tutti, si chiama Garrone, è il più grande della classe, ha quasi quattordici anni, la testa grossa, le spalle larghe; è buono, si vede quando sorride; ma pare che pensi sempre come un uomo. Ora ne conosco già molti dei miei compagni. Un altro mi piace pure, che ha nome Coretti, e porta una maglia color cioccolata e un berretto di pelo di gatto: sempre allegro, figliuolo di un rivenditore di legna, che è stato soldato nella guerra del 66, nel quadrato del principe Umberto, e dicono che ha tre medaglie. C’è il piccolo Nelli, un povero gobbino, gracile e col viso smunto. C’è uno molto ben vestito, che si leva sempre i peluzzi dai panni, e si chiama
Votini. Nel banco davanti al mio c’è un ragazzo che chiamano il muratorino, perché suo padre è muratore; una faccia tonda come una mela con un naso a pallottola: egli ha un’abilità particolare, sa fare il muso di lepre, e tutti gli fanno fare il muso di lepre, e ridono; porta un piccolo cappello a cencio che tiene appallottolato in tasca come un fazzoletto. Accanto al muratorino c’è Garoffi, un coso lungo e magro col naso a becco di civetta e gli occhi molto piccoli che traffica sempre con pennini, immagini e scatole di fiammiferi, e si scrive la lezione sulle unghie, per leggerla di nascosto. C’è poi un signorino, Carlo Nobis, che sembra molto superbo, ed è in mezzo a due ragazzi che mi sono simpatici: il figliuolo d’un fabbro ferraio, insaccato in una giacchetta che gli arriva al ginocchio, pallido che par malato e ha sempre l’aria spaventata e non ride mai; e uno coi capelli rossi che ha un braccio morto, e lo porta appeso al collo: suo padre è andato in America e sua madre va attorno a vendere erbaggi. È anche un tipo curioso il mio vicino di sinistra, – Stardi, – piccolo e tozzo, senza collo, un grugnone che non parla con nessuno e pare che capisca poco, ma sta attento al maestro senza batter palpebra, con la fronte corrugata e coi denti stretti: e se lo interrogano quando il maestro parla, la prima e la seconda volta non risponde, la terza tira un calcio. E ha daccanto una faccia tosta e trista, uno che si chiama Franti che fu già espulso da un’altra Sezione. Ci sono anche due fratelli, vestiti eguali, che si somigliano a pennello, e portano tutti e due un cappello alla calabrese, con una penna di fagiano. Ma il più bello di tutti, quello che ha più ingegno, che sarà il primo di sicuro anche quest’anno, è Derossi; e il maestro, che non l’ha già capito lo interroga sempre. Io però voglio bene a Precossi, il figliuolo del fabbro ferraio, quello della giacchetta lunga, che pare un malatino. Dicono che suo padre lo batte; è molto timido, e ogni volta che interroga o tocca qualcuno dice: «Scusami», e guarda con gli occhi buoni e tristi. Ma Garrone è il più grande e il più buono. Edmondo De Amicis , Cuore, Mondadori
«La mia classe: una compagnia di amici coi quali ho condiviso tanti momenti ed esperienze». Presenta la tua classe, descrivi alcuni compagni, racconta un’esperienza significativa che hai vissuto con la tua classe.
Il mio amico Garrone
Non furon che due giorni di vacanza, e mi parve di stare tanto tempo senza riveder Garrone. Quanto più lo conosco, tanto più gli voglio bene, e così segue a tutti gli altri, fuorché ai prepotenti, che con lui non se la dicono, perché egli non lascia far prepotenze. Ogni volta che uno grande alza la mano su uno piccolo, il piccolo grida: «Garrone!» e il grande non picchia più. Suo padre è macchinista della strada ferrata; egli cominciò tardi le scuole, perché fu malato due anni. È il più alto e il più forte della classe, alza il banco con una mano, mangia sempre, è buono. Qualunque cosa gli domandino, matita, gomma, carta, temperino, impresta tutto; e non parla e non ride in iscuola: se ne sta sempre immobile nel
banco troppo stretto per lui, con la schiena arrotondata e il testone dentro le spalle; e quando lo guardo, mi fa un sorriso con gli occhi socchiusi, come per dirmi: «Ebbene, Enrico, siamo amici?».
Mi fa ridere, grande e grosso com’è, che ha giacchetta, calzoni, maniche, tutto troppo stretto e troppo corto, un cappello che non gli sta in capo, il capo rapato, le scarpe grosse, e una cravatta sempre attorcigliata come una corda. Caro Garrone, basta guardarlo in viso una volta per prendergli affetto.
Tutti i più piccoli gli vorrebbero essere vicini di banco. Sa bene l’aritmetica. Porta i libri a castellina, legati con una cinghia di cuoio rosso. Ha un coltello col manico di madreperla che trovò l’anno scorso in piazza d’armi, e un giorno si tagliò un dito fino all’osso, ma nessuno in iscuola se ne avvide, e a casa non rifiatò per non spaventare i parenti.
Qualunque cosa si lascia dire per celia, e mai non se ne ha per male; ma guai se gli dicono: «Non è vero» quando afferma una cosa: getta fuoco dagli occhi allora, e martella pugni da spaccare il banco. Sabato mattina diede un soldo a uno della prima superiore, che piangeva in mezzo alla strada, perché gli avevano preso il suo e non poteva più comprare il quaderno. Ora sono tre giorni che sta lavorando attorno a una lettera di otto pagine con ornati a penna nei margini, per l’onomastico di sua madre, che spesso viene a prenderlo, ed è alta e grossa quanto lui, e simpatica. Il maestro lo guarda sempre, e ogni volta che gli passa accanto gli batte la mano sul collo, come a un buon torello tranquillo. Io gli voglio bene. Sono contento quando stringo nella mia la sua grossa mano, che par la mano di un uomo. Sono così certo che rischierebbe la vita per salvare un compagno, che si farebbe anche ammazzare per difenderlo, si vede così chiaro nei suoi occhi; e benché paia sempre che brontoli con quel vocione, è una voce che viene da un cor gentile, si sente.
Quali atteggiamenti di Garrone inducono l’amico a dire che il ragazzo è “buono”?
Margaret
Margaret, Meg, la più grande delle quattro sorelle, ha sedici anni ed è graziosa e florida; ha grandi occhi, capigliatura morbida e ricca di color castano, una bocca dolce e mani bianchissime delle quali è molto orgogliosa.
Josephine, Jo, ha quindici anni, è alta e snella e fa ricordare un giovane puledro, sembra sempre imbarazzata dalle sue lunghissime braccia e gambe. Ha una bocca dal taglio risoluto, un nasetto un po’ comico, gli occhi grigi, mobili, che sembra afferrino tutto e che, alle volte, lampeggiano o ridono o sono pensierosi. I lunghi e folti capelli sono la sua unica bellezza, ma essa usualmente li raccoglie in una reticella per levarseli d’attorno.
Elisabeth, o Beth come tutti la chiamano, è una rosea ragazza di tredici anni, dagli occhi sereni e dai capelli folti, con modi gentili, voce timida e un’espressione di dolcezza che difficilmente si smentisce.
Amy, la più giovane, è un personaggio importante, per lo meno a suo giudizio. È una bambola, bianca come la neve, di personcina regolare, con gli occhi azzurri ed i capelli biondi ricadenti sulle spalle; pallida e slanciata, ella tiene sempre un contegno da giovane signora contegnosa.
Sottolinea gli aggettivi che caratterizzano le sorelle e sostituiscili con i loro contrari, divertendoti a stravolgere la descrizione delle protagoniste sperando che non si offendano nel caso le leggessero!
Mettiamoci all’opera
Il ritratto del compagno
Disegna con la matita grafite su un foglio dell’album da disegno il ritratto del tuo compagno, fino alle spalle, facendo molta attenzione alle proporzioni e alle caratteristiche che rendono unico il suo volto. Coloralo in bianco e nero ponendo attenzione a luci e ombre. Inventa uno sfondo colorato che abbia un motivo ripetuto (es. righe di varia natura) o consista in una gradazione di colore (dal giallo al blu) e coloralo facendo molta pressione con la mano in modo che si crei un forte contrasto tra lo sfondo acceso e i delicati toni del volto in bianco e nero.



Incontro con padre Gemelli
Eravamo nel 1940.
Da appena un anno io ero venuto all’Università Cattolica come professore di ruolo. Padre Gemelli mi aveva guardato, scrutato, annusato come fanno le massaie con i polli per vedere se sono vecchi.
«Mi pare possa andare bene» aveva concluso. E mi aveva nominato segretario del consiglio di amministrazione: che è composto, di solito, da uomini molto seri, che si radunano una volta al mese, perché l’Università vada bene.
Io ero giovane e pieno di energie.
Fu allora che conobbi veramente padre Gemelli, il Padre, come si diceva in segno di rispetto e di riverenza. O per abbreviare… Era un uomo poderoso nel suo ampio saio di frate; occhi che, quando ti guardavano, ti guardavano fino in fondo, mani grandissime; andatura irruente; aspetto imponente. Un colosso.
Quel giorno, dunque, entrò come una folata di vento impetuoso nella sala delle riunioni; mentre tutti eravamo ammutoliti. Disse in fretta il Padre Nostro, mangiandone via una parte, poi sedette: e cominciò a parlare.
Io ero il più giovane e dovevo fare il verbale: cioè il riassunto accurato di quello che ciascuno avrebbe detto. Ma invece di scrivere velocemente, con la faccia china sulla carta, mi guardavo intorno lentamente, disegnando di tanto in tanto, quasi inavvertitamente, delle oche, dei pesci, dei serpenti, con un solo tratto di penna.
Il Padre se ne accorse, si seccò, si interruppe e con voce foriera di tempesta mi disse seccamente: «Tu non stai attento!».
• Sottolinea nel brano le azioni che padre Gemelli compie e che ci aiutano a delineare il suo comportamento.
• Ricerca nel brano la similitudine usata dall’autore per descrivere padre Gemelli.
Lucia
Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle mani della madre. Le amiche si rubavano la sposa, e le facevan forza perché si lasciasse vedere; e lei s’andava schermendo, con quella modestia un po’ guerriera delle contadine, facendosi scudo alla faccia col gomito, chinandola sul busto, e aggrottando i lunghi e neri sopraccigli, mentre però la bocca s’apriva al sorriso. I neri e giovanili capelli, spartiti sopra la fronte, con una bianca e sottile dirizzatura, si ravvolgevan, dietro il capo, in cerchi molteplici di trecce, trapassate da lunghi spilli d’argento, che si dividevano all’intorno, quasi a guisa de’ raggi d’un’aureola, come ancora usano le contadine nel Milanese. Intorno al collo aveva un vezzo di granati alternati con bottoni d’oro a filigrana: portava un bel busto di broccato a fiori, con le maniche separate e allacciate da bei nastri: una corta gonnella di filaticcio di seta, a pieghe fitte e minute, due calze vermiglie, due pianelle, di seta anch’esse, a ricami. Oltre a questo, ch’era l’ornamento particolare del giorno delle nozze, Lucia aveva quello quotidiano d’una modesta bellezza, rilevata allora e accresciuta dalle varie affezioni che le si dipingevan sul viso: una gioia temperata da un turbamento leggero, quel placido accoramento che si mostra di quand’in quando sul volto delle spose, e, senza scompor la bellezza, le dà un carattere particolare.
Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi
• Descrivi l’aspetto di Lucia. Aiutati osservando in particolare l’uso di aggettivi e verbi.
• Ritratto psicologico/carattere. Quali sono i gesti fisici da cui si può intuire il carattere di Lucia?
• Giochiamo con le parole. Trova i contrari: schermirsi aggrottare modestia placido
Auda
La sua lucente capigliatura, regolarmente divisa in due parti, inquadra i contorni armoniosi delle sue gote delicate e bianche, splendenti di levigatezza e di freschezza. Le sue sopracciglia d’ebano hanno la forma e la potenza dell’arco di Kama, il dio dell’amore, e sotto le sue lunghe ciglia di seta, nella pupilla nera dei suoi grandi, limpidi occhi, navigano, come nei laghi sacri dell’Himalaya, i riflessi più puri della luce celeste. I suoi denti, fini, regolari e bianchi, risplendono tra le labbra aperte al sorriso come gocce di rugiada nel seno semichiuso di un fiore di melograno. Le sue piccole orecchie dalle curve simmetriche, le sue mani vermiglie, i suoi piedi minuscoli e teneri come i fiori del loto, brillano con lo splendore delle più belle perle di Ceylon, dei più bei diamanti di Golconda. La sua sottile e flessuosa vita, che una mano basta a cingere, rialza l’elegante curva dei fianchi torniti e la ricchezza del suo busto, dove la giovinezza in fiore sparge i suoi più perfetti tesori. Sotto le pieghe soffici della sua tunica, ella sembra essere stata modellata in argento puro, dalla mano divina di Vicvacarma, l’eterno statuario.
Jules Verne , Il giro del mondo in 80 giorni, Bur
• Cerchia le parti del volto e del corpo citate. Riscrivile accompagnate dalle parole o espressioni che l’autore ha usato per descriverle.
• Secondo te l’autore a chi paragona Auda? Quali espressioni te lo fanno capire?
Pablo Picasso
Pablo Ruiz Picasso fu uno dei maestri della pittura del Novecento.
Qual è lo scopo di un artista? Cos’è l’arte?
A queste domande non sappiamo dare risposta in modo semplice, ma possiamo dirvi che molti grandi artisti furono e sono dislessici. E per grandi artisti intendiamo proprio i più grandi. La grandezza di un artista la si può vedere da come riesce a comunicare le sue emozioni e da quanto queste emozioni vengono condivise dalla gente, da tutta la gente.
Nacque in Spagna. Suo padre era pittore, perciò Pablo era circondato da splendide immagini e dal meraviglioso odore dei colori a olio. Tentò di ricreare a scuola l’atmosfera di casa sua portandosi in classe i colombi che erano nello studio del padre, rifiutandosi di stare seduto tranquillo a leggere, scrivere e fare calcoli. La sua unica passione era la pittura; il pennello era diventato il prolungamento del suo braccio. Il padre si rese conto presto delle capacità artistiche innate del figlio e del suo amore per il disegno.
Pablo era di salute malferma e i suoi continui problemi legati al rispetto delle regole scolastiche convinsero il padre a ritirarlo dalla scuola a dieci anni, dopo aver tentato anche con una scuola privata e un precettore a casa. Fu allora che decise di lasciarlo vagabondare per le strade della sua città, dove Pablo godeva nel vedere ciò che gli accadeva intorno, disegnando e dipingendo a suo piacere.
A otto anni aveva già dipinto la sua prima tela: un picador della corrida di Madrid.
A tredici anni organizzò la sua prima mostra di quadri. Il profitto alla scuola media era ancora insufficiente, ma intanto, agli esami di ammissione all’accademia d’arte, superò in un solo giorno esami che sarebbero dovuti durare un mese. Aveva imparato a usare la memoria visiva!
La fortuna di Pablo Picasso ragazzo fu l’opportunità di fare l’esperienza della vita di strada a Madrid. Egli stravolse tutte le regole del senso comune rappresentando una realtà che non è solo ciò che si vede, bensì tutto ciò che esiste. Non a caso i volti e i corpi da lui dipinti presentano più punti di vista ritratti contemporaneamente, quasi come se l’artista girasse intorno alle figure e legasse i diversi profili che di volta in volta intravedeva.
Pablo Picasso fu un rivoluzionario dell’arte. Creò un nuovo modo di guardare, capì che l’occhio è molto più importante di quanto si fosse pensato fino a quel momento (vi ricordate Leonardo da Vinci e Galileo?).
Lui dipingeva guardando oltre le figure che ritraeva, ed ecco che queste apparivano con tutti e due gli occhi da una sola parte della faccia e i colori diventavano innaturali. Si inventò un modo di scomporre le figure in pezzi elementari che richiamavano forme geometriche spigolose, e così creò il Cubismo.
Capì che “arte” non significava riproduzione del vero, ma ricostruzione di uno stato d’animo, di una sensazione, di un sentimento influenzato da tutto ciò che si ha intorno, influenzato dall’epoca e da tutte le trasformazioni della nostra vita. Fu così che nacque l’arte moderna e che la pittura si staccò dalla riproduzione del vero. Così Picasso, personaggio dal pensiero inquieto, non smise di cercare nuovi modi per esprimersi e per ricercare la verità dell’espressione dell’essere umano.
Rossella Grenci, Daniele Zanoni, Storie di straordinaria dislessia. 15 dislessici famosi raccontati ai ragazzi, Erickson
Il ritratto della mia bambina
La mia bambina con la palla in mano, con gli occhi grandi colore del cielo e dell’estiva vesticciola: «Babbo – mi disse – voglio uscire oggi con te». Ed io pensavo: Di tante parvenze che s’ammirano al mondo, io ben so a quali posso la mia bambina assomigliare.
Certo alla schiuma, alla marina schiuma che sull’onde biancheggia, a quella scia ch’esce azzurra dai tetti e il vento sperde; anche alle nubi, insensibili nubi che si fanno e disfanno in chiaro cielo; ed altre cose leggere e vaganti.
Umberto Saba
Viola
Viola vestita di limpido giallo, che festa, che amore ad un tratto scoprirti venire innanzi con grazia di ballo di tra ginepri e odore dei mirti!
La ricca estate si filtra e si dora sopra il tuo piccolo volto rotondo; ad ogni moto dell’iride mora bevi nel riso la gioia del mondo.
Par che la terra, rifatta stamani più generosa, più fresca di ieri voglia specchiarsi negli occhi silvani tuoi, risplendenti di casti pensieri.
Al tuo venire volante s’allieta questo mio cuore e con Dio si rimpacia, l’arida bocca del padre poeta torna a pregare allor quando ti bacia.
Giovanni Papini
Il mio bambino
Come trovo dipinto il mio bambino in fin di desinare, è uno sgomento! Ha le patacche addosso a cento a cento e la bocca color di stufatino;
ha il nasetto, si sa, tinto di vino, e sulla fronte un po’ di condimento, e uno spaghetto appiccicato al mento che gli penzola giù sul grembiulino.
E sfido! In tutto pesca e tutto tocca, e si strofina la forchetta in faccia, e stenta un’ora per trovare la bocca;
e son tutti i miei strilli inefficaci: egli, vecchio volpone, apre la braccia ed io gli netto il muso co’ i miei baci.
Edmondo De Amicis
FIABE E RACCONTI
La tartaruga
Mentre una notte se n’annava a spasso, la vecchia tartaruga fece er passo più lungo de la gamba e cascò giù cò la casa vortata sottoinsù. Un rospo je strillò: «Scema che sei! Queste sò scappatelle che costeno la pelle…». «Lo so – rispose lei –ma, prima de morì, vedo le stelle».
Trilussa
Ascoltiamo insieme
Aria di Papageno da “Il flauto magico” di Mozart
In questo brano si presenta un uomo che di lavoro alleva gli uccelli, intrattenendoli con il suo carillon, che qui dialoga con l’orchestra.


Moby-Dick
Chiamatemi pure Ismaele.
Anni fa – non importa quanti con precisione – decisi di prendere le vie del mare. Se dovessi spiegare esattamente perché operai questa scelta, mi sarebbe difficile. Posso dirvi soltanto che il mare mi entrò nel sangue fin da ragazzo: sono cresciuto fra una tempesta e uno sciacquio pigro di onde, il vociare delle ciurme e il rollio delle carene, il gonfiarsi delle vele alla brezza di ponente e la schiuma immacolata delle scie di bordo. Dalla mia prima esperienza di mozzo ho conservato questo senso singolare, per cui, ogni volta che mi assale la malinconia, ogni volta che sento crescere in me un torbido rimescolio d’insoddisfazione per le cose del mondo, abbandono tutto e mi metto a navigare. Sono fatto così. Il mare è per me la libertà, il respiro dell’avventura, la fuga dalle tristezze.
Quella volta che decisi di rimettermi a solcare le onde, ero attratto da un desiderio prepotente, sortomi all’improvviso: partecipare alla caccia della balena. L’idea del mostro mi affascinava, ma ancor più mi affascinava l’ambiente dei marinai cacciatori di balene, strana razza di gente eroica e spericolata, prepotente e generosa. Tutta la mia passione per le terre ignote, per il rischio, per l’imprevisto pareva ritrovare in quella prospettiva uno sfogo desideratissimo.
Stetti a meditare un poco e finalmente, un giorno, non resistetti più: cacciai una camicia o due nel mio vecchio sacco di iuta, me lo posi sotto il braccio e dissi addio alla mia buona e vecchia città di Manhattan.

Questo brano è scritto in:
⬜ terza persona singolare
⬜ prima persona singolare
⬜ seconda persona singolare
Il protagonista è:
⬜ un uomo
⬜ una donna
⬜ un ragazzo
Quale tempo verbale il narratore utilizza maggiormente:
⬜ l’imperfetto
⬜ il futuro semplice
⬜ il passato remoto
In che paese vive il protagonista:
⬜ America
⬜ Italia
⬜ Australia
Sciacquio è un nome derivato da:
⬜ scia
⬜ acqua
⬜ sciacquare
Cosa significa che lo sciacquio
è pigro?
È pigro in analisi logica si definisce:
⬜ predicato verbale
⬜ predicato verbale più aggettivo
⬜ predicato nominale
Per che cosa il protagonista prova insoddisfazione?
⬜ per la città
⬜ per le persone
⬜ per le cose del mondo
Quali sono gli aggettivi con cui il narratore descrive i marinai cacciatori di balene?
A che modo del verbo appartiene resistetti?
⬜ congiuntivo
⬜ indicativo
⬜ condizionale
Che cos’è la iuta?
⬜ un materiale tessile
⬜ un sacco di corda
⬜ un materiale impermeabile
I fatti narrati:
⬜ devono ancora succedere
⬜ sono già a ccaduti
⬜ stanno per accadere
Navigare per il protagonista è rimedio per che cosa?
Quale titolo daresti a questo brano?
Il narratore e il protagonista:
⬜ sono la stessa persona
⬜ si conoscono
⬜ non sono la stessa persona
Il cappello
Il signor Veneranda salì sul treno e si sedette accanto al finestrino. Subito dopo un signore entrò nello scompartimento, si avvicinò al signor Veneranda e gli disse cortesemente:
«Scusi, questo posto è mio: lei si è seduto sul mio cappello».
«Io mi sono seduto sul suo cappello – rispose il signor Veneranda con calma e restando seduto – ma questo non vuol dire che il posto sia suo. Sarà suo il cappello».
«Ma io il cappello l’avevo messo lì sul sedile» balbettò il signore.
«Ha fatto benissimo e io non mi sono permesso di levarlo: il suo cappello c’è ancora. Eccolo qua».
E il signor Veneranda levò da sotto il sedere il cappello del signore.
«Ma anche il posto è mio – gridò il signore – ci ho messo il cappello».
«Senta – protestò il signor Veneranda – se lei mette il suo cappello su un prosciutto, vuol dire che il prosciutto è suo?».
«Io non ho messo il cappello su un prosciutto. L’ho messo in quel posto lì» replicò il signore confuso.
«Ma se questo posto qui fosse stato un prosciutto» urlò il signor Veneranda fuori di sé «lei ci avrebbe messo il cappello sopra e poi avrebbe detto che il prosciutto era suo».
«Ma io volevo sedermi» balbettò il signore che non sapeva più che pesci pigliare.
«Sul prosciutto?» gridò il signor Veneranda. «Senta mi dia retta: faccia quello che vuole, io con certa gente non voglio avere a che fare».
E sprofondò nella lettura del giornale.
Carlo Manzoni , Il signor Veneranda, Rizzoli
L’operazione
Due infermieri entrarono in sala operatoria spingendo una barella e depositarono il malato sul letto chirurgico. L’anestesista sistemò la maschera. Dopo un po’ entrò il celebre chirurgo.
«Bisturi!».
Un’infermiera si affrettò a ubbidire, e il celebre chirurgo aprì il ventre del paziente. D’un tratto rimase pensieroso e guardò il suo assistente:
«Senta, Martinez, cosa dobbiamo togliere a questo signore?».
L’assistente guardò il Maestro, indeciso.
«Mah… mi sembra di ricordare che fosse qualcosa che finiva in - accio…».
«In - accio?» ripeté il celebre chirurgo.
«È troppo vago. Potrebbe essere il braccio, il polpaccio… vado a sentire se mia moglie se ne ricorda» disse il celebre chirurgo, e si diresse verso il telefono:
«Senti, Enrichetta, ti ricordi di ciò che dovevo togliere al paziente coi baffi ed il vestito marrone?».
«Affatto, lo sai che non mi piace immischiarmi nei tuoi affari».
«Era qualcosa che finiva in -accio».
«Senti, a proposito, non dimenticare di portare il formaggio quando torni a casa».
«Che tipo di formaggio?».
«Qualunque».
«E davvero non ti ricordi dell’operazione?».
«No, assolutamente».
«Va bene, cara, porterò il formaggio…».
E il celebre chirurgo ritornò in sala operatoria.
«Niente di niente».
«E se domandassimo a casa sua?» suggerì l’assistente.
«Niente male l’idea» disse il celebre chirurgo, e andò al telefono.
«Signora Ramirez? Come va? Sono il dottor Armando».
«È successo qualcosa a mio marito?».
«No, no, niente, non si allarmi. L’ho chiamata per domandarle se ricorda cosa dobbiamo togliere a suo marito».
«Mah… ho sentito dire qualcosa che finiva in -etto».
«Non sarà stata un peletto?».
«No, non era un peletto».
«Un calletto?».
«No, non era nemmeno un calletto».
«Aspetti, ora le dico tutto ciò che ricordo che finisce in -etto: petto, gambaletto, setto, letto, occhietto…».
«No, non era niente di tutto ciò».
«Allora che gli leviamo?».
«Gli tolga ciò che vuole. Non mi piace immischiarmi nelle cose di mio marito». «Va bene, signora. In tutti i modi, grazie».
Quando il celebre chirurgo entrò di nuovo in sala chirurgica, il malato si era svegliato.
«Neanche sua moglie sa niente» disse il celebre chirurgo. «Mia moglie non sa mai niente» commentò il malato.
Il celebre chirurgo lo interruppe: «Scusi, ma… si ricorda cosa le dovevamo togliere?».
E il paziente rispose: «Non credo che dovessero togliermi qualcosa. Io sono venuto a riparare la luce; ma giacché sto qui, mi faccia il piacere di darmi qualche punto a questa pancia che mi si è scucita».
Tono (Antonio de Lara), in Umoristi del Novecento, a cura di G. Vicari, Aldo Garzanti Editore
Ernestino
Quando arrivano le vacanze io, Annibale e gli altri (meno Bibbo, che è fatto completamente a modo suo), possiamo restarcene a Dese, dove c’è il lago di Garda e un sacco di altre belle cose, oppure possiamo andarcene in giro per il mondo. Per esempio, Annibale ha un cugino, di nome Amilcare Trallallero, che vive a Napoli, è sempre allegro, ha la casa tappezzata di cartoline di Napoli e ha anche un cane parlante, che sa cantare O sole mio, anche se non la canta molto bene.
Altre volte viene a trovarci il nostro amico Alfredo Sputakkiovic, che quando parla sputa talmente che per stargli vicino occorre tenere l’ombrello aperto. Bibbo Ziribibbo-Gliero qualche volta va da un suo misterioso parente, dal nome che più strano non si può, Antenore A/é/óóó (praticamente, si pronuncia vomitando), che un giorno venne anche a Desenzano, e fu un giorno tremendo, di cui vi parlerò un’altra volta, forse.
Ma il più delle volte, quando vogliamo prenderci una bella vacanza, andiamo a trovare il nostro amico Ernesto Gomez Delaviuda, che noi chiameremo sempre Ernestino Gomez. Ernestino ha una fattoria in Spagna, dove alleva tori. Quando i tori sono abbastanza grandi li carica su un treno-merci, che ferma lì vicino, e li spedisce a Madrid. La vita di Ernestino Gomez è fatta tutta di tori e treni, tori e treni. Adesso devo dirvi, e mi dispiace perché è un amico, che Ernestino non è molto intelligente. Non lo era nemmeno quando andava a scuola, ma poi è peggiorato per colpa del mestiere che fa. Per la verità, va a giorni, a seconda del tempo. Ci sono giorni particolarmente brutti, in cui in pratica diventa un toro anche lui, cammina a quattro zampe, entra nel recinto, scalpita, muggisce e prende a cornate i tori. Non è un bello spettacolo. Anche quando è in forma, però, non è molto capace di ragionare. Per lui esistono solo tori e treni: qualunque cosa, o è un toro o è un treno. Se ha le ruote è un treno, se no è un toro. Ad esempio, quando io, Annibale e Asdru arriviamo da lui in macchina, ci corre incontro gridando:
«Salve, tori! Venite giù da quel treno e entrate nel mio toro!» (che vuol dire: «Salve, amici! Scendete dalla macchina e entrate in casa mia!»).
Una bottiglia è un toro.
Un televisore è un toro.
Una valigia è un toro. Attenzione, però: ci sono le valigie con le rotelle, che sono treni.
La prima volta che vide la rotellina per tagliare la pasta disse:
«Che trenino piccolo!».
Anche la radio per lui è un treno, perché ha le manopole rotonde, che secondo lui sono ruote. Perciò a volte dice:
«Lì nel treno hanno detto che pioverà».
Se non conoscete Ernestino Gomez, è impossibile capire quello che dice, e si fa una gran confusione fra tori e treni.
Ernestino inventore
Ma la cosa peggiore è che Ernestino si crede intelligente. Se voi gli domandate che mestiere fa, lui risponde: «L’inventore».
E se gli domandate che cos’è un inventore, lui risponde: «È un toro con la mente che corre come un treno».
Oppure:
«È un treno che scalpita come un toro».
Lui stesso ritiene di essere un toro:
«Sono un bravo toro, io».
Dunque, dicevo che Ernestino Gomez fa l’inventore. O così, almeno, pensa lui.
In ogni caso, di invenzioni Ernestino non ne ha fatte tante: solo due, e mica tanto buone. Ma, a pensarci bene, quante invenzioni poteva fare? Per lui esistono solo tori e treni.
Ma ecco la breve storia delle sue trovate.
Il trenoro
Fu un’invenzione pacifica. Io e Annibale Zumpapà ce ne stavamo stravaccati sotto il portico della sua fattoria a bere acqua e anice, quando ci accorgemmo che mancava proprio lui.
Dellomodarme Luigi stava sdraiato sulla sua Lambretta Sprint e leggeva un giornale intitolato “Lambrette”, che ho visto solo in mano a lui.
Luigi-Occhio-Di-Lince stava appollaiato sull’unico albero della fattoria e dormiva.
«Ehi» fa Annibale. «Dov’è Ernestino?».
Aveva appena finito di parlare, quando udimmo uno strano verso:
«Mu-muuuu!».
«È la voce di un toro» dissi io.
«Sì, ma fa il verso del treno» disse Annibale.
Infatti, era un mu-muuuu simile al tu-tuuuu del treno.
«M?» domandò Dellomodarme Luigi (che vuol dire: «Cosa sarà successo?»).
«Mu-muuuu!» ripeté la voce, che sembrava provenire da un toro e, insieme, da un treno.
Anche noi ci domandavamo cosa fosse successo, e stavamo per alzarci, quando Luigi-Occhio-Di-Lince, che intanto si era svegliato, gridò con la sua vocina sottile: «Viene lui! Viene lui! Viene lui!».
Infatti, di lì a poco arrivò tutto entusiasta Ernestino Gomez.
«Giovani tori!» disse (che vuol dire: «Ragazzi!»).
«Ho fatto un’invenzione straordinaria».
«Tu un’invenzione?» disse Annibale, che non ci credeva.
«Ve la faccio vedere subito».
E ci condusse col suo treno (col suo furgone) fino alla ferrovia (che lui chiama “toro”, perché le ferrovie non hanno le ruote). Sulla ferrovia c’era un lungo treno merci. Si era rotto il locomotore, e allora Ernestino Gomez, che si trovava lì per caricare un toro, prese il toro, e invece di farlo salire sul vagone lo attaccò al posto del locomotore. I macchinisti ridevano, e anche gli altri tori sistemati nei vagoni ridevano:
«Ah ah ah ah!».
«Muh muh muh muh!».
Ernestino allora prese la coda del suo toro e la tirò forte:
«Mu-muuuu!» fece il povero toro, che sotto le frustate dei macchinisti tirò, tirò, tirò, finché il treno si mosse.
«Visto, giovani tori?» disse Ernestino.
«Questo è il trenoro. Che ne dite?».
«Bello» disse Annibale. «Però ho paura che tra poco il tuo toro morirà di stanchezza».
«Uh, hai ragione, toro» disse Ernestino, grattandosi la testa.
Ma quel giorno Ernestino era pieno di idee.
«Ho trovato!» gridò.
E, sotto gli occhi dei macchinisti, di Annibale, di Dellomodarme Luigi, di Luigi-Occhio-Di-Lince e di me, aprì tutti i vagoni, fece scendere tutti i tori e li legò davanti al treno. In fila indiana. I macchinisti continuavano a ridere.
«Ah ah ah ah!».
I tori, invece, non ridevano più: adesso bisognava lavorare. La grande forza di tutti quegli animali tirò facilmente il treno vuoto, che scomparve presto dietro una collina verso Madrid.
«Che bello essere intelligenti come me» disse Ernestino, che non aveva il senso della misura. «Vedrete che adesso inventerò qualcos’altro».
Il toreno
Noi speravamo che non avrebbe inventato più niente. Invece inventò. Ahimè. E questa volta successe un vero disastro. La sera prima, mentre andavamo a dormire, ci aveva detto:
«Andate pure a toro (che vuol dire: a letto). Io sto su a lavorare».
La mattina dopo, verso le cinque, fummo svegliati da un fracasso tremendo: muggiti, grida, tonfi, stridii. Poi ci fu un “crassshh!!!” fortissimo, seguito da un frastuono di zoccoli. Io e Annibale ci affacciammo alla finestra e cosa
vedemmo? Un povero toro con quattro skate-board legati sotto le zampe, uno per zampa. Il toro faticava a stare in piedi e sgambettava da far pietà, andando a sbattere dappertutto. Gli altri tori avevano una fifa blu e se ne stavano in piedi sulla palizzata (non chiedetemi come facevano: non l’ho mai capito), coi denti che battevano: ta-ta-ta-ta-ta…
L’unico che stava benone era Ernestino, che in mezzo al recinto rideva di gioia. Quando ci vide affacciati alla finestra gridò:
«Ehi, tori! Venite a vedere cosa ho inventato ancora» (come dire: non faccio in tempo a inventare una cosa, che subito me ne viene in mente un’altra ancora più bella).
«Lo vediamo benissimo da qui» dissi io.
«Complimenti» disse Annibale, senza nessun entusiasmo.
Ci vestimmo e scendemmo per la colazione. Ernestino era ancora nel recinto, a tentare di insegnare a quel toro come si va sullo skate. Ma il toro era sempre più spaventato e non voleva imparare niente.
«Ehilà, tori» disse Erni, vedendoci. «Vi presento la mia ultima invenzione: il toreno. Dopo il trenoro, viene il toreno».
Mentre facevamo colazione (intanto, il povero toro continuava a urlare), Annibale fece questo discorsetto: «Complimenti, Erni. Prima il trenoro, poi il toreno. Ma, senti un po’: vorrei farti una domanda difficile».
«Fammela pure, toro: per me non ci sono domande difficili».
«Dunque» disse Annibale. «Se tu attacchi un treno dietro un toreno, cosa salta fuori? Il trenoreno o il toreneno?».
Era una domanda difficile, e Ernesto Gomez Delaviuda dovette pensarci su un po’. Ma in quei giorni era troppo intelligente. Ed ecco la sua risposta:
«Se attacchi un toreno davanti a un treno, farai un trenoreno. Se, invece, attacchi un treno dietro un toreno, allora fai un toreneno».
«Che differenza c’è?» domandai.
«Eh sì che c’è. Il trenoreno deve andare sempre sul suo toro (cioè sui binari), mentre il toreneno può farne a meno».
«E se attacchi un toreno davanti a un trenoro?».
«Viene un trenorenoro».
«E se da un trenoro togli un toro, cosa rimane?».
«Un treno».
«Questo era facile, Erni. Ma se da un trenoro togli un toreno cosa resta?».
La domanda era molto difficile, ma quel giorno Ernestino Gomez era un fulmine.
«Facile» rispose. «Resta un toro».
Risposta giustissima. Ma non mi va di spiegarvi perché. Provate ad arrivarci da soli.
Giufà e la statua di gesso
C’era una mamma che aveva un figlio sciocco, pigro e mariolo.
Si chiamava Giufà. La mamma, che era povera, aveva un pezzo di tela, e disse a Giufà: «Prendi questa tela e valla a vendere; però se ti capita un chiacchierone non gliela dare: dalla a qualcuno di poche parole».
Giufà prese la tela e cominciò a strillare pel paese: «Chi compra la tela? Chi compra la tela?».
Lo fermò una donna e gli disse: «Fammela vedere».
Guardò la tela e poi domandò: «Quanto ne vuoi?».
«Tu chiacchieri troppo,» disse Giufà, «alla gente chiacchierona mia madre non vuole venderla» e andò via.
Trovò un contadino: «Quanto ne vuoi?».
«Dieci scudi».
«No: è troppo!».
«Chiacchierate, chiacchierate: non ve la do».
Così tutti quelli che lo chiamavano o gli si avvicinavano gli pareva parlassero troppo e non la volle vendere a nessuno. Cammina di qua, cammina di là, si infilò in un cortile. In mezzo al cortile c’era una statua di gesso, e Giufà le disse: «Vuoi comprare la tela?» Attese un po’, poi ripeté: «La vuoi comprare la tela?». Visto che non riceveva nessuna risposta: «Oh, vedi che ho trovato qualcuno di poche parole! Adesso sì che gli vendo la tela». E l’avvolse intorno alla statua.
«Fa dieci scudi. D’accordo? Allora i soldi vengo a prenderli domani» e se ne andò. La madre appena lo vide gli domandò della tela.
«L’ho venduta».
«E i quattrini?».
«Vado a prenderli domani».
«Ma è persona fidata?».
«È una persona proprio come la volevi tu: figurati che non mi ha detto neppure una parola».
La mattina andò per i quattrini. Trovò la statua, ma la tela era sparita. Giufà disse: «Pagamela».
E meno riceveva una risposta più s’arrabbiava.
«La tela te la sei presa, no? E i quattrini non me li vuoi dare? Ti faccio vedere io, allora!». Prese una zappa e menò una zappata alla statua da mandarla in cocci. Dentro la statua c’era una pentola piena di monete d’oro. Se la mise nel sacco e andò da sua madre .
«Mamma, non mi voleva dare i denari, l’ho preso a zappate e m’ha dato questi». La mamma che era all’erta, gli disse: «Dammi qua, e non raccontarlo a nessuno».
Italo Calvino, Fiabe italiane, Mondadori
Gli occhialini d’oro
«L’assistente del professor Coram è stato ucciso stamane nello studio. La governante ha detto di aver sentito un grido disperato e un tonfo sordo. Ci ha chiamato immediatamente: abbiamo trovato il giovane Smith disteso per terra, morto. Unico indizio: nella sua mano destra abbiamo trovato questo…» disse in un fiato l’ispettore Hopkins mostrando a Sherlock Holmes un paio di occhialini d’oro.
«Smith aveva un’ottima vista, dunque gli occhiali devono appartenere all’assassino» concluse.
Sherlock Holmes prese e li esaminò con molta attenzione.
Se li appoggiò sul naso, cercò di leggere, li osservò alla luce della lampada.
Poi si rivolse all’ispettore Hopkins: «Cercate una donna che abiti in un quartiere elegante. Ha un naso molto grosso, gli occhi ravvicinati, la fronte aggrottata. Negli ultimi mesi è andata almeno due volte da un oculista».
Hopkins aveva un’espressione esterrefatta.
Sherlock Holmes sorrise: «Ma via, sono deduzioni elementari! La montatura delicata e d’oro massiccio indica chiaramente che gli occhiali appartengono a una donna, ricca ed elegante. La molla, stretta per il mio naso, suggerisce che il naso della donna è largo all’attaccatura. Inoltre, io non riesco a centrare le mie pupille in queste lenti: ciò significa che la signora ha gli occhi vicini alla radice del naso. Noterà poi che le lenti sono molto spesse: chi ha una miopia così forte tiene la fronte aggrottata, nello sforzo di mettere a fuoco le immagini».
«E la duplice visita all’oculista?» domandò Hopkins.
«Osservi: le molle sono foderate con strisce di sughero per alleviare la stretta sul naso. Una di queste strisce è scolorita e consumata, l’altra è nuova, ma di tipo identico. Ne deduco che la donna è tornata dallo stesso oculista per sostituire quella che probabilmente aveva perso».
«Perbacco, fantastico!» esclamò Hopkins. «E pensare che avevo in mano tutti questi indizi senza saperlo!».
Arthur Conan Doyle, Tutto Sherlock Holmes, Newton Compton
Tonino l’invisibile
Una volta un ragazzo di nome Tonino andò a scuola che non sapeva la lezione ed era molto preoccupato al pensiero che il maestro lo interrogasse.
«Ah,» diceva tra sé, «se potessi diventare invisibile…».
Il maestro fece l’appello e quando arrivò al nome di Tonino il ragazzo rispose: Presente! ma nessuno lo sentì, e il maestro disse:
«Peccato che Tonino non sia venuto, avevo giusto pensato di interrogarlo. Se è ammalato speriamo che non sia niente di grave».
Così Tonino comprese di essere diventato invisibile come aveva desiderato. Per la gioia spiccò un salto dal suo banco e andò a finire nel cestino della carta straccia. Si rialzò e si aggirò qua e là per la classe tirando i capelli a questo e a quello e rovesciando i calamai. Nascevano rumorose proteste, litigi a non finire. Gli scolari si accusavano l’un l’altro di quei dispetti, e non potevano sospettare che la colpa era invece di Tonino l’invisibile.
Quando si fu stancato di quel gioco, Tonino uscì dalla scuola e salì su un filobus, naturalmente senza pagare il biglietto, perché il fattorino non poteva vederlo. Trovò un posto libero e si accomodò. Alla fermata successiva salì una signora con la borsa della spesa e fece per sedersi proprio su quel sedile che ai suoi occhi era libero. Invece si sedette sulle ginocchia di Tonino che si sentì soffocare. La signora gridò:
«Che tranello è questo? Non ci si può nemmeno sedere? Guardate, faccio per posare la borsa e rimane sospesa per aria».
La borsa in realtà era posata sulle ginocchia di Tonino. Nacque una gran discussione e quasi tutti i passeggeri pronunciarono parole di fuoco contro l’azienda tramviaria. Tonino scese in centro, si infilò in una pasticceria e iniziò a servirsi a volontà, pescando a due mani tra maritozzi, bignè al cioccolato e paste di ogni genere.
La commessa che vedeva sparire le paste dal banco, diede la colpa a un dignitoso signore che stava comprando delle caramelle col buco per una vecchia zia. Il signore protestò:
«Io un ladro? Lei non sa con chi parla. Lei non sa chi era mio padre. Lei non sa chi era mio nonno!».
«Non voglio nemmeno saperlo» rispose la commessa.
«Come si permette di insultare mio nonno!».
Fu una lite spaventosa. Corsero le guardie. Tonino l’invisibile scivolò tra le gambe del tenente e si avviò verso la scuola per assistere all’uscita dei suoi compagni. Difatti li vide uscire, anzi rotolare giù a valanga dai gradini della scuola, ma essi non lo videro affatto. Tonino si affannava invano a rincorrere questo e quello, a tirare i capelli al suo amico Roberto, a offrire un lecca-lecca al suo
amico Guiscardo. Non lo vedevano, non gli davano retta per nulla, gli sguardi lo trapassavano come se fosse stato di vetro.
Stanco e un po’ scoraggiato Tonino rincasò. Sua madre era al balcone ad aspettarlo.
«Sono qui, mamma!» gridò Tonino.
Ma essa non lo vide e non lo udì e continuava a scrutare ansiosamente la strada alle sue spalle.
«Eccomi, papà» esclamò Tonino quando fu in casa, sedendosi a tavola al suo solito posto. Ma il babbo mormorava, inquieto:
«Chissà perché Tonino tarda tanto. Non gli sarà mica successa qualche disgrazia!».
«Ma sono qui, sono qui! Mamma, papà!» gridava Tonino. Ma essi non udivano la sua voce.
Tonino ormai piangeva, a che servono le lacrime se nessuno può vederle?
«Non voglio più essere invisibile» si lamentava Tonino col cuore in pezzi. «Voglio che mio padre mi veda, che mia mamma mi sgridi, che il maestro mi interroghi! Voglio giocare con i miei amici! È brutto essere invisibili, è brutto star soli».
Uscì sulle scale e scese lentamente in cortile.
«Perché piangi?» gli domandò un vecchietto seduto a prendere il sole su una panchina.
«Ma lei mi vede?» domandò Tonino pieno d’ansia.
«Ti vedo sì. Ti vedo tutti i giorni andare e tornare da scuola».
«Ma io non l’ho mai visto, lei».
«Eh, lo so, di me non si accorge nessuno. Un vecchio pensionato, tutto solo, perché mai dei ragazzi dovrebbero guardarlo? Io per voi sono proprio come l’uomo invisibile».
«Tonino!» gridò in quel momento la mamma dal balcone.
«Mamma, mi vedi?».
«Ah, non dovrei vederti, magari. Vieni, vieni su e sentirai il babbo».
«Vengo subito, mamma» gridò Tonino pieno di gioia.
«Non ti fanno paura gli sculaccioni?» rise il vecchietto.
Tonino gli volò al collo e gli diede un bacio.
«Lei mi ha salvato» disse.
«Eh, che esagerazione» disse il vecchietto.
Gianni Rodari, Tonino l’invisibile, Emme Edizioni
La vera libertà
«Psst… Psst… è dall’altra parte che ci si volta!».
«Io mi volto dove mi pare! Tu pensa per te e non seccarmi!».
Questo dialogo, si sta svolgendo in un campo, sottovoce tra due girasoli uno dei quali, mentre tutti gli altri tengono il capo rivolto verso il sole, se ne sta voltato dalla parte opposta.
Non è la prima volta che il girasole si comporta così.
«E se lo fai per farti notare, ci riesci benissimo!» commenta una rondine.
«Non lo faccio per farmi notare» risponde il fiore, punto sul vivo «Il mio comportamento ha ragioni più profonde, filosofiche direi».
«Forse è meglio che i fiori non cerchino di fare i filosofi» suggerisce la rondine «e si accontentino di fare i fiori. Tu sei un girasole e devi voltarti verso di lui: lo dice il tuo nome stesso».
«Senti, senti che ragionamento intelligente!» replica sarcastico il fiore. «Questa è proprio la dimostrazione che noi non siamo liberi: persino il nostro nome ci impone quello che dobbiamo fare! A me, invece, nessuno può imporre niente! E ti suggerisco anche di finirla di chiamarmi “girasole”: preferisco essere un “controsole”, così si capirà subito che io, con il sole, non voglio avere nulla a che fare».
«Ma sei sempre così permaloso?» domanda la rondine.
«Non sono permaloso, solo ci tengo a chiarire bene le cose, qui in mezzo a questa selva di marionette. Ma guardali: sembrano legati al sole con un filo così che, come si muove lui, si muovono anche loro».
«È vero, – dice la rondine – Io li trovo commoventi. A volte penso che a forza di specchiarsi nel sole, sono diventati simili a lui, sono dei piccoli soli che risplendono sulla terra».
«Balordaggini!» commenta il controsole «Io li trovo semplicemente ridicoli. Ah, se non avessi queste radici che mi tengono legato al terreno, me ne andrei il più lontano possibile da questo sole che condiziona tutta la mia vita. Dovessi arrivare in capo al mondo!».
«Se sono le radici il tuo problema – dice la rondine decisa a dare una bella lezione a quel filosofo – posso liberarti io e portarti dove vuoi».
«Dici davvero? Questo è il più bel giorno della mia vita! Sradicami in fretta, ti prego e portami lontano, molto lontano da qui».
Il tempo di volare a chiedere aiuto a qualche altra rondine ed ecco che il fiore, liberato dalla stretta della terra, può librarsi nel cielo, sorretto dalle rondini.
Il più lontano possibile dal sole, aveva desiderato andare il controsole ma ora, dopo tre giorni di volo, si accorge che, per quanto lontano si vada, non è possibile sfuggirgli.
«Fermiamoci qui! – propongono le rondini – noi siamo stanche e per te diventa pericoloso stare così a lungo lontano dalla terra».
«Nemmeno per idea! – risponde il fiore – Ho detto che voglio andare là dove il sole non arriva e ci andrò».
«Ma questo posto non esiste!» spiega una rondine. «Il sole giunge dappertutto e non si può sfuggire alla sua luce. Al massimo puoi sottrarti a essa per sei mesi, andando nelle terre polari dove, per sei mesi appunto, il sole non si fa vedere».
«Benissimo: andiamo al Polo» dice il controsole più deciso che mai.
«Ma morirai congelato!» esclamano in coro le rondini.
«Uffa, volete pensare agli affari vostri? Mi ricordate tanto certi girasoli che ho lasciato dietro di me!».
Non si sa come, le povere rondini sono arrivate, tremanti e intirizzite, in vista del Polo Sud e qui hanno lasciato cadere il fiore sul ghiaccio, facendo immediatamente dietrofront. Giunto al Polo, il controsole si guarda attorno con circospezione: le rondini avevano ragione, davvero qui non sembra esserci traccia della calda luce del sole perché la notte polare avvolge ogni cosa.
«Per sei mesi posso stare tranquillo!», pensa il fiore, tirando un sospiro di sollievo e cercando di affondare le radici nel ghiaccio.
«Guarda che così ti prenderai i reumatismi!» lo avverte un pinguino che lo sta osservando da qualche minuto.
«Cosa vuoi che siano i reumatismi di fronte alla libertà che ho appena conquistata!».
«Ah, sei anche tu uno di quei girasoli che lasciano la loro terra per fuggire via dal Sole?» domanda il pinguino con l’aria di uno che la sa lunga.
«Uno di quei girasoli, hai detto? Vuol dire che non sono l’unico?».
«Tutti vi credete sempre unici, ma io, di girasoli così, ne ho visti proprio tanti: siete tutti uguali».
Decisamente le parole del pinguino hanno ferito l’amor proprio del fiore. Dunque lui non è unico, altri prima di lui hanno avuto i suoi pensieri! È veramente seccante fuggire dalla propria terra per non essere uguali agli altri e arrivare in un posto dove ti dicono che sei come tutti quanti. Benché non apprezzi affatto la conversazione del pinguino, il controsole è ormai deciso a chiarire questa faccenda perciò domanda:
«Si può sapere che fine hanno fatto tutti gli altri?».
«Oh, chi prima, chi dopo, sono ritornati indietro tutti…».
«Questa sì che è una bella notizia! – pensa il fiore – Perché da questo si vedrà che io non sono come tutti gli altri: io non tornerò indietro mai!».
Passano veloci i giorni.
Fitte di dolore sempre più acute salgono dalle radici del fiore lungo lo stelo.
I pensieri gli si sono anche un po’ intorpiditi per il freddo. Ma non c’è molto da pensare quando si è felici. E felice il controsole lo è sicuramente.
Due settimane sono già passate. Il fiore ora non riesce più a reggersi diritto sullo stelo: giace disteso sulla superficie ghiacciata, tremante e senza pensieri. Nel cuore ha solo un vago senso di paura.
È già trascorso un mese, forse due.
Scosso dai brividi, stremato dal freddo, il controsole dice a se stesso, in un ultimo sprazzo di lucidità:
«Devo pensare subito a qualcosa, devo fare qualcosa…».
Ma la sua mente intorpidita è incapace di prendere una decisione. Steso sul ghiaccio, mormora parole sconnesse finché, in un guazzabuglio di frasi senza senso, si fa strada un nome che sembrava dimenticato.
«Sole… – mormora il fiore – Sole…».
Proprio in quel momento, il pinguino che lo aveva visto arrivare al Polo passa accanto a lui.
«Sole… – continua a invocare il povero fiore – Sole… io muoio!».
Il pinguino sa già cosa deve fare: corre a chiamare un gabbiano il quale solleva il fiore malconcio e, volando più in fretta che può, lo riporta a casa.
I raggi caldi del sole accarezzano ora la corolla del fiore, ne asciugano i petali con delicatezza. Il girasole è troppo felice, confuso e pieno di vergogna per riuscire a dire qualche cosa. Ma forse non ce n’è bisogno. Almeno per il momento. È così bello essere lì, è così consolante la carezza del sole, rassicurante l’abbraccio della terra, dolce la compagnia degli altri girasoli.
Nessuno parla, ma un senso di gioia e di allegrezza percorre tutto il campo. Perché è sempre una grande festa quando un girasole ritorna a casa. A sera poi, quando il sole tramonta, tutti i girasoli si volgono verso oriente, là dove il sole sorgerà domani.
«Perché la sua venuta è certa» sussurra un girasole prima di addormentarsi.
«Perché tu sei il mio bene» mormora un altro.
«Perché è nella notte che bisogna credere alla luce» dice il girasole più alto.
«Perché io ho bisogno di te!» bisbiglia il più piccolino.
«Perché il sole mi ama e io amo lui e dove c’è l’amore c’è la vera libertà» pensa il girasole che è ritornato dal Polo Sud.

Il brutto anatroccolo
Era così bello in campagna, era estate! Il grano era bello giallo, l’avena era verde e il fieno era stato ammucchiato nei prati; la cicogna passeggiava sulle sue slanciate zampe rosa e parlava egiziano, perché aveva imparato quella lingua da sua madre. Intorno ai campi e ai prati c’erano grandi boschi, e in mezzo ai boschi si trovavano laghi profondi; era proprio bello in campagna!
Esposto al sole si trovava un vecchio maniero circondato da profondi canali, e tra il muro e l’acqua crescevano grosse foglie di farfaraccio, e erano così alte che i bambini più piccoli potevano stare dritti all’ombra delle più grandi.
Quel luogo era selvaggio come un profondo bosco; lì si trovava un’anatra col suo nido. Doveva covare gli anatroccoli, ma ormai era quasi stanca, sia perché ci voleva tanto tempo sia perché non riceveva quasi mai visite. Le altre anatre preferivano nuotare lungo i canali piuttosto che risalire la riva e sedersi sotto una foglia di farfaraccio a chiacchierare con lei.
Finalmente una dopo l’altra, le uova scricchiolarono. «Pip, pip» si sentì, tutti i tuorli delle uova erano diventati vivi e sporgevano fuori la testolina.
«Qua, qua!» disse l’anatra, e subito tutti schiamazzarono a più non posso, guardando da ogni parte sotto le verdi foglie; e la madre lasciò che guardassero, perché il verde fa bene agli occhi.
«Com’è grande il mondo!» esclamarono i piccoli, adesso infatti avevano molto più spazio di quando stavano nell’uovo.
«Credete forse che questo sia tutto il mondo?» chiese la madre. «Si stende molto lontano, oltre il giardino, fino al prato del pastore; ma fin là non sono mai stata. Ci siete tutti, vero?» e intanto si alzò. «No, non siete tutti. L’uovo più grande è ancora qui. Quanto ci vorrà? Ormai sono quasi stufa» e si rimise a covare.
«Allora, come va?» chiese una vecchia anatra giunta a farle visita.
«Ci vuole tanto tempo per quest’unico uovo!» rispose l’anatra che covava. «Non vuole rompersi. Ma dovresti vedere gli altri! Sono i più deliziosi anatroccoli che io abbia mai visto assomigliano tanto al loro padre, quel briccone, che non viene neppure a trovarmi».
«Fammi vedere l’uovo che non si vuole rompere!» disse la vecchia. «Può essere un uovo di tacchina! Anch’io sono stata ingannata una volta, e ho passato dei guai con i piccoli che avevano una paura incredibile dell’acqua. Non riuscii a farli uscire. Schiamazzai e beccai, ma non servì a nulla. Fammi vedere l’uovo. Sì, è un uovo di tacchina. Lascialo stare e insegna piuttosto a nuotare ai tuoi piccoli».
«Adesso lo covo ancora un po’; l’ho covato così a lungo che posso farlo ancora un po’!».
«Fai come vuoi!» commentò la vecchia anatra andandosene.
Finalmente quel grosso uovo si ruppe. «Pip, pip» esclamò il piccolo e uscì: era molto grande e brutto. L’anatra lo osservò.
«È un anatroccolo esageratamente grosso! – disse – Nessuno degli altri è come lui! Purché non sia un piccolo di tacchina! Bene, lo scopriremo presto. Deve entrare in acqua, anche a costo di prenderlo a calci!».
Il giorno dopo era una giornata bellissima; il sole splendeva sulle verdi foglie di farfaraccio. Mamma anatra arrivò con tutta la famiglia al canale. Splash! si buttò in acqua; «Qua, qua!» disse, e tutti i piccoli si tuffarono uno dopo l’altro. L’acqua coprì le loro testoline, ma subito tornarono a galla e galleggiarono beatamente; le zampe si muovevano da sole e c’erano proprio tutti, anche il piccolo brutto e grigio nuotava con loro.
«No, non è un tacchino!» esclamò l’anatra. «Guarda come muove bene le zampe, come si tiene ben dritto! È proprio mio! In fondo è anche carino se lo si guarda bene. Qua, qua! venite con me, vi condurrò nel mondo e vi presenterò agli altri abitanti del pollaio, ma state sempre vicino a me, che nessuno vi calpesti, e fate attenzione al gatto!».
Entrarono nel pollaio. C’era un chiasso terribile, perché due famiglie si contendevano una testa d’anguilla, che alla fine andò al gatto.
«Vedete come va il mondo!» disse la mamma anatra leccandosi il becco, dato che anche lei avrebbe voluto la testa d’anguilla. «Adesso muovete le zampe –aggiunse – provate a salutare e a inchinarvi a quella vecchia anatra. È la più distinta di tutte, è di origine spagnola, per questo è così pesante! Guardate, ha uno straccio rosso intorno a una zampa. È una cosa proprio straordinaria, la massima onorificenza che un’anatra possa ottenere. Significa che non la si vuole abbandonare, e che è rispettata sia dagli animali che dagli uomini. Muovetevi! Non tenete i piedi in dentro! Un anatroccolo ben educato tiene le gambe ben larghe, proprio come il babbo e la mamma. Ecco! Adesso chinate il collo e dite qua!».
E così fecero, ma le altre anatre lì intorno li guardarono e esclamarono «Guardate! Adesso arriva la processione, come se non fossimo abbastanza, e, mamma mia com’è brutto quell’anatroccolo! Lui non lo vogliamo!» e subito un’anatra gli volò vicino e lo beccò alla nuca.
«Lasciatelo stare – gridò la madre – non ha fatto niente a nessuno!».

«Sì, ma è troppo grosso e strano! – rispose l’anatra che lo aveva beccato – e quindi ne prenderà un bel po’!».
«Che bei piccini ha mamma anatra! – disse la vecchia con lo straccetto intorno alla zampa – sono tutti belli, eccetto uno, che non è venuto bene. Sarebbe bello che lo potesse rifare!».
«Non è possibile, Vostra Grazia! – rispose mamma anatra – non è bello, ma è di animo molto buono e nuota bene come tutti gli altri, anzi un po’ meglio. Credo che, crescendo, diventerà più bello e che col tempo sarà meno grosso. È rimasto troppo a lungo nell’uovo, per questo ha un corpo non del tutto normale». E intanto lo grattò col becco sulla nuca e gli lisciò le piume.
«Comunque è un maschio – aggiunse – e quindi non è così importante. Credo che avrà molta forza e riuscirà a cavarsela!».
«Gli altri anatroccoli sono graziosi – disse la vecchia – Fate come se foste a casa vostra e, se trovate una testa d’anguilla, portatemela».
E così fecero come se fossero a casa loro.
Ma il povero anatroccolo che era uscito per ultimo dall’uovo e che era così brutto venne beccato, spinto e preso in giro, sia dalle anatre che dalle galline: «È troppo grosso!» dicevano tutti, e il tacchino, che era nato con gli speroni e quindi credeva di essere imperatore, si gonfiò come un’imbarcazione a vele spiegate e si precipitò contro di lui, gorgogliando e con la testa tutta rossa. Il povero
anatroccolo non sapeva se doveva rimanere o andare via, era molto abbattuto perché era così brutto e tutto il pollaio lo prendeva in giro.
Così passò il primo giorno, e col tempo fu sempre peggio. Il povero anatroccolo veniva cacciato da tutti, persino i suoi fratelli erano cattivi con lui e dicevano sempre: «Se solo il gatto ti prendesse, brutto mostro!» e la madre pensava: «Se tu fossi lontano da qui!». Le anatre lo beccavano, le galline lo colpivano e la ragazza che portava il mangime alle bestie lo allontanava a calci.
Così volò oltre la siepe; gli uccellini che si trovavano tra i cespugli si alzarono in volo spaventati. «È perché io sono così brutto» pensò l’anatroccolo e chiuse gli occhi, ma continuò a correre. Arrivò così nella grande palude, abitata dalle anatre selvatiche. Lì giacque tutta la notte: era molto stanco e triste. Il mattino dopo le anatre selvatiche si alzarono e guardarono il loro nuovo compagno. «E tu chi sei?» gli chiesero, e l’anatroccolo si voltò da ogni parte e salutò come meglio poté.
«Sei proprio brutto!» esclamarono le anatre selvatiche «Ma a noi non importa nulla, purché tu non ti sposi con qualcuno della nostra famiglia!». Quel poveretto non pensava certo a sposarsi, gli bastava solamente poter stare tra i giunchi e bere un po’ di acqua della palude.
Lì rimase due giorni, poi giunsero due oche selvatiche, o meglio, due paperi selvatici, dato che erano maschi. Era passato poco tempo da quando erano usciti dall’uovo e per questo erano molto spavaldi.
«Ascolta, compagno – dissero – tu sei così brutto che ci piaci molto! Vuoi venire con noi e essere uccello di passo? In un’altra palude qui vicino si trovano delle graziose oche selvatiche, tutte signorine, che sanno dire qua! Tu potresti avere fortuna, dato che sei così brutto!».
«Pum, pum!» si sentì in quel momento, entrambe le anatre caddero morte tra i giunchi e l’acqua si arrossò per il sangue. «Pum, pum!» si sentì di nuovo, e tutte le oche selvatiche si sollevarono in schiere. Poi spararono di nuovo. C’era caccia grossa; i cacciatori giravano per la palude, sì, alcuni s’erano arrampicati sui rami degli alberi e si affacciavano sui giunchi. Il fumo grigio si spandeva come una nuvola tra gli alberi neri e rimase a lungo sull’acqua. Nel fango giunsero i cani da caccia “plasch, plasch!”. Canne e giunchi dondolavano da ogni parte. Spaventato, il povero anatroccolo piegò la testa cercando di infilarsela sotto le ali, ma in quello stesso momento si trovò vicino un cane terribilmente grosso, con la lingua che gli pendeva fuori dalla bocca e gli occhi che brillavano orrendamente; avvicinò il muso all’anatroccolo, mostrò i denti aguzzi e “plasch!” se ne andò senza fargli nulla.
«Dio sia lodato!» sospirò l’anatroccolo. «Sono così brutto che persino il cane non osa mordermi».
E rimase tranquillo, mentre i pallini fischiavano tra i giunchi e si sentiva sparare un colpo dopo l’altro.
Solo a giorno inoltrato tornò la quiete, ma il povero giovane ancora non osava rialzarsi; attese ancora molte ore prima di guardarsi intorno, e poi si affrettò a lasciare la palude il più presto possibile. Corse per campi e prati, ma c’era molto vento e faceva fatica a avanzare.
Verso sera raggiunse una povera e piccola casa di contadini, era così misera che lei stessa non sapeva da che parte doveva cadere, e così rimaneva in piedi. Il vento soffiava intorno all’anatroccolo, tanto che lui dovette sedere sulla coda per poter resistere, ma diventava sempre peggio. Allora notò che la porta si era scardinata da un lato e era tutta inclinata, e che lui, attraverso la fessura, poteva infilarsi nella stanza, e così fece.
Qui abitava una vecchia col suo gatto e la gallina; il gatto, che lei chiamava “figliolo”, sapeva incurvare la schiena e fare le fusa, e faceva persino scintille se lo si accarezzava contro pelo. La gallina aveva le zampe piccole e basse e per questo era chiamata “coccodè gamba corta”, faceva le uova e la donna le voleva bene come a una figlia.
Al mattino si accorsero subito dell’anatroccolo estraneo, e il gatto cominciò a fare le fusa e la gallina a chiocciare.
«Che succede?» chiese la vecchia, e si guardò intorno, ma non ci vedeva bene e così credette che l’anatroccolo fosse una grassa anatra che si era smarrita.
«È proprio una bella preda! – disse – ora potrò avere uova di anatra, purché non sia un maschio! Lo metterò alla prova».
E così l’anatroccolo restò in prova per tre settimane, ma non fece nessun uovo. Il gatto era il padrone di casa e la gallina era la padrona, e sempre dicevano: «Noi e il mondo!» perché credevano di esserne la metà, e naturalmente la metà migliore. L’anatroccolo pensava che si potesse avere anche un’altra opinione, ma questo la gallina non lo sopportava.
«Fai le uova?» chiese la gallina.
«No».
«Allora te ne vuoi stare zitto!».
E il gatto gli disse: «Sei capace di inarcare la schiena, di fare le fusa e di fare scintille?».
«No!».
«Bene, allora non devi avere più opinioni, quando parlano le persone ragionevoli».
E l’anatroccolo se ne stava in un angolo, di cattivo umore. Poi cominciò a pensare all’aria fresca e al bel sole. Lo prese una strana voglia di andare nell’acqua, alla fine non poté trattenersi e lo disse alla gallina.
«Cosa ti succede?» gli chiese lei. «Non hai niente da fare, è per questo che ti vengono le fantasie. Fai le uova, o fai le fusa, vedrai che ti passa!».
«Ma è così bello galleggiare sull’acqua! – disse l’anatroccolo – così bello averla sulla testa e tuffarsi giù fino al fondo!».
«Sì, è certo un gran divertimento! – commentò la gallina – tu sei ammattito! Chiedi al gatto, che è il più intelligente che io conosca, se gli piace galleggiare sull’acqua o tuffarsi sotto! Quanto a me, neanche a parlarne! Chiedilo anche alla nostra signora, la vecchia dama! Più intelligente di lei non c’è nessuno nel mondo. Credi che lei abbia voglia di galleggiare o di avere l’acqua sopra la testa?».
«Voi non mi capite!» disse l’anatroccolo.
«Certo, se non ti capiamo noi chi dovrebbe capirti, allora? Non sei certo più intelligente del gatto o della donna, per non parlare di me! Non darti delle arie, piccolo! E ringrazia il tuo creatore per tutto il bene che ti è stato fatto. Non sei forse stato in una stanza calda e non hai una compagnia da cui puoi imparare qualcosa? Ma tu sei strambo, e non è certo divertente vivere con te. A me puoi credere: io faccio il tuo bene se ti dico cose spiacevoli; da questo si riconoscono i veri amici. Cerca piuttosto di fare le uova o di fare le fusa o le scintille!».
«Credo che me ne andrò per il mondo» disse l’anatroccolo.
«Fai come vuoi!» gli rispose la gallina.
E così l’anatroccolo se ne andò. Galleggiava sull’acqua e vi si tuffava, ma era disprezzato da tutti gli animali per la sua bruttezza.
Venne l’autunno. Le foglie del bosco ingiallirono, il vento le afferrò e le fece danzare e su nel cielo sembrava facesse proprio freddo. Le nuvole erano cariche di grandine e di fiocchi di neve, e sulla siepe si trovava un corvo che, “ah! ah!” si lamentava dal freddo. Vengono i brividi solo a pensarci. Il povero anatroccolo non stava certo bene.
Una sera che il sole tramontava splendidamente, uscì dai cespugli uno stormo di bellissimi e grandi uccelli; l’anatroccolo non ne aveva mai visti di così belli. Erano di un bianco lucente, con lunghi colli flessibili: erano cigni. Mandarono un grido bizzarro, allargarono le loro magnifiche e lunghe ali e volarono via, dalle fredde regioni fino ai paesi più caldi, ai mari aperti! Si alzarono così alti che il brutto anatroccolo sentì una strana nostalgia, si rotolò nell’acqua come una ruota, sollevò il collo verso di loro e emise un grido così acuto e strano, che lui stesso ne ebbe paura. Oh, non riusciva a dimenticare quei bellissimi e fortunati uccelli e quando non li vide più, si tuffò nell’acqua fino sul fondo, e tornato a galla era come fuori di sé. Non sapeva che uccelli fossero e neppure dove si stavano dirigendo, ma ciò nonostante li amava come non aveva mai amato nessun altro. Non li invidiava affatto. Come avrebbe potuto desiderare una simile bellezza! Sarebbe stato contento se solo le anatre lo avessero accettato tra loro. Povero brutto animale!
E l’inverno fu freddo, molto freddo. L’anatroccolo dovette nuotare continuamente per evitare che l’acqua ghiacciasse, ma ogni notte il buco in cui nuotava si faceva sempre più stretto. Ghiacciò, poi la superficie scricchiolò. L’anatroccolo doveva muovere le zampe senza fermarsi, affinché l’acqua non si chiudesse; alla fine si indebolì, si fermò e restò intrappolato nel ghiaccio.
Al mattino presto arrivò un contadino, lo vide e col suo zoccolo ruppe il ghiaccio, poi lo portò a casa da sua moglie. Lì lo fecero rinvenire.
I bambini volevano giocare con lui, ma l’anatroccolo credette che gli volessero fare del male; e per paura cadde nel secchio del latte e lo fece traboccare nella stanza. La donna gridò e agitò le mani, lui allora volò sulla dispensa dove c’era il burro, e poi nel barile della farina, e poi fuori di nuovo! Uh, come si era ridotto! La donna gridava e lo inseguiva con le molle del camino e i bambini si urtavano tra loro cercando di afferrarlo e intanto ridevano e gridavano. Per fortuna la porta era aperta; l’anatroccolo volò fuori tra i cespugli, nella neve caduta, e lì restò, stordito.
Sarebbe troppo straziante raccontare tutte le miserie e i patimenti che dovette sopportare nel duro inverno. Si trovava nella palude tra le canne, quando il sole ricominciò a splendere caldo. Le allodole cantavano, era giunta la bella primavera!
Allora sollevò con un colpo solo le ali, che frusciarono più robuste di prima e che lo sostennero con forza, e prima ancora di accorgersene si trovò in un grande giardino, pieno di meli in fiore, dove i cespugli di lilla profumavano e piegavano i lunghi rami verdi giù fino ai canali serpeggianti. Oh! Che bel posto! e com’era fresca l’aria di primavera! Dalle fitte piante uscirono, proprio davanti a lui, tre bellissimi cigni bianchi; frullarono le piume e galleggiarono dolcemente sull’acqua. L’anatroccolo riconobbe quegli splendidi animali e fu invaso da una strana tristezza.
«Voglio volare da loro, da quegli uccelli reali; mi uccideranno con le loro beccate, perché io, così brutto, oso avvicinarmi a loro. Ma non mi importa! È meglio essere ucciso da loro che essere beccato dalle anatre, beccato dalle galline, preso a calci dalla ragazza che ha cura del pollaio, e soffrire tanto d’inverno!». E volò nell’acqua e nuotò verso quei magnifici cigni; questi lo guardarono e si diressero verso di lui frullando le piume. «Uccidetemi!» esclamò il povero animale e abbassò la testa verso la superficie dell’acqua in attesa della morte, ma, che cosa vide in quell’acqua chiara? Vide sotto di sé la sua propria immagine: non era più il goffo uccello grigio scuro, brutto e sgraziato, era anche lui un cigno.
Che cosa importa essere nati in un pollaio di anatre, quando si è usciti da un uovo di cigno?
Ora era contento di tutte quelle sofferenze e avversità che aveva patito, si godeva di più la felicità e la bellezza che lo salutavano. E i grandi cigni nuotavano intorno a lui e lo accarezzavano col becco.
Nel giardino giunsero alcuni bambini e gettarono pane e grano nell’acqua; poi il più piccolo gridò: «Ce n’è uno nuovo!». E gli altri bambini esultarono con lui: «Sì, ne è arrivato uno nuovo!». Battevano le mani e saltavano, poi corsero a chiamare il padre e la madre, e gettarono di nuovo pane e dolci in acqua, e tutti
dicevano: «Il nuovo è il più bello, così giovane e fiero! E i vecchi cigni si inchinarono davanti a lui».
Allora si sentì timidissimo e infilò la testa dietro le ali, non sapeva neppure lui cosa avesse! Era troppo felice, ma non era affatto superbo, perché un cuore buono non diventa mai superbo! Ricordava come era stato perseguitato e insultato, e ora sentiva dire che era il più bello di tutti gli uccelli! I lillà piegarono i rami fino all’acqua e il sole splendeva caldo e luminoso. Allora lui frullò le piume, rialzò il collo slanciato e esultò nel cuore: «Tanta felicità non l’avevo mai sognata, quando ero un brutto anatroccolo!».
• Perché il brutto anatroccolo decise di allontanarsi dai suoi fratelli e partì all’avventura?
• Quali difficoltà incontrò lungo il suo viaggio il brutto anatroccolo?
• Cosa accadde al brutto anatroccolo quando vide «uno stormo di bellissimi e grandi uccelli» volare nel cielo?
• Cosa significa la frase «Che cosa importa essere nati in un pollaio di anatre, quando si è usciti da un uovo di cigno?».
• Come si conclude la fiaba?
Bellinda e il mostro
C’era una volta un mercante di Livorno, padre di tre figlie a nome Assunta, Carolina e Bellinda. Era ricco, e le tre figlie le aveva avvezzate che non mancasse loro niente. Erano belle tutte e tre, ma la più piccola era d’una tale bellezza che le avevano dato quel nome di Bellinda. E non solo era bella, ma buona e modesta ed assennata, quanto le sorelle erano superbe, caparbie e dispettose, e per di più sempre cariche d’invidia. Quando furono più grandi, andavano i mercanti più ricchi della città a chiederle per spose, ma Assunta e Carolina tutte sprezzanti li mandavano via dicendo: «Noi un mercante non lo sposeremo mai». Bellinda invece rispondeva con buone maniere: «Sposare io non posso perché sono ancora troppo ragazza. Quando sarò più grande, se ne potrà riparlare». Ma dice il proverbio: finché ci sono denti in bocca, non si sa quel che ci tocca.
Ecco che al padre successe di perdere un bastimento con tutte le sue mercanzie e in poco tempo andò in rovina. Di tante ricchezze che aveva, non gli rimase che una casetta in campagna, e se volle tirare a campare alla meglio, gli toccò d’andarcisi a ritirare con tutta la famiglia, e a lavorare la terra come un contadino. Figuratevi le boccacce che fecero le due figlie maggiori quando intesero che dovevano andare a far quella vita. «No, padre mio – dissero, – alla vigna noi non ci veniamo; restiamo qui in città. Grazie a Dio, abbiamo dei gran signori che vogliono prenderci per spose». Ma sì, valli a rincorrere i signori! Quando sentirono che erano rimaste al verde, se la squagliarono tutti quanti. Anzi, andavano dicendo: «Gli sta bene! Così impareranno come si sta al mondo. Abbasseranno un po’ la cresta». Però, quanto godevano a vedere Assunta e Carolina in miseria, tanto erano spiacenti per quella povera Bellinda, che non aveva mai arricciato il naso per nessuno. Anzi, due o tre giovanotti andarono a chiederla in sposa, bella com’era e senza un soldo. Ma lei non voleva saperne, perché il suo pensiero era d’aiutare il padre, e ora non poteva abbandonarlo. Infatti, alla vigna era lei ad alzarsi di buonora, a far le cose di casa, a preparare il pranzo alle sorelle e al padre. Le sorelle invece s’alzavano alle dieci e non muovevano un dito; anzi ce l’avevano sempre con lei, quella villana, come la chiamavano, che s’era subito abituata a quella vita da cani.
Un giorno, al padre arriva una lettera che diceva che a Livorno era arrivato il suo bastimento che si credeva perso, con una parte del carico che s’era salvato. Le sorelle più grandi, già pensando che tra poco sarebbero tornate in città e sarebbe finita la miseria, quasi diventarono pazze dalla gioia. Il mercante disse: «Io ora parto per Livorno per vedere di recuperare quel che mi spetta. Cosa volete che vi porti in regalo?». Dice l’Assunta: «Io voglio un bel vestito di seta color d’aria», e Carolina: «A me invece portatemene uno color di pesca», Bellinda invece stava zitta e non chiedeva niente. Il padre dovette domandarle ancora, e
lei disse: «Non è il momento di far tante spese. Portatemi una rosa, e sarò contenta». Le sorelle la presero in giro, ma lei non se ne curò.
Il padre andò a Livorno, ma quando stava per metter le mani sopra alla sua mercanzia, saltarono fuori altri mercanti, a dimostrare che lui era indebitato con loro e quindi quella roba non gli apparteneva. Dopo molte discussioni, il povero vecchio restò con un pugno di mosche. Ma non voleva deludere le sue figlie, e con quei pochi quattrini che gli rimanevano comprò il vestito color aria per Assunta e il vestito color pesca per Carolina. Poi non gli era rimasto neanche un soldo e pensò che tanto la rosa per Bellinda era così poca cosa, che comprarla o no non cambiava nulla.
Così, s’avviò verso la sua vigna. Cammina cammina, venne notte: s’addentrò in un bosco e perse la strada. Nevicava, tirava vento: una cosa da morire. Il mercante si ricoverò sotto un albero, aspettandosi da un momento all’altro d’essere sbranato dai lupi, che già sentiva ululare da ogni parte. Mentre stava così, voltando gli occhi, scorse un lume lontano. S’avvicinò e vide un bel palazzo illuminato. Il mercante entrò. Non c’era anima viva; gira di qua, gira di là: nessuno. C’era un camino acceso: zuppo fradicio com’era, il mercante ci si scaldò, e pensava: «Adesso qualcheduno si farà avanti». Ma aspetta, aspetta, non si faceva viva un’anima. Il mercante vide una tavola apparecchiata con ogni sorta di grazia di Dio, e si mise a mangiare. Poi prese il lume, passò in un’altra camera dov’era un bel letto ben rifatto, si spogliò e andò a dormire.
Al mattino, svegliandosi, restò di stucco: sulla seggiola vicino al letto c’era un vestito nuovo nuovo. Si vestì, scese le scale e andò in giardino. Un bellissimo rosaio era fiorito in mezzo ad una aiola. Il mercante si ricordò del desiderio di sua figlia Bellinda e pensò che ora poteva soddisfare anche quello. Scelse la rosa che gli pareva più bella e la strappò. In quel momento, dietro alla pianta si sentì un ruggito e un Mostro comparve tra le rose, così brutto che faceva incenerire solo a guardarlo. Esclamò: «Come ti permetti, dopo che t’ho alloggiato, nutrito, e vestito, di rubarmi le rose? La pagherai con la vita!».
Il povero mercante si buttò in ginocchio e gli disse che quel fiore era per sua figlia Bellinda che non desiderava altro che una rosa in dono. Quando il Mostro ebbe sentito la storia, si ammansì, e gli disse: «Se hai una figlia così, portamela, che io la voglio tenere con me, e starà come una regina. Ma se non me la mandi, perseguiterò te e la tua famiglia dovunque siate». Al poveretto, più morto che vivo, non parve vero di dirgli di sì pur di andarsene, ma il Mostro lo fece ancora salire nel palazzo e scegliere tutte le gioie, gli ori e i broccati che gli piacevano e ne riempì una cassa, che avrebbe pensato lui a mandargliela a casa.
Tornato che fu il mercante alla sua vigna, le figlie gli corsero incontro, le prime due con molte smorfie chiedendogli i regali, e Bellinda tutta contenta e premurosa. Lui diede uno dei vestiti ad Assunta, l’altro a Carolina, poi guardò Bel-
linda e scoppiò in pianto, porgendole la rosa, e raccontò per filo e per segno la sua disgrazia. Le sorelle grandi cominciarono subito a dire: «Ecco! Lo dicevamo, noi! Con le sue idee strane. La rosa, la rosa! Ora dovremo tutti pagarne le conseguenze». Ma Bellinda, senza scomporsi, disse al padre: «Il Mostro ha detto che se vado da lui non ci fa nulla? Allora, io ci andrò perché è meglio che mi sacrifichi io piuttosto di patire tutti». Il padre le disse che mai e poi mai ve l’avrebbe condotta; e anche le sorelle, ma lo facevano apposta, le dicevano che era matta: ma Bellinda non sentiva più nulla; puntò i piedi e volle partire.
La mattina dopo, dunque, padre e figlia all’alba si misero in strada. Ma prima, alzandosi per partire, il padre aveva trovato a piè del letto la cassa con tutte le ricchezze che aveva scelto al palazzo del Mostro. Senza dir niente alle due figlie grandi, egli la nascose sotto il letto. Al palazzo del Mostro arrivarono di sera e lo trovarono tutto illuminato. Salirono le scale: al primo piano c’era una tavola imbandita per due, zeppa di ogni ben di Dio. Fame non ne avevano molta, pure si sedettero a piluccar qualcosa. Finito ch’ebbero di mangiare, si sentì un gran ruggito, e apparve il Mostro. Bellinda restò senza parola: brutto fino a quel punto non se l’era proprio immaginato. Ma poi, piano piano, si fece coraggio, e quando il Mostro le chiese se era venuta di sua spontanea volontà, franca gli rispose di sì. Il Mostro parve tutto contento. Si rivolse al padre, gli diede una valigia piena di monete d’oro e gli disse di lasciar subito il palazzo e di non mettervi più piede:
avrebbe pensato lui a tutto quel che poteva servire alla famiglia. Il povero padre diede l’ultimo bacio alla figlia, come avesse avuto cento spine in cuore e se ne tornò a casa piangendo da commuovere anche i sassi.
Bellinda, rimasta sola (il Mostro le aveva dato la buonanotte e se n’era subito andato) si spogliò e si mise a letto e dormì tranquilla per la contentezza d’aver fatto una buona azione e salvato suo padre da chissà quali sciagure. La mattina, s’alzò serena e fiduciosa, e volle visitare il palazzo. Sulla porta del suo appartamento c’era scritto: “Appartamento di Bellinda”. Sullo sportello del guardaroba c’era scritto: “Guardaroba di Bellinda”. In ognuno dei begli abiti c’era ricamato: “Vestito di Bellinda”. E dappertutto c’erano cartelli che dicevano:
La regina qui voi siete, Quello che volete avrete.
La sera, quando Bellinda si sedette a cena, si sentì il solito ruggito, e comparve il Mostro. «Permettete,» le disse, «che vi faccia compagnia mentre cenate?». Bellinda, garbata, gli rispose: «Siete voi il padrone». Ma lui protestò: «No, qui padrona siete solo voi. Tutto il palazzo e quel che ci sta dentro è roba vostra». Stette un po’ zitto, come sovrappensiero, poi chiese: «È vero che sono così brutto?». E Bellinda: «Brutto siete brutto, ma il cuore buono che avete vi fa quasi bello». E allora lui, subito: «Bellinda, mi vorresti sposare?». Lei tremò da capo a piedi e non seppe cosa rispondere. Pensava: «Ora se gli dico di no, chissà come la prende!» poi si fece coraggio e rispose: «Se ho da dirvi la verità, di sposarvi non me la sento proprio». Il Mostro, senza far parola, le diede la buonanotte e se n’andò via sospirando.
Così avvenne che Bellinda restò tre mesi in quel palazzo. E tutte le sere il Mostro veniva a chiederle la stessa cosa, se lo voleva sposare, e poi se n’andava via sospirando. Bellinda ci aveva tanto preso l’abitudine, che se una sera non l’avesse visto, se l’avrebbe avuta a male.
Bellinda passeggiava tutti i giorni nel giardino, e il Mostro le spiegava le virtù delle piante. C’era un albero fronzuto che era l’albero del pianto e del riso.
«Quando ha le foglie dritte in su,» le disse il Mostro, «in casa tua si ride; quando le ha pendenti in giù, in casa tua si piange».
Un giorno Bellinda vide che l’albero del pianto e del riso aveva tutte le fronde diritte con la punta in su. Domandò al Mostro: «Perché s’è così ringalluzzito?».
E il Mostro: «Sta andando sposa tua sorella Assunta».
«Non potrei andare ad assistere alle nozze?» chiese Bellinda. «Va’ pure», disse il Mostro. «Ma che entro otto giorni tu sia ritornata, se no mi troveresti bell’e morto. E questo è un anello che ti do: quando la pietra s’intorbida vuol dire che sto male e devi correre subito da me. Intanto prendi pure nel palazzo quel che più ti garba di portare in regalo di nozze, e metti tutto in un baule stasera a piè del letto». Bellinda ringraziò, prese un baule e lo riempì di vestiti di seta, bian-
cheria fine, gioie e monete d’oro. Lo mise a piè del letto e andò a dormire: e la mattina si svegliò a casa di suo padre, col baule e tutto. Gli fecero una gran festa, anche le sorelle, ma quando seppero che lei era così contenta e ricca, e il Mostro era tanto buono, ripresero a esser rose dall’invidia, perché loro conducevano una vita che, pur senza mancar di nulla per via dei regali del Mostro, tuttavia non poteva dirsi ricca, e l’Assunta sposava un semplice legnaiolo. Dispettose com’erano, riuscirono a portar via a Bellinda l’anello, con la scusa di tenerlo un po’ in dito, e glielo nascosero. Bellinda cominciò a disperarsi, perché non poteva vedere la pietra dell’anello; e arrivato il settimo giorno tanto pianse e pregò, che il babbo ordinò alle sorelle di renderle subito l’anello. Appena l’ebbe in mano, lei vide che la pietra non era più limpida come prima; e allora volle subito partire e tornare al palazzo.
All’ora di desinare il Mostro non comparve, e Bellinda era preoccupata e lo cercava e chiamava dappertutto. Lo vide solo a cena comparire con un’aria un po’ patita. Disse: «Sai che sono stato male e se tardavi ancora m’avresti trovato morto? Non mi vuoi più bene?».
«Sì che ve ne voglio» lei rispose.
«E mi sposeresti?».
«Ah, questo no» esclamò Bellinda.
Passarono altri due mesi e si ripeté il fatto dell’albero del riso e del pianto con le foglie alzate perché si sposava la sorella Carolina. Anche stavolta Bellinda andò con l’anello e un baule di roba. Le sorelle l’accolsero con un risolino falso; e Assunta era diventata ancora più cattiva perché il marito legnaiolo la bastonava tutti i giorni. Bellinda raccontò alle sorelle cosa aveva rischiato per essersi trattenuta troppo la volta prima e disse che stavolta non poteva fermarsi. Ma ancora le sorelle le trafugarono l’anello e quando glielo ridiedero la pietra era tutta intorbidita. Tornò piena di paura e il Mostro non si vide né a pranzo né a cena; venne fuori la mattina dopo, con l’aria languente e le disse: «Sono stato lì lì per morire. Se tardi un’altra volta sarà la mia fine».
Altri mesi passarono. Un giorno, le foglie dell’albero del pianto e del riso pendevano tutte giù come fossero secche. «Che c’è a casa mia?» gridò Bellinda.
«C’è tuo padre che sta per morire» disse il Mostro. «Ah, fatemelo rivedere!» disse Bellinda. «Vi prometto che stavolta tornerò puntuale!».
Il povero mercante, a rivedere la figlia minore al suo capezzale, dalla contentezza cominciò a star meglio. Bellinda l’assistette giorno e notte, ma una volta nel lavarsi le mani posò l’anello sul tavolino e non lo trovò più. Disperata lo cercò dappertutto, supplicò le sorelle, ma quando lo ritrovò la pietra era nera, tranne un angolino.
Tornò al palazzo ed era spento e buio, come fosse disabitato da cent’anni. Prese a chiamare il Mostro strillando e piangendo, ma nessuno rispondeva. Lo cer -
cò dappertutto, e correva disperata per il giardino, quando lo vide steso sotto il rosaio che rantolava tra le spine. S’inginocchiò accanto a lui, sentì che ancora il cuore gli batteva, ma poco. Si buttò sopra di lui a baciarlo e a piangere e diceva: «Mostro, Mostro, se tu muori non c’è più bene per me! Oh, se tu vivessi, se tu vivessi ancora, ti sposerei subito per farti felice!». Non aveva finito di dirlo, che d’un tratto si vide il palazzo tutto illuminato e da ogni finestra uscivano canti e suoni. Bellinda volse il capo sbalordita e quando tornò a guardare nel rosaio, il Mostro era sparito e in vece sua c’era un bel cavaliere che s’alzò di tra le rose, fece una riverenza e disse: «Grazie, Bellinda mia, m’hai liberato». E Bellinda restata di stucco: «Ma io voglio il Mostro» disse. Il cavaliere si gettò in ginocchio ai suoi piedi e le disse: «Eccolo il Mostro. Per un incantesimo, dovevo restare mostro finché una bella giovane non avesse promesso di sposarmi brutto com’ero». Bellinda diede la mano al giovane, che era un Re, e insieme andarono verso il palazzo. Sulla porta c’era il padre di Bellinda che l’abbracciò, e le due sorelle. Le sorelle, dall’astio che avevano, restarono una da una parte e una dall’altra della porta e diventarono due statue. Il giovane Re sposò Bellinda e la fece Regina. E così felici vissero e regnarono.
Il lino
Il lino era in fiore. Aveva bellissimi fiori blu, morbidi come le ali di una falena, o forse ancora più morbidi. Il sole splendeva sul lino e le nuvole di pioggia lo innaffiavano, e a lui piaceva come a un bambino piace essere lavato e avere un bacio dalla mamma; i bambini diventano ancora più belli e lo stesso accadeva al lino.
«La gente dice che io sto molto bene – esclamava il lino – e che diventerò bello alto e mi trasformerò in una pezza di stoffa. Oh, come sono felice! Sono certamente il più felice di tutti! Sto proprio bene e diventerò qualcuno. Come mi rallegra il sole e che buon profumo ha l’aria, e come mi rinfresca la pioggia! Sono immensamente felice, il più felice di tutti!».
«Certo, certo!» dissero le assi dello steccato. «Tu non conosci il mondo, noi invece lo conosciamo e ci sono venuti i nodi per i tanti affanni!» e scricchiolavano pietosamente:
Snip, snap, snurre, Basselurre, la canzone è finita.
«Non è vero!» rispose il lino. «Il sole splende, la pioggia fa bene, io mi sento crescere e so di essere in fiore! Sono il più felice di tutti!».
Ma un giorno arrivò gente che afferrò il lino dalla cima e lo sradicò, che male! Poi venne messo nell’acqua, come se lo dovessero affogare, e infine fu posto sul fuoco, e gli sembrava di arrostire: che sofferenza!
«Non si può stare sempre bene!» si disse il lino. «Per sapere qualcosa, bisogna provarlo!».
Ma diventò sempre più terribile. Il lino venne spezzettato e tritato, pestato e pettinato: già, cosa ne sapeva lui di come si dice! Fu messo sul rocchetto e, snurre rur! era impossibile raccogliere i propri pensieri!
«Sono stato straordinariamente felice!» pensò nel suo dolore. «Bisogna essere contenti delle cose belle che si sono ricevute. Contenti, contenti!» e stava ancora dicendo così quando si trovò sul telaio. Così si trasformò in una bella pezza di tela. Tutto il lino, ogni singola fibra, si trasformò in quell’unica pezza.
«È incredibile! Non l’avrei mai pensato. La fortuna mi assiste! Le assi dello steccato non la conoscevano proprio la vita, con il loro:
Snip, snap, snurre, Basselurre!
La canzone non è affatto terminata! Comincia proprio ora! È incredibile! Certo, ho sofferto un po’, ma ora sono diventato qualcuno! Sono il più felice di tutti! Sono così forte e morbido, così bianco e lungo. È tutta un’altra cosa che essere una pianta, anche se avevo i fiori. Non venivo curato e l’acqua la ricevevo solo quando pioveva. Adesso sono servito a puntino! La cameriera mi gira ogni mattina e ogni sera vengo bagnato con l’innaffiatoio. Persino la moglie del pastore ha parlato di me e ha detto che ero la pezza di stoffa più bella in tutta la parrocchia. Non potrei essere più felice!».
La tela venne portata in casa e venne trattata con le forbici. Come tagliavano, come squarciavano, e come pungevano gli aghi, quando arrivavano! Non fu un divertimento. La tela si trasformò in dodici capi di biancheria, di quella che non si può nominare, ma che tutte le persone devono avere. Ecco, dodici capi di quella.
«Adesso sono diventato importante! Era il mio destino! Un destino benedetto! Adesso sono utile al mondo, e così dev’essere, perché questa è la vera gioia. Ora siamo dodici capi, ma restiamo comunque una cosa sola, siamo una dozzina!
Che gioia incredibile!».
Passarono gli anni, e, alla fine, si consumarono.
«Arriva la fine per tutto, prima o poi!» esclamò ogni capo. «Avrei voluto resistere ancora un po’, ma non si può pretendere l’impossibile!». Così vennero trasformati in stracci e brandelli; credettero che tutto fosse ormai finito, perché furono tritati e macerati e cotti, e altre cose che non sapevano neppure loro, e alla fine diventarono una bella carta bianca sottilissima.
«Che sorpresa, che meravigliosa sorpresa!» esclamò la carta. «Adesso sono ancora più sottile di prima, e dovranno scrivere su di me. Che cosa scriveranno? Che straordinaria fortuna!». E vennero scritte le storie più belle, e la gente le ascoltò perché erano così vere e così belle che resero le persone migliori e più sagge. Era proprio una benedizione che, attraverso le parole, veniva impartita alla carta.
«È molto più di quanto avessi mai sognato, quando ero un piccolo fiore blu del campo! Come avrei potuto immaginare che avrei dovuto portare gioia e sapere tra gli uomini? Ma è proprio così! Il Signore sa che io personalmente non ho fatto nulla se non quello che era necessario perché sopravvivessi. Eppure mi sta ricoprendo di gioie e di onori, uno dopo l’altro. Ogni volta mi ripeto: la canzone è finita! E invece mi succede qualcosa di molto meglio e più elevato. Adesso dovrò certamente viaggiare, essere mandato in tutto il mondo, affinché tutti gli uomini possano leggermi! È la cosa più probabile. Prima avevo fiorellini blu, ora per ogni fiore posseggo i pensieri più belli! Sono il più felice di tutti!».
Ma la carta non si mise a viaggiare, andò invece in tipografia e tutto quello che vi era stato scritto venne stampato in un libro, o meglio, in molte centinaia di libri, perché così molta gente poté trarne gioia e utilità; se quell’unico foglio di carta su cui si era scritto fosse stato mandato in giro per il mondo, a metà strada sarebbe già stato logoro.
«Questa è la soluzione più ragionevole!» pensò la carta scritta. «Non ci avevo affatto pensato! Così io resto a casa e ricevo gli onori come un vecchio nonno. Hanno scritto su di me, le parole dalla penna sono scivolate su di me. Io resto qui e i libri se ne vanno in giro. Adesso si comincia a concludere qualcosa. Come sono felice! Come sono fortunato!».
La carta venne raccolta a fasci e posta su uno scaffale. «È bello riposarsi e meditare sul proprio operato!» esclamò la carta. «Ed è giusto che ci si raccolga a meditare su quello che si ha dentro. Solo adesso so con precisione cosa ho dentro di me. Conoscere se stessi è il vero progresso. Chissà cosa accadrà adesso? Naturalmente accadrà qualcosa di nuovo, perché è sempre così».
Un giorno tutta la carta venne messa nel camino; doveva essere bruciata, dato che non poteva essere data al droghiere per avvolgervi il burro o lo zucchero. Tutti i bambini della casa si erano raccolti per vedere la carta prendere fuoco, per vedere le numerose scintille rosse della cenere che scappavano via e si spegnevano, una dopo l’altra, molto velocemente; sembrano i bambini che escono da scuola, e l’ultima scintilla è il maestro, si crede che sia già andato via, e invece eccolo che arriva poco dopo gli altri.
Tutta la carta fu messa nel fuoco in un unico fascio. Come prese fuoco subito!
«Uh!» disse, e fu tutta una fiamma. Guizzò altissima, dove mai il lino aveva saputo alzare il suo fiorellino blu, e brillò come mai la bianca tela aveva saputo brillare. Tutte le lettere scritte diventarono rosse in un attimo e tutte le parole e i pensieri presero fuoco.
«Ora arrivo fino al sole!» disse una voce tra le fiamme, e fu come se migliaia di voci l’avessero detto contemporaneamente; e la fiamma uscì all’aperto attraverso il camino; lì, ancora più eteree della fiamma stessa e invisibili agli occhi degli uomini, volarono piccolissime creature, tante quanti erano stati i fiorellini del lino. Erano ancora più leggere della fiamma da cui erano nate, e quando questa si spense e della carta rimase solo nera cenere, danzarono un’ultima volta prima di posarsi, poi lasciarono soltanto le loro impronte, le rosse scintille.
I bambini erano usciti da scuola e il maestro per ultimo, era proprio un divertimento guardarli, e i bambini della casa si misero a cantare intorno alla cenere spenta: Snip, snap, snurre, Basselurre, la canzone è finita.
Ma ognuno di quei piccoli esseri invisibili diceva: «La canzone non è mai finita! Questa è la cosa più bella! Io lo so e per questo sono il più felice del mondo!».
Ma i bambini non vedevano e non capivano e del resto era giusto così, perché i bambini non devono sapere tutto.
Hans Christian Andersen , Fiabe, Mondadori
• Suddividi la fiaba in sequenze e numerale; poi, per ognuna di esse, inventa un titoletto e riscrivilo sul quaderno.
• Riassumi la fiaba, utilizzando il tempo presente.
Il principe Giovanni e gli omini neri
Il principe Giovanni abitava in uno splendido castello dove passava splendidamente le sue giornate. Il castello, che sorgeva sulla cima rocciosa di un’altura sovrastante un vasto territorio, aveva torri, torrette, merli, merletti, persino pinnacoli e nell’interno giardini, giardinetti, cortili, cortiletti e ancora più nell’interno, stanze, stanzoni, stanzette. Il principe aveva anche tanta servitù: servi, serve, cuochi, giardinieri e governanti per pulire, ripulire, lucidare l’intero castello. Ma la vera forza di Giovanni, che pure era un giovane felice e brillante pieno di tante bellissime qualità, stava in una piccola bimba alta tre centimetri, una piccola bimba con i capelli biondi e lisci, simpatica e carina che si chiamava Speranza. Era piccolina di statura, piccolina, piccolina, ma aveva un cuore che non si sapeva neppure da dove cominciava. Era un cuore infinito. La piccola Speranza non abbandonava mai Giovanni; l’uso infatti che il principe faceva delle sue doti naturali, del suo temperamento, del suo castello e di tutto quello che aveva era un uso lieto e simpatico proprio perché Speranza era sempre con lui e dava il tono a tutto.
Ma un brutto giorno il principe Giovanni si svegliò con la luna di traverso. Gli sembrava che tutto andasse storto, cominciò a prendersela con la servitù e non volle neanche dar retta alla piccola Speranza che ballonzolava sempre intorno a lui. Perché dovete sapere che Speranza era affettuosissima: ora saltava sulla
spalla, ora saltava sulle mani, ora saltava addirittura sul naso, sui capelli, entrava nel taschino della giubba, nella tasca dei pantaloni, scivolava giù lungo i pantaloni, si fermava sulla punta dei piedi, poi balzava sopra un pomello del letto e guardava con occhi simpaticissimi il suo Giovanni infondendogli quella energia senza la quale la vita non è neanche bella. Ma quel giorno Giovanni non ne voleva sapere di Speranza, si aggirava sempre più tetro per il castello, imprecando e prendendo a calci tutto quello che gli capitava sotto tiro. Fu proprio da quel giorno che le cose cominciarono a precipitare: Giovanni non aveva più nessun interesse per le cose, per la sua vita, per gli ospiti e per il suo castello. Così passavano i giorni e la sporcizia si accumulò, le erbacce crebbero, la servitù sentendosi abbandonata a se stessa non ubbidì più e finì col non far più niente. Dopo tre mesi il castello era quasi irriconoscibile. Le porte non curate cominciavano a cigolare, non stavano mai chiuse e sbattevano continuamente, le erbacce erano cresciute persino nelle giunture tra una pietra e l’altra sia dei cortili che delle mura del castello, tutto aveva l’aspetto decrepito e cadente di un luogo abbandonato. Eppure in quel castello c’era sempre Giovanni e c’era sempre Speranza. Ma Speranza non veniva più ascoltata. Lei si dava da fare, giorno dopo giorno, saltava sul letto dove c’era Giovanni, lo implorava: «Ma dai, su, fatti coraggio Giovanni, guardami, guardami negli occhi».
Lui non la guardava mai negli occhi, era diventato come un uomo spento.
Speranza cominciava un po’ a dimagrire, dimagriva dal nervoso. In compenso c’era chi invece si dava alla pazza gioia: le formichine cominciavano ad entrare da una parte e dall’altra, invadendo prima la cucina e poi, da lì, via alla caccia al tesoro nel castello. Ma le formichine sono chiacchierine, hanno chiamato gli scarafaggi e, gli scarafaggi con la voce da trombone hanno chiamato i ragni, che sono pigri però sono sensibili alla voce di trombone, ed hanno deciso di venire a vedere cosa c’è di bello e di buono nel castello. Si sa che quando un castello è invaso dagli insetti non è più bello viverci. Difatti, al principe Giovanni man mano che passava il tempo veniva sempre meno la voglia di vivere, non solo di vivere nel castello, ma proprio di vivere. Tutto andava a catafascio, tutto andava in rovina. Dalla parte nord del castello c’era uno strapiombo e in fondo l’immondezzaio del castello. Normalmente la servitù puliva quella zona bruciando tutti i rifiuti, ma da quando era abbandonata a se stessa e non aveva più una guida non puliva più neanche la zona dell’immondezzaio. Una puzza veniva su da quel posto! Tutti i rifiuti abbandonati, non bruciati, avevano attirato degli omini neri, con gli occhietti rossi fosforescenti. Questi omini neri, pigri, pigrissimi, stavano accoccolati in mezzo ai cespugli: sapete che i rami a un certo punto hanno una biforcazione o una triforcazione; bene, lì dove c’era la biforcazione, la triforcazione o la quadriforcazione loro si accoccolavano e dormivano con la pancetta su, oppure guardavano maliziosi le cose intorno con gli occhietti fo -
sforescenti. Il capo dormiva su una pianta insieme a tanti altri e da lì poteva guardare bene dentro la stanza di Giovanni, dopo una lunga osservazione un giorno decise di chiamare a raccolta i suoi omini neri. «Il momento è giunto miei prodi! Vale la pena di entrare nel castello perché il principe Giovanni ormai ha rinnegato Speranza. Noi ce ne infischiamo di Giovanni, faccia la sua strada bene o male, non ci interessa. Noi abbiamo un’altra nemica, una nemica che abbiamo da sempre nel sangue e negli occhi: la piccola Speranza. Allora propongo di fare così: saliamo attraverso il pluviale, scivoliamo lungo la grondaia e, arrivati vicino alla finestra, entriamo nella stanza del principe, poi ci distribuiamo e andiamo a vedere dov’è. Quando abbiamo trovato il principe possiamo essere sicuri di aver trovato anche Speranza, lei non lo abbandona mai, e allora la prendiamo e le diamo una manica di botte».
«Bene!» gridano tutti «Proprio quello che volevamo! Ma certo, addosso a Speranza!».
«Una volta che l’avremo legata,» continuò il capo «la metteremo in prigione e la sorveglieremo notte e giorno. Ucciderla non si può perché Speranza è immortale, ma la terremo legata e imbavagliata all’infinito e diventeremo i padroni del castello!».
«Alé! Alé! Così va bene. Viva il capo!».
Così, quando giunse la mezzanotte e nel cielo splendeva una falce di luna appannata da una leggera nebbiolina, mentre tutt’intorno si respirava un’aria di brivido e di misteriosa attesa, gli omini neri con gli occhi fosforescenti misero in atto il loro piano. Salirono dal tubo di scarico della pioggia, scivolarono lungo la grondaia ed entrarono dalla finestra nella stanza del principe, ma lui non c’era. Cominciarono a girare da una parte all’altra e finalmente lo trovarono nella stanza del trono che, seduto sulla sedia reale, dormiva. Accoccolata ai suoi piedi c’era Speranza, pallida e triste. Appena la videro le furono addosso e la riempirono di botte. Speranza era fantastica, aveva i pugnetti come pallottoline durissime e cominciò subito a sferrare pugni e calci difendendosi a tutto spiano. Ma gli omini neri erano troppo numerosi, centinaia e centinaia, e la piccola Speranza fu presto sopraffatta: tutta piena di bernoccoli sulla testa, fu legata e trascinata, ormai quasi in coma, fino in cantina. Trecento omini neri si misero di guardia alla porta sbarrata, gli altri, a centinaia invasero ogni angolo del castello, buttarono tutto all’aria con gran fragore di barattoli, latte, pentole e coperchi. La gente in lontananza si guardava allibita e diceva: «Quello è diventato il castello degli spiriti! Cosa mai starà succedendo al nostro amico Giovanni?».
Ora bisogna sapere che in una delle torri del castello c’era un apparecchio con gli specchi, che serviva per mandare i messaggi notturni da un castello all’altro. Tutto quel territorio infatti era cosparso di collinette, su ogni collinetta c’era un castello e, in ogni castello, vivevano un principe o una principessa, un castella-
no o una castellana. Come facevano a comunicare tra loro? Semplice. Quando la sera scendeva, accendevano i fuochi con la legna secca che avevano sulla torre più alta; la luce del fuoco veniva riflessa dagli specchi e, veniva mandata sugli specchi dei castelli che sorgevano sulle collinette circostanti. Così, a segnali di alfabeto Morse, i vari prìncipi e principesse comunicavano tutto quello che volevano dirsi. Ma ormai, da mesi e mesi, il castello di Giovanni non rispondeva più ai segnali e dalla sua torre più alta non partiva mai nessun messaggio. Gli omini neri erano saliti fin sulla torre e avevano fracassato tutti gli specchi. Erano proprio degli omini neri della malora! Preoccupato del lungo silenzio un bel giorno il principe Igor, che abitava nel castello di un’altissima collinetta giù verso sud-est, decise: «Basta! È giunto il tempo di andare a vedere che cosa è capitato al nostro caro amico Giovanni!». Tutti i principi e le principesse si diedero appuntamento per la mattina alle 7 al ponte levatoio del castello di Igor per decidere il da farsi. Fu la principessa Liuba, la grande amica di Giovanni, a dare le direttive. «Noi ora marceremo verso il castello di Giovanni. Quando saremo nelle vicinanze, cominceremo ad innalzare il nostro cantico di amicizia. Se non risponde ci avvicineremo di più e se non risponde ancora, entreremo!».
Così avvenne, in breve giunsero al castello di Giovanni cantando il loro inno
di amicizia, ma dall’interno non venne alcun segno di vita. C’era uno strano silenzio di morte. Scesero tutti da cavallo, si avvicinarono al portone e gridarono. «C’è nessuno? C’é nessuno?».
Nessuno rispose, allora entrarono nel castello. Si sentivano rumori sordi, giù in cantina, ogni tanto dei tonfi e dei movimenti strani. I principi si dicevano tra loro: «C’è qualcosa di strano, di misterioso in questo castello, ma non dobbiamo avere paura!».
Ciascuno di questi principi e principesse infatti era sostenuto dalla propria piccola Speranza. Ad un certo punto scorsero il principe Giovanni, seduto con occhi quasi spenti sul trono principesco. «Che fai qui, Giovanni? Ehi! Ma come sei sporco, disordinato! Hai le gambe grosse grosse, che malattia hai? Non riesci più a muoverti? Dov’è Speranza?».
Lui non rispondeva e neanche apriva gli occhi, e se li apriva, gli occhi dentro erano spenti. Si avvicinò Liuba, che era la sua grande amica, e disse: «Ma Giovanni, sono mesi che noi cerchiamo di lanciarti messaggi e tu non rispondi, ma che cosa hai fatto? Cosa ti è successo? Sono entrati i nemici? È capitato qualche cosa che non va?».
Giovanni era svagato, non sapeva cosa dire: «Ah, sì, no, no… non so… Ciao. ciao, andate».
«Ma come andate! Noi siamo venuti per darti una mano!».
«No, no, tanto ormai non c’è più niente da fare. No! per carità».
«Ma no, guarda che noi ti vogliamo sempre bene, c’è sempre la possibilità di ricominciare. Ti cureremo, cercheremo di aiutarti a guarire!».
«No, ma no, tanto ormai muoio».
«Ma che muoio, tu non muori, tu devi ritrovare Speranza. Dov’è Speranza?».
«No, io non… Speranza… ma chi è? Cos’è? No, non mi interessa, è morta, è morta».
«Tu sai che Speranza è immortale, non muore».
«Sì, ma per me è morta, morta, morta. Lei non mi interessa più, per niente».
Allora Liuba gli dà un bacio sulla fronte, poi un altro, poi gli accarezza i capelli e Giovanni la guarda. Liuba sorride, lui la guarda e gli si illuminano un po’ gli occhi, perché di fronte all’amore anche gli occhi dei più sfortunati si illuminano di letizia.
«Dov’è Speranza?» chiede Liuba.
«Mah, non so, l’han fatta prigioniera, l’hanno imprigionata gli omini neri».
«Gli omini neri? Ma chi sono gli omini neri?».
«Sono degli omini piccolissimi, brutti, che corrono dappertutto».
«Ah! sì dobbiamo averli intravvisti. Ma alzati svelto devi mandarli via subito! Devi ritrovare Speranza! Noi ti accompagneremo, ma dovrai essere tu con le tue gambe, con le tue mani, con il tuo cuore a liberare Speranza».
I principi si fanno attorno a Giovanni, lo sollevano dalla sedia e lo aiutano a fare i primi passi e lui, lentamente incomincia a camminare, si dirige verso la porta, scende da una scaletta, imbocca un lungo corridoio, gira a sinistra, attraversa un grande atrio, trova un altro corridoio. Poi scende giù, giù, fino in cantina. Uno stuolo di omini neri, centinaia e centinaia sul pavimento, sui muri, sulla porta sbarrata erano lì a difendere la loro prigioniera. Giovanni avanza con i suoi piedi che paiono enormi e… crash, crash, schiaccia tutti gli omini neri che capitano sul suo cammino, molti vorrebbero scappare ma restano come impietriti vedendo l’incedere deciso del principe. Con un calcio Giovanni apre la porta, la piccola Speranza appena lo vede freme, ma non può muoversi, non può parlare perché è tutta legata. Allora lui si china, e la libera, toglie i legacci e Speranza, che era come una Cenerentolina tutta magrolina con le guancette pallide pallide e i capellini che venivano giù tutti dritti, con il vestito tutto rotto, salta immediatamente al collo di Giovanni e gli dà un bacio e Giovanni si sente invadere da una forza nuova, che era una forza antica. E questa forza gli permette di andare all’assalto degli omini neri. Corre a prendere uno schiacciamosche e pam! pam! pam! non ne manca nemmeno uno, li uccide tutti. Speranza sulla sua spalla è raggiante! Giovanni si sente rimescolare il sangue nelle vene, scopre di essere pieno di vigore guarda i suoi amici con un gusto antico, li accarezza con gli occhi e li abbraccia uno per uno.
Tutti lo baciano lo abbracciano, poi vanno di sopra e cominciano a darsi da fare per mettere a posto il castello. Viene chiamata tutta la servitù che era diventata buzzurra, tamarra, e tutti si inchinano davanti al principe: «Scusa Giovanni, ma noi senza guida non eravamo capaci di fare niente, per questo ci siamo buttati nell’ozio. Adesso ti seguiremo di nuovo, avanti, avanti, di nuovo tutti ai loro posti di combattimento e mettiamo a posto il castello». Nel giro di due settimane il castello è ridiventato splendente. Tolte tutte le erbacce, tutti i ragni cacciati dai buchi, le formichine spazzate via, pulita la cucina, rimesso tutto a nuovo. E quando tutto è rimesso a nuovo Giovanni con i suoi amici fa un bellissimo banchetto. È il banchetto della ritrovata Speranza, del nuovo gusto di vivere che Speranza sempre infonde.
Carlo Romagnoni
RACCONTI STORICI
Profezia della gloria di Roma
Roma circonderà i suoi sette colli con invincibili mura e si popolerà di guerrieri realizzando un impero che non avrà d’uguali al mondo.
L’imperatore Augusto porterà la pace, estenderà l’Impero oltre le estreme terre dell’Oriente e dell’Africa e governerà secondo le leggi più sacre, insegnando a essere generosi con chi è stato sconfitto e umiliare chi invece è superbo.


Storia di due bimbi appena nati
«Eccoli» disse l’uomo, portando una cesta di vimini elegante, con le legature di rame, al principe Amulio.
«Sono qui? Due? Due bimbi? Non li voglio vedere, non li voglio toccare. Portali fuori dal palazzo e dalla città: in questo stesso giorno devono morire: oggi, hai capito? Non m’importa di sapere come e dove, mi basta essere sicuro che son morti. Va’, portali dove ti pare: ben lontano nella foresta dove ci siano dei lupi affamati. No, non basta; uccidili tu stesso, subito, nella foresta. Portali via, ti dico. E quando torni alla mia presenza, questi due bambini – hai ben capito? –non devono più essere al mondo».
L’uomo che portava la cesta era uno dei cacciatori più fidi e feroci del principe Amulio. Aveva ucciso innumerevoli lupi e cinghiali selvaggi, i nemici del suo signore li aveva ammazzati senza pietà. Ma a vedere quei due bimbi così belli e ridenti, che parevano frutti maturi nel loro cesto di vimini, a vederli così deboli, due cosini da niente, che a farli morire non ci voleva nemmeno un po’ di forza né di lotta, il vecchio cacciatore rimase incerto. A disobbedire al principe non ci pensava neppure: sapeva troppo bene quello che sarebbe successo se lui se n’accorgeva! Prese la cesta di vimini e uscì dal palazzo. Traversò la città e andò a vagare per i boschi, lontano lontano, dove si sentivano gli urli dei lupi.
I bambini, per fortuna, dormivano tranquilli: come se non ci fossero neppure. Il cacciatore non depose la cesta nel bosco, ma voltò a destra dalla parte del fiume.
«Che cosa ne faccio, che cosa ne faccio?».
Arrivò al Tevere, che correva rapido e biondo.
Non lontano dal Tevere c’era una casupola, nella quale abitava un uomo, che custodiva i porci del principe Amulio. Intorno alla casupola una quantità di maiali grandi e piccoli, grufolavano: le madri grosse e nere, con le codine arricciate, conducevano i loro branchi di maialetti rosa là dove il sudicio era più pantanoso, sorvegliando intorno attente per difendere i figli dai possibili pericoli. Il cacciatore andò avanti, risalendo il corso del fiume, pensando a quella cesta che teneva sotto il mantello, e ai due bimbi che dormivano così tranquillamente come se fossero nelle braccia della loro madre.
A un tratto si scosse come da un sogno e alzò la testa, guardandosi intorno. Sopra un monticello, ritta e come tagliata in nero sul fondo del cielo azzurro, grande, con gli orecchi aguzzi e gli occhi lucenti come carboni accesi, vide una lupa che lo guardava fisso.
«Ecco chi ucciderà i bambini. Quella ha certo i lupacchiotti a casa e sta cercando qualche cosa da mangiare per loro. Lascio qui tutto e fra un’ora i bambini son bell’e divorati. Poveri piccini, mi dispiace! Ma l’ordine è questo: io devo obbedire».
E il vecchio cacciatore depose la cesta fra i cespugli spinosi, sulla riva del fiume. Poi tornò in città.
«Tutto fatto?» domandò il principe.
«Tutto fatto: sono sistemati come meglio non si poteva. E adesso dammi altri ordini. Ci sono lupi, orsi, cinghiali, nemici da combattere? Io li ucciderò tutti».
E il principe Amulio fu contento, perché ebbe la certezza che i figli della principessa Silvia erano morti, ben morti; non sarebbero mai venuti a rivendicare i loro diritti al trono del re Numitor, che gli dava così poca noia e studiava sempre!
Ma intanto fra i cespugli presso al fiume succedeva una cosa strana.
Una lupa veniva tutti i giorni dal bosco e andava verso il fiume. Passava davanti alla casupola del guardiano di porci, traversava il piano coperto di sassi e si accovacciava fra i cespugli sempre allo stesso posto: rimaneva accovacciata per un certo tempo, e poi riprendeva la via del bosco. Veniva ogni giorno, e più di una volta al giorno. E un picchio volava accanto alla lupa e se ne stava anche lui fra i cespugli, tutto affaccendato, come se lì ci avesse fatto il suo nido.
Il guardiano di porci, Faustolo, vide la lupa passare. La vide un giorno, la vide due, la vide tre giorni. Allora lo disse a sua moglie, Acca Larenzia.
«Acca, ma non sai? Una lupa viene tutti i giorni dal bosco, e va verso il fiume. Viene tranquilla tranquilla e non guarda nemmeno i maialini, ma passa lesta come se avesse qualche cosa d’importante da fare. Rimane al fiume un poco, circa sempre lo stesso tempo, e ritorna al bosco tranquilla e contenta, come una che abbia fatto il suo dovere. Che cosa ci può essere di tanto interessante per lei laggiù?».
«Io non l’ho vista: te la sarai sognata!» rispose la moglie.
«Non me la sono sognata; l’ho vista, l’ho vista con questi occhi: tre volte è passata, e sempre alla medesima ora. Domani si sta alla vedetta: te ne persuaderai anche tu. Verrà anche domani: sono sicurissimo!».
Il giorno dopo Faustolo e sua moglie stettero a guardare insieme. E videro infatti la lupa uscire dal bosco, avviarsi seria seria verso il fiume come chi non ha tempo da perdere. Poi si fermò e s’accucciò, nel posto preciso del giorno prima: e il picchio volava anche lui intorno a quella macchia, tutto affaccendato come se lì ci avesse il suo nido. Dopo un poco la lupa se ne tornò indietro tranquilla e contenta, ma il picchio rimase ancora un pezzetto in faccende, come se fra quei cespugli avesse il suo nido.
«Si va a vedere che cosa c’è laggiù?» propose Acca quando la lupa fu tornata nel bosco.
«Andiamo, andiamo!» rispose Faustolo.
E andarono. Scorsero fra i cespugli una cesta di vimini con legature di rame, e in quella cesta qualche cosa che si muoveva, che rideva.
«Un bambino, due bambini!» esclamò Faustolo. «Come sono belli, che brava bestia! Che si fa?».

«Si prendono con noi» disse la donna. «Ci pensa una lupa a questi due piccolini, e vuoi che non ci pensiamo noi? È chiaro che son protetti da qualche dio o da qualche dea. Guarda questo picchio come se ne sta qui intorno, e che voglia ha di fare qualche cosa anche lui!».
«Già» rispose il marito di Acca grattandosi l’orecchio. «Ma ci sono delle difficoltà! Bisogna nutrirli, questi bambini! E poi, se il nostro padrone viene a sapere che abbiamo adottato un bambino, anzi due, che cosa dirà? Mi secca, questa faccenda!».
«Prima di tutto il principe Amulio non saprà mai che abbiamo adottato due bambini! Ti pare che un principe come lui si occupi di quello che fanno due poveri diavoli come noi? Se poi se ne accorge, gli diremo che sono nostri, o bella! Figlioli non ne abbiamo, ma si potrebbe anche averne!».
«E da mangiare, chi glielo dà?».
«Toh! Continuerà la lupa, come finora. Vedrai che se li trova fuori della capanna quando passa, il suo latte seguiterà a darglielo. Ormai c’è affezionata, a questi bimbi. Ma guarda come sono belli, e sani, e forti: eppure devono essere nati da pochi giorni».
Acca prese su la cesta, si portò i due piccini a casa, e se ne occupò con molto amore. Quanto al mangiare, aveva ragione lei. La lupa continuò a venire tutti i giorni, e invece di andare al solito posto accanto al fiume, si fermava vicino alla capanna, lì dove Acca ogni giorno alle stesse ore deponeva i bambini. Dava loro il suo latte, ed essi la riconoscevano, si rallegravano quando la vedevano arrivare, e giocavano con lei come due lupacchiotti.
Anche il picchio svolazzava intorno: che cosa facesse non lo saprei dire, ma certo pensava di essere molto importante, e che senza di lui le cose non potevano andare, perché si dava certe arie!
I bambini crescevano, tra il fiume biondo e i boschi neri; sempre un po’ selvaggi per via del latte di lupa col quale erano nutriti. Crescevano, e diventavano così forti che vincevano tutti gli altri ragazzi.
Laura Orvieto, La nascita di Roma, Giunti Junior
Perché febbraio ha 28 giorni?
Tanti secoli fa, prima del nostro attuale calendario (detto gregoriano), gli antichi Romani utilizzavano quello di Romolo, composto da 304 giorni, ovvero 10 mesi: il primo dell’anno era marzo, mentre settembre, ottobre, novembre e dicembre si chiamavano così perché erano il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo mese.
Nel 713 a.C., Numa Pompilio aggiunse alla fine dell’anno gennaio e febbraio, che era l’ultimo mese e a cui vennero assegnati 29 giorni.
Poi arrivò Giulio Cesare, che inserì gli anni bisestili e cambiò il capodanno, spostandolo a gennaio.
Successivamente, si decise di dedicare ad Augusto il mese di sestile, che divenne “agosto”, ma che aveva solo 30 giorni invece di 31, come il mese di luglio, dedicato a Giulio Cesare. Per dare uguale importanza ai due imperatori, si aggiunse un altro giorno ad agosto, rubandolo proprio al povero febbraio, che rimase così con soli 28 giorni, anche se per alcuni storici avrebbe sempre avuto 28 giorni. Su un dato però sono tutti d’accordo: questo mese era considerato il più brutto, infatti era il mese dedicato alle purificazioni dopo gli errori commessi durante l’anno.
«Focus Junior», settembre 2013
Il ponte
L’ultimo re di Roma, Tarquinio il Superbo, nel 509 a.C., fu cacciato dai suoi sudditi poiché governava con la violenza e il terrore. Essendo egli di origine etrusca, si era accordato con Porsenna, re della città di Chiusi, un’importante città etrusca, che intendeva muovere guerra a Roma, per tentare di rientrare in città e riprendere il potere.
Poiché Roma si estendeva sul fiume Tevere, Porsenna, per poterla assediare, avrebbe dovuto prima attraversare con il suo esercito il fiume. Esisteva un unico ponte per farlo, il ponte Sublicio, costruito dal quarto re di Roma, Anco Marzio. Questo ponte era molto stretto…
Questo pensiero confortava Orazio Coclite, il centurione romano posto con un drappello di soldati a guardia del ponte. Egli vedeva avanzare l’imponente esercito etrusco di Porsenna e sapeva che tutti quegli uomini sarebbero dovuti transitare su quel ponte, l’unico esistente, per conquistare Roma.
La situazione era difficile e i suoi lo guardavano spaventati. Egli andò all’inizio del ponte, dalla parte da cui sarebbero arrivati i nemici, i quali erano sempre più vicini al ponte e cominciavano a sfavillare le prime frecce.
Orazio, rivolgendosi ai suoi uomini, disse: «Voi restate alle mie spalle e comin-
ciate a demolire il ponte! Di qui non devono passare! Cercherò di ostacolarli il più possibile!».
«Ma è un’impresa difficilissima; ti uccideranno!» gli gridarono i soldati.
«Voi pensate a fare a pezzi il ponte! E tenete alti gli scudi!» ribatté Orazio.
E fu così che, sia pure con un solo occhio, mentre nell’aria si sentivano i colpi d’ascia dei compagni che cercavano di abbattere il ponte, Orazio cominciò a sferrare colpi contro i nemici, che intanto colpivano a morte i Romani guidati da Orazio Coclite. Quando restava da abbattere soltanto una piccola parte del ponte, Orazio ordinò ai suoi soldati di mettersi in salvo, rimanendo a combattere da solo.
«Io non sto difendendo un ponte» urlò al nemico che lo derideva «ma la mia patria e la mia libertà, che appartiene a me e al mio popolo e non a quel Tarquinio tiranno che vorreste rimettere sul trono!».
Così dicendo trafisse il soldato che aveva di fronte e a lui ne seguirono molti altri. I cadaveri degli Etruschi si ammassavano ai suoi piedi, mentre gli uomini alle sue spalle lavoravano senza sosta. Il loro massacrante lavoro non durò però a lungo, perché dall’altra parte del ponte si sentivano i soldati romani gridare al loro comandante: «Il ponte sta per crollare! Presto, Orazio, raggiungici!».
Orazio, invece restò ancora a combattere da solo contro il nemico e solo quando sentì uno scricchiolio più forte, seguito da uno schianto, decise di arretrare. Gli Etruschi non si erano accorti di quanto stava accadendo e invasero in massa la passerella. Ciò causò il crollo del ponte che vide precipitare la gran parte dei soldati etruschi. Lo stesso Orazio non poté più arretrare perché il ponte alle sue spalle non esisteva più e, dopo aver rivolto una preghiera agli dei per avergli consentito di salvare la patria, si lasciò cadere in acqua con la pesante armatura. Il Tevere fu buono e consentì ad Orazio di raggiungere a nuoto l’altra riva. Roma era salva e i Romani dedicarono al loro comandante una statua nel foro, la prima di cui si ha notizia nella storia di Roma. Gli fu anche concesso un pezzo di terra grande quanto riuscisse a delimitarne, dall’alba al tramonto, con un aratro trainato dai buoi.
ESEMPI DI EROISMO
Il vessillifero della decima legione
Poiché i nostri soldati esitavano soprattutto per la profondità del mare, colui che portava l’aquila della decima legione, dopo aver invocato gli dei affinché il suo atto portasse fortuna alla legione, disse: «Saltate giù, commilitoni, se non volete consegnare l’aquila ai nemici: io, per quanto mi riguarda, assolverò al mio dovere verso lo Stato e verso il comandante».
Detto ciò a gran voce, si gettò dalla nave e cominciò a portare l’aquila verso i nemici.
Allora i nostri, incoraggiatisi tra loro a non tollerare così grande vergogna, tutti quanti saltarono giù dalla nave. Dalle navi vicine, avendoli visti, li seguirono e si avvicinarono ai nemici.
Caio Giulio Cesare, Commentarii De bello gallico, IV, 25, Edizioni
Acilio
I suoi soldati, poi, nutrirono verso di lui una tale simpatia e gli erano tanto affezionati che, mentre nelle campagne militari precedenti non si erano dimostrati affatto superiori ai loro compagni, ora riuscirono invincibili e si gettarono in qualsiasi pericolo per assicurare la gloria di Cesare; nessuno poteva più resistere loro. E qui si potrebbe citare quell’Acilio, che nella battaglia navale di Marsiglia saltò a bordo di una nave nemica ed ebbe la mano destra mozzata da un colpo di daga; non depose però lo scudo, che teneva con la mano sinistra, ma, premendolo sulla faccia dei nemici, li sgominò tutti quanti e si impadronì della nave.
Plutarco, Vite parallele: Alessandro e Cesare, 16, Bur
Cassio Sceva
Oppure Cassio Sceva nella battaglia di Durazzo ebbe un occhio asportato da una freccia, la spalla trapassata da un giavellotto, come pure la coscia; ricevette centotrenta proiettili sopra lo scudo e alla fine chiamò i nemici, dicendo di volersi arrendere; ma quando due di essi si fecero avanti, ad uno staccò la spalla con la daga, all’altro assestò un colpo in faccia e li fece fuggire entrambi, riuscendo ancora a salvarsi perché i suoi compagni lo presero in mezzo e lo difesero.
Plutarco, Vite parallele: Alessandro e Cesare, 16, Bur
Un soldato
Quest’altro fatto avvenne in Britannia: i nemici assalirono i comandanti dei reparti che si erano spinti innanzi ed erano caduti in una palude fangosa, piena d’acqua; un soldato si lanciò però nel folto dei nemici – Cesare assisteva di persona alla battaglia – e, dopo aver compiuto innumerevoli, cospicue prove di
coraggio, mise in fuga i barbari, salvò i comandanti e attraversò la palude per ultimo dopo tutti, fra gravi difficoltà, gettandosi nella corrente limacciosa: ne uscì infine a stento, senza scudo, un po’ a nuoto e un po’ a piedi. Cesare e il suo seguito, meravigliati di tanta prodezza, gli andarono incontro con grida di gioia; ma il soldato, assai sconfortato e in lacrime, si gettò ai piedi di Cesare e gli chiese perdono di avere abbandonato lo scudo.
Plutarco, Vite parallele: Alessandro e Cesare, 16, Bur
Granio Petrone
In Libia le truppe di Pompeo catturarono una nave appartenente alla flotta sulla quale viaggiava Granio Petrone, il questore eletto. Tutti gli altri membri dell’equipaggio furono considerati come preda di guerra, al questore invece fecero salva la vita. Egli protestò che i soldati di Cesare usano concedere non ricevere la salvezza, e si uccise con un colpo di spada.
E Plutarco ci aiuta a capire qual era l’origine di tale eroismo: Era lo stesso Cesare a favorire e alimentare simile spirito di coraggio e tale desiderio di gloria, innanzitutto compiacendo i soldati e premiandoli senza risparmio, dimostrando così che non raccoglieva denaro dalle guerre per lusso privato o per soddisfare le sue voglie, ma che esso si trovava presso di lui custodito come premio comune del valore, e che egli ne aveva parte in quanto ne distribuiva ai soldati degni; in secondo luogo poi con il partecipare volontariamente a ogni azione rischiosa e con l’accettare qualsiasi fatica.
Plutarco, Vite parallele: Alessandro e Cesare, 16, Bur
La visione di Costantino
Costantino si avviò adagio, adagio verso le tende. Dinnanzi all’ingresso trovò Valentino, che fissava il cielo come incantato.
«Che succede in cielo?» stava per domandare. Ma non domandò nulla, e si mise anche lui a fissare il firmamento. Il sole stava per tramontare, e sopra di esso si librava una strana massa color arancione. La massa si sciolse, si trasformò in un gigantesco getto di fuoco scagliato verso il cielo… e il getto si divise in due rami… Un lunghissimo getto, due rami e la trasformazione continuava. «Somiglia… somiglia… a una croce» disse Costantino. Pulsante, vivida e scintillante… in eterno moto. La vedeva ancora, allo svegliarsi, e gli parve proferire alcune parole, che andò poi ripetendo: «In questo segno vincerai! In questo segno vincerai!».
Si levò barcollante.
In questo segno vincerai!
Chi l’aveva detto? L’aveva detto qualcuno? O l’aveva visto scritto?
In questo segno vincerai!
Entrando, l’aiutante trovò l’imperatore dritto davanti alla scrivania, completamente sveglio. «Prendi nota, Valentino! Ordine generale a tutte le truppe…». Le nebbie mattutine del 28 ottobre si alzavano. Bemborige si destò, scacciò il sonno dagli occhi sfregandoli, e fissò uno sguardo stupito su Vito, già completamente armato.
«Che succede? Chi ci ha chiamato?».
«Alzatevi, oggi è la giornata! Voi sapete cosa intendo. Avete visto i segni come li ho visti io. Vi ho pur detto che ci saranno dati dei segni: eccoli!» disse Vito. «Va’ là con tutte le tue eterne superstizioni! Non si può più nemmeno dormire in pace».
«È stato il segno della croce. Questo è il segno. Ne vedrai altri. Questo è il giorno» disse Vito tranquillamente.
«Sveglia, tutti in piedi! Prepararsi al più presto!» tuonò la voce profonda del centurione Apro che entrava già equipaggiato, seguito da un uomo che portava una secchia piena di color bianco.
«Attenzione!» comandò il centurione. Tutti lo guardarono imbarazzati: una grande croce bianca era dipinta sul suo elmo.
«Ordine dell’imperatore: ognuno dipinga una croce sull’elmo e un’altra sullo scudo. E senza spruzzare il colore. State attenti bestioni! Avanti! Indossate l’armatura».
Videro Vito andare incontro all’uomo della secchia, inginocchiarsi verso la secchia, mettere da parte lo scudo e togliersi l’elmo con un gesto quasi sacerdotale. Un robusto pennello fu immerso nella secchia. Il lavoro fu eseguito rapidamente e Vito si levò. «Bene, avanti il prossimo!» disse Apro.
Louis De Wohl, L’albero della vita. Il romanzo di sant’Elena, Bur
Mettiamoci all’opera
Come i Romani:
la pavimentazione a mosaico
Possiamo scoprire la molteplicità, la combinazione, il ritmo e l’ordine delle forme geometriche lavorando con delle piastrelline quadrate e cercando di creare composizioni ordinate, con ritmi ripetuti per realizzare sequenze geometriche.
Se osserviamo i pavimenti di epoca romana rico nosciamo la medesima logica compositiva: simmetria, ritmo, ripetizione di motivi. Che bellezza e che effetto ottico possono dare piccoli pezzetti di pietra colorati o bianchi e neri. Ci sono un ordine e una regolarità che attirano il nostro sguardo. Chi l’avrà realizzato? Chi l’avrà pensato? Gli Antichi possono essere considerati veri e propri maestri dai quali imparare e con i quali sentirsi in sintonia.

Lavorando con i tuoi compagni puoi progettare e comporre una figura quadrata che poi unita alle altre, con lo stesso motivo, può formare una pavimentazione. Il disegno geometrico è una “lingua speciale” per capire e ritrovare il pensiero ordinato che ha portato a realizzarlo. Attraverso gesti semplici e precisi riusciamo a copiare, inventare, realizzare composizioni che appaiono complesse ma in realtà sono composte da elementi semplici.

SCRITTORI ANTICHI
I Latini sono il popolo che ha abitato l’Italia dal X secolo a.C. e ha dato origine alla grande civiltà romana che si è estesa durante i secoli in Europa, in Africa settentrionale e nel vicino Oriente, creando un grande impero da cui poi nel IV-V secolo hanno cominciato a crearsi i regni da cui sono nati gli stati europei.
Ci hanno lasciato in eredità molte ricchezze: la nostra organizzazione delle città e della giustizia si basa sul modello romano, la costruzione dei nostri edifici utilizza le tecniche costruttrici dei Romani, la nostra lingua, come il francese e lo spagnolo derivano dal latino ( lupus, italiano“ lupo”, francese “loup”, spagnolo “lobo”).
Ma soprattutto ci hanno lasciato molti scritti in cui hanno espresso il loro modo di pensare e di vivere la storia, la guerra, la città e la natura, l’amicizia, l’amore e il rispetto per il Dio, in parte traendo spunto dalla civiltà greca, in parte introducendo un loro personale modo di pensare. Ecco qualche esempio.
I difetti
Giove ci mise due bisacce: pose dietro la schiena la bisaccia piena dei propri difetti, sospese davanti al petto la pesante bisaccia dei vizi degli altri. A causa di ciò non possiamo vedere i nostri difetti, ma siamo censori non appena gli altri sbagliano.
I nostri antenati
Sallustio in un momento molto difficile per la vita politica di Roma in cui i Romani lottavano tra di loro divisi in due partiti, ricorda la grandezza dei loro antenati che avevano sempre saputo prendere il meglio anche dai nemici, costruendo così la loro grande civiltà.
I nostri antenati non mancarono certo né di saggezza né di audacia, né l’orgoglio impedì loro di adottare istituzioni di altri popoli, purché esse fossero valide. Presero dai Sanniti la maggior parte delle armi, dagli Etruschi le insegne delle magistrature: insomma, tutto ciò che a loro, presso gli alleati o presso i nemici, sembrava utile lo imitavano col massimo impegno in casa loro, perché preferivano imitare piuttosto che invidiare i buoni esempi.
Sallustio, La congiura di Catilina, 51, 37-38
Le lodi d’Italia
Né l’India né tutta l’Arabia ricca di sabbie che contengono incenso superano i pregi dell’Italia.
Qui la primavera è perenne e l’estate si estende al di là dei mesi estivi: qui il bestiame dà figli due volte l’anno, due volte l’albero produce frutti. Non ci sono le tigri rabbiose, né la razza crudele dei leoni, il serpente squamoso non striscia per terra con le immense curve né si raccoglie in una così enorme spirale. Aggiungi tante illustri città ed opere, tante fortezze innalzate sui monti scoscesi e i fiumi che bagnano le mura antiche. Devo ricordare il mare che la circonda da entrambi i lati? O i grandi laghi? Te, lago di Como, più grande di tutti, te, lago di Garda, che ti innalzi con onde e fragore marini? O devo ricordare i porti, e il mare che infuria con grande fragore? In questa stessa terra vi erano vene d’argento, miniere di rame e l’oro scorreva abbondante. E ha creato una forte razza di uomini, i Marsi, i Sabelli, i Liguri abituati agli stenti, i Volsci armati di lancia, e i Deci, i Marii, i grandi Camilli, gli Scipioni duri in guerra e te, grandissimo Cesare, che ora già vittorioso nelle estreme terre dell’Asia, tieni lontani dalle rocche di Roma gli Orientali non abituati alla guerra. Salve, grandissima madre di messi, terra Saturnia, e madre di eroi!
Virgilio, Georgiche II, 138-173
Cause del terremoto il motivo del nostro timore
In quest’opera il filosofo Seneca indaga sui fenomeni naturali, tra cui ad esempio il terremoto che sconvolgeva spesso il territorio dell’Italia. Cerca le cause così come i moderni scienziati, non accontentandosi di voci e superstizioni.
Gioverà credere che gli sconvolgimenti del cielo e della terra non sono le conseguenze della collera divina: questi fenomeni hanno le loro cause, e non infuriano a comando, ma gli elementi, come i nostri corpi, vengono alterati e, mentre sembra che facciano del male, lo subiscono. Tutti questi fenomeni provocano in noi ammirazione e timore: e poiché la causa del nostro timore è l’ignoranza, non vale la pena di sapere, per non avere più paura? Quanto è meglio ricercare le cause, e dedicarsi completamente a questo con tutti se stessi! Ricerchiamo, dunque, che cosa sia che scuote la terra fin dal profondo, che muove una massa così pesante… «Quale vantaggio ne trarremo?», chiedi. Il più grande di tutti: la conoscenza della natura. Infatti, l’affrontare questo argomento, pur avendo in sé molte cose che potranno essere utili, non ha niente di più bello del fatto che con la sua magnificenza avvince l’uomo e che la ricerca viene condotta non in vista di un guadagno, ma per la meraviglia destata da questi fenomeni. Indaghiamo, dunque, per quale motivo accadano queste cose.
Dopo aver elencato tutte le cause pensate dagli antichi, conclude:
Io credo… che la causa di questo flagello sia l’aria. Il terremoto non si verifica in superficie o in prossimità della superficie, ma sottoterra, e proviene dalle profondità. Una prova di questo è il fatto che mari profondissimi sono agitati, evidentemente a causa del moto di quelle regioni sopra le quali si distendono: è, dunque, verosimile che il terremoto abbia origine dalle profondità della terra e che lì l’aria si ammassi in enormi cavità. Dev’essere una lesione più interna e più profonda a scrollare la terra: la prova migliore a favore di questa tesi può forse essere il fatto che, quando il suolo si è aperto a causa di un terremoto violento, provocando gravi danni, talvolta quella voragine inghiotte e seppellisce intere città.
Quando l’aria con la sua grande forza ha riempito completamente una cavità sotterranea e ha cominciato a lottare e a cercare una via d’uscita, colpisce più frequentemente proprio le pareti fra le quali è nascosta, sopra le quali sono talvolta situate delle città. Queste pareti a volte ricevono delle scosse tali che gli edifici sovrastanti crollano, a volte il terremoto è così forte che le pareti che sorreggono tutta la volta della cavità rovinano sullo spazio vuoto che si apre sotto e intere città sprofondano nell’immensa voragine.
Seneca, Naturales quaestiones II, 24
Eccomi alla fine della quinta!
Finalmente ho raggiunto la meta!
Mi sembra ieri di sentire la maestra pronunciare il mio nome nell’atrio il primo giorno di scuola.
In questi anni sono cresciuto sia in altezza sia in saggezza.
Sono stati anni indimenticabili, speciali, ognuno con le sue esperienze ricche e belle, ma anche con i suoi ostacoli, dai quali ho imparato a ripartire.
Dalla prima alla quinta ho visto io stesso un grande cambiamento in me: ho scoperto il mio valore, ho dimostrato i miei pregi e mi sono fatto conoscere, sono maturato ed ho saputo vedere tutto come un dono e non ho avuto paura di dire la mia.

Mi ricordo ancora quando ero in prima: i miei fratelli mi prendevano in giro perché non sapevo nulla della scuola. Mi dicevo: «Non ce la farò mai ad arrivare in quinta, non so niente ora e non saprò mai niente».
Poi conoscendo i miei insegnanti e i miei compagni ho capito che tutti possiamo fare qualsiasi cosa, basta mettersi d’impegno. Infatti ho capito una cosa molto importante: non bisogna accontentarsi di poco, ma bisogna puntare in alto. Ogni anno è stato ricco di proposte che sono servite perché io “ci sono sempre stato”.
Inoltre, in quinta mi sono accorto di essere responsabile di quello che faccio. Perché? Perché quest’anno mi è stato affidato un bambino di prima con cui ho trascorso molti momenti speciali e piacevoli. Incontrando il mio bambino di prima ho imparato a stare volentieri con persone non solo della mia età, ma anche con quelle più piccole di me.
Ogni anno, anche se diverso, è stato per me come un grande e ripido ghiacciaio da attraversare. La mia maestra – che dovrebbe vincere il Premio Nobel per la pazienza – mi ha allungato la mano e mi ha portato sulla vetta: tutto è più facile quando qualcuno ti tende la mano.
Avrò molta nostalgia della mia classe e dei miei insegnanti, ma so che anche se un capitolo finisce, ne inizia subito un altro!
Matteo, classe V
TESTI DI NARRATIVA PER LA LETTURA INTEGRALE IN CLASSE
La nascita di Roma
di Laura Orvieto Giunti Junior, 2015
Più di duemila anni fa, quando nel mondo non c’erano Londra né Parigi né Milano né Roma, racconta la leggenda, due bambini di stirpe regale, appena nati, venivano abbandonati lungo le rive del Tevere. Erano Romolo e Remo. Una lupa li allattò e due pastori li allevarono finché, grandi e forti, decisero di riconquistare il regno che apparteneva loro e di fondare una nuova città. Ma tra i due in lotta fratricida, Remo morì proprio dove sarebbe nata la città eterna che da Romolo prese il nome: Roma.
Come in tutte le narrazioni epiche, gli avvenimenti sono intessuti di tranelli, invidie e gelosie; avventure, battaglie e duelli; prepotenze e riscosse; oppressione e schiavitù e riscatto e libertà.
Nel libro le vicende della fondazione di Roma si intrecciano con quelle di altri due fratelli, Servio e Plistino, fuggiti alla schiavitù e diventati uomini liberi dopo aver raggiunto il Luogo Sacro del Nume Asileo. Attraverso le loro vicissitudini Laura Orvieto ci svela la quotidianità della vita di quei tempi.
Il viaggio di Elisabet di Jostein Gaarder Tea, 2015
Elisabet è una bambina che, per accarezzare un agnellino visto in un supermercato, lo insegue nel suo cammino verso una meta a lei inizialmente sconosciuta. Intraprende così un viaggio nello spazio e nel tempo: dalla Norvegia sino a Betlemme e dai nostri giorni fino all’anno zero. In ventiquattro giorni, la bambina incontra sulla strada parecchi personaggi del presepe che si uniscono alla comitiva e, la notte di Natale, giungono davanti al Bambino Gesù. Tutta la vicenda è snocciolata giorno per giorno in un magico calendario natalizio acquistato da Joakim, un bambino norvegese dei nostri tempi, e condiviso dai suoi genitori. Con lui si apre una vicenda parallela nella quale Elisabet è realmente esistita: è una bambina profuga palestinese, scomparsa nel 1948, di cui si son perse le tracce. Attraverso le ricerche e l’aiuto di Johannes, il redattore del magico calendario, la famigliola rintraccia Elisabet che racconta la sua vera storia a Joakim, proprio il giorno di Natale. Due storie in una, per narrare il valore della nascita di Gesù.
Magellano
di Stefan Zweig riduzione a cura di P. Molinari, F. Farina, M. De Nigris, Sestante, 2014
Il testo è una riduzione per ragazzi del romanzo omonimo scritto da Stefan Zweig. Magellano è un uomo straordinario, un navigatore portoghese che, per conto del re di Spagna, per primo ha circumnavigato la Terra trovando lo stretto che collega l’Oceano Atlantico con l’Oceano Pacifico: quello stretto che oggi porta il suo nome: lo “Stretto di Magellano”. Avventura, rischio, lealtà, tradimenti, amicizia, felicità, fede e indicibili sofferenze s’intrecciano in questo testo che racconta una storia vera, giunta a noi grazie anche al diario di bordo scritto dal vicentino Pigafetta.
Il giro del mondo in 80 giorni
Jules Verne
Il giro del mondo in 80 giorni racconta la storia di Mr. Fogg, ricco londinese preciso e metodico, che decide, per una scommessa, di fare il giro del mondo in 80 giorni esatti. Il protagonista trascina con sé Passepartout, il suo fedele e pasticcione servo francese. Un’incredibile avventura li porterà dall’Egitto al Giappone, fino alle Americhe attraversando mari e monti, inseguiti dall’agente Fix sempre pronto ad intralciare il loro programma. Dalle prime pagine la descrizione dei personaggi principali cattura subito l’attenzione e facilita l’immedesimazione nelle loro avventure e nel loro temperamento: Mr. Fogg è apparentemente freddo e insensibile; Passepartout è impulsivo, generoso e pasticcione; Fix furbo ma sfortunato.
Oltre al sapore di avventura, il libro offre la possibilità di incontrare gli stati e gli ambienti del mondo. Man mano che si procede nella lettura i ragazzi possono identificare il tragitto sul planisfero nominando i continenti, i paesi, gli stretti, i mari e gli oceani. La simpatica ostinazione di Passepartout nel ritenere che, dovunque vada, sia il suo orologio a segnare l’ora giusta, permette di aprire la conoscenza di meridiani e paralleli e dei fusi orari.
Fratelli di Bart Moeyaert Rizzoli, 2011
È la semplice vita, ma non troppo, di una famiglia composta da padre, madre e sette figli maschi. Il più piccolo, l’autore del libro, raccoglie le vicende quotidiane in 49 brevi racconti ricchi di burle, avventura, fantasia, guai, riflessioni infantili, sottintesi… tutti narrati con espressioni tipiche dei ragazzi. Dentro e oltre i fatti comprensibili a tutti si nascondono bellezze e valori di vita fraterna e familiare.
Bravo, Burro!
di John Fante Einaudi, 2010
La storia è quella di Manuel, un ragazzino di spiccata intelligenza e buon cuore, che vive con il padre nell’hacienda di don Francisco, in Messico. Suo padre, Juan Cabriz, era stato un tempo un valoroso torero, fino a quando la corrida non divenne l’ossessione della sua vita e lo costrinse a darsi alla fuga durante un debutto in arena davanti a un toro che lo caricava. Un giorno Manuel incrocia il suo cammino con un asinello coraggioso, sfuggito eroicamente da un combattimento con un puma affamato e tra i due inizia un rapporto di complicità. Montaña Negra è un toro da record, il vanto di tutto il Messico e quando la situazione finanziaria della hacienda si mette male, don Francisco si convince a venderlo a peso d’oro. Un giorno, ubriaco di tequila, Juan appicca involontariamente il fuoco alla tenuta e Montaña Negra scappa via. Per redimere e riscattare il padre, considerato un buono a nulla, Manuel va alla ricerca del toro col suo fedele El Valiente e con tenacia lo riporta indietro.
Questo racconto, pur nella sua semplicità, è una toccante storia di amicizia e fede. È particolarmente significativo il rapporto tra Manuel e il padre: pur vedendone e subendone le debolezze, Manuel ama suo padre in modo incondizionato, lo rispetta ed è pronto a sacrificarsi per lui.
I piegatori
di banane
di Bernhard Lassahn Salani, 2000
Robert e Louise sono due fratelli che vivono ai nostri giorni nei Mari del Sud in qualche arcipelago vicino alla Nuova Zelanda. Con una canoa vanno ad esplorare le isole della Micronesia ed è in questa innocente gita che scoprono che alcuni pirati stanno cercando un tesoro: questo è lo spunto per una serie di avventure molto gustose ed avvincenti. È un libro di avventura che ricalca le atmosfere dei grandi classici del Mare (Stevenson in testa) con sortite di pirati, tesori, indigeni e due ragazzini che con la loro intelligenza e desiderio di scoprire nuovi orizzonti aiutano a scoprire un mistero. Libro ironico, divertente e ben scritto.
Le avventure di Annibale Zumpapà
di Luca Doninelli Vallardi, 1994
Annibale Zumpapà è il protagonista, un tipo strano che vive un’amicizia vera con tutti i suoi strampalati amici: la fidanzata Asdrubalona, Ziribibbo-Gliero, Ernesto Gomez Delaviuda.
Il libro racconta le esuberanti e imprevedibili storie di questi e altri strani personaggi sempre in cerca di avventure perché, come dice Zumpapà, «Senza un po’ di movimento la vita sarebbe una noia tremenda».
La banda delle quattro strade
di Mario Schiani Salani, 2009
Lino ha nove anni e, alla fine della scuola, viene mandato dai genitori in campagna, a trascorrere l’estate con la nonna. È un ragazzo mingherlino, pallido e timido che ha paura di tante cose, come il tetano, le congestioni, la polmonite, e perfino dei galli. Un giorno, perlustrando il paese, fa amicizia con Chicco, maestro delle mitiche palline clic-clac, di moda negli anni Settanta, e acerrimo nemico di Nero, il bulletto del paese. Insieme a Chicco, Fausto e Lisa, Lino compone la banda delle Quattro Strade, che deve subito difendersi dalle aggressioni del malvagio Nero e dalla banda del Vallino, il gruppo dei teppisti del paese. Uniti, i quattro ragazzi riescono ad affrontare le situazioni più pericolose e a smascherare tutte le malefatte di Nero. Una storia di amicizia, di giochi e di grandi prove di coraggio da affrontare insieme per imparare a superare le paure. Orzowei
di Alberto Manzi Bur, 2009
Il romanzo narra la vicenda di Isa, un ragazzo bianco cresciuto in Sud Africa in una tribù di Swazi, cioè di neri Bantù. Per quanto abbronzato, però, Isa ha la pelle più chiara, è diverso da loro, perciò i Bantù non lo accettano fino in fondo, anzi lo odiano, lo chiamano l’Orzowei, il ‘trovato’, e lo respingono continuamente. La vita di Isa è caratterizzata da due elementi: la continua ricerca del proprio posto nel mondo e l’incontro con altri uomini. La vicenda si conclude con una cruenta battaglia e la scoperta di ciò che rende veramente felici gli uomini: amare il cuore dell’altro, rispettare l’altro per quello che è e non per quello che appare. È un romanzo che appassiona i ragazzi, benché sia ambientato in uno spazio e in un tempo molto lontani da loro.
Ciò che lo rende attuale e quindi coinvolgente è l’umanità del ragazzo protagonista: il suo desiderio di diventare grande, le sue paure ma anche il suo coraggio, la sua determinazione di fronte alle difficoltà, il suo bisogno di essere amato, ma anche il desiderio d’imparare, la sua intelligenza e bontà d’animo. Altrettanto affascinante la figura del maestro (Pao, capo del “piccolo popolo”) misterioso sapiente, alto meno di un bambino, però colmo di antica sapienza e capace di amare. Pao insegna ad Orzowei a diventare un bravo cacciatore che sa osservare, decifrare, attendere, rispettare la foresta in cui vive, ma lo aiuta anche a conoscere ed amare se stesso. È infine una storia che insegna ad andare oltre l’apparenza per scoprire il valore profondo delle cose e delle persone.
GRAMMATICA
Giocondo Corcontento
Giocondo Corcontento, falegname di talento, è un vero tesoro, ha un carattere d’oro: pacione pacioccone, gentile e cordiale con ogni sorta di persone.
Il suo segreto? Eccolo in una parola: egli s’arrabia sempre con un “b” sola... Così nessuno si offende, nessuno se la prende. In grazia di un errore di ortografia vive con tutti in pace e in allegria.
Gianni Rodari

VERBI NOMI PRONOMI

CONGIUNZIONI
ORTOGRAFIA
A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
MAIUSCOLA Si usa per nomi propri, sacri e di cariche, nomi geografici e di popoli, a inizio della frase e nel discorso diretto.
CIA ciambella CE cerotto
CIO cioccolato CI cinema CIU ciuffo
CA casa CHE chela CHI chicco CO colomba CU cupola
GIA giallo GE gelato GI giraffa GIO gioco GIU giullare
GA gallo GHE gheriglio GHI ghiro GO gorilla GU guscio
QUA quaderno QUE questo, quello
QUI
Qui al sole si sta proprio bene!
CQU
QUI quindi
QUO quota
CU + CONSONANTE culla, cura, custode, cuscino, cucina
Attenzione! Perfareiplurali: seprimadiCoG c’èunaconsonante: CEpancia › pance, GEfrangia › frange seprimadiC/G c’èunavocale: CIEciliegia › ciliegie
GIEvaligia › valigie
CUI
Il ragazzo a cui ho prestato il libro non me lo ha più restituito.
acqua e parole derivate acquistare, acquisto, nacque, piacque, giacque
GLI maglione, conchiglia biglia, aglio, foglia
GNA castagna GNE montagne
GNI cigni
QQ soqquadro
LI ciliegia, oliera petrolio, candeliere
GNO signore GNU giugno
SCE ascensore, ruscello, discesa, mascella, scettro
MB bambola, tamburo
ZIA spaziale
ZIE pazienza
MP pompiere, lampada
ZIO stazione
Attenzione! Alcune parole sono originali:cuore, cuoio, scuola, cuoco, percuotere,cuocere,scuotere, riscuotere, taccuino, circuito
Attenzione! compagnia, disegniamo, accompagniamo, impegniamo, guadagniamo, consegniamo, vergogniamo
Attenzione! scienza, coscienza e le parole che derivano da esse
DIVISIONE IN SILLABE
I gruppi gn, sc, ch, gh, gl non si dividono mai: gno-mo, bar-che
La s non si separa mai dalla consonante che la segue: de-sti-no
Le consonanti doppie (anche cq) si dividono sempre in due sillabe: sas-so, ac-qua
Le vocali che si pronunciano separatamente formano una sillaba e si separano: ma-e-stra, o-ce-a-no
Le consonanti l, m, n, r si separano dalla consonante che le seguono: el-mo, len-to
ACCENTO Nella lingua italiana l’accento si scrive solo quando cade sulla vocale finale: città, bontà, caffè
MONOSILLABI ACCENTATI
dà verbo
dì nome = giorno
↔ da preposione semplice
↔ di preposione semplice
è verbo ↔ e congiunzione
là avverbio ↔ la articolo
lì avverbio ↔ li pronome
né avverbio = e non
sé pronome
sì avverbio
tè nome
↔ ne pronome
↔ se congiunzione
↔ si pronome
↔ te pronome
APOSTROFO un albero, un’aquila (una), c’è, c’era
H
a preposizione
Claudio va a casa sua. ha verbo Matteo ha gli occhi celesti.
ah esclamazione
ai preposizione articolata
Ah, che bella giornata!
Stefano va ai giardini. hai verbo
ahi esclamazione
anno nome
Attenzione! fu tre re me ne so va sta fa sto mai accenterò!
Sul qui e sul qua l’accento non va!
Attenzione! qual è si scrive senza apostrofo!
Tu hai un cuore generoso.
Ahi, mi hai fatto male!
L’anno scorso sono stato in Francia. hanno verbo
o congiunzione
I bambini hanno cantato bene!
Partirò stasera o domani. ho verbo
Oggi ho poco appetito. oh esclamazione
Oh, finalmente sei tornato!
TRONCAMENTO un po’
I SEGNI DI PUNTEGGIATURA
PUNTO
VIRGOLA
“ ”
PUNTO E VIRGOLA
)
DUE PUNTI
PUNTO INTERROGATIVO
PUNTO ESCLAMATIVO
VIRGOLETTE
PARENTESI
Sempre alla fine della frase
Quando
• fai un elenco di parole
• fai un elenco di frasi
• devi separare i diversi sintagmi di tempo, luogo o modo
• prima della congiunzione ma
• per inserire un inciso
Quando, nella frase, un pensiero è concluso, ma la frase continua con lo stesso argomento
Quando spieghi
Quando devi porre una domanda
Quando la frase è un’esclamazione
Aprono e chiudono il discorso diretto si usano anche le lineette – –o le caporali « »
Quando devi inserire qualche parola o frase che spieghi meglio
Attenzione!
Mai la virgola tra soggetto e verbo
ESERCIZI DI ORTOGRAFIA E PUNTEGGIATURA
1. Disponi in ordine alfabetico le seguenti parole: penna, pennello, pennino, pennellino, pennellessa, pennone, pena, pane, pittore, penne.
2. Pensando alle lettere dell’alfabeto, spiega le seguenti espressioni.
1. Un corridoio a L:
2. Un fiume a S:
3. Mettere i puntini sulle I:
4. Una strada a U:
5. Dire dalla A alla Z:
3. Un’enciclopedia è divisa in 10 volumi, che sono classificati in questo modo.
A-BEL FUO-ILA DUO-FUN MA-PAP BEM-CHI RE-STR ILL-LUZ STU-ZUZ CIA-DUN PAR-REG
Disponi i 10 volumi in ordine alfabetico, dall’1 al 10, così:
1. A-BEL 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
Se devi cercare nell’enciclopedia notizie dei seguenti poeti, quale volume devi consultare? Scrivi il numero corrispondente.
Dante Alighieri Francesco Petrarca Ludovico Ariosto
Torquato Tasso Giacomo Leopardi Alessandro Manzoni
Vittorio Alfieri Ugo Foscolo Giovanni Pascoli
Umberto Saba Eugenio Montale Cesare Pavese
Se devi trovare notizie relative ai seguenti paesi, quale volume dovrai consultare? Scrivi il numero corrispondente.
Uruguay Yemen Argentina Portogallo Cile
Canada Messico Stati Uniti Belgio India
Pakistan Vietnam Bolivia Madagascar
4. Individua i nomi propri e trascrivili in modo corretto, poi scegli 6 di essi, tra quelli di personaggi storici e luoghi geografici e scrivi 6 frasi.
monte bianco, fagiolo, sorelle, firenze, s patrizio, zurigo, adige, mamma, signore iddio, ape, italia, soldati, manzoni, papa, papà, bicchieri, sicilia, australiano, molise, madagascar, pericle, tavolini, australia.
5. Scrivi 10 nomi propri appartenenti alle seguenti categorie: città, personaggi storici, regioni, stati, titoli di libri, feste religiose.
6. Riconosci i vari suoni (dolci o duri), sottolineali con colori diversi, poi trascrivili in due colonne, che cosa scopri? Alcune parole hanno il suono doppio. Scrivi una frase per ogni parola con i due suoni. cioccolato, cera, giostre, cinese, chiodi, gherigli, camino, cimice, ciabatte, coccodrilli, campanaccio, lucchetto, mucca, angelo, chiacchiere, pigolare, maghi, chioccia, chiocciole, giudizio, gamba, lumachine, cerotti, sacchetto, socchiusa, scorgere, scheggia, pulcini, catenaccio, gelato, Giacomo.
7. Scrivi 10 parole con il suono dolce di C o di G; poi scrivine 10 con i due suoni duri.
8. Trasforma al plurale le seguenti parole: lancia, faccia, regia, arancia, ciliegia, camicia, treccia, frangia, roggia, roccia, loggia, pancia, mancia, valigia, strategia, torcia, focaccia, guancia, freccia, cuccia.
9. Scrivi il maggior numero di parole, che conosci, con le sillabe qua, que, qui, quo.
10. Individua le parole errate e sottolineale, trascrivile corrette, poi scegline 6 e scrivi una frase con ognuna. quscino, quindici, qulla, quaranta, questo, cuello, cuasi, aquila, cucina, cuattro, qustode, cura, quadro, licuore, ecuilatero, quaglia, cuadrato, quindi, cuaderno, quattro.
11. Completa le frasi con le parole suggerite dalla definizione. Paolo e Federica escono correndo da (ci si va per imparare). Posano le loro cartelle di (è una pelle molto dura) sotto un albero e iniziano a giocare nei giardini. Vedono un signore che sta maltrattando il suo cane e insieme esclamano: «Non si devono (significa picchiare) gli animali! E poi quel cane è (non fa male, non è pericoloso), non potrebbe far male neanche a una mosca».
Federica comincia a raccogliere dei ( piante con quattro foglie) mentre Paolo disegna un grande (batte nel petto) sul suo ( può essere a righe o a quadretti). In lontananza un atleta di un circo cerca di ( piegare a forma di arco) una sbarra di ferro. Sul ramo di un albero una piccola (un uccello) osserva la scena; una forte raffica di vento le fa perdere l’ (ti occorre per non cadere dalla bicicletta) ed essa cade a terra. Paolo e Federica la vedono, la raccolgono e decidono che la devono ( per fare guarire); la portano a casa e la posano su un morbido (vi si posa la testa per dormire). Il giorno dopo la bestiola è pronta di nuovo a volare (calma, serena) nel cielo.
12. Scrivi una frase con ciascuna delle seguenti parole: piacque, acquattarsi, acquistare, nacque, acquisire, tacque.
13. Pronuncia bene e discrimina quando il suono è GN e quando è NI, sottolinea le parole con colori diversi, poi trascrivile in due colonne. magnolie, campagna, maniero, compagno, panieri, miniera, insegnare, maniere, pugno, niente, ragnatele, genio, lasagne, scrutinio, castagna, criniere, coniuge, ragno, Germania, cigni, Antonio, stagno, geranio, compagnia.
14. Scrivi una frase con ogni forma verbale. disegniamo, consegniamo, vergogniamo, accompagniamo, impegniamo, guadagniamo.
15. Continua la breve storia, scrivendo una frase per ogni parola.
cespuglio In mezzo ad un ricco cespuglio.
tiglio coniglio
sbadiglio germogli
bottiglia bavaglia parapiglia
16. Scrivi i nomi derivati che indicano mestieri e professioni. gioiello cammello
mobile stalla
barella cavallo
petrolio giochi
17. Volgi al plurale i seguenti scioglilingua:
1. La liscia biscia fruscia e striscia senza coscia.
2. Il ruscello fruscia, il ruscello scroscia.
3. Sulla neve scintillante scia lo sciatore aitante.
4. La sciocca scimmia lascia il gheriglio e sceglie il guscio.
5. Lo scellerato sceicco sguaina la sciabola scintillante.
18. Sottolinea e trascrivi correttamente la parola sbagliata (ce n’è una in ogni serie).
1. luminescenza conoscenza inconscenza
2. ascella mascella rusciello
3. scientifico sciettico ascetico
4. scelta scienza sciettro
5. misciela scemenza nascente
6. cresciente incosciente discendente
7. fasce ascie cosce
8. adolescienza recrudescenza fantascienza
19. Con alcune delle parole suggerite componi una breve storia; se ne hai bisogno, pensane altre dello stesso tipo. bomba, ombrello, bimbo, temporale, lampi, lampadina, pompieri, zampe, campane, tamburo, tromba, campagna, ombra, bambola, tombola.
20. Trova almeno cinque parole che terminino in –ione e, con esse, componi una breve frase. ragione, nazione…
21. Indica il nome derivato, poi scrivi una frase con ognuno. mazzo carrozza corazza tappezzare
22. Dividi in sillabe le seguenti parole: fotosintesi, tavolo, acqua, pomodori, Pantelleria, primini, Polifemo, passeggiata, buccia, asciugamani, consonanti, meridiana, pulitissimo, cammello, cappelliera, antologia, pappagallo, quadernino, cuscino, cespuglietti, veliero, agnellino, azzardo, azionare, zitella.
23. Dividi in sillabe le seguenti parole: stratosfera, stamberga, Stradivari, tridente, spremuti, astrofisico, appretto, sdrucciolevole, sdrammatizzare, strappato, astrattismo, coccodrillo, ambrato, sbranare, strumenti, australopiteco, sbragati, incoscientemente, Strasburgo, sprangare, sprizzare.
24. Metti l’accento dove occorre.
1. Nella mia citta, si terra un famoso spettacolo di varieta.
2. Non ce la faccio piu: da un’ora, il papa mi manda giu in cantina a portare i vecchi giochi.
3. Non bisogna esagerare con il caffe, non prenderne piu di tre al giorno.
4. Nell’attivita di scienze, sono meno in difficolta che in quella di geografia.
5. Vorrei avervi tutti qua a cena: chi non puo me lo dica al piu presto.
6. Un pipistrello usci troppo presto dal suo rifugio, la luce lo abbaglio e non volo piu.
25. A seconda dell’accento interno le parole cambiano di senso. Prova per ognuna a comporre una frase.
Venti In classe siamo in vénti
I vènti da nord sono freddi
Pesca
Legge
Botte
Volto
Scopo
26. Scegli i monosillabi corretti e inseriscili nelle frasi.
1. L’insegnante (da/dà) agli alunni accaldati del (te/tè) molto freddo.
2. La mamma dice (di /dì) mangiare la verdura ogni (di /dì), ma a me non (va/và).
3. ( la/là) sul mobile, c’è ( la/là) statuina di legno (da/dà) riportare alla nonna.
4. Non ho trovato (ne/né) pesche, (ne/né) ciliegie; (se/sé) (ne/né) trovi, le mangeremo.
5. Lucia è uscita: non ha con (se/sé) (ne/né) l’ombrello, (ne/né) un cappello… e piove!
6. ( li/lì) sul tavolo, ci sono i biscotti: ( li/lì) ho appena cucinati e te ( li/lì) offro.
7. Ho detto di (si/sì) all’invito dei nonni: (si/sì) prevede
una bella festa!
27. Sottolinea le parole che vogliono l’apostrofo, componi una frase con ogni forma corretta. sotto acqua | sotto il mare | di sera | di estate | mezza giornata mezza ora | di accordo | di serenità | nello hotel | nella casa uno zoccolo | una arancia | tutto intorno | tutto rotto niente altro|niente cena
28. Scrivi una frase per ogni espressione. sera / s’era luna / l’una cera / c’era lago / l’ago loro / l’oro.
29. Scegli la forma adeguata, completa, poi scrivi una frase con ognuna di esse (LO / L’HO; LA / L’HA; GLIELO / GLIEL’HO; GLIELA / GLIEL’HA; GLIEL’HANNO).
1. Vuoi un’arancia? portata anche per te, altrimenti chiedo a Sara.
2. Questa matita è di Elisa, puoi dare tu? Certo, do subito!
3. Ho preparato la frittata: mangi adesso o te metto nel panino?
4. Il libro che leggi, scritto Milani; letto anch’io: è bello!
5. Mi piace il cappello rosso: metto sempre, poi rimetto in ordine.
6. Mattia aveva un bel pallone, ma i cugini bucato; ricomprerò.
7. Simone ha un cane nuovo: regalato i suoi; ogni sera porta fuori.
8. Luca non trova più la biro: chi presa? presterò io!
30. Metti la virgola dove serve.
1. Il vento soffiava forte le fronde stormivano la pioggia picchiava sui vetri le imposte sbattevano.
2. Una donna la zia Sofia mi guardava sorridendo.
3. La tua matita è caduta lì sotto il tavolo.
4. La luna che si era appena levata all’orizzonte illuminava tutta la valle.
5. I due cani dopo avermi guardato con diffidenza si allontanarono da me.
31. Metti i due punti dove servono.
1. Questa pianta è secca devi esserti dimenticato di annaffiarla.
2. Da quel ristorante esce un ottimo profumino si deve mangiare proprio bene!
3. Nella cartella ho due libri quello di storia e quello di matematica.
4. Queste scarpe sono rotte occorre portarle dal calzolaio o comprarne un paio nuovo.
5. Dobbiamo fermarci c’è il semaforo rosso.
32. Inserisci i segni di punteggiatura necessari in questa favola di Esopo. un lupo tutto striminzito dalla fame incontra un cane ben pasciuto si salutano e si fermano donde vieni così lucido e bello che hai mangiato per farti così grasso io che sono tanto più forte di te muoio di fame e il cane se vuoi ce n’è anche per te basta che tu presti lo stesso mio servizio al padrone e che servizio custodirgli la porta di casa e tenere lontani i ladri la notte uh ma io sono prontissimo adesso sopporto nevi e piogge nel bosco trascinando una vita maledetta ma deve essere molto facile vivere sotto un tetto e riempirsi lo stomaco in pace allora vieni con me e vanno lungo la via il lupo vede una spelatura al collo del cane che roba è quella amico mio oh è niente ma se vuoi dirmelo qualche volta per la mia natura impetuosa mi tengono legato perché stia quieto durante il giorno e vigili la notte ma al crepuscolo vado in giro dove mi piace mi si porta il pane senza che io debba richiederlo il padrone mi dà gli ossi della sua tavola la servitù mi getta qualche boccone gli avanzi di ognuno sono miei così senza fatica mi empio la pancia ma se hai voglia di uscire è permesso proprio interamente no addio caro goditi pure le tue gioie io non baratto la mia libertà per un regno
PARTI DEL DISCORSO
PARTI VARIABILI
determinativo il, la, lo, l’ , i, gli, le
ARTICOLO
NOME primitivo casa derivato cartolaio alterato stradina collettivo gregge composto capotreno concreto amico astratto amicizia
AGGETTIVO qualificativo buono, immenso possessivo mio indefinito alcuni dimostrativo questi numerale tre
genere, numero indeterminativo un, un’ , uno, una, dei, degli, delle partitivo del, dello, della
PRONOME personale io, tu, noi, mi, ti, ci relativo che, cui, chi, il quale, la quale, i quali, le quali possessivo mio indefinito alcuni dimostrativo questi numerale tre
PREPOSIZIONI articolate dalla, nei, allo, sulla…
VERBO coniugazione propria essere, avere modo, tempo, persona 1a , 2a , 3a coniugazione andare, vedere, sentire
PARTI INVARIABILI
CONGIUNZIONI e, o, ma, perciò, infatti, quindi…
PREPOSIZIONI semplici di, a, da, in, con… non varia improprie davanti, verso…
AVVERBI volentieri, sempre, vicino, troppo, certamente, forse…
ESCLAMAZIONI ah, eh, oh, uffa, boh…
L’ARTICOLO
Gli articoli sono le piccole parole (articolo = piccolo arto) che precedono il nome.
Singolari Plurali
Determinativi
Indeterminativi
Partitivi
IL · LA · LO
UN · UNA · UN
DEL · DELLO · DELLA
Attenzione!
I · GLI · LE
DEI, DEGLI e DELLE possono essere usati come articoli indeterminativi plurali: un aquilone › degli aquiloni L’articolo partitivo invece non ha il plurale: Ho mangiato del pane (= un po’ di pane).
IL NOME
Il nome identifica e distingue ogni cosa: persona, animale, oggetto, concetto, sentimento, azione…
NOMI COMUNI E NOMI PROPRI
I nomi si suddividono in comuni e propri; i nomi propri si scrivono con la lettera iniziale maiuscola.
Sono nomi propri anche:
• i nomi geografici (Milano, Po, Tevere, Italia…)
• i nomi di popoli (Romani, Fenici, Sumeri, Italiani…)
IL GENERE E IL NUMERO DEI NOMI
Il genere dei nomi può essere maschile o femminile. Il numero dei nomi può essere singolare o plurale.
TANTI TIPI DI NOME
Se guardiamo come sono formati, con quali “pezzi”, i nomi si distinguono in primitivi, derivati, alterati, composti.
Sono nomi primitivi quei nomi che sono formati solo dalla radice e dalla desinenza.
Tavol-o, libr-o, zi-a, amor-e.
Sono nomi derivati quei nomi che si sono formati dalla radice di altri nomi o da verbi, e hanno un significato che richiama quello di partenza, ma è diverso.
Fior-ista (fiore), scienz-iato (scienza), cent-inaia (cento).
Sono nomi alterati quei nomi che indicano la stessa cosa del nome primitivo, ma sottointendono degli aggettivi (grande, piccolo, bello, brutto).
Man-ina (mano), vi-uzza (via), cavall-uccio (cavallo), libr-one (libro).
Ci sono quattro forme di alterazione:
• accrescitivo › nome + aggettivo grande › casona
• diminutivo › nome + aggettivo piccolo › casina
• vezzeggiativo › nome + aggettivo bello › casuccia
• dispregiativo › nome + aggettivo brutto › casaccia
Sono nomi composti quei nomi che sono formati da due parole unite.
Capo-stazione, ferro-via, super-mercato, pesce-cane.
ALTRI TIPI DI NOMI
I nomi possono anche essere distinti per quello che indicano.
NOMI INDIVIDUALI E COLLETTIVI
Sono nomi individuali quelli che indicano una sola persona, un solo animale, una sola cosa.
Bambino, gatto, treno, albero…
Sono nomi collettivi quei nomi che pur avendo una forma singolare esprimono una pluralità: un insieme di persone, animali, oggetti.
Squadra, mandria, orchestra, pineta…
NOMI CONCRETI E ASTRATTI
I nomi concreti indicano cose: oggetti, persone, animali, luoghi, sostanze…
Tavolo, nonno, leone, scuola, profumo, suono…
I nomi astratti indicano idee o concetti.
Bontà, orgoglio, sincerità, sicurezza…
L’AGGETTIVO
L’aggettivo determina il nome: è una parola che si aggiunge al nome per attribuirgli una caratteristica.
L’aggettivo concorda sempre col nome a cui è riferito: ha cioè lo stesso genere e lo stesso numero.
Articolo, nome e aggettivo concordano e si possono analizzare insieme.
L’AGGETTIVO QUALIFICATIVO
L’aggettivo qualificativo si aggiunge a un nome per determinarne la qualità (forma, colore, natura, condizione…).
Le qualità degli aggettivi qualificativi hanno diversi gradi e si possono confrontare.
Giovanni è alto.
Giovanni è meno alto di Stefano.
Giovanni è più alto di Giacomino.
Giovanni è alto come Angelo.
Nella prima frase “alto” è usato normalmente, senza fare confronti, cioè al grado positivo.
Nelle altre frasi, invece, l’aggettivo qualificativo “alto” è messo a confronto fra persone (si possono confrontare anche animali e cose). Si formano così i gradi comparativi (comparare = confrontare).
• Comparativo di minoranza › meno di…
• Comparativo di maggioranza › più di…
• Comparativo di uguaglianza › come…
Il grado SUPERLATIVO RELATIVO
esprime la qualità dell’aggettivo in relazione (confrontato) con gli altri.
Il grado SUPERLATIVO ASSOLUTO
esprime la qualità dell’aggettivo al grado massimo, senza confronto con altri.
Ricorda!
Il superlativo assoluto si può formare anche con i prefissi ultra-, arci-, stra-…; con le parole molto e assai; oppure ripetendo due volte l’aggettivo.
Attenzione!
Alcuni aggettivi, insieme a quelle regolari, possiedono forme irregolari di comparativi di maggioranza e superlativi assoluti.
Si tratta di forme derivate dal latino.
Buono più buono, migliore buonissimo, ottimo
Cattivo più cattivo, peggiore cattivissimo, pessimo
Grande più grande, maggiore grandissimo, massimo
Piccolo più piccolo, minore piccolissimo, minimo
IL PRONOME
Il pronome si usa al posto del nome e serve a sostituirlo.
PRONOMI PERSONALI
I pronomi personali servono per sostituire un nome indicante una persona, ma anche un animale o un oggetto, al fine di evitare le ripetizioni.
In una frase possono avere la funzione di soggetto o di complemento.
I PRONOMI PERSONALI
io me mi (a me)
tu te ti (a te)
egli-esso lui-lo gli (a lui)
ella-essa lei-la le (a lei)
Attenzione!
• A me mi è una forma errata perché contiene un pronome di troppo.
• Lui e lei come soggetto sono usati con valore rafforzativo (es. È stato lui!), lo stesso vale per loro (es. Hanno vinto loro!).
• Lo – la – gli – le sono pronomi quando sostituiscono un nome; sono articoli determinativi quando precedono un nome.
• Gli = a lui; le = a lei; loro = ad essi.
noi noi ci (a noi)
voi voi vi (a voi)
essi loro-li
esse loro-le
Ricorda!
• Vado da Roberto e GLI parlo (parlo a lui).
• Vado da Stefania e LE parlo (parlo a lei).
• Vado da Roberto e Stefania e parlo LORO (parlo a loro).
PRONOMI RELATIVI
Sono pronomi relativi quelle parole che sostituiscono il nome e mettono in relazione due frasi.
Saluta Marco che sta uscendo.
Il bambino che gioca con la palla è mio cugino. Non trovo più il libro di cui ti ho parlato.
L’auto su cui sali è nuova.
Il pronome relativo si mette vicino al nome a cui si riferisce.
L’AGGETTIVO E IL PRONOME
AGGETTIVI E PRONOMI POSSESSIVI
Aggettivi e pronomi possessivi indicano un possesso, cioè dicono a chi appartiene una certa cosa, persona o animale. Attenzione alle seguenti frasi!
Il mio cappello è blu, il TUO è rosso.
La vostra insegnante è più giovane della NOSTRA .
Il suo quaderno è ordinato, il VOSTRO no.
Le parole sottolineate indicano sempre un possesso, ma quelle in minuscolo sono aggettivi (c’è il nome di fianco) mentre quelle in maiuscolo sono pronomi possessivi.
Essi si dicono pronomi perché stanno al posto del nome.
Dunque, distinguere l’aggettivo dal pronome non è difficile: l’aggettivo è sempre riferito ad un nome, il pronome, invece, lo sostituisce.
Il mio cappello è blu, il TUO è rosso › mio = aggettivo tuo = pronome
AGGETTIVI E PRONOMI
DIMOSTRATIVI
Il dimostrativo è la parola che, nella frase, ha la funzione di mostrare, indicare, ciò di cui si parla.
I più usati, nei vari generi e numeri, sono questo e quello.
Alcuni dimostrativi sono soltanto pronomi: costui, costei, costoro, colui, colei, coloro, ciò; questi e quegli (maschile singolare).
AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI
Gli indefiniti esprimono la quantità di persone, animali o cose senza numerarla.
Gli indefiniti più usati, nei vari generi e numeri, sono: alcuno, molto, poco, parecchio, tutto, tanto, nessuno, altro, ogni, ognuno, ciascuno.
AGGETTIVI E PRONOMI NUMERALI
Le parole uno, due, tre… si dicono aggettivi (o pronomi) numerali cardinali poiché indicano una quantità numerica precisa e costituiscono i “cardini” (= le basi) della nostra numerazione.
Le parole primo, secondo, terzo… si dicono aggettivi (o pronomi) numerali ordinali in quanto indicano il posto d’ordine occupato in una serie.
AGGETTIVI E PRONOMI INTERROGATIVI ED ESCLAMATIVI
Con quale aereo parte Luigi?
Che classe frequenta tua sorella?
Quali aggettivi conosci?
Quale sorpresa mi hai fatto!
Quanti bei fiori hai comprato!
Che compiti difficili!
Che, quanto, quale si definiscono aggettivi interrogativi o esclamativi quando precedono un nome nelle forme interrogative o esclamative. Naturalmente, interrogativi ed esclamativi assumono la funzione di PRONOME se, invece di accompagnarsi ad un nome, lo sostituiscono.
Che cosa hai visto?
Dei libri della biblioteca, quali hai letto?
IL VERBO
Il verbo (verbum = parola) è la parte fondamentale della frase.
Senza il verbo non è possibile esprimere un pensiero sensato. È la parte più variabile del discorso.
Attraverso le sue variazioni indica la persona di cui porta informazioni, il tempo in cui accade, il modo in cui avviene.
I verbi essere e avere hanno una coniugazione propria.
Sono verbi ausiliari perché sono di aiuto alla formazione dei tempi composti di altri verbi (vedi le tabelle in fondo al libro).
LE CONIUGAZIONI
I verbi si raggruppano in tre coniugazioni:
• prima coniugazione: - are
• seconda coniugazione: - ere
• terza coniugazione: - ire.
Attenzione!
I verbi fare e dire appartengono alla seconda coniugazione perché mantengono la forma del verbo latino (facere e dicere).
RADICE E DESINENZA
Se togliamo al lessema del verbo all’infinito la desinenza (il morfo), otteniamo la radice: il verbo è così pronto a ricevere tutte quelle “terminazioni”, uguali per i verbi della stessa coniugazione, che ci danno tante informazioni.
I MODI FINITI
Sappiamo già che un verbo esprime la persona ed il tempo in cui avviene l’azione.
Andrea legge un libro.
Legge = terza persona singolare, tempo presente. Ma il verbo esprime anche altre importanti distinzioni.
Andrea legge un libro.
Ah. Se Andrea leggesse un libro.
Andrea leggerebbe un libro se lo avesse!
– Andrea, leggi un libro! – dice la maestra.
La situazione è sempre la stessa, ma con notevoli diversità:
• nel primo caso viene descritta un’azione certa, reale (modo INDICATIVO);
• nel secondo caso viene espresso il desiderio che sia compiuta tale azione (modo CONGIUNTIVO);
• nel terzo caso viene espressa la possibilità che l’azione venga compiuta (modo CONDIZIONALE );
• nell’ultimo si ordina che l’azione venga compiuta (modo IMPERATIVO).
I modi indicativo, congiuntivo, condizionale e imperativo sono detti
MODI FINITI e indicano sempre la persona, il numero e il tempo.
I MODI INDEFINITI
Il verbo, quando esprime l’evento senza terminazioni che indicano la persona e il numero, si coniuga nei modi indefiniti.
Anche i tempi del verbo sono ridotti nei modi indefiniti: il tempo presente e il tempo passato.
Il modo infinito:
Mangiare, correre, donare (presente).
Aver mangiato, aver corso, aver donato (passato).
Il modo participio:
Cadente, vivente, ripetente (presente).
Caduto, vissuto, ripetuto (passato).
Il modo gerundio:
Salendo, giocando, venendo (presente).
Avendo salito, avendo giocato, essendo venuto (passato).
VERBI TRANSITIVI E INTRANSITIVI
I verbi sono diversi non solo nella forma in cui si coniugano, ma anche per la funzione che esprimono.
Alcuni verbi sono TRANSITIVI, esprimono un’azione del soggetto che passa direttamente su un oggetto (persona, animale, cosa) che la riceve.
Lucia legge un libro.
Altri verbi sono INTRANSITIVI, esprimono uno stato o un’azione che il soggetto compie senza che ricada su un oggetto.
Carlo ride.
VERBI TRANSITIVI: LA FORMA ATTIVA, PASSIVA E RIFLESSIVA
Quando il soggetto ha un ruolo attivo rispetto all’azione indicata dal verbo, il verbo ha una forma ATTIVA . Il soggetto agisce: Marco beve.
Quando il soggetto subisce l’azione indicata dal verbo, il verbo ha la forma PASSIVA . Chi agisce non è il soggetto, ma qualcuno (o qualcosa) che viene definito appunto complemento d’agente:
Luca è preso da Mario.
Il verbo alla forma passiva è sempre in un tempo composto. Un verbo alla forma passiva può sempre passare alla forma attiva.
Quando il soggetto agisce e subisce l’azione, il verbo ha una terza forma, quella RIFLESSIVA . Il soggetto compie un’azione su se stesso.
Andrea si veste.
LE PREPOSIZIONI
Le preposizioni sono brevi parole che si premettono ad altre per metterle in relazione.
A, di, da, in, con, su, per, tra, fra sono preposizioni semplici.
Le preposizioni semplici si uniscono agli articoli e formano le preposizioni articolate.
A al allo all’ alla ai agli alle
DI del dello dell’ della dei degli delle
DA dal dallo dall’ dalla dai dagli dalle
IN nel nello nell’ nella nei negli nelle
SU sul sullo sull’ sulla sui sugli sulle
LE PREPOSIZIONI IMPROPRIE E LE LOCUZIONI PREPOSITIVE
Alcune parole svolgono la funzione di preposizione.
Verso, sopra, prima…
Vengono chiamate preposizioni improprie perché possono svolgere la funzione di altre parti del discorso: verso può essere un nome o un verbo.
Le locuzioni prepositive sono espressioni formate da due o più parole che hanno la funzione di un’unica preposizione.
A fianco di, di lato a, in compagnia di, a favore di, al di là del...
LE CONGIUNZIONI
Le congiunzioni (con giungere = unire insieme) uniscono, congiungono parole o frasi.
Come gli articoli e le preposizioni, sono parole che da sole non riescono a significare granché, ma hanno nella frase il compito di legare in modo significativo altre parole.
Le principali congiunzioni sono: e, ma, pure, né, neppure, o, oppure, però, anche, tuttavia, anzi, cioè, infatti, dunque, quindi, perciò, perché, allora, mentre…
GLI AVVERBI
Gli avverbi (ad verbum = vicino alla parola) precisano e modificano il significato di un verbo, ma possono riferirsi anche ad un aggettivo o ad un altro avverbio.
Ecco i principali avverbi.
• di modo (come?): bene, male, lentamente, velocemente…
• di tempo (quando?): ieri, oggi, domani, adesso, ora, prima, poi, mai…
• di luogo (dove?): lì, là, qui, qua, lassù, vicino, lontano, sopra, sotto, fuori, dentro…
• di quantità (quanto?): poco, tanto, molto, più, meno, niente…
• di negazione: no, non, neppure…
• di affermazione: sì, certo, certamente…
• di dubbio: forse, probabilmente, magari…
Alcuni avverbi possono avere il grado comparativo e superlativo.
Lontano, più o meno lontano, lontanissimo.
Le locuzioni avverbiali sono due o più parole che hanno la funzione degli avverbi.
Di corsa, così così, per di qua…
LE ESCLAMAZIONI
Le esclamazioni sono parole invariabili che servono ad esprimere emozioni e sensazioni (gioia, esultanza, dolore, paura…):
Ahi, oh, uffa!
Caspita! Evviva!
Sono spesso seguite dal punto esclamativo.
Attenzione!
Ci sono parole che si formano riportando i suoni, i rumori o i versi che sentiamo attraverso vocali e consonanti.
Tic tac, cip cip, din don dan, gulp, splash, bang. Queste parole si chiamano ONOMATOPEE.
ESERCIZI DI PARTI DEL DISCORSO
1. Premetti l’articolo indeterminativo.
nemico automobile papavero albero
zainetto uovo attrice urlo gnomo
animale scolaro anatra esercito
antiquario occasione
2. Volgi al singolare.
gli anni le eliche
gli abiti le sorelle
gli animali le amiche
gli insetti le finestre
gli istrici le amache
3. Volgi al plurale.
un albero un uccello
un’orsa una zia
un’àncora uno spirito
uno sci una vespa
un’ombra un’ascia
4. Metti l’articolo determinativo e indeterminativo.
gatto di mia nonna pollo allo spiedo pollo avanzato ieri cane randagio
cane che ha abbaiato bambina nella fotografia
5. Sottolinea i nomi e gli articoli.
Se al mattino faceva pratica in fabbrica, nel pomeriggio Ambrogio si godeva liberamente le vacanze.
Dedicandosi anzitutto a lunghe ore di lettura in giardino.
Sedeva di solito su una sdraio sotto un albero di fico, cresciuto spontaneo al margine del prato: intorno l’erba coi suoi fiori incoltivati: ranuncoli gialli, margherite, tarassachi e altri di cui ignorava il nome.
Spesso nelle ore di gran sole in giardino non c’era nessuno all’infuori di lui, se non talvolta i due fratelli più piccoli, Rodolfo e Giudittina (gli altri erano partiti per la montagna), che indugiavano chini sul terreno a giocare con gli stampi e la terra.
Portavano – i due bambini – berretti bianchi calati fin sulla nuca, anzi sul collo, e i loro gesti erano lenti, assonnati: così chini pareva che il gran sole dall’alto li premesse con la sua vampa contro il suolo.
In quelle ore non giungevano ad Ambrogio altri rumori che ronzii di insetti, il pigolio dei passeri dal tetto di casa, crescente a volte fino a sfociare in improvvise baruffe subito risolte (i passeri, che tra gli uccelli sono i più vicini agli uomini, sembrano anche fra tutti i più rissosi), e ogni tanto dagli alberi la strofa ben modulata del capinero: un gorgheggio di poche note delicatamente variate, che per lui finiva col costruire la voce stessa dell’estate in Brianza…
6. Scrivi sul quaderno un nome proprio di… un monte, un mare, un arcipelago, un fiume, un pianeta, un continente, una via, uno stato, un popolo, un vulcano, una regione, una donna, un cane, un’isola, un lago, un giornale.
7. Trascrivi le seguenti frasi mettendo la lettera maiuscola quando il nome è proprio.
1. Nel mare adriatico alcuni marinai hanno avvistato delle balene.
2. marco è un ragazzo simpatico e scherzoso.
3. marta è l’amica preferita di luisa.
4. Quest’estate la nostra famiglia ha trascorso le vacanze in toscana e ha visitato la città di firenze.
5. Quest’anno in quinta studiamo i romani.
8. Indica il genere dei nomi (m = maschile; f = femminile).
il vigile la poetessa un nipote la nuora il faggio il dentifricio l’attore un atleta l’infermiera il faraone il gelo una tana il nespolo l’astuccio
la balconata il traffico un coperchio un’eroina
9. Trasforma il nome evidenziato da maschile in femminile e inventa con esso una frase.
1. Il foglio su cui stai scrivendo è sgualcito.
2. Le navi attraccano al porto.
3. Il velo della sposa è bianco.
4. Il collo della giraffa è lunghissimo.
5. Il tuo banco è ordinato.
10. Volgi sul quaderno al femminile i seguenti nomi premettendo l’articolo indeterminativo: eroe, suocero, zio, poeta, cane, conte, compagno, professore, commesso, scrittore, duca.
11. Volgi al maschile i seguenti nomi: avvocatessa, nuora, figlia, parrucchiera, autrice, lettrice, orsa, Paola, soldatessa, pittrice, sorella.
12. Volgi sul quaderno dal singolare al plurale facendo attenzione alla desinenza (ultima sillaba). pacco, dialogo, cieco, pesco, cuoco, biscia, striscia, fascia, ascia, coscia.
13. Volgi dal plurale al singolare. gocce, bucce, spiagge, frange, camicie, ciliegie, valigie, querce, magie, rocce.
14. Sottolinea in rosso i nomi singolari, in blu i nomi plurali e in verde i nomi che hanno la stessa forma al singolare e al plurale. sedia, bar, foto, divano, città, tazza, caffè, sport, re, piante, serie, scimpanzé, vestito, salsiccia, castagna.
15. Scrivi sul quaderno un nome collettivo per dire… un insieme di calciatori, un insieme di api, un insieme di uccelli in volo, un insieme di pini, un insieme di abeti, un insieme di ulivi, un insieme di suonatori, un insieme di navi, un insieme di montagne, un insieme di isole, un insieme di amici.
16. Spiega sul quaderno il significato dei seguenti nomi collettivi: ciurma, folla, gregge, corteo, costellazione, flotta, scolaresca, cucciolata.
17. Cerchia il verbo giusto per completare la frase e poi trascrivila sul quaderno scrivendo in rosso il nome collettivo.
1. Una mandria di mucche pezzate pascolavano/pascolava sull’altopiano.
2. Uno sciame d’api inferocite inseguiva/inseguivano il povero orsetto.
3. La folla applaudiva/applaudivano all’arrivo dei ciclisti.
4. La scolaresca seguivano/seguì con molta attenzione la lezione.
18. Per ognuno dei seguenti nomi primitivi scrivi un nome derivato: campana, dente, porta, legno, fiore, cane, occhio, vetro, negozio, libro, mare.
19. Per ognuno dei seguenti nomi derivati scrivi il nome primitivo da cui deriva: pizzaiolo, autista, formicaio, cittadino, montanaro, barcaiolo, viaggiatore, scarpiera, pastificio, lampadario, calciatore.
20. Scrivi P accanto ai nomi primitivi e D accanto ai nomi derivati. salumiere mobilificio libreria marinaio alpinista gelateria ghiaccio pasta limonata orefice muro maniglia fioriera pollo saliera
21. Scrivi sul quaderno il nome alterato corrispondente. fiore piccolo, strada brutta, orto piccolo e curato, libro sgualcito, pancia grossa, candela piccola, voce sgraziata, piede grosso, vaso piccolo e grazioso, gatto cattivo e crudele, bocca piccola e graziosa.
22. In queste frasi sottolinea con il blu i nomi alterati e specifica nelle parentesi se si tratta di diminutivi, accrescitivi, dispregiativi, vezzeggiativi.
1. Non vedo l’ora che arrivi la mia cara zietta. ( )
2. Nella baita in montagna c’era una stanzona fredda e umida.
( )
3. Eravamo in spiaggia quando cadde una pioggerella sottile.
( )
4. Ogni mattina bevo una bella tazzona di latte e caffè. ( )
5. La strega gridò con una vociona da far spavento. ( )
6. È proprio una giornataccia: piove e fa freddo. ( )
23. Tra questa serie di nomi troverai qualche falso alterato: parole che finiscono con –ino, -one, -accia, ma hanno un significato proprio. Trovali. paesello, bagnino, mulino, torretta, torrone, focaccia, catenaccio, bastone, nasone, mattino, aquilone, pagliaccio.
24. Sostituisci le seguenti espressioni con un nome composto.
1. Strumento per togliere i tappi dalle bottiglie.
2. Aiuta i bambini a rimanere a galla.
3. Persona che dirige una stazione ferroviaria.
4. Attrezzo per appendere abiti.
25. Separa le due parole che compongono i seguenti nomi composti e spiega che cosa sono. Volgi poi i nomi al plurale come indicato nell’esempio. asciugamano = asciuga + mano (verbo + nome) asciugamani
aspirapolvere, biancospino, ferrovia, terracotta, cassaforte, contachilometri, portacenere, lavastoviglie, capofila, portachiavi, pescespada, doposole, sottopassaggio.
26. Nelle seguenti frasi i nomi sottolineati sono usati in senso proprio o in senso figurato. Per ognuno indica in quale senso è usato.
1. Per la strada c’è un mare di gente.
2. La stella polare indica il nord.
3. Tuo fratello è proprio una volpe.
4. Il drago lanciava fiamme dalle narici.
5. Quando Paolo corre è una vera lepre.
6. La lepre corre nei campi.
7. Questo romanzo è un mattone.
8. Mi serve un altro mattone per il muretto.
9. Appena ti ha sentito, Luca ha mangiato la foglia.
10. Sull’albero non c’è più nemmeno una foglia.
27. Spiega il significato figurato dei seguenti modi di dire.
1. Tenere qualcuno sulla corda.
2. Dare corda a qualcuno.
3. Gettare fumo negli occhi.
4. Mandare in fumo.
5. Avere la testa tra le nuvole.
6. Cascare dalle nuvole.
7. Chiudere un occhio.
8. Costa un occhio.
28. Trascrivi sul quaderno i nomi e a fianco gli aggettivi che si riferiscono ad ogni nome. Alessia ha tredici mesi. È tonda, soda, colorita, provvista di due gambe corte e solidissime; ha gli occhi azzurri vivaci e mobilissimi. Frequenta il nido e arriva ogni mattina felice, strappandosi il cappotto per la frenetica voglia di entrare. È traboccante di energie e di vitalità, di umore sempre allegro, attiva, curiosissima, rumorosa, vivacissima. Ha imparato a camminare a dieci mesi, ora procede in modo veloce e cade qualche volta, ma non si lamenta. Si rialza e riparte con allegria.
29. Sottolinea gli aggettivi qualificativi e circonda i nomi a cui si riferiscono.
Tra i petali carnosi di ogni rosa vivevano minuscoli ragni che sembravano granchi e scappavano di lato quando li si disturbava.
I loro piccoli corpi trasparenti avevano lo stesso colore rosa, rosso, giallo, dei fiori su cui abitavano. Sugli steli delle rose le coccinelle zampettavano come giocattoli dipinti: coccinelle di un rosso pallido con grandi macchie nere, coccinelle rosse con macchie marroni; coccinelle arancioni macchiate di grigio e di nero. Le api zigzagavano su e giù per i sentieri, indaffarate.
Tra i ciottoli bianchi, grosse formiche nere barcollavano e gesticolavano intorno a strani trofei: un bruco morto, un pezzetto di petalo di rosa o un capolino secco.
30. Nelle seguenti frasi sottolinea i comparativi, i superlativi assoluti e i superlativi relativi, poi scrivili nella colonna giusta della tabella.
1. Fra tutte le mie compagne di scuola, Anna è la più simpatica.
2. Il testo di Licia è meno lungo del tuo.
3. Il mio amico Giorgio è simpaticissimo e mi fa sempre ridere.
4. Non brontolate, questo problema è molto facile.
5. Il mio cane è affamato come il tuo, perciò darò un croccantino ad entrambi.
6. Questo libro è il più interessante di tutti.
7. Il mare Adriatico è meno profondo del Tirreno.
8. Ieri, in montagna, la neve scendeva molto fitta.
9. Il lago di Garda è il più grande d’Italia.
10. Nel giardino della nonna crescono fiori bellissimi.
11. Sul viso della Strega Bianca spiccava la bocca rossa rossa.
12. Max è un bambino bellissimo.
COMPARATIVI
SUPERLATIVI
di maggioranza di minoranza di uguaglianza relativi assoluti
31. Nelle seguenti frasi sottolinea con due colori diversi gli aggettivi e i pronomi dimostrativi.
1. Oggi indosso questa maglietta gialla, domani indosserò quella azzurra che mi ha regalato la nonna.
2. Portami quei quaderni e codesti libri.
3. Questa torta è squisita. Quella che ho mangiato ieri al ristorante era troppo dolce.
4. Quell’armadio è troppo ingombrante, questo è troppo piccolo.
5. Ho comprato alcuni vasi di fiori da mettere sul balcone: questi sono gerani, quelli che ho messo sulla finestra della cucina sono ciclamini.
32. Inserisci i dimostrativi adatti e sottolinea in verde gli aggettivi e in viola i pronomi (questo, codesto, quello).
1. Ho già corretto quaderni, li correggerò domani.
2. Quando guardo attentamente montagne, mi sento felice.
3. Io prendo scatolone, tu prendi .
4. Ho usato matite per completare il mio disegno.
5. Guarda là! è la mia amica Chiara.
6. libro ha 128 pagine, ne ha 15 in più.
33. Scrivi un possessivo adatto. Cerchia in rosso se è aggettivo e in verde se è pronome.
1. Il giubbino è identico al .
2. Ognuno assuma la responsabilità.
3. Prestami il libro di fiabe e io ti presterò i fumetti.
4. Raccontateci la avventura e noi vi racconteremo la .
5. Ho in tasca le figurine, perché voglio scambiarle con le .
6. È bene chiamare ogni cosa con il nome.
7. L’orsacchiotto marrone appartiene a fratello, questo invece è il .
8. Vuoi i pattini? Oppure usi i ?
34. Scrivi accanto ad ogni pronome possessivo il nome che sostituisce.
1. Oggi ho portato in spiaggia la mia paletta perché voglio costruire con Giacomo una pista per le biglie. Spero che egli porti la sua ( ), così termineremo più velocemente. Le sue biglie sono di plastica, le mie ( ) sono di vetro.
2. All’intervallo giochiamo spesso con la palla insieme alla quinta B: talvolta usiamo la nostra ( ), a volte usiamo la loro ( ).
3. La mia stanza è più spaziosa della tua ( ), ma il tuo giardino è più grande del mio ( ).
35. Scrivi alcune frasi contenenti aggettivi e pronomi possessivi e poi sottolinea i pronomi e gli aggettivi con colori diversi.
36. Sottolinea con due colori diversi gli aggettivi numerali (collegali al nome cui si riferiscono) e i pronomi numerali (aggiungi sopra di essi il nome sottinteso).
1. Il terzo ragazzo della fila è più alto del quarto.
2. Puoi prestarmi dieci euro?
3. Gli zii arriveranno da Livorno fra otto giorni.
4. Settembre è il nono mese dell’anno, novembre è l’undicesimo.
5. Bernardo ha segnato un goal al ventesimo minuto.
6. Questo libro ha sessantaquattro pagine, io sono arrivato alla quarantesima.
7. Il primo corridore ha tagliato il traguardo, il secondo è arrivato tre secondi dopo di lui.
8. Prendi cinque caramelle: due all’arancia e tre alla fragola.
37. Copia sul quaderno i numerali dell’esercizio precedenti e dividili in cardinali e in ordinali.
38. Sottolinea con due colori diversi gli aggettivi indefiniti (e circonda il nome a cui si riferiscono) e i pronomi indefiniti (scrivi sopra il nome che sostituiscono).
1. All’intervallo alcuni bambini hanno giocato a basket, altri invece hanno giocato a nascondino.
2. Hai svolto qualche esercizio in più per allenarti.
3. Ieri siamo stati al museo e abbiamo visto tante varietà di farfalle, avevano tutte dei colori bellissimi, solo alcune erano bianche.
4. Prima della partita l’allenatore ha dato ai suoi giocatori qualche consiglio.
5. Ti mancano poche pagine per finire il libro.
39. Scegli quale indefinito è il più adeguato fra quelli tra parentesi. Scrivi se è aggettivo o pronome.
1. Sto aspettando (qualche, altri, alcuni) amici per andare al cinema.
2. (Qualche, Ogni, Nessun) mercoledì vado a pranzo a casa dei nonni.
3. In vacanza, dopo pranzo, (parecchie, qualche, poche) volte mi sdraio sul divano a leggere.
4. (Molti, Alcuni, Tutti) hanno svolto già tutti i compiti, (altri, molti, nessuno) non li hanno ancora iniziati.
40. Ricopia le frasi sostituendo al pronome LE – A LEI e al pronome GLI – A LUI.
1. Marta ha incontrato la nonna e le ha dato un bacio.
2. Elisa ha fatto gli auguri a Margherita e le ha portato un regalo.
3. Matteo aveva sete e la mamma gli ha comprato una coca cola.
4. Federico è allegro: gli piace scherzare.
41. Sottolinea con due colori diversi gli articoli e i pronomi personali. Poi ricopia le frasi sostituendo al pronome il nome a cui si riferisce.
1. Prendo lo scatolone e lo apro.
2. Prendo la cartella e la riempio.
3. Scarto la caramella e la mangio.
4. Calzo le scarpe e le allaccio.
5. Taglio le arance e le spremo.
6. Lavo i piedi e li asciugo.
42. Riscrivi le seguenti frasi, sostituendo le parti sottolineate con i pronomi personali adatti.
1. Carlo porta al parco il cane e dà al cane un biscotto.
2. Luca va a casa di Federico e porta a Federico un regalo.
3. Oggi è il compleanno della nonna e il nonno porta i fiori alla nonna.
4. Carola era ammalata ed Enrico ha portato i compiti a Carola.
5. La mamma sbuccia la mela e mangia la mela.
6. Andrea prende il pallone e tira il pallone.
7. Giacomo lava le mani e asciuga le mani.
43. Nelle seguenti frasi osserva le parole in neretto, individua se sono articoli o pronomi e sottolineali con due colori diversi.
1. Le storie che mio nonno racconta sono meravigliose, le ascolto sempre con molta gioia e attenzione.
2. Le ho chiesto di aiutarmi a preparare le torte per la festa.
3. Lucia e Miriam sono le amiche di Teresa. Durante l’intervallo le hanno detto che la inviteranno alla loro festa di compleanno.
4. L’altro ieri ho incontrato la zia al supermercato, le ho chiesto di venire a cena da noi la prossima settimana.
5. Luca è sceso in cortile a giocare, è andato a citofonare a Marco e lo ha invitato a scendere con lui .
44. Inserisci l’aggettivo o il pronome interrogativo adatto e poi sottolineali con colori diversi.
1. siete?
2. pesci hai pescato?
3. è arrivato primo nella gara?
4. tempo è passato dall’ultima volta che ci siamo incontrati?
5. ora è?
6. bussa?
7. ha dipinto questo quadro?
8. pasticcini hai comprato?
9. colore preferisci?
45. Inserisci l’aggettivo o il pronome esclamativo adatto e poi sottolineali con colori diversi.
1. bello vederti!
2. bei luoghi hai visitato in queste vacanze!
3. cielo azzurro stamattina!
4. bambini a questa festa!
5. stelle stasera!
6. bello questo gioco!
7. pioggia è caduta oggi!
8. si vede!
46. Riscrivi le seguenti frasi, sostituendo le parole che si ripetono con il pronome relativo CHE . Segui l’esempio:
La mamma mi ha detto di prendere il libro; il libro è sul tavolo. La mamma mi ha detto di prendere il libro che è sul tavolo.
1. Sono stato al cinema a vedere un film; il film mi è piaciuto molto.
2. Elisa guarda il suo fratellino; il suo fratellino gioca a palla.
3. Ho studiato con attenzione la lezione; la lezione è stata spiegata dalla maestra.
4. Ho invitato Andrea alla mia festa di compleanno; la mia festa si svolgerà giovedì pomeriggio.
47. Nelle seguenti frasi, sottolinea i pronomi relativi e circonda le parole a cui si riferiscono. Segui l’esempio:
Il treno che abbiamo preso per tornare a casa è arrivato in ritardo.
1. Giovedì andremo a vedere la casa in cui ci trasferiremo a settembre.
2. Nel mare azzurro c’era tanta gente che nuotava e tanti bambini che si spruzzavano.
3. I primi a mettersi al lavoro sono i panettieri; i quali devono sfornare il pane per la giornata.
4. Il libro che ho letto in questi giorni è molto avvincente.
5. Marco aveva un sacco di amici con cui passeggiare tra i boschi.
6. La zia da cui andrò in vacanza si chiama Lucia.
48. Nel seguente brano individua e sottolinea con colori diversi quando il CHE è pronome relativo e quando invece è congiunzione (per essere sicuro che sia pronome relativo puoi sostituirlo con il quale, la quale, i quali e le quali).
Evviva le differenze!
Ogni giorno in classe i bambini parlavano delle loro esperienze, di quello che succedeva nella loro vita. Così scoprirono che erano tutti diversi anche se avevano la stessa età. Le diversità di questi scolari erano una più bella dell’altra.
C’era Marzia che, ogni volta che provava un’emozione, inventava una poesia.
C’era Fabrizio che era bravissimo nel disegno. C’era Cosetta che, quando era di luna buona, da un’idea tirava fuori scene di teatro che incantavano i compagni.
C’era Marco che non smetteva mai di leggere….
49. Il pronome relativo deve stare vicino al nome che lo sostituisce. Metti a posto le situazioni assurde causate dal CHE messo male riscrivendo la frase corretta sul quaderno.
1. Il cane è della mia vicina che senti abbaiare ogni sera.
2. Il pappagallo è di mio zio che sta sul trespolo.
3. La baita è del nonno che sorge sulla montagna.
50. Trascrivi le frasi sul quaderno unendole con i pronomi relativi anteponendo a QUALE e CUI la preposizione semplice o articolata corretta.
1. Questa è la piscina. Nella piscina faccio il bagno.
2. Non ritrovo più la via. Per la via sono passato ieri.
3. Questo è il campo da pallone. Nel campo da pallone gioco la partita.
4. Ho letto con attenzione le istruzioni. Delle istruzioni mi servirò per giocare in modo corretto.
5. Ho telefonato al medico. Al medico ho chiesto un appuntamento.
6. Francesca è una compagna. Con Francesca svolgo volentieri i compiti.
7. Ti voglio far conoscere un mio amico. Sono molto affezionata all’amico.
51. Completa le frasi usando il pronome relativo adatto.
1. Siamo andati a vedere la chiesa ci avevi parlato.
2. Dimmi l’indirizzo ti trovi e verrò a prenderti in macchina.
3. La materia ho meritato un bel voto è inglese.
4. L’idraulico mi sono rivolta mi ha riparato il rubinetto.
52. Leggi le seguenti frasi e sottolinea i pronomi personali.
1. Luca e Gaia giocano in giardino mentre voi fate merenda; io li sorveglio dalla finestra.
2. Gabriele ha fatto un disegno e io lo aiuterò a colorare.
3. Martina ha scritto una lettera a Sofia: le manda tanti baci e la saluta.
4. Mattia è un bambino dispettoso: egli ci fa degli scherzi terribili!
5. I bambini amano giocare con la PlayStation, per loro è meglio di qualsiasi altro gioco e la preferiscono persino al calcio!
53. Ricopia le frasi completandole con i pronomi personali adeguati. Poi sottolinea i pronomi personali.
1. Scrissi ad un cugino, inviai auguri sinceri e invitai a casa mia.
Scrissi ad una cugina…
Scrissi ai cuginetti…
Scrissi alle cuginette…
2. Giovanni è buono e tutti stimano e vogliono bene.
Giovanna è buona…
Giovanni e Federico sono buoni…
Giovanna e Federica sono buone…
3. Mario disubbidì, la mamma sgridò e diede un castigo.
Maria disubbidì…
Mario e Francesco disubbidirono…
Maria e Francesca disubbidirono…
54. Sottolinea LO, LE, LA, GLI, L’ in rosso quando sono articoli e in blu quando sono pronomi.
1. L’uva mi piace, ma quest’anno non l’ho ancora mangiata.
2. Gli alunni di quinta sono stati promossi tutti.
3. Gli ho sempre detto che doveva studiare di più!
4. La prossima volta la chiamo e le dico di venire prima.
5. Le ho detto che le rose che mi avete chiesto erano finite.
6. Ugo ha lo zaino grande. Lo porta sempre in montagna con sé.
55. Scrivi due frasi con GLI in funzione di pronome e di articolo.
PRONOME: 1. 2.
ARTICOLO: 1. 2.
56. Sottolinea in verde le voci del verbo essere con funzione ausiliare e in rosso quelle con funzione propria.
1. Enrico era arrabbiato e se n’è andato via.
2. Stefano è partito ed è stato contento.
3. Siamo andati al cinema insieme perché siamo amici.
4. Sofia è uscita mentre io sono in casa.
5. Quando sarete arrivati in spiaggia, io sarò già in acqua.
6. Le alte vette sono candide e sono accarezzate dal vento.
57. Sottolinea in verde le voci del verbo avere con funzione ausiliare e in rosso quelle con funzione propria.
1. Il bambino ha smesso di correre perché non ha più fiato.
2. Ho molto sonno perché questa notte non ho riposato abbastanza.
3. Ho nello zaino il libro che mi hai prestato.
4. Quando avremo terminato i compiti, avremo tempo per giocare.
5. Daniele ha molti amici e li ha invitati tutti alla sua festa.
6. Abbiamo preparato una scenetta divertente: hai tempo di vederla?
58. Ricopia volgendo al modo infinito i seguenti verbi. Dividi in tre colonne, secondo la coniugazione. hanno elaborato; avrete intrapreso; indagammo; farai; vede; gioiva; esclamerò; elargisce; avevi scoperto; affermò; ha annuito; ebbero corso; avremo recuperato; è salito; aveva abbaiato; partivate; disse.
59. Leggi le frasi e sottolinea i verbi. Poi, di questi, esegui l’analisi grammaticale scritta sul quaderno.
1. Non appena la mamma ebbe preso il budino dal frigo, tutti i bambini corsero presso di lei.
2. Al tramonto, il cielo aveva lasciato l’azzurro e diventò rosso all’orizzonte.
3. Quando Hamilton avrà raggiunto la curva con la sua Ferrari potente, tenterà di superare l’avversario Vettel.
4. Mentre attraversavamo la città, scoppiò un terribile temporale!
5. Tutte le volte che guardavamo la televisione, mia sorella pretendeva di vedere i suoi programmi preferiti.
6. Finché rimarrete con me, sarete al sicuro!
7. Poiché avete ottenuto il miglior tempo, riceverete un premio!
60. Leggi le frasi e sottolinea con colori diversi i modi finiti del verbo.
1. La nonna avrebbe cucinato una buona torta salata se la corrente non fosse mancata nel pomeriggio.
2. Chi ha qualcosa da dire, parli adesso o taccia per sempre!
3. L’Apollo XIII sarebbe sbarcato sulla Luna se non avesse avuto un’imprevista avaria.
4. «Hai la febbre. Bevi la medicina!» disse la mamma a Giuseppe.
5. Se fossi Leonardo quante cose inventerei!
6. Il comandante ordinò: «Correte!».
7. Credo che tu abbia studiato con molto impegno.
8. Verremmo con te al parco se non dovessimo tornare a casa prima delle cinque.
61. Gli imperativi della vita quotidiana: Mettiti le scarpe! Sbrigati a scendere! Finisci il tuo piatto! Continua tu.
62. Completa la tabella.
INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO spolverato avere visto
partire spalancando risorgere essendo stato avendo coperto desiderante avere avuto
63. Sostituisci la parte tra parentesi con un verbo al modo gerundio presente o passato.
1. (Da quando ho conosciuto) tua zia, ho capito a chi assomigli.
2. (Dato che siamo arrivati in ritardo) , abbiamo perso la prima parte dello spettacolo.
3. Devi recuperare i compiti della scorsa settimana, (dal momento che sei stato assente) .
4. (Quando gonfi) troppo il palloncino, lo scoppi!
5. (Mentre scalavano) la montagna, hanno visto un panorama mozzafiato.
6. Ho ritrovato il tuo orecchino (mentre pulivo) sotto al letto.
64. Fai l’analisi scritta delle seguenti voci verbali:
1. Sarai andato, credesti, aveste disegnato, abbiamo avuto, foste.
2. Abbiate parlato, che tu avessi saputo, avrebbero cantato, sentirebbe, parla.
3. Sentimmo, dicevo, che sia venuto, avrei mangiato, piangente.
65. I verbi transitivi fanno transitare l’azione direttamente dal soggetto al complemento oggetto. Completa le frasi rispondendo alla domanda “Chi? Che cosa?” e scrivi il verbo transitivo.
1. Preparo per andare a scuola. ( )
2. Nel pomeriggio ho fatto insieme a Giovanni. ( )
3. Il gatto avvistò che era caduto dal nido. ( )
4. Quest’estate leggerò che non ho letto durante l’anno. ( )
5. La mamma cucina squisito. ( )
6. I pompieri spengono con molta fatica . ( )
66. Le frasi con i verbi intransitivi possono essere completate rispondendo ad alcune domande.
1. Ieri sono andato (dove?) .
2. Io corro (come?) .
3. Gli zii sono tornati (da dove?) .
4. Il temporale è durato (per quanto?) .
5. Patrizia dorme (dove?) .
6. Io sono nato (quando?) .
67. Sottolinea in rosso i verbi transitivi e in verde i verbi intransitivi.
1. Il fagiano è scappato nei cespugli.
2. Il guardiacaccia ha allontanato il cacciatore.
3. L’atleta corre velocissimo.
4. Il treno percorre un lungo tratto.
5. La nonna trascorre molto tempo con me.
6. Lo scalatore fotografa le stelle alpine.
68. Sottolinea in blu i verbi nella forma attiva, in rosso quelli in forma passiva. Riscrivi le frasi nella forma inversa.
1. Il vento allontanò le nuvole.
2. La pioggia sferza alberi e cespugli.
3. Il fuoco era alimentato dal vento.
4. La notizia sarà pubblicata da tutti i giornali.
5. Il bambino è corso dalla sua mamma.
6. I figli sono amati dai genitori.
7. Carla è arrossita dalla vergona.
69. Indica se le frasi sono attive (A) o passive (P).
1. Nella stazione ferroviaria i passeggeri impazienti attendevano il treno.
2. Durante le vacanze di carnevale Anna e Paolo andranno a Bormio.
3. L’automobile di Marco è stata bloccata da una tempesta di neve.
4. Le mascherine di carnevale sono colorate dai bambini di prima elementare.
5. Il papà prepara le valigie per il viaggio.
6. Sono state invitate dalle loro amiche a una grande festa a Venezia.
70. Sottolinea le frasi in cui l’azione si riflette (ricade) su chi la compie.
1. Giulia si pettina. Giulia pettina la bambola. La bambola è pettinata da Giulia.
2. Lucia e Cosimo salutano la mamma. Lucia e Cosimo si salutano. La mamma è salutata da Lucia e Cosimo.
3. Il bidello ha pulito le scarpe. Il bidello si è pulito le scarpe. Le scarpe sono state pulite dal bidello.
71. Coniuga il verbo “lavarsi” al passato prossimo del modo indicativo. Io mi sono lavato, tu…
72. Inventa e scrivi delle frasi usando i seguenti verbi riflessivi: pulirsi, lavarsi, vestirsi, specchiarsi, pettinarsi, presentarsi, accorgersi, mostrarsi, tuffarsi, comportarsi, incamminarsi.
73. Inserisci la preposizione adatta.
1. Non sono potuto venire da te ieri, impegni di lavoro.
2. I tuoi genitori sono molto contenti tuo comportamento.
3. quel frastuono improvviso sobbalzammo la paura.
4. Era molto tardi e gli occhi dei più piccoli cadevano il sonno.
5. quelle parole, nessuno di noi seppe trattenere il riso.
74. Completa le frasi, facendo uso delle diverse preposizioni. da .
1. Sono venuto a . per . su .
2. Carlo mise i suoi libri con . in . su .
3. Il ladro fuggì con . in . del .
4. La zia apre la porta con . per . di .
5. Lia legge quel libro con . su .
75. Scrivi una frase per ogni espressione in cui la preposizione da viene apostrofata.
D’altra parte, d’allora in poi, d’altronde, d’altro canto, d’ora in poi.
76. Unisci le frasi con una congiunzione adatta.
1. Il postino suonò il campanello fece scivolare una busta
nella cassetta della posta.
2. Oggi è il tuo compleanno ti farò un regalo.
3. Comportati bene vuoi essere stimato dai compagni.
4. Mi sono vestito in fretta sono andato a scuola di corsa.
5. La mamma stette in pensiero il babbo arrivò tardi.
6. Mia sorella si riposa è molto stanca.
7. Noi andiamo al mare la temperatura sia ancora fredda.
8. Io pago alla cassa tu metti la spesa nella busta.
9. Alla cassa c’è molta gente la cassiera è veloce.
10. I biscotti sono al cioccolato sono buoni.
77. Completa le frasi con le congiunzioni opportune: perché, se, quando, quindi, o, e, ma.
1. La mamma mi sgrida non leggo.
2. Il babbo frena il semaforo è rosso.
3. Prendo l’ombrello piove.
4. Vado al Luna Park non vado al cinema.
5. Oggi la nonna non viene fa troppo freddo.
6. Il mio cane è molto bello abbaia troppo.
7. Domani è la festa della mamma le compro i fiori.
8. Nel negozio ci sono tanti giocattoli posso sceglierne uno.
9. A volte non sei simpatico prepotente antipatico.
10. Dallo scaffale prendi la marmellata il burro.
11. Preferisci andare al cinema in piscina?
78. Scrivi una frase con ognuna delle seguenti congiunzioni: infatti, però, oppure, finché, quindi, quando, anche, ma, dunque.
79. Completa le seguenti frasi con le congiunzioni adatte: a patto che, affinché, benché, come, perché, poiché, qualora, quando, tanto che.
1. ho sonno, vado a dormire.
2. Non sono venuto ero ammalato.
3. ti dico che è così, è così!
4. Ti concederò di uscire tu ti metta a studiare.
5. Mi hanno dato il modulo mi iscrivessi all’oratorio.
6. arrivato, ripartì.
7. tu non potessi venire, avvisami.
8. È pallido sembra malato.
9. io lo desideri, non potrò partire.
10. Sono sicuro che me ne andrò, lui arriverà!
80. Sottolinea gli avverbi che riconosci nelle frasi e collegali con una freccia al verbo.
1. Laggiù vedo delle persone che stanno aspettando il tram.
2. Non studio adesso: voglio guardare la televisione!
3. Il mio papà lavora sempre di sabato.
4. Andremo domani al cinema.
5. Metti lì la tua borsa e apri subito il regalo.
6. Hai mangiato bene a casa mia?
7. Il mio gatto dorme dappertutto.
8. Abbiamo giocato allegramente in casa.
81. Sostituisci con un avverbio le espressioni in corsivo.
1. La mamma mi parla con dolcezza.
2. Mio padre è solito guidare con prudenza.
3. Quando c’è nebbia bisogna procedere con attenzione.
4. Di solito io bevo latte caldo prima di andare a letto.
5. Alla fine sono riuscito a imparare a memoria la poesia.
6. Il ladro penetrò nell’appartamento in silenzio.
7. Piantiamo la tenda in questo luogo.
8. Vi racconterò in breve tempo come ho trascorso le vacanza.
9. L’acqua bolle: bisogna buttare la pasta in questo momento.
10. Si impara a sciare per gradi.
82. Scegli dei colori per ogni parte fondamentale. Poi individua nel brano ogni parte e sottolineala con il colore scelto.
⬜ articoli ⬜ nomi ⬜ aggettivi
⬜ pronomi ⬜ verbi ⬜ preposizioni
⬜ congiunzioni ⬜ avverbi ⬜ esclamazioni
Benito era un oste di un paese vicino a Betlemme. Naturalmente fu tra i primi a sapere della nascita del Divino Bambino. Era stato informato da un pastore.
Subito era sceso in cantina e aveva riempito un boccale con vino resinato. «È un vino forte, lo so» si era detto «ma forse a quella povera mamma, che ha appena partorito, un gocciolino non potrà che far bene!».
Ma per strada ebbe una visione: vide una bellissima donna con un bimbo in grembo. Per la sorpresa inciampò e gli cade il boccale di vino che si ruppe. «Che faccio ora? Ritorno indietro?».
Vinto dalla curiosità arrivò fino alla stalla e trovò Maria e Giuseppe che si versavano un po’ di vino da un boccale uguale al suo.
Benito guardò stupefatto. «Talvolta» disse Maria con un sorriso «le intenzioni valgono tanto quanto le buone azioni…».
Natale è un presepio, a cura di Guido Davico
LA COMBINAZIONE LOGICA
Le parole che abbiamo conosciuto (articoli, nomi, aggettivi, verbi…) si accordano e si combinano per formare le frasi, espressioni che hanno un senso.
Le composizioni delle parole che costruiscono una frase di senso compiuto si chiamano SINTAGMI.
Il cane / della zia Michela / abbaia / tutto il giorno / alle persone / del vicinato.
Nella frase ogni sintagma svolge una funzione particolare e contribuisce a costruire il significato complessivo.
IL PREDICATO
Come sai il verbo è la parola più significativa. Per questo occorre partire dal verbo: la parola che dice; è il PREDICATO.
Il sintagma che dice, che predica qualcosa del soggetto, è il sintagma verbale. La domanda a cui risponde è: che cosa si dice?
La frase è una combinazione significativa di parole costruita intorno ad un verbo.
Attenzione!Il verbo ha una funzione così forte che in alcuni casi forma da solo una frase: Piove.
IL SOGGETTO
L’altro sintagma significativo e indispensabile è quello del nome che indica e nomina il soggetto di cui si parla.
È il sintagma del SOGGETTO.
La domanda a cui risponde e che ti serve per individuarlo è: di chi si parla?
Il soggetto è il sintagma che determina il numero e la persona del predicato.
Il sintagma con funzione di soggetto può anche non essere espresso quando il predicato lo rivela chiaramente, in questo caso si ha il soggetto sottointeso (o implicito).
Gioco volentieri a calcio › il soggetto implicito è io.
Soggetto e predicato (di chi si parla e che cosa si dice) sono gli elementi essenziali di ogni frase.
In ogni frase sono riconoscibili ed è possibile distinguerli dal resto.
Soggetto e predicato concordano e costituiscono la frase minima.
Attenzione! Qualsiasi parte del discorso può svolgere la funzione di soggetto. Leggere è utile › Il soggetto è un verbo all’infinito.
PREDICATO VERBALE E NOMINALE
Ogni giorno / molte persone / MUOIONO / di fame.
Durante le vacanze natalizie / Riccardo / È ANDATO / in montagna.
Tutte le ballerine / AVEVANO RACCOLTO / i capelli.
Lucia / è bella.
La sorella / di Marta / è una bambina simpatica. Il papà / del mio amico Franco / è un vigile urbano.
Distinguiamo due tipi di predicato:
• PREDICATO VERBALE che è formato solo da una voce verbale (come quelli scritti in stampato e sottolineati );
Ricorda!
Quando il verbo essere ha il significato di stare, trovarsi, appartenere, esistere è un predicato verbale.
• PREDICATO NOMINALE che è formato dal verbo essere più nome e/o aggettivo (come quelli scritti in corsivo e sottolineati ).
Per capire ed eseguire correttamente l’analisi logica devi:
• dividere la frase in sintagmi, le combinazioni di parole che sono unite perché svolgono una funzione nella frase;
• individuare il predicato, cioè il sintagma del verbo che ti permette di capire che cosa si dice;
• riconoscere il soggetto, cioè il sintagma di cui parla il predicato e con cui concorda.
I COMPLEMENTI
Le frasi sono solitamente formate da altri sintagmi che hanno la funzione di completare la frase minima. Questi sintagmi si chiamano COMPLEMENTI.
Fra i vari complementi si distingue il sintagma che spesso completa la frase minima: è il complemento diretto (o complemento oggetto). Si chiama diretto quel complemento che è direttamente legato al verbo, in quanto l’azione espressa dal predicato “cade” direttamente sull’oggetto nominato in questo complemento. Di solito questo complemento è formato da un nome preceduto dall’articolo. Risponde alla domanda: Chi? Che cosa?
Quando i sintagmi che completano la frase sono introdotti da una preposizione sono complementi indiretti.
Ogni complemento indiretto esprime diversi significati e fornisce un’informazione che contribuisce al senso della frase. Ad esempio può esprimere un’indicazione di tempo (Luca è arrivato in ritardo), di luogo (Piero è entrato in classe), di modo ( Anna parla in modo incomprensibile). Quando? Dove? In che modo? sono alcune prime domande che permettono di completare la frase e aiutano a esprimere il senso.
ESERCIZI DI COMBINAZIONE LOGICA
1. Trova il PREDICATO ponendo la domanda: “Che cosa si dice?”.
1. Lo scoiattolo si arrampica sull’albero.
2. La maestra scrive un testo al computer.
3. I bambini di quinta A guardano la lavagna.
4. Il cane morde l’osso.
5. L’osso è morso dal cane.
6. Navigano le navi a vele spiegate.
7. Oggi a catechismo abbiamo cantato.
8. Leggiamo un libro.
9. Abbiamo rotto un vaso.
10. Un vaso è stato rotto.
2. Trova il SOGGETTO ponendo la domanda: “Di chi/cosa si parla?” (prima cerca il predicato).
1. Chi vuole la pizza?
2. Il rosso è il mio colore preferito.
3. Lavorare stanca!
4. Arrivammo in ritardo.
5. Andrea e Giovanni hanno telefonato per salutarti.
6. Sullo scaffale ci sono i tuoi libri.
7. Le lucertole si scaldano al sole.
8. Dalla terrazza osserveremo il panorama.
9. Nevica!
10. Manca ancora una settimana alla fine dell’anno scolastico.
11. Questa estate ogni settimana la televisione ha ridato lo stesso film.
3. Riconosci i diversi sintagmi, cambiali mantenendo la stessa struttura della frase.
Esempi. La bidella \ ha pulito \ la classe \ con la scopa. Mia cugina \ ha rotto \ il vaso \ con un calcio.
1. Ogni giorno sbocciano nuovi fiori.
2. Il capitano ha incitato i giocatori con un discorso.
3. Gli alunni stanno preparando la Via Crucis per la Pasqua.
4. Raggiunsi la destinazione in tre ore.
4. «Il cacciatore uccise il cinghiale con un colpo preciso». Indica tra le frasi seguenti quella costruita con parole dello stesso tipo (es. verbo, articolo, ecc.) e disposte nello stesso ordine della frase sopra.
1. I pescatori catturavano i pesci con una rete logora.
2. La donna asciugò le sue lacrime con un fazzoletto candido.
3. I poliziotti inseguivano il ladro con la pistola in pugno.
4. Il treno arrivò in stazione con un leggero anticipo.
5. Dividi in sintagmi le seguenti frasi, sottolinea il soggetto e il predicato. Riscrivi poi solo la FRASE MINIMA.
1. Ieri sera la mamma ha cucinato un piatto di spaghetti alla carbonara.
2. Gli splendidi pesci argentati nuotano tra le alghe dell’acquario.
3. Nell’ora di punta le automobili strombazzano nella via affollata.
4. Sulla pista del gran premio d’Italia i bolidi sfrecciavano con grande fragore.
5. Questo pomeriggio giocherò a bambole a casa della mia amica.
6. La mamma ha comprato in una bancarella del mercato del pesce squisito.
6. Dividi in sintagmi. Sottolinea il PREDICATO e il suo SOGGETTO.
1. Questa sera andremo all’osservatorio astronomico di Brembate.
2. Ho bisogno di un favore da parte tua.
3. Vorrei restituire la bicicletta a Mario il prima possibile.
4. Il disco di Nebra è fatto di metallo.
5. Lunedì alle ore 17.00 inizieranno i tornei tra le classi.
6. La sera, al tramonto, il cielo assume spesso un colore rosso.
7. Un acquazzone improvviso interruppe l’intervallo della mattina.
8. L’anziano e malato Geppetto è stato portato sulle spalle da Pinocchio.
9. L’anno scorso Mario ha frequentato la quinta elementare con mio fratello.
10. Ogni giorno nel giardino della scuola giocano moltissimi alunni.
11. Quella verifica di grammatica fu difficile per me.
12. Nella partita di domenica hai sbagliato il primo calcio di rigore.
13. Da piccola mia mamma era uguale a me.
14. I tuoi amici sono stati sinceri con noi.
15. Quel bellissimo fiore nel vaso sul tavolo della cucina è una camelia.
16. Stanotte nel cielo stellato splendeva una meravigliosa luna piena.
17. Nell’acquario del salotto guizzano tanti pesci tropicali.
18. Domenica pomeriggio Laura ha visitato una meravigliosa mostra di pittura.
19. L’estate scorsa Elena ha attraversato l’Italia in treno con suo fratello.
20. Tutte le mattine nell’atrio della scuola passano molti bambini e si fermano con meraviglia davanti al presepe.
21. Durante questi giorni di vacanza ha svolto con cura i compiti assegnatogli.
22. Da giovane mio papà era simile a me.
23. I tuoi fratelli sono stati generosi con me.
24. Quello stupendo presepe nell’atrio della scuola è un’opera d’arte.
25. Stamattina nel cielo terso splendeva un tiepido sole invernale.
26. Nelle strade di Milano brilla un’esplosione di luci natalizie.
27. È arrivato il mio simpaticissimo cugino Alberto.
28. Ieri sera è scoppiato un fortissimo temporale.
29. Oggi sono arrivati in ritardo a scuola.
30. A questo penso io!
7. In quale delle seguenti frasi “fragole” ha funzione di soggetto?
1. Maria ha raccolto le fragole nel bosco.
2. Nel bosco sono nate le fragole.
3. Abbiamo mangiato le fragole con la panna.
4. Mi piace la marmellata di fragole.
8. Indica se la parola sottolineata è nome o verbo.
1. Mia madre dice sempre che ho un aspetto trasandato.
Aspetto mia sorella da un’ora.
2. Sogno spesso di volare.
Ho fatto un sogno bellissimo: volavo.
3. Ti porto a vedere la barca di mio zio.
La barca di mio zio è ormeggiata nel porto.
9. Costruisci una frase per ogni soggetto abbinando il predicato più adeguato.
SOGGETTO
PREDICATO
Il cane sono partiti
Paolo e il nonno sorride
I ciclisti sono fiorite
Le rose continuate
Laura abbaia
Voi pedalano
10. Sottolinea in blu il SINTAGMA DEL SOGGETTO e in rosso il SINTAGMA VERBALE (sopra scrivi se si tratta di un PREDICATO VERBALE o di UN PREDICATO NOMINALE).
1. La balena è un mammifero. La balena allatta i suoi piccoli.
2. L’abete è un sempreverde. L’abete vive sui monti.
3. Il Colosseo è a Roma. Molti turisti visitano il Colosseo.
4. La nebbia sembra un velo. La partita è finita.
11. Riconosci il PREDICATO NOMINALE e analizzalo.
1. Questo risultato è il massimo che potevi raggiungere.
2. Tuo fratello Guido è minore del mio.
3. Mio nonno era un uomo generoso.
4. Sono contenta del tuo lavoro.
5. Il tuo gelato è ultra buono.
6. La tua casa è migliore della mia.
7. Marco è un ottimo ragazzo.
8. Paola e Andrea sono i miei cugini.
9. Oggi siamo stanchi di scrivere.
10. La mia preparazione è inferiore alla tua.
Per ciascuno dei seguenti soggetti, inventa due frasi: una frase con un predicato verbale e una frase con il predicato nominale: il ragno, il fabbro, le mucche, la luna, gli alunni.
12. Qual è il PREDICATO VERBALE che puoi unire al soggetto “la cioccolata”?
a. È al latte. b. È molto amara. c. È stata mangiata. d. È fondente.
13. Sottolinea il PREDICATO in rosso, il SOGGETTO in blu e cerca il COMPLEMENTO OGGETTO.
1. Il melo nel prato ha molti frutti.
2. Voglio del miele di acacia nel latte.
3. Ti ho comprato quel braccialetto.
4. Caterina e Davide avevano raccolto delle castagne.
5. La nonna mi coccola sempre.
6. Qualcuno ha scarabocchiato quel foglio.
7. Desidero una bibita fresca.
8. Oggi abbiamo giocato a calcio in giardino.
9. In classe risuonavano le urla festose dei ragazzi.
10. Avevate mangiato una pizzetta e una mela.
11. Sabato pomeriggio noi mostreremo la recita alle nostre famiglie.
12. Lorenzo realizzò il suo sogno.
13. Anna ha chiesto il permesso alla mamma.
14. Lo zio Carlo mi accompagna a scuola ogni giorno.
15. Tutti i giorni Francesco e Lucia tornano a casa alle due.
14. Trova il PREDICATO, il SOGGETTO e il COMPLEMENTO OGGETTO.
Poi trasforma le seguenti frasi attive nella forma passiva.
1. Il sole ha prosciugato il laghetto.
2. Il papà ha preparato la torta.
3. La bambina ha rotto la bambola.
4. Il gatto rincorre il canarino.
5. La maestra ha letto una fiaba.
6. Irene lancia la palla.
7. Il sindaco ha incontrato gli alunni.
8. La nonna raccoglie le mele.
9. La zia ha acquistato le patatine.
10. Il vigile ha fermato un automobilista.
15. Trova il PREDICATO, il SOGGETTO e il COMPLEMENTO D’AGENTE. Poi trasforma le seguenti frasi passive nella forma attiva.
1. La siepe del giardino è stata potata dal nonno.
2. Il vetro della finestra è stato rotto da Luca.
3. L’albero è stato colpito da un fulmine.
4. Questa statua fu realizzata da Davide.
5. I muri sono stati tinteggiati dal papà.
6. I panni stesi sono stati bagnati dalla pioggia.
7. La caduta del muro è stata causata dal terremoto.
8. La spesa è stata fatta da Elena e dalla mamma.
9. Il film non è stato registrato dal papà.
16. Amplia le seguenti frasi minime aggiungendo informazioni (aiutati con le domande).
1. Lorenzo ha raccolto una moneta.
2. Mi sono lavata.
3. I bambini hanno rovesciato una bottiglia.
4. L’America è stata scoperta.
5. Il papà punì suo figlio.
6. Giovanni e Roberto hanno imparato.
7. Anna corre.
8. Sventolano le bandiere.
9. Gli etruschi commerciavano.
10. Romolo e Remo fondarono.
17. Indica quali delle seguenti espressioni sono già frasi complete e corrette e quali hanno bisogno di essere completate.
Poi aggiungi l’elemento indispensabile.
1. Il fratello di Marco ritaglia dai giornali.
2. La mamma mise.
3. Il gatto dorme.
4. Il bambino piange.
5. Giovanni abitava.
6. Che avete meritato.
18. Sottolinea il PREDICATO in rosso, il SOGGETTO in blu e individua i complementi che conosci (aiutati con le domande).
1. Lucia legge alcune pagine ogni sera di un libro di avventura.
2. L’albero fiorito è una magnolia nel giardino del mio condominio.
3. Guarda l’albero fiorito improvvisamente negli ultimi giorni.
4. Prendimi quel cappello!
5. Domani giocare sarà divertente.
6. Andate subito in classe, ai vostri posti!
7. Siamo andati presto al cinema con il papà.
8. Anna ascolta sempre i consigli della mamma.
9. I consigli della mamma aiutano Anna nello studio.
10. Con i consigli della mamma Anna è più sicura.
11. Il mio cane ha rincorso il tuo per tutto il pomeriggio.
12. I Romani sconfissero la flotta cartaginese nella battaglia navale presso le isole Egadi.
13. Il vento di ieri ha spogliato gli alberi del giardino in un baleno.
14. Il lago durante l’estate è stato prosciugato dal sole.
15. Sabato Elena e la zia hanno fatto la spesa al supermercato di Novara.
TABELLE DEI VERBI
IL VERBO ESSERE
MODO INDICATIVO
Presente
Passato prossimo
Presente
MODO CONGIUNTIVO
Passato
io sono io sono stato che io sia che io sia stato tu sei tu sei stato che tu sia che tu sia stato egli è egli è stato che egli sia che egli sia stato noi siamo noi siamo stati che noi siamo che noi siamo stati voi siete voi siete stati che voi siate che voi siate stati essi sono essi sono stati che essi siano che essi siano stati
Imperfetto
Trapassato prossimo
Imperfetto
Trapassato io ero io ero stato che io fossi che io fossi stato tu eri tu eri stato che tu fossi che tu fossi stato egli era egli era stato che egli fosse che egli fosse stato noi eravamo noi eravamo stati che noi fossimo che noi fossimo stati voi eravate voi eravate stati che voi foste che voi foste stati essi erano essi erano stati che essi fossero che essi fossero stati
Passato remoto Trapassato remoto
MODO CONDIZIONALE io fui io fui stato
Presente
Passato tu fosti tu fosti stato io sarei io sarei stato egli fu egli fu stato tu saresti tu saresti stato noi fummo noi fummo stati egli sarebbe egli sarebbe stato voi foste voi foste stati noi saremmo noi saremmo stati essi furono essi furono stati voi sareste voi sareste stati essi sarebbero essi sarebbero stati Futuro semplice Futuro anteriore io sarò io sarò stato tu sarai tu sarai stato
MODO IMPERATIVO egli sarà egli sarà stato Presente noi saremo noi saremo stati tu sii voi sarete voi sarete stati noi siamo essi saranno essi saranno stati voi siate
MODO INFINITO
Presente Passato
MODO PARTICIPIO
Presente Passato
MODO GERUNDIO
Presente Passato essere essere stato ente stato essendo essendo stato
IL VERBO AVERE
MODO INDICATIVO
Presente Passato prossimo Presente
MODO CONGIUNTIVO
Passato io ho io ho avuto che io abbia che io abbia avuto tu hai tu hai avuto che tu abbia che tu abbia avuto egli ha egli ha avuto che egli abbia che egli abbia avuto noi abbiamo noi abbiamo avuto che noi abbiamo che noi abbiamo avuto voi avete voi avete avuto che voi abbiate che voi abbiate avuto essi hanno essi hanno avuto che essi abbiano che essi abbiano avuto
Imperfetto
Trapassato prossimo
Imperfetto
Trapassato io avevo io avevo avuto che io avessi che io avessi avuto tu avevi tu avevi avuto che tu avessi che tu avessi avuto egli aveva egli aveva avuto che egli avesse che egli avesse avuto noi avevamo noi avevamo avuto che noi avessimo che noi avessimo avuto voi avevate voi avevate avuto che voi aveste che voi aveste avuto essi avevano essi avevano avuto che essi avessero che essi avessero avuto
Passato remoto
Trapassato remoto
MODO CONDIZIONALE io ebbi io ebbi avuto Presente Passato tu avesti tu avesti avuto io avrei io avrei avuto egli ebbe egli ebbe avuto tu avresti tu avresti avuto noi avemmo noi avemmo avuto egli avrebbe egli avrebbe avuto voi aveste voi aveste avuto noi avremmo noi avremmo avuto essi ebbero essi ebbero avuto voi avreste voi avreste avuto essi avrebbero essi avrebbero avuto Futuro semplice Futuro anteriore io avrò io avrò avuto tu avrai tu avrai avuto
MODO IMPERATIVO egli avrà egli avrà avuto Presente noi avremo noi avremo avuto tu abbi voi avrete voi avrete avuto noi abbiamo essi avranno essi avranno avuto voi abbiate
MODO INFINITO
MODO PARTICIPIO
MODO GERUNDIO
Presente Passato Presente Passato Presente Passato avere avere avuto avente avuto avendo avendo avuto
IL VERBO LAVORARE
MODO INDICATIVO
MODO CONGIUNTIVO
Presente Passato prossimo Presente Passato io lavoro io ho lavorato che io lavori che io abbia lavorato tu lavori tu hai lavorato che tu lavori che tu abbia lavorato egli lavora egli ha lavorato che egli lavori che egli abbia lavorato noi lavoriamo noi abbiamo lavorato che noi lavoriamo che noi abbiamo lavorato voi lavorate voi avete lavorato che voi lavoriate che voi abbiate lavorato essi lavorano essi hanno lavorato che essi lavorino che essi abbiano lavorato
Imperfetto Trapassato prossimo Imperfetto Trapassato io lavoravo io avevo lavorato che io lavorassi che io avessi lavorato tu lavoravi tu avevi lavorato che tu lavorassi che tu avessi lavorato egli lavorava egli aveva lavorato che egli lavorasse che egli avesse lavorato noi lavoravamo noi avevamo lavorato che noi lavorassimo che noi avessimo lavorato voi lavoravate voi avevate lavorato che voi lavoraste che voi aveste lavorato essi lavoravano essi avevano lavorato che essi lavorassero che essi avessero lavorato
Passato remoto Trapassato remoto
MODO CONDIZIONALE io lavorai io ebbi lavorato Presente Passato tu lavorasti tu avesti lavorato io lavorerei io avrei lavorato egli lavorò egli ebbe lavorato tu lavoreresti tu avresti lavorato noi lavorammo noi avemmo lavorato egli lavorerebbe egli avrebbe lavorato voi lavoraste voi aveste lavorato noi lavoreremmo noi avremmo lavorato essi lavorarono essi ebbero lavorato voi lavorereste voi avreste lavorato essi lavorerebbero essi avrebbero lavorato Futuro semplice Futuro anteriore io lavorerò io avrò lavorato tu lavorerai tu avrai lavorato
MODO IMPERATIVO egli lavorerà egli avrà lavorato Presente noi lavoreremo noi avremo lavorato tu lavora voi lavorerete voi avrete lavorato noi lavoriamo essi lavoreranno essi avranno lavorato voi lavorate
MODO INFINITO
Presente Passato
MODO PARTICIPIO
Presente Passato
MODO GERUNDIO
Presente Passato lavorare avere lavorato lavorante lavorato lavorando avendo lavorato
IL VERBO TEMERE
MODO INDICATIVO
MODO CONGIUNTIVO
Presente Passato prossimo Presente Passato io temo io ho temuto che io tema che io abbia temuto tu temi tu hai temuto che tu tema che tu abbia temuto egli teme egli ha temuto che egli tema che egli abbia temuto noi temiamo noi abbiamo temuto che noi temiamo che noi abbiamo temuto voi temete voi avete temuto che voi temiate che voi abbiate temuto essi temono essi hanno temuto che essi temano che essi abbiano temuto
Imperfetto Trapassato prossimo Imperfetto Trapassato io temevo io avevo temuto che io temessi che io avessi temuto tu temevi tu avevi temuto che tu temessi che tu avessi temuto egli temava egli aveva temuto che egli temesse che egli avesse temuto noi temevamo noi avevamo temuto che noi temessimo che noi avessimo temuto voi temevate voi avevate temuto che voi temeste che voi aveste temuto essi temevano essi avevano temuto che essi temessero che essi avessero temuto
Passato remoto Trapassato remoto
MODO CONDIZIONALE io temei io ebbi temuto Presente Passato tu temesti tu avesti temuto io temerei io avrei temuto egli temé (temette) egli ebbe temuto tu temeresti tu avresti temuto noi tememmo noi avemmo temuto egli temerebbe egli avrebbe temuto voi temeste voi aveste temuto noi temeremmo noi avremmo temuto essi temerono essi ebbero temuto voi temereste voi avreste temuto essi temerebbero essi avrebbero temuto Futuro semplice Futuro anteriore io temerò io avrò temuto tu temerai tu avrai temuto
MODO IMPERATIVO egli temerà egli avrà temuto Presente noi temeremo noi avremo temuto tu temi voi temerete voi avrete temuto noi temiamo essi temeranno essi avranno temuto voi temete
MODO INFINITO
Presente Passato
MODO PARTICIPIO
MODO GERUNDIO
Presente Passato Presente Passato temere avere temuto temente temuto temendo avendo temuto
IL VERBO PARTIRE
MODO INDICATIVO
Presente Passato prossimo
Presente
MODO CONGIUNTIVO
Passato io parto io sono partito che io parta che io sia partito tu parti tu sei partito che tu parta che tu sia partito egli parte egli è partito che egli parta che egli sia partito noi partiamo noi siamo partiti che noi partiamo che noi siamo partiti voi partite voi siete partiti che voi partiate che voi siate partiti essi partono essi sono partiti che essi partano che essi siano partiti
Imperfetto
Trapassato prossimo
Imperfetto
Trapassato io partivo io ero partito che io partissi che io fossi partito tu partivi tu eri partito che tu partissi che tu fossi partito egli partiva egli era partito che egli partisse che egli fosse partito noi partivamo noi eravamo partiti che noi partissimo che noi fossimo partiti voi partivate voi eravate partiti che voi partiste che voi foste partiti essi partivano essi erano partiti che essi partissero che essi fossero partiti
Passato remoto Trapassato remoto
MODO CONDIZIONALE io partii io fui partito
Presente
Passato tu partisti tu fosti partito io partirei io sarei partito egli partì egli fu partito tu partiresti tu saresti partito noi partimmo noi fummo partiti egli partirebbe egli sarebbe partito voi partiste voi foste partiti noi partiremmo noi saremmo partiti essi partitono essi furono partiti voi partireste voi sareste partiti essi partirebbero essi sarebbero partiti Futuro semplice Futuro anteriore io partirò io sarò partito tu partirai tu sarai partito
MODO IMPERATIVO egli partirà egli sarà partito
Presente noi partiremo noi saremo partiti tu parti voi partirete voi sarete partiti noi partiamo essi partiranno essi saranno partiti voi partite
MODO INFINITO
Presente Passato
MODO PARTICIPIO
Presente Passato
MODO GERUNDIO
Presente Passato partire essere partito partente partito partendo essendo partito
Se vuoi costruire una nave, non radunare uomini solo per raccogliere il legno e distribuire i compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e infinito.
Antoine de SAint-exupéry
ALLA SCOPERTA DEL MONDO
PERCORSO PER LA SCUOLA PRIMARIA



1 Fieri di saper leggere, scrivere, contare
2 Il ritmo delle stagioni
3 Leggere è incontrare
4 Occhi aperti Sussidiario dei linguaggi
4 Sussidiario delle discipline
5 La lettura, che avventura! Sussidiario dei linguaggi
5 Sussidiario delle discipline































