





Partner: Luiss Data Lab, RAI, TIM, Ansa, T6 Ecosystems, ZetaLuiss, NewsGuard, Pagella Politica, Harvard Kennedy School, ministero degli Esteri, Alliance of Democracies Foundation, Corriere della Sera, Reporters Sans Frontières, MediaFutures, European Digital Media Observatory, The European House Ambrosetti, Catchy, CY4GATE, ministero dell’Istruzione e del Merito




Cover Story
«Vedo il mio Paese che brucia»
di Paolina Palmisciano e Antonia Verderosa
«Orgogliosi di questa gioventù»
di Andrea De Luca Italia
Photogallery, l’Iran si ribella di Marco Chiaradonna e Valerio Forte
Venezuela
«Grazie, Trump», la diaspora si fa sentire di Salvatrice D’Anna Campo
Da Caracas, voci che non tacciono di Salvatrice D’Anna Campo
Da Miami a Doralzuela di Andrea Charur
La Conferenza dei vescovi: prudenza di Vincenzo Lilli e João Kerr Bidetti
Europa
«Erasmus vuol dire scambio» di Paolina Palmisciano
Biologia marina in undici atenei di Lavinia Ceci
I piccoli alla scoperta dell’Europa di Antonia Verderosa
Esteri
A Gaza la guerra diventa musica di Andrea De Luca Italia
I versi per riscoprire la vita di Camilla Stacchiotti
«Non potevo restare a guardare» di Silvia Sisto
«Finché non c’è un corpo, una madre spera» di Maria Giulia Giordanelli
La Polizia speciale di Rio de Janeiro di Costanza Saporito
Tra guerra, fake news e satellitari di Lorenzo Gironacci
Social media
I giovani che danno voce ai politici di Valerio Forte
Il potere dei meme di Davide Bertusi
Ferschetty, viaggio nel mondo dei colori di Giovanni Denti
Dalla Rete allo scaffale di Alessandro Marchiello
AI & Tech
Un vaccino contro i deep fake di Michelangelo Mecchia
Se l’IA entra in tribunale di Sofia Vegezzi
Il benchmark misura quanto siamo utili di Gianluca Brazzioli
Droni, navi e dati aperti di Gianmaria Oroni
Società
Così l’Italia rinasce dalla memoria di Desirée Palombelli
Dai gommoni alle fabbriche di Andrea Carbotti
Fuori dal branco di Matilde Risi
Aborto sicuro, un’opportunità dall’Europa di Alice Pavarotti
Se la crescita della donna spaventa l’uomo di Annavera Scandone
Dalla cameretta al mondo di Ludovico Falzone
Il mistero dell’esorcista di Bianca Bettacci
Roma
La sfida difficile dei migranti LGBTQ+ di Joe Toolan
È texano il futuro degli ex Mercati Generali di Dylan Browne-Wilkinson
Un grande anello per i ciclisti di Elin Kaasa
Condividere l’energia di Tommaso Provera Cultura
La nuova Black British music di Luca Galati
Alla ricerca dei dischi perduti di Marco Chiaradonna
Photogallery, Il restauro che fa ballare di Marco Chiaradonna
La narrazione dell’ugly hot man di Paola Del Prete e Sabrina Fasano
L’amore che lo sport non vuole vedere di Federico D’Onofrio
Sport
Senza di loro non c’è partita di Pietro Morolli
Calcio, uno spazio per riscoprirsi di Chiara Servino
Recensioni a cura di Autori vari Zeta risponde a cura di Andrea Carbotti
Zetazodiaco a cura di Sabrina Fasano
Periodico della Scuola di Giornalismo e Comunicazione multimediale
Università Luiss Guido Carli Numero 27 Gennaio 2026

Le frontiere del nostro tempo sono luoghi di separazione e di incontro, di difesa e di contesa. Sono passaggi controllati, violati e attraversati, talvolta nello stesso istante. Osservarle da vicino significa interrogarsi su come viviamo lo spazio, il potere, i diritti.
Negli ultimi mesi abbiamo visto queste tensioni manifestarsi in forme radicali. In Iran, il controllo si è fatto muro invalicabile. In Venezuela, la sovranità è diventata uno spazio fragile, compressa tra autoritarismo e ingerenze esterne. Lo stesso avviene in conflitti che segnano il nostro tempo, come in Ucraina o in guerre che restano ai margini dell’attenzione pubblica, come in Sudan. A Gaza, il confine è una condizione quotidiana: regola accessi, spostamenti, futuro.
In questi casi, la frontiera è un dispositivo che interrompe relazioni, riduce lo spazio del possibile, stabilisce chi può muoversi e chi resta fermo. Accanto a queste chiusure nette, esistono soglie meno visibili. Quelle che attraversiamo ogni giorno e che ridefi-
ZETA
Periodico della Scuola
Superiore di Giornalismo
“Massimo Baldini” supplemento
Direttore responsabile
Gianni Riotta
Condirettori
Giorgio Casadio
Alberto Flores d’Arcais
Supervisione
Giorgio Casadio
niscono il modo in cui agiamo, comunichiamo, costruiamo fiducia. L’intelligenza artificiale è ormai parte di queste infrastrutture invisibili: un ambiente che media ciò che vediamo, ciò che riteniamo credibile, ciò che resta ai margini. In questo spazio si giocano nuove decisioni, spesso opache, che incidono sul potere, sull’accesso alle informazioni, sulla possibilità di orientarsi nel presente.
Altre frontiere funzionano come varchi. Programmi come l’Erasmus hanno insegnato a generazioni diverse che muoversi significa cambiare sguardo prima ancora che indirizzo. Il ritorno del Regno Unito nel circuito di scambio europeo riapre collaborazioni, dialogo, immaginari comuni.
Queste pagine guardano anche altrove per capire come cambiano linguaggi, pratiche, modi di stare insieme. Il primo numero di Zeta del Biennio 2025/2027 nasce da qui. Dalla volontà di abitare queste soglie, di riconoscere le tensioni che attraversano il nostro tempo, di raccontare il presente nella sua complessità.
Redazione Viale Pola, 12 – 00198 Roma
Stampa Centro riproduzione dell’Università
Contatti
0685225358 giornalismo@luiss.it
a cura di Paolina Palmisciano
La guerra di Piero
Ed arrivasti a varcar la frontiera
In un bel giorno di primavera E mentre marciavi con l'anima in spalle
Vedesti un uomo in fondo alla valle
Che aveva il tuo stesso identico umore
Ma la divisa di un altro colore
Fabrizio De André (1966)
Confine
Confine diceva il cartello cercai la dogana, non c’era non vidi dietro il cancello ombra di terra straniera
Giorgio Caproni (1975)

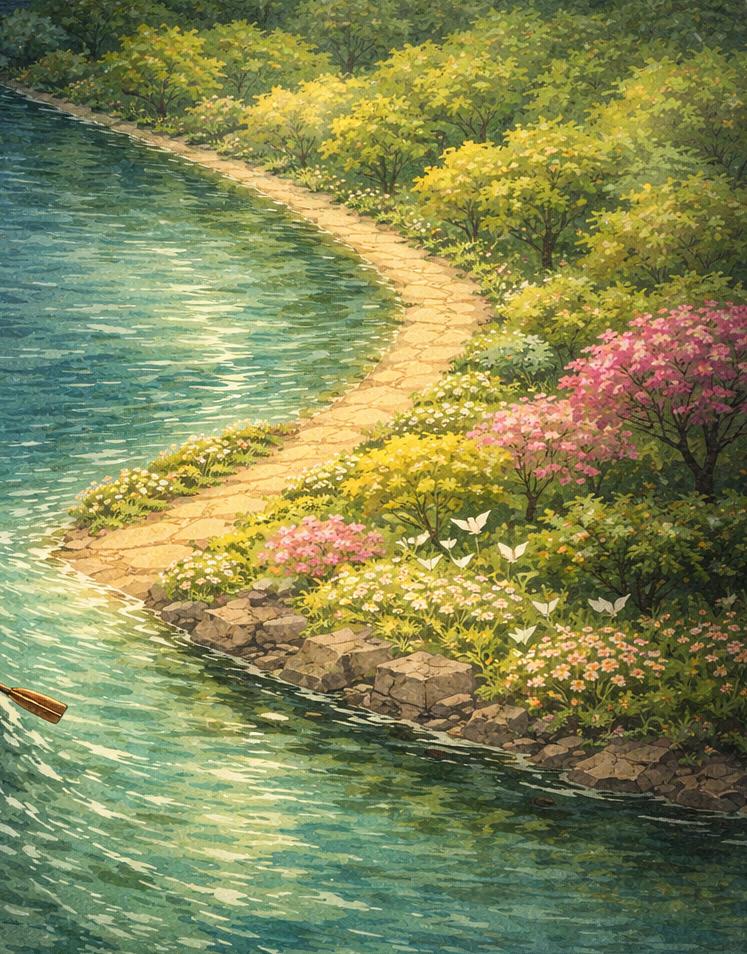
(dal provenz. ant. frontiera, der. del lat. frons frontis «fronte») a. Linea di confine, soprattutto in quanto ufficialmente delimitata e riconosciuta e dotata, in più casi, di sistemi difensivi
b. Nella storiografia americana, il termine indicava una regione scarsamente e recentemente colonizzata
c. Linea che separa situazioni o concezioni differenti, e che in alcuni casi è intesa come confine fisso, invalicabile, in altri come confine che può essere spostato e modificato
Tra repressione violenta, blackout delle comunicazioni e proteste, l’Iran attraversa una fase di rottura profonda. Un’analisi delle fratture del regime, delle debolezze dell’opposizione e dei possibili scenari futuri
Il fumo sale denso dalle carcasse delle auto incendiate, annerisce il cielo sopra Teheran e rende l’aria irrespirabile. A terra restano bossoli, vetri rotti, scarpe perse nella fuga. I manifestanti continuano a marciare tra i colpi, mentre corpi senza vita vengono trascinati via e lasciano macchie scure sull’asfalto. Sono le immagini circolate online prima del blackout digitale imposto l’8 gennaio 2026 dalla Repubblica islamica dell’Iran. «È un bagno di sangue», dice Arash Azizi, giornalista del mensile The Atlantic e ricercatore iraniano residente negli Stati Uniti. «Migliaia di persone sono state uccise e ho paura che la situazione peggiori ancora». La sua voce è venata dalla tensione di chi guarda il proprio paese bruciare da lontano.
Il silenzio digitale si affianca alla violenza nelle strade. «La mia famiglia è in Iran», racconta Azizi a Zeta: «Come molti iraniani all’estero, non ho avuto modo di mettermi in contatto con loro per una settimana. Quando siamo riusciti a parlare è stato per brevi telefonate, per sapere che erano vivi e stavano bene». Le comunicazioni restano frammentarie, intermittenti, sempre a rischio di interruzione.
Le proteste iniziate il 28 dicembre 2025 hanno segnato una nuova fase di scontro aperto in Iran. La crisi economica, l’isolamento internazionale, la repressione sempre più violenta hanno fatto esplodere una rabbia che covava da anni. «Lo status quo è semplicemente insostenibile», spiega Azizi: «Lo è sul piano materiale perché le persone non riescono più a far fronte ai costi della vita, ma lo è anche perché il regime non è in grado di offrire alcuna prospettiva al popolo iraniano». La Repubblica islamica, nata nel 1979 a seguito della cacciata dello scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi, è incapace di rispondere ai bisogni di una società giovane, istruita e distante dall’ideologia del regime.
«Questa frattura non è nuova», spiega Azizi, mentre ripercorre le proteste che da oltre vent’anni scuotono il paese. Dal movimento studentesco del 1999 alle manifestazioni del 2009, fino alle ondate del 2017, 2019 e 2022. La società iraniana ha continuato a sfidare un potere che il giornalista non esita a definire «profondamente antidemocratico, dove l’80% del potere è concentrato nelle mani di un solo uomo». Il riferimento è all’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran

al potere dal 1989. «Ci sono intere generazioni che hanno conosciuto un solo leader, che esercita un potere assoluto e teocratico per mezzo di una costituzione folle», riflette Azizi con amarezza, «un modello che ricorda il re-filosofo della Repubblica di Platone».
«Il problema è che si tratta di una rivolta spontanea, nata dal rifiuto di un ordine che non funziona, ma che proprio per questo resta frammentata». Sono proteste a cui manca una leadership riconoscibile in grado di offrire una proposta politica strutturata e alternativa. Un passo importante è stato il movimento “Donna, vita, libertà”, nato nel 2022 dopo la morte della 22enne curda Masha Amini, arrestata per aver indossato lo hijab in modo ritenuto improprio. «Le persone hanno cominciato a sognare una vita diversa, un Iran libero e progressista. Una visione che, però, è rimasta sospesa: non è riuscita a tradursi in un progetto politico capace di sostenerla e darle continuità».
Nella Repubblica islamica dell’Iran la vita quotidiana è sottoposta a un controllo capillare e il regime esamina ogni aspetto dell’esistenza: «Una canzone vietata, un libro proibito, un sito web non autorizzato, un abito ritenuto inadeguato: tutto rischia di diventare un crimine». Un rigido scrutinio «paragonabile solo al regime dei Talebani in Afghanistan» che gli iraniani non tollerano più. Dal conflitto armato scoppiato a giugno con Israele la credibilità dell’ayatollah si è incrinata: «Per decenni il regime ha giustificato l’esercizio di un potere così pervasivo con la necessità di proteggere i cittadini da minacce straniere, ma dalla guerra dei 12 giorni questa motivazione non regge più e Khamenei non sembra più intoccabile».

Tra chi sventola bandiere con il sole e il leone dell’antica Persia, qualcuno inneggia a Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià. «Molti lo sostengono perché è l’unico nome che conoscono», osserva Azizi, riflettendo sulle diverse anime che compongono le proteste: «Ma tanti suoi sostenitori odiano lo slogan “Donna, vita, libertà” e le sue implicazioni». La conseguenza è un vuoto politico difficile da colmare: «Gli iraniani hanno bisogno che gli oppositori al regime si uniscano e formino un’ampia coalizione che sia in grado di rappresentare i loro interessi».
Una trasformazione che secondo il giornalista può arrivare dai vertici del potere: «Non escludo una svolta dall’interno, magari con un colpo di stato e lo smantellamento graduale di alcune strutture chiave, mantenendo in vita parte del potere».
Il futuro più probabile delineato da Azizi per il Paese ricorda la recente parabola venezuelana: dopo la cattura del dittatore Nicolás Maduro il potere non è passato all’opposizione democratica guidata da María Corina Machado, ma a Delcy Rodríguez, vice del leader chavista e figura di continuità dell’apparato di governo.
«In Iran potrebbe avvenire qualcosa di simile», afferma il ricercatore, che non esclude un intervento statunitense: «Un attacco militare degli Usa o d’Israele non è impossibile, ma è molto difficile che riescano ad arrestare o uccidere Khamenei. Si nasconderebbe nella regione sudorientale del paese, dove diventerebbe impossibile da rintracciare. È anche un problema di intelligence». La voce di Arash Azizi è tesa, mentre dagli Usa ripensa alla patria e agli affetti lontani: «Il mio sogno è fare ritorno in un Iran più libero e forse, un giorno, di vivere tra i due

paesi». Si definisce «un internazionalista», ha vissuto in Canada, Germania, Malesia e Messico ma nessuna distanza ha reciso il legame con il luogo d’origine: «Mi sento a casa dappertutto, ma in Iran sono nato, occupa un posto speciale nel mio cuore». È in questo spazio sospeso tra distanza e appartenenza, che oggi si gioca il futuro dell’Iran: nelle strade invase dal fumo, nei silenzi digitali imposti dal regime, nella determinazione di una società che, osserva Azizi, «continua a bussare alle porte della storia, cercando di cambiare il proprio destino».

Conversazione con un padre e un figlio iraniani rifugiati in Italia. Il punto di vista di due differenti generazioni sulle rivolte popolari contro il regime di Khamenei
di Andrea De Luca Italia
Arman, nome di fantasia, ha la voce gentile per essere un nemico di Dio. Un mohareb. In Iran, il Paese dov’è nato senza esserci mai vissuto, lo condannerebbero così per la sua voglia di essere libero. La stessa che avevano Rubina Aminian, Yasin Mirzai e tutti i suoi coetanei ventenni assassinati dal regime di Teheran nelle proteste di piazza del gennaio 2025. La stessa che negli anni ’90 ha spinto suo padre Farid, nome di fantasia, a fuggire «da un inferno senza futuro», prima di trovare asilo in Italia.
«È difficile spiegare quello che ho visto, quello che ho vissuto, a chi è nato in Occidente: svegliarsi nel terrore di non poter formulare un pensiero», racconta Farid. «Non c’era futuro per i giovani in Iran allora e non c’è neanche oggi. Non ne faccio un discorso solo di diritti, ma anche economico, il popolo si è dovuto abituare alla miseria a cui l’ha ridotto una classe dirigente avida. Come potrebbe stupirmi vedere le immagini delle moschee in fiamme, sapendo l’odio che la Repubblica Islamica si è tirata addosso in tutti questi anni? Era l’unica conseguenza possibile».
«Non è la prima volta che le persone scendono in piazza per provare a riprendersi l’Iran. Penso alle manifestazioni del 2019 scoppiate per l’aumento del prezzo della benzina o a quelle del 2022, in risposta all’omicidio di Mahsa Amini». Mentre nomina Amini, altra voce di questa Generazione Z spenta dal regime, morta a vent’anni nelle carceri del Basīj, la polizia religiosa, dopo aver violato la legge sull’obbligo del velo, lo sguardo del padre incrocia quello del figlio.
«Soffro. Mi fa stare male il pensiero che ci sia voluto così tanto tempo per arrivare a una consapevolezza così estesa», dice Arman. «Ma al tempo stesso sono davvero orgoglioso, sono felice di vedere che sono i giovani a provare a cambiare un Paese che per lungo tempo ho smesso di sentire mio, a causa di quello che ha riservato alla mia famiglia. Dalle generazioni precedenti non mi aspettavo molto: chi ha contribuito alla Rivoluzione Islamica del 1979 di sicuro non ha cambiato idea oggi. Non potevano che essere le vittime di quel sistema a volere una svolta».
«Il vero problema, secondo me, è stato quello di non essere riusciti a trovare una guida che convogliasse su di sé lo spirito delle proteste degli ultimi anni. Sono rimasti episodi senza una struttura». Farid annuisce. È l’unico dei due ad avere un ricordo dell’ultimo leader laico in Iran, lo scià Mohammad Reza Pahlavi, padre di quel Reza che dal suo esilio statunitense si candida in


maniera sempre più forte a raccogliere l’eventuale eredità dell’ayatollah Khamenei. «È vero che il popolo è stato abbandonato – replica – ma non sono sicuro che il ritorno dello scià sia la soluzione ai problemi dell’Iran. La gente tende a dimenticare. Anche prima del 1979 il Paese aveva seri problemi: penso alle minoranze nel Kurdistan o nell’Azerbaigian persiano e al trattamento repressivo che è stato riservato loro. Ho anche il timore che dietro un’operazione così ben studiata si possa nascondere l’interesse degli Stati Uniti».
E anche quando Arman prova a ricordargli che «la gente di Teheran avrebbe dei motivi validi per accettare un male minore», Farid non ha dubbi. «Trump non ha attaccato il Venezuela per porre fine a una dittatura. Ha attaccato il Venezuela per il suo petrolio. L’Iran è il terzo Stato per riserve petrolifere al mondo. Temo che le bombe non tarderanno a cadere su Teheran. Penso alla Libia, alla Siria. Ho paura che il Paese scivoli in una guerra civile da cui sarà difficile riprendersi».
«Perch’i’ no spero di tornar giammai». Poiché io non credo che farò più ritorno. C’è questo verso del poeta duecentesco Guido Cavalcanti nella pausa infinita che Farid fa dopo aver pronunciato l’ultima frase. L’angoscia di chi vorrebbe tornare, ma sa che non potrà farlo. «Ogni volta che ascolto le note di una musica persiana, piango», riesce ad aggiungere. «C’è qualcosa nelle radici che non si può cancellare. Per quanto un luogo che chiami casa può averti fatto male, rimane pur sempre casa».
«Ogni volta che penso alle storie di mio padre sulla sua adolescenza, a mio nonno sulla soglia del suo negozio a Teheran… anche se non ho mai visto niente di tutto questo con i miei occhi, non per scelta mia ma di chi avrebbe voluto impormi idee in cui non potrò mai identificarmi, so che una parte di me è lì», è il controcanto di Arman.
«E anche se ora la paura è grande, per le possibili ripercussioni di un regime che non è ancora caduto o per lo scoppio di una crisi senza ritorno, ho ancora un po’ di speranza che la prima volta in cui vedrò l’Iran, sarà un Iran libero».
«Sono davvero orgoglioso, sono felice di vedere che sono i giovani a provare a cambiare un Paese che per lungo tempo ho smesso di sentire mio»
Alcune delle poche foto scattate a Teheran durante le proteste successive al blocco di internet da parte del regime: scritte che inneggiano al ritorno del principe Reza Pahlavi, una manifestante che innalza la sua foto, una moschea in fiamme, manifestanti che occupano le strade a cura di Marco Chiaradonna e Valerio Forte











L'arresto di un leader di lunga data ha scatenato emozioni contrastanti all'estero e all'interno del Paese, mettendo in luce divisioni sul coinvolgimento militare
«È molto difficile descrivere lo stato d’animo generale. C’è grande gioia espressa intensamente dalla diaspora venezuelana in tutto il mondo, mentre all’interno del Venezuela stesso l’umore è molto più contenuto e cauto», afferma Tomás Páez, sociologo venezuelano e direttore dell’«Osservatorio della diaspora venezuelana», spiegando i sentimenti complessi nei confronti dell’operazione militare statunitense del 3 gennaio 2026, che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro.
L’escalation statunitense in Venezuela è iniziata nell’agosto 2025 con il dispiegamento di una task force navale nei Caraibi meridionali nell’operazione Southern Spear, presentata dal Presidente Donald Trump come una campagna antidroga. Dopo una serie di attacchi aerei contro navi vicino alle acque venezuelane, un rapido raid ha portato alla cattura di Maduro e della moglie, trasferiti a New York con accuse di narcotraffico.
Páez, attualmente residente in Spagna, ha osservato come i venezuelani di tutto il mondo si siano riuniti nelle strade per festeggiare collettivamente la rimozione di Maduro, cantando «Venezuela libre» («Venezuela libero»). Sono circa 8 milioni i venezuelani che hanno lasciato il Paese. Nonostante l’euforia iniziale, Páez non crede che ciò si tradurrà in un’inversione significativa dei modelli migratori. «L’80% della diaspora venezuelana ha costantemente affermato che non tornerà in Vene-
zuela. Sono passati ventisette anni e molti di coloro che sono arrivati come genitori sono ora nonni; molti di coloro che sono arrivati single ora hanno figli. Non è facile invertire questa tendenza».
Sebbene molti abbiano gioito, vestiti di rosso, blu e giallo, cantando e applaudendo, e persino esclamando «grazie, Trump», è emersa una significativa divisione tra i venezuelani all’estero e quelli all’interno del Paese riguardo all’intervento degli Stati Uniti. A Caracas sono scoppiate proteste quando migliaia di persone hanno marciato contro l’intervento straniero, cantando «Maduro aguanta, el pueblo se levanta» («Maduro, resisti, il popolo si sta ribellando») e «tú a mi país no lo vas a intervenir» («non interverrai nel mio Paese»).
Páez ha sostenuto che «il governo non ha alcun sostegno e qualsiasi mobilitazione ufficiale è stata ottenuta costringendo la popolazione. Naturalmente, alcuni sono convinti e sostengono il governo, ma sono, ripeto, una minoranza assoluta».
Che l’opinione pubblica fosse divisa si rifletteva nei dati dei sondaggi. Secondo AtlasIntel il 64% dei venezuelani all’estero sosteneva l’azione militare degli Stati Uniti contro Maduro, rispetto al 34% dei venezuelani all’interno del Paese. Indipendentemente dal fatto che i venezuelani residenti nel Paese approvassero in generale il governo, il sondaggio mostrava solo un sostegno minimo all’intervento straniero come linea d’azione praticabile.
Páez ha poi sottolineato che la legge statunitense richiede l’approvazione del Congresso, spiegando come tale vincolo possa essere aggirato qualificando l’operazione come "un’estrazione giudiziaria". Ha anche definito «inappropriati» i commenti di Trump riguardo al presunto controllo statunitense sulle riserve petrolifere del Venezuela.
Mentre molti nella diaspora hanno espresso la volontà di scambiare il petrolio con la libertà, altri che sono rimasti nel Paese, in particolare quelli che sono scesi in piazza per protestare, hanno ribadito con forza la loro rivendicazione sulle risorse naturali del Venezuela e hanno rifiutato l’intervento straniero come prezzo del cambiamento politico.

1. Venezuelani a Buenos Aires, in Argentina, che celebrano la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro il 3 gennaio 2026, tenendo un cartello con scritto ‘Llego el día, Venezuela Libre’ (in italiano: «È arrivato il giorno, Venezuela libera»)
2. Tomás Páez; sociologo e direttore dell'”Osservatorio della diaspora venezuelana"; foto crediti a "Casa de America" 2
Le reti comunitarie si sono mobilitate per proteggere i cittadini, mostrando la forza della resilienza

«Esiste un potere popolare organizzato molto forte, un movimento ampiamente sottovalutato dall’esterno», afferma da Caracas la giornalista venezuelana Andreína Chávez Alava. Nel paese si è progressivamente consolidata una rete di organizzazione comunitaria che ha sostenuto intere popolazioni dal basso. Chávez spiega che questi gruppi hanno organizzato la produzione alimentare, i servizi essenziali e le reti di difesa, consentendo alle comunità di resistere per anni alle sanzioni e di trovarsi oggi in prima linea nella risposta del Venezuela alle ingerenze straniere.
Chávez racconta che la mattina dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, era tranquilla: la gente restava in casa o faceva scorte di cibo e acqua di fronte a un futuro incerto, prima che la calma lasciasse spazio alla mobilitazione popolare. Migliaia di persone hanno riempito le strade di Caracas, sventolando bandiere mentre si dirigevano verso il Palazzo Miraflores, sede del governo venezuelano. La folla avanzava unita denunciando «il bombardamento, l’aggressione militare e il fatto che un capo di Stato in carica fosse stato rapito, il che è contrario alle norme internazionali e alla Carta delle Nazioni Unite».
La mobilitazione è stata sostenuta dalla forza organizzativa delle comuni venezuelane, strutture di base riconosciute dalla Costituzione e fondate su assemblee, che affermano di aver rafforzato la propria resilienza contro un decennio di sanzioni statunitensi. Passando dalla dipendenza dalle importazioni a una quasi autosufficienza alimentare, gestiscono reti come "Pueblo a Pueblo" ("Dal popolo al popolo"), che distribuiscono cibo a prezzi accessibili in tutto il Paese. Chávez ha aggiunto che il movimento comunitario stava già resistendo a quello che descrive come un blocco navale illegale imposto dal presidente
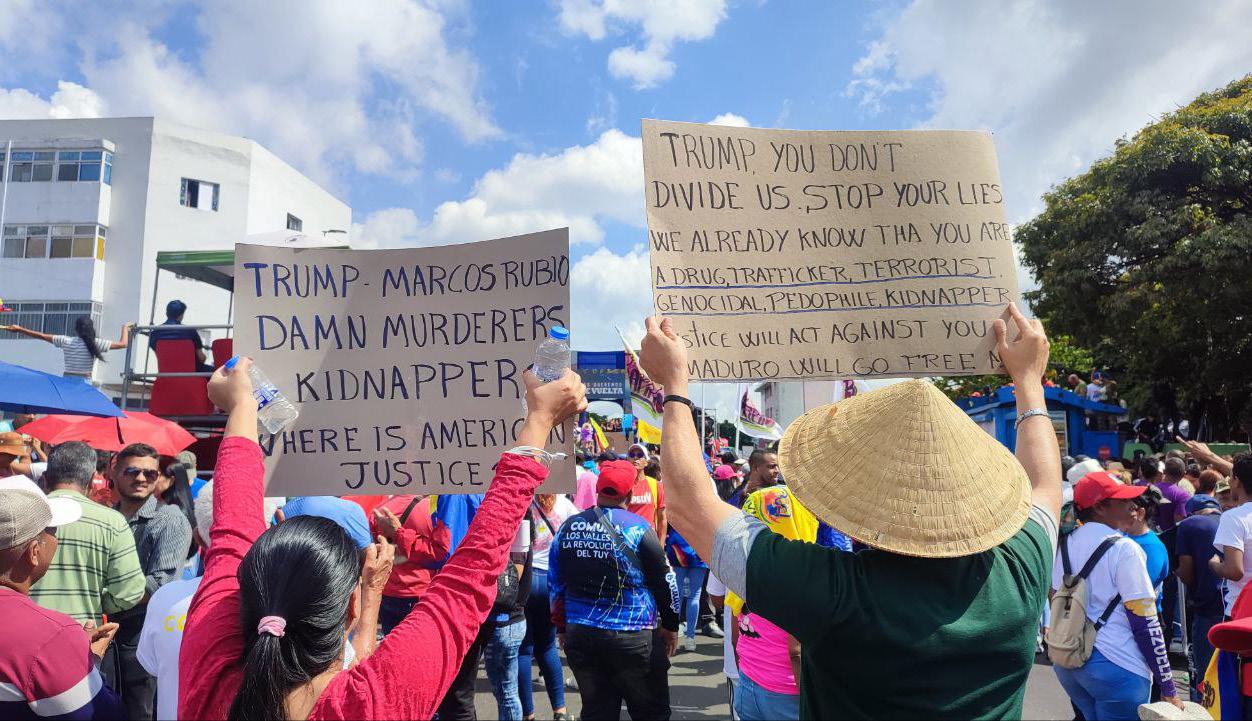
Donald Trump. «La maggior parte delle persone in Venezuela fa parte di qualche tipo di organizzazione popolare. Ecco perché la mobilitazione avviene così rapidamente: esiste già una rete di comunicazione tra loro».
È proprio la voce interna venezuelana che, secondo Chávez, viene messa a tacere. «È piuttosto disonesto da parte dei media internazionali proiettare l’idea di una diaspora festante e ignorare ciò che sta accadendo all’interno del Paese», ha sottolineato. La diaspora celebrata dai media «non rappresenta tutti» e molti fuori dal Paese le hanno scritto: «Non siamo tutti uguali».
Una delle narrazioni non reali è quella dell’esistenza di un governo di transizione. «All’amministrazione Trump conviene affermare di aver rimosso Maduro e di aver avviato una transizione di potere. Ma questo non è vero: l’autorità politica, compresa Delcy Rodríguez, rimane la stessa dell’era Maduro».
Nonostante la continuità nella leadership, dopo le minacce di Trump alla presidente ad interim Delcy Rodríguez, i venezuelani temono per lei un destino peggiore di quello di Maduro. «Il Paese è già stato bombardato una volta, sappiamo che sono capaci di farlo, sappiamo che ci sono minacce di farlo di nuovo. Non c’è altra scelta che negoziare». Eppure, Chávez descrive l’amministrazione come capace di mantenere una governance calma ed efficace, coinvolgendo i settori agricolo, industriale e comunitario. La gente può vivere normalmente, andare al lavoro, gestire le proprie attività e portare i figli a scuola. «La normalità è un modo per rivendicare la pace e la sicurezza che provavamo come nazione prima degli eventi del 3 gennaio».
Traccia un parallelo tra il Venezuela e altri Paesi in cui gli Stati Uniti sono intervenuti, come l’Iraq e la Libia, dove inizialmente molti hanno festeggiato. «C’erano persone che pensavano che qualsiasi cambiamento sarebbe stato migliore. Oggi, nella società irachena, si riscontra un forte antiamericanismo. Nessun Paese che ha subito l’intervento e l’occupazione degli Stati Uniti esprime gratitudine per tutto ciò che hanno fatto. Perché sappiamo già come andrà a finire».
Manifestanti durante una protesta di strada a Caracas, nel corso delle mobilitazioni delle comuni venezuelane del 7 gennaio 2026; Crediti: Andreína Chávez Alava
1. Un gruppo regge un cartello che chiede la liberazione di Nicolás Maduro e Cilia Flores, indicati come sequestrati
2. Persone tengono cartelli con accuse di sequestro e messaggi di protesta rivolti a Donald Trump e a Marco Rubio 2

Tra la speranza per il futuro della patria e le preoccupazioni per le nuove politiche migratorie statunitensi
di Andrea Charur
A Miami, nel quartiere Doral, fuori da una stazione di servizio chiamata El Arepazo, il 3 gennaio 2026 i passanti hanno notato una folla che sventolava bandiere venezuelane e cantava inni. Oggi quel quartiere ha un nuovo nome: Doralzuela. I manifestanti celebravano la rimozione del presidente venezuelano Nicolás Maduro dopo un’operazione militare statunitense ordinata da Donald Trump. L’azione ha di fatto posto fine al regime chavista iniziato con l’elezione del leader di estrema sinistra Hugo Chávez nel 1998. Con l’esodo dei venezuelani in fuga dal declino economico degli anni successivi, la Florida è diventata un polo migratorio: il 40% dei venezuelani negli Stati Uniti vive nello Stato.
Aileen Chirinos ha lasciato il Venezuela nel 2019 dopo tre lunghi anni di crisi economica. Ha vissuto carenze di cibo, medicine e materiale di primo soccorso, dopo che nel 2016 il governo Maduro aveva aumentato il controllo sul settore alimentare. Sono seguite proteste alle quali lei e la sua famiglia hanno partecipato, ma questo ha portato a una vera e propria persecuzione. I suoi tre figli sono stati i primi ad abbandonare il Paese. Nel 2022 Chirinos è tornata in Venezuela, ma pochi mesi dopo
se n’è andata di nuovo, trasferendosi a Miami. «Che cosa vedo in Venezuela? La stessa criminalità, la stessa povertà mascherata». Prima dell’alba del 3 gennaio, suo fratello ha bussato alla sua porta per dirle che alcuni amici in Venezuela avevano sentito dire che Maduro non c’era più. Chirinos ha cercato su Internet informazioni verificate, ma soprattutto ha deciso di ascoltare chi era rimasto nel Paese. «So che è un passo; so che abbiamo rotto il primo strato», ha detto, ma «non c’è ancora libertà di espressione e io festeggerò solo quando festeggeranno anche i venezuelani che sono lì».
Vicentina Parillo ha ricordi diversi del Venezuela. Si è trasferita negli Stati Uniti nel 1982, a 15 anni, non per necessità ma perché sua madre voleva essere più vicina ad altri familiari. «A me il Venezuela piaceva tantissimo», ha raccontato. Quando Chávez è salito al potere, è stata tagliata fuori dal Paese e non è riuscita a tornarvi nemmeno per rinnovare il passaporto venezuelano. Parillo ha trovato conforto lasciando il freddo di New York per Miami, dove ha costruito una carriera e una famiglia. Mantiene il legame con il Venezuela attraverso una chat WhatsApp con amici delle scuole medie e superiori e invia spesso loro denaro per cibo, medicine e altri beni essenziali.
Sia Parillo sia Chirinos sostengono la decisione di Trump di rimuovere Maduro, nonostante la sfida al diritto internazionale. Parillo, cittadina statunitense senza affiliazione politica, ha detto che l’operazione non ha cambiato le sue altre valutazioni sul presidente. «Io la vedo in questo modo: lui sta facendo qualcosa che favorisce anche sé stesso». Per Chirinos, la mossa di Trump e altre iniziative internazionali sono benvenute. «Credo che stia facendo ottimi passi verso un cambiamento mondiale».
La fine dello Status di Protezione Temporanea (TPS) per i venezuelani, decisa da Trump — una scelta con cui Parillo non è d’accordo — impedisce ora ad altri venezuelani di unirsi a coloro che sono riusciti a fuggire. La stessa Chirinos si dice «molto spaventata» da come le politiche migratorie potrebbero influire su di lei come richiedente asilo per persecuzione politica, ma afferma che «quando le cose si fanno nel modo giusto, si ottengono questi benefici». (Si sono verificati casi di richiedenti asilo trattenuti dall’ICE durante procedimenti legali).
Chirinos ha spiegato anche che adattarsi al sistema di Miami le è costato fatica, ma di aver trovato «molta tranquillità e molta pace». Nonostante la caduta del regime, ha aggiunto: «Tornare in Venezuela per me è come tornare in un Paese che non conosco più. È come ricominciare da capo».

Sostegno ai fedeli, appello alla calma e al dialogo e i limiti di un ruolo non politico, ma morale
Nel 2019 Papa Francesco rispose a una giornalista, su un volo di ritorno da Panama, di appoggiare «tutto il popolo venezuelano, perché è un popolo che sta soffrendo, quelli che stanno da una parte e quelli che stanno dall’altra». Ma, aggiunse, «se io entrassi a dire “date ascolto a questi paesi, date ascolto a questi altri”, mi metterei in un ruolo che non conosco, sarebbe un’imprudenza da parte mia e farei danno». La Chiesa non può sostituirsi alla politica, ma può ricordarle i suoi limiti.
Alla notizia dell’arresto del presidente Maduro, i circa sette milioni di venezuelani emigrati all’estero hanno celebrato la caduta di un leader a loro giudizio responsabile del drammatico impoverimento del Paese. In patria invece, i timori sulle ricadute per un popolo privo sia di beni che di prospettive hanno sovrastato l’entusiasmo. La Chiesa cattolica venezuelana, rappresentante del 70% della popolazione, intercetta queste inquietudini e le restituisce al dibattito pubblico. Jesús González Salas, presidente della Conferenza episcopale venezuelana, ha descritto a Vatican News lo stato d’animo dei fedeli, rivelando che «per molti, in questo momento, ci sono più interrogativi che risposte»; non è chiaro se il governo guidato da Delcy Rodriguez, avrà potere decisionale o se a prevalere saranno i diktat Usa.
Se da un lato la reazione dei cittadini è stata fare scorta di beni essenziali, dall’altro si è percepito il desiderio di tornare alla normalità il prima possibile e la domenica successiva «la partecipazione alle celebrazioni eucaristiche è stata quasi normale». Salas ha anche spiegato che «la realtà dinamica ci ha insegnato a privilegiare l’accompagnamento del nostro popolo» e a «mantenere una comunicazione costante con i nostri sacerdoti».
Salas ha proseguito ringraziando Leone XIV, che «ha dimostrato grande amore per i venezuelani e conoscenza della nostra realtà». Il Pontefice statunitense con cittadinanza peruviana, che ha amministrato a più riprese la sua diocesi di Chiclayo, è un punto di riferimento essenziale per tutto il Sudamerica.
Nell’udienza ai membri del Corpo diplomatico, a una settimana dall’operazione Usa, ha espresso preoccupazione per «l’acuirsi delle tensioni nel Mar dei Caraibi e lungo le coste americane del Pacifico», tra cui il blitz in Venezuela, l’attenzione di Trump su Cuba e la sua politica anticinese a Panama. Poi, a sorpresa, il cambio di marcia. Il 12 gennaio Leone accoglie nel Palazzo Apostolico la leader dell’opposizione venezuelana, la premio Nobel per la pace María Corina Machado, assieme al cardinale Segretario di Stato Parolin, ex nunzio apostolico proprio a Caracas.
La Chiesa venezuelana ha un margine d’azione ristretto: proteggere i fedeli da nuove lacerazioni sociali, senza però sostituirsi alle istituzioni ed essere percepita parte in causa, come disse Francesco.
La vicinanza ai venezuelani è stata riaffermata dall’intera comunità cattolica sudamericana, con il Consiglio episcopale latinoamericano che ha inoltrato un messaggio di solidarietà firmato dal suo presidente, il cardinale Jaime Spengler. Un’attenzione pastorale che oltrepassa il continente verso il resto del mondo. I cardinali europei, asiatici ed americani riunitisi nel Concistoro straordinario del 7 e 8 gennaio hanno discusso apertamente della crisi venezuelana e ribadito, in conferenza stampa, per bocca del filippino Pablo Virgilio David, l’obbligo di percorrere la «via del dialogo» e la necessità di una «costruzione reale e concreta della pace».

Gli studenti raccontano le conseguenze dell’allontanamento tra Londra e Bruxelles e le loro speranze per il futuro sette anni dopo la Brexit
Nell’aria c’è odore di birra, fumo di sigaretta e sudore. Lo schermo del piccolo televisore all’angolo della sala mostra un uomo dai capelli biondi e arruffati. È la sera del 12 dicembre 2019 e in Inghilterra il partito conservatore ha vinto 365 seggi su 650, guadagnandosi la maggioranza assoluta a Westminster. Seduto su uno sgabello alto e traballante in un pub di Leeds, Marco Chiaradonna tamburella le dita su un bicchiere vuoto e a Boris Johnson pensa poco. In quel momento non immaginava che sarebbe stato l’ultimo studente dell’Università di Perugia a studiare in Inghilterra grazie ai fondi europei. A sei anni di distanza, sa che il trionfo dell’allora primo ministro inglese ha portato all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (Ue) e dal programma Erasmus+. Una decisione che ha ridotto le partenze da e per la Gran Bretagna di migliaia di studenti. Fino al gennaio 2027, quando gli scambi riprenderanno su iniziativa del governo laburista del nuovo premier Keir Starmer.
Dopo mesi di trattative e tentativi di riavvicinamento, il 10 dicembre 2025 il ministro britannico per le relazioni con l’Ue Nick Thomas-Symonds ha incontrato a Bruxelles Maroš Šefčovič, commissario Ue al Commercio. I due hanno discusso le condizioni per il rientro della Gran Bretagna nel programma europeo di scambi universitari Erasmus+ e il 17 dicembre 2025 è stata annunciata la conclusione dell’accordo e il rientro del paese nel circuito di mobilità studentesca. L’intesa è parte di un piano di rilancio delle relazioni tra le due sponde della Manica e s’inserisce nel quadro del «nuovo partenariato strategico» siglato a maggio tra Londra e Bruxelles. «È un’enorme vittoria per i nostri giovani» ha sostenuto Thomas-Symonds: «Non si tratta solo di viaggiare», ma di consentire «alla prossima generazione di accedere alle migliori opportunità possibili».
Il Regno Unito aveva lasciato il circuito nel dicembre 2020 a seguito della Brexit. «Una decisione difficile», l’aveva definita Johnson al tempo, giustificandola con i costi elevati e la disparità tra gli studenti partiti e quelli accolti nel paese. In sostituzione il governo britannico aveva lanciato il “Turing Scheme”, dal nome del matematico Alan Turing, che dal 2021 ha consentito agli studenti «di andare non solo in università europee, ma nelle migliori università del mondo». Nonostante la promozione di un piano sostitutivo, la scelta del governo conservatore di lasciare l’Erasmus aveva causato disappunto negli studenti britannici e dell’Europa continentale.

«Sono un po’ arrabbiata», confessa con tono malinconico Alice Burton, ex studentessa di Cambridge, che da settembre 2023 ad agosto 2024 ha studiato sei mesi a Napoli e sei a Berlino grazie al “Turing scheme”. «Sono felice per chi avrà l’opportunità di ricevere finanziamenti per andare a studiare in Europa» ci tiene a specificare: «Ma non posso fare a meno di chiedermi perché io abbia dovuto rinunciarvi». «Non posso lamentarmi delle esperienze fatte», aggiunge e la voce le si addolcisce quando ripensa al suo periodo all’estero. La paura di lasciare casa, la prima volta che ha visto il mare di Napoli, il primo giro ai mercatini delle pulci a Berlino. Gli amici trovati in Italia e in Germania. «È stato l’anno più bello della mia vita», dice convinta: «Ma sarebbe stato molto più semplice se avessi potuto avere accesso ai fondi Erasmus».
Eliza Dean, laureata di Oxford, ricorda i mesi a Parigi come i più intensi e formativi. Avendo studiato francese è stata obbligata a trascorrere un periodo in Francia tra il 2022 e il 2023. «Sapevo fosse richiesto per laurearmi e quando gli accordi Erasmus sono stati interrotti ho avuto paura di non riuscire a ottenere una borsa di studio», spiega mentre la preoccupazione torna a farle aggrottare la fronte. «Sono stata fortunata perché Oxford aveva fondi avanzati dagli anni precedenti, ma ho dovuto fare due lavori per mantenermi. È stato faticoso e avevo poco tempo per me, ma sono contenta di averlo fatto». Ride ripensando al primo giorno a Parigi, quando guardando i tetti grigi delle palazzine dalla terrazza di un bar scoppiò a piangere tra le braccia della madre. «Stare lontana dai miei cari mi terrorizzava, ora non più e l’ho imparato partendo».
«Sognavo l’Erasmus da quando avevo quattordici anni, ma al mio secondo anno di università ho dovuto fare i conti con l’interruzione degli accordi», nelle parole di Matthew Robson, laureato in italiano




e francese a Manchester, c’è un pizzico di amarezza. «Se studi lingue sei costretto a partire e sono contento del mio periodo in Italia, ma ottenere i visti necessari è stato un inferno», ammette mentre ripensa a chi ha scelto di restare a casa per evitare la procedura e i costi. «È un processo lungo e dispendioso» aggiunge e spiega di essere stato costretto a lavorare al British Council come assistente linguistico nel corso degli otto mesi trascorsi a Varese tra il 2023 e il 2024. «Se avessi potuto accedere ai fondi Erasmus, avrei scelto di studiare invece di lavorare, ma non è stato possibile».
«Più che la sospensione dell’Erasmus è stata la Brexit a rendere difficile la mobilità», riflette Eliza ripensando alle difficoltà per ottenere il visto, «ma chissà forse un giorno anche quello cambierà». Per ora Matthew spera che «anche se il Regno Unito non è più nell’Ue possiamo ancora lavorare insieme». È in un’ottica di collaborazione che il governo britannico ha annunciato un contributo al programma da 570 milioni di sterline (650 milioni di euro) per l’anno 2027-2028.
«Mi sembra un passo importante», sorride Marco e lo sguardo gli si anima mentre ripensa al libro di poesie che si è dovuto guadagnare in una piccola libreria di York, rispondendo alle domande della vecchia proprietaria: «Per me Erasmus vuol dire scambio: di letteratura, di idee, di musica». Adesso c’è una generazione che si è disabituata allo scambio. Ma ce n’è un’altra che può tornare a imparare.


Valigie sempre pronte e città che cambiano: nei progetti Erasmus Mundus il master è una vita in movimento, tra burocrazia, ricerca sul campo e nuovi inizi globali
di Lavinia Ceci
«Ho scelto di partecipare all’International Master of Science in Marine Biologica Resources (IMBRSea) perché, oltre alla qualità della formazione, potevo spostarmi e conoscere nuovi contesti di ricerca», dice Anna, tedesca, che negli ultimi due anni ha vissuto tra Europa e Australia. Oggi la sua valigia contiene pochi vestiti e molti dati grezzi di laboratorio, appunti di campo e fotografie scattate in aeroporti di passaggio: una sintesi perfetta della vita frenetica e frammentata di chi parte per un master Erasmus Mundus, il programma dell’Unione europea che finanzia joint degrees (master congiunti) gestiti da consorzi di università in paesi diversi.
Alla fine del biennio, gli studenti ricevono un diploma firmato da tutte le università partner. Si tratta di una miscela intensa e difficilmente replicabile, che ridisegna il modo di stare al mondo e di approcciarsi al lavoro. Soprattutto quando si tratta di campi poco diffusi nelle grandi università per mancanza di fondi, laboratori o reti internazionali adeguate, come nel caso della biologia marina. Da questa esigenza nasce IMBRSea: un master finanziato da Erasmus Mundus e realizzato da undici università europee, tra cui l’Università Politecnica delle Marche.
«In ogni progetto Erasmus Mundus l’obiettivo è connettere i ragazzi tra di loro e con équipe di studiosi d’eccellenza», racconta Yans Vandenboer, Project Officer di IMBRSea. «La scienza è sempre di più una disciplina internazionale, e networking e scambio di punti di vista sono una parte fondamentale della formazione». Il consorzio seleziona ogni anno studenti con borse Erasmus Mundus che possono coprire tasse


e parte del sostentamento. A loro volta i ragazzi scelgono le destinazioni in base agli indirizzi della disciplina, e spesso si inseriscono nei contesti di ricerca visitati durante il programma. I progetti Erasmus Mundus come IMBRSea, infatti, garantiscono una «quality label» sul curriculum: un modo per farsi conoscere e apprezzare nell’ambiente – «il mondo della biologia marina è molto piccolo e i grandi nomi si fanno sentire». Inoltre, sottolinea Vandenboer, progetti ad alta mobilità permettono di sviluppare soft skill fondamentali, primo tra tutti lo spirito di adattamento.
«Si tratta di capacità molto spendibili nel settore della ricerca, soprattutto della biologia marina, in cui i laboratori sono spesso in zone isolate e poco accoglienti». Lo conferma Virginia Sofia, italiana, che ha studiato anche nelle Filippine e in Brasile. «A Mati era umido, faceva caldo e passavamo ore in acqua. Abbiamo fatto immersioni e dormito poco per seguire la ricerca». A Rio de Janeiro, invece, la situazione era più vivibile: «Faceva molto caldo e nuotare nell’oceano per studiare il comportamento dei pesci era pazzesco!». Viaggiare è una delle ragioni che spinge molti a partire. «Ho scelto di partecipare a IMBRSea perché, oltre alla qualità della formazione, potevo spostarmi e conoscere nuovi contesti lavorativi e di ricerca», afferma Anna, tedesca, che ha studiato tra Europa e Australia. E c’è anche chi arriva da oltreoceano, come Isabella, colombiana: «È stata una bella esperienza, ma ai futuri studenti extra-Ue dico: “Attenzione al visto!” Purtroppo per ragioni burocratiche ho potuto spostarmi solo tra Belgio e Italia, ma ho conosciuto una dimensione più locale della ricerca, con tutti gli alti e i bassi di un piccolo centro».
Per molti, alla fine del biennio, più del diploma conta la mappa delle città in cui hanno vissuto e delle persone che hanno conosciuto. Sta poi a ciascuno decidere se quella valigia da rifare ogni sei mesi diventerà la regola di una vita o il ricordo di due anni irripetibili.

L'Erasmus coinvolge i primi anni di scuola, promuovendo inclusione e apertura culturale
di Antonia Verderosa
Qualcuno vola per la prima volta, qualcun altro saluta già con un timido «hola». Un gruppo di bambini di tre, quattro e cinque anni sale su un aereo stringendo gli zainetti colorati. Direzione Malaga, Spagna. «Non pensavo che mio figlio potesse partire così sereno», racconta la mamma di uno dei piccoli. «Per lui era un’avventura. Non aveva paura, era solo curioso». I protagonisti del viaggio sono tra i più giovani studenti Erasmus d’Europa.
Il programma Erasmus+, promosso dall’Unione europea, nel ciclo 2021-2027, sta ampliando il proprio raggio d’azione, consentendo a studenti e docenti di ogni ordine e grado di vivere esperienze di mobilità in scuole europee.
«L’Erasmus non è soltanto spostarsi da un Paese all’altro, ma imparare a guardare la scuola con occhi nuovi», spiega Gianluca Marano, Ambasciatore Erasmus. «Il nostro ruolo è aiutare le scuole a progettare e a immaginare percorsi di internazionalizzazione che nascano dai bisogni reali degli studenti».
A livello nazionale iniziano a diffondersi progetti che coinvolgono anche i più piccoli. È il caso della Scuola paritaria dell’infanzia La Girandola di Sirignano, in provincia di Avellino, tra le prime in Italia a organizzare una mobilità di dieci giorni a Malaga. «Per noi è stata una grande emozione», continua la mamma. «Grazie all’approccio innovativo della scuola, abbiamo potuto vivere un’occasione unica, totalmente gratuita». Per i bambini coinvolti tutto è iniziato molto prima della partenza: ancora in Italia, le insegnanti hanno introdotto semplici parole in lingua straniera, hanno letto storie ambientate nel Paese ospitante, hanno preparato piccoli rituali quotidiani. «A casa mio figlio continuava a cantare una canzoncina in spagnolo. Non capiva tutto, ma sentiva che stava succedendo qualcosa di speciale».


L’esperienza Erasmus, a questa età, si costruisce soprattutto attraverso il corpo, le emozioni e il gioco. Arrivati nella scuola partner, i bambini hanno partecipato a laboratori didattici e attività creative con i compagni spagnoli, con cui hanno condiviso merende e sorrisi. «I bambini comunicano con uno sguardo, con un gesto. Anche senza parlare la stessa lingua, si sono capiti subito».
Il viaggio è stato anche un’opportunità per scoprire culture e tradizioni diverse dalle proprie. «Durante il soggiorno abbiamo assaggiato piatti tipici, visitato luoghi insieme alle famiglie spagnole. È stata un’immersione nella vita quotidiana di un altro Paese».
Le famiglie diventano parte attiva del percorso. «Non è solo “mandare” i bambini all’estero, ma sostenerli, vivere con loro l’apertura al mondo. Ci siamo sentiti onorati di far parte di questa avventura».
Secondo Marano, il progetto Erasmus+ offre opportunità educative insostituibili: «Anche i più piccoli sviluppano competenze fondamentali: la scoperta della diversità, il rispetto verso l’altro, la capacità di adattarsi a contesti nuovi. Sono semi che germoglieranno più avanti, magari senza un ricordo preciso, ma con una traccia duratura». Inclusione, sostenibilità e cittadinanza europea sono i valori al centro del programma Erasmus+. «L’idea è che nessuno resti indietro. Il programma dà priorità a chi non ha mai avuto opportunità simili e prevede strumenti specifici per garantire la partecipazione di tutti, con fondi specifici per studenti con disabilità».
Alla fine del viaggio, restano il diario di bordo, le foto, qualche parola nuova e soprattutto un’esperienza che difficilmente si dimentica. «Mio figlio non saprà spiegarti cos’è l’Erasmus», conclude la mamma, «ma sa che esistono bambini come lui in un altro Paese, e che può giocare con loro. Forse è da qui che comincia davvero l’idea di Europa».
Mohannad Al-Ashram sognava di diventare un musicista ma l’esercito israeliano ha distrutto la sua casa e i suoi strumenti. Ora insegna ai bambini palestinesi come l’Arte può diventare una cura
di Andrea De Luca Italia
In una poesia di Bertolt Brecht i bambini giocano alla guerra. In una tenda nel campo profughi di Al-Maghazi a Gaza, invece, i bambini giocano con la guerra. Un coro di voci bianche duetta con i caccia militari. Sullo scoppio di una bomba ci si appoggia per tenere il ritmo. Una conchiglia sul pollice e una sull’indice diventano le nacchere di una nuova canzone.
Prima di insegnare musica ai suoi giovani studenti, Mohannad Al-Ashram insegna loro che, per parafrasare di nuovo il poeta tedesco, anche tra le macerie, anche nei tempi bui, si può ancora cantare.
Al-Ashram ha appena vent’anni quando la guerra prova a togliergli la voce. Nel 2023 suona in una band chiamata Dozan, tiene concerti in Palestina, il suo Paese, sogna di diventare un musicista. Lo scoppio del conflitto israelo-palestinese, nel novembre di quell’anno, cambia tutti i suoi piani. «Io e la mia famiglia eravamo dentro casa nostra, quando i bombardamenti l’hanno colpita e rasa al suolo. Siamo rimasti intrappolati tra i detriti per un po’ di tempo, feriti e insanguinati», racconta.
«Grazie a Dio ne sono uscito vivo, ma molti dei miei familiari non ce l’hanno fatta. Tutti i miei strumenti, chitarre, violini, oud (strumento a corde tipico del Medio Oriente, ndr) sono stati distrutti, così come lo studio di registrazione che avevo costruito e dentro cui lavoravo in quel periodo. La mia convalescenza è durata fino al 2024».
«Quando mi sono ripreso – dice sicuro – sapevo già cosa avrei fatto: volevo aiutare i bambini di Gaza a convivere con la devastazione e farlo tramite la musica».
Esiste una parola araba, sumūd, che descrive bene l’approccio di Al-Ashram a questa nuova vocazione. Un atteggiamento in cui «le attività quotidiane diventano una forma di resistenza elementare, un modo di trasfor-


mare la semplice presenza in un’ostinazione privata», come la descrive nel 1986 lo scrittore Edward Said in After The Last Sky: Palestinian Lives.
Il musicista palestinese capisce che, se non può fermare la guerra, può almeno provare a trasformarla in uno strumento di cura. In uno dei video con più visualizzazioni condivisi sul suo profilo Instagram nel gennaio 2025, Al-Ashram è seduto in un’aula-tenda, davanti a una lavagna su cui ha scritto: «Musica, sogniamo insieme». Tiene in braccio una chitarra classica e insegna ai suoi studenti il nome delle note. Un drone israeliano sovrasta il suono del canto.
«La prima volta che ho pensato di usare il rumore di un drone militare come uno strumento musicale è stata durante una lezione in un campo profughi. Quel ronzio alto e costante continuava a interromperci e a turbare i bambini. Erano tutti distratti, tesi, spaventati».
«Ho chiesto loro di concentrarsi e ascoltare con attenzione la tonalità di quel rumore, provando a intonare le loro voci. Volevo che reclamassimo insieme il controllo su un evento traumatico. Che non fossero più dominati sul piano emotivo, ma che fossero in grado di interagire con quel disturbo in maniera creativa. Questo li ha aiutati a calmarsi, ad accrescere la loro consapevolezza sulle loro doti musicali, soprattutto la capacità di ascolto e la precisione vocale, e ad allontanare la paura. Hanno capito di poter vedere le cose da un punto di vista differente».
Nonostante il cessate il fuoco scattato il 9 ottobre 2025 e il piano di pace approvato dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu il 17 novembre 2025, la situazione a Gaza, racconta Al-Ashram, rimane complessa. «Il cessate il fuoco ha ridotto l’intensità dei bombardamenti, ma non li ha fermati del tutto», spiega.
«La quotidianità è ancora difficile. Molte famiglie sono sfollate, beni di prima necessità come cibo, elettricità e acqua pulita sono disponibili in quantità limitate. Il trauma è ancora molto radicato, soprattutto tra i bambini con cui sono a contatto ogni giorno ad Al-Maghazi,
Deir al-Balah e nel resto della Striscia di Gaza. Questo per me è lo stimolo principale per continuare il mio lavoro: l’urgenza di avere musica, arte e sostegno emotivo è più alta che mai, oggi». Per Al-Ashram la musica non è solo terapia. È anche un modo per tenere in vita un’identità, quella palestinese, messa a dura prova da due anni di conflitto. «Per me – spiega – preservare l’identità musicale palestinese è di fondamentale importanza. Strumenti tradizionali come l’oud rappresentano una parte vitale del nostro patrimonio, riflettono il nostro percorso e raccontano una storia che non può essere dimenticata».
«Salvaguardare questo patrimonio significa non far morire la memoria di un intero popolo e dare voce alle storie vissute dai nostri antenati. Utilizzare questi strumenti non è solo un modo per onorare il passato, ma anche una dichiarazione del fatto che siamo ancora qui, vivi. E che la nostra musica continua a prosperare ed evolversi».
Una dichiarazione che non si esaurisce nella musica, come dimostra ad esempio Melodies of Hope, progetto che ha dato vita nell’agosto 2025 a una rivista curata da Al-Ashram insieme ai bambini gazawi. «Abbiamo costruito il primo numero con disegni, illustrazioni e pensieri scritti da loro durante i laboratori. L’obiettivo è quello di raccogliere dei fondi per finanziare l’acquisto di cibo e vestiti, ma anche condividere con il mondo quello che creiamo qui a Gaza, qualcosa che va oltre l’Arte».
In una pagina della rivista, accanto al disegno di Lama M., 16 anni, la didascalia recita: «Lama ha disegnato sé stessa mentre guarda al futuro con ottimismo, dal centro della guerra. Non ha perso la speranza di poter raggiungere i suoi sogni nonostante la sofferenza e la distruzione che si sono abbattute su Gaza. Sogna ogni giorno un futuro migliore».
«La lezione più grande che ho imparato dai miei studenti – aggiunge Al-Ashram – è che l’Arte, in particolare la musica, non si limita a note o melodie: è uno stato di connessione emotiva e umana. Questi ragazzi, nonostante tutte le sfide che affrontano, mi insegnano ogni giorno come essere artisti sia una finestra per la crescita personale e l’espressione di sé. Mi mostrano che la creatività non ha limiti e che la musica può essere uno strumento per trovare la pace interiore, anche nei contesti più difficili».
«Utilizzare questi strumenti non è solo un modo per onorare il passato, ma anche una dichiarazione del fatto che siamo ancora qui, vivi. E che la nostra musica continua a prosperare ed evolversi»
Bayan Rok, giovane madre palestinese, oggi rifugiata di guerra nelle Marche, compone poesie e sogna di diventare scrittrice
di Camilla Stacchiotti
«Sono partita da Gaza attraversando il valico di Kerem Shalom, dopo essere stata sottoposta ai controlli dell’esercito israeliano. Il percorso è stato lungo e carico di paura, fino a quando siamo arrivati in Italia alle tre del mattino. Non riesco a descrivere quella prima visione: ho sentito la vita tornare dentro di me, dopo due anni di guerra. Ho rivisto la natura, le luci delle strade, i tetti colorati delle case e ho ritrovato la speranza».
A raccontarlo è Bayan Rok, 24 anni, madre palestinese di due bambini di quattro e tre anni, Wael e Maryam, che vive a Porto Recanati. Nel nostro Paese è arrivata verso la metà di giugno, grazie a uno dei corridoi umanitari attivati nella striscia di Gaza dalla Croce Rossa Internazionale e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per consentire l’evacuazione medica di persone in condizioni sanitarie critiche. La figlia Maryam, infatti, rientra nei quasi duecento bambini con gravi patologie congenite o ferite di guerra, comprese amputazioni, accolti negli ospedali italiani dall’inizio del conflitto. Le cure sono state rese possibili grazie alla collaborazione della Presidenza del Consiglio, del Ministero degli Esteri e della Protezione Civile italiana ed europea. «All’Ospedale Regina Margherita di Torino mia figlia è stata operata per una patologia cardiaca. La sera successiva all’intervento è stata la prima volta, dopo molto tempo, in cui abbiamo dormito serenamente, senza paura. Ricordo il silenzio quasi assordante della stanza, sembrava irreale», racconta la giovane donna.
La scelta di iniziare una nuova vita in una piccola città affacciata sul Mare Adriatico non è stata casuale. A trasferirla da Torino nelle Marche con lo status di rifugiata è stata l’associazione locale no profit Porto Recanati Solidale, che da anni opera nel volontariato e negli aiuti umanitari in aree critiche del mondo. «Ho conosciuto Bayan durante una missione svolta tra la Turchia e Gaza per la consegna di forniture idriche in quei territori martoriati. Da lì è nata un’amicizia profonda, che mi ha spinto a compiere un gesto concreto per lei e la sua famiglia», spiega Giampiero Cappetti, presidente dell’organizzazione. Da questo legame è nata anche la volontà di andare oltre, cercando di realizzare il sogno
«Vedo i ricordi come fantasmi che si formano nella nebbia, come se li vivessi di nuovo.
Vedo la nebbia abbracciare i miei desideri, li porta lontano, e io seduta su quella sedia li guardo, con uno sguardo profondo;
Se li inseguissi li afferrerei, e se li lasciassi andare li raggiungerei. Ho chiuso un po’ i miei occhi freddi
e ho fatto una breve passaggiata nella mia mente, trovandomi più calma.
Mi chiedo, sarà questa calma buona o cattiva?
È una luce affievolita o una morte silenziosa dentro di me?
Sono tornata di nuovo, ho lasciato quella sedia al centro della piazza e sono andata via, portando i miei desideria nei sogni, che forse un giorno troveranno la strada per tornare a me»
della donna di diventare scrittrice. Prima dello scoppio delle ostilità, Bayan frequentava infatti un circolo di scrittura a Khan Yunis, la sua città di origine, un’attività interrotta bruscamente quando è stata costretta ad abbandonare la propria casa per rifugiarsi in uno dei numerosi campi allestiti per la popolazione civile. «Sono cresciuta in un ambiente contadino molto semplice, a contatto con la natura e gli animali, ma ho sempre sentito in me l’esigenza di esprimermi attraverso le parole. Le 28 lettere dell’alfabeto arabo sono diventate presto la mia guida, il mio faro, una costante fonte di ispirazione, da cui sono nati poesie, racconti e storie».
Una passione che non si è spenta neppure sotto i bombardamenti dell’esercito israeliano. Grazie al contatto telefonico quotidiano con l’associazione marchigiana, è nata l’idea di pubblicare un diario digitale sulla piattaforma Facebook, attraverso il quale la giovane madre ha continuato a coltivare la propria vocazione letteraria e a condividere aggiornamenti sulla sua vita, mantenendo viva l’attenzione sulla situazione nei territori d’origine. «Stiamo pensando anche a un libro, per non disperdere le testimonianze e le esperienze vissute in questi due anni» precisa Cappetti.
In attesa che questo progetto prenda forma, Bayan prosegue il suo percorso a Porto Recanati, dove frequenta insieme ai figli un corso di lingua italiana, con il pensiero costantemente rivolto ai familiari rimasti a Gaza: «Il mio desiderio più grande è riunirmi con mio marito e i miei genitori e sapere che stiano bene. Anche dopo la firma del cessate il fuoco lo scorso ottobre, gli attacchi sono continuati e il senso di insicurezza persiste. Spero però che un giorno io possa ritrovare le mie radici lì dove sono nata, in Palestina».

La scelta di Polo, volontario italiano al fronte, il racconto di chi combatte per difendere la libertà del popolo ucraino
di Silvia Sisto
«Attualmente mi trovo a Zaporižžja, la situazione sul fronte peggiora di giorno in giorno, i russi sono sempre più vicini alla capitale Kyiv e la loro tecnologia per uccidere è sempre più letale, economica e precisa». A parlare è Polo, nome di battaglia di uno dei numerosi cittadini italiani che hanno scelto di unirsi alle forze ucraine, rispondendo all’appello lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky il 27 febbraio 2022: «Chiunque voglia unirsi alla difesa dell'Ucraina, dell'Europa e del mondo può venire e combattere fianco a fianco con gli ucraini contro i russi criminali di guerra».
Il “callsign”, spiega Polo, serve a proteggere la sua identità e a rendere immediato il riconoscimento tra i combattenti: «Deve essere breve, facile da pronunciare e ricordare, perché quando intorno emerge il caos dello scontro, sono i minuti quelli che contano».
La sua storia da combattente inizia quando lascia il suo lavoro come project manager nel settore dei servizi alla persona e sceglie di arruolarsi. Una scelta influenzata anche da legami personali: «Avendo partecipato al programma Erasmus avevo amici ucraini che mi raccontavano direttamente il dolore e la disperazione che l'esercito russo ha scatenato contro di loro».
Oggi Polo mette a disposizione le sue competenze per costruire servizi per i volontari combattenti attraverso l'associazione STUR, che fornisce supporto psicologico per i combattenti e le loro famiglie, protezione sanitaria e protezione legale. Alla domanda sulle motiva-


zioni che lo hanno spinto a partire risponde: «Per quanto mi riguarda, ideologiche, personali e legate al senso del dovere. Provengo da una famiglia di partigiani e non ho scordato le lezioni di chi ieri ha mangiato pane e cipolla e ha vissuto la solitudine, la paura, le fucilazioni, le rappresaglie e la speranza connesse alle azioni compiute per liberare l'Italia dalle catene dei totalitarismi. Questo non deve accedere mai più».
Chi come Polo ha fatto questa scelta è abituato a sentirsi affibbiare molti epiteti, «foreign fighters, freedom fighters, voluntary fighters, pazzi, mercenari, infiltrati, assassini», ma ci tiene a rivendicare il loro ruolo: «Operiamo come regolari soldati dell'esercito ucraino. Su di noi oneri e responsabilità del ruolo, al pari degli ucraini, ma con elementi di maggiore "morbidezza" dovuti al fatto che siamo volontari che vengono da lontano per aiutare a tutelare il diritto all'autodeterminazione degli ucraini».
Ognuno di loro ha un compito ben preciso: «Chi ha esperienza di trincea, come me, passa le giornate a controllare che i russi non arrivino, a ripararsi dall'artiglieria che martella le trincee, a nascondersi dai droni che sganciano granate o ti si schiantano addosso carichi di esplosivo, a cercare di curare l'igiene personale, a scavare per rinforzare le posizioni difensive» e poi ci sono «le notti a sperare che i rumori che provengono dall'esterno dei blindage (buchi sottoterra pieni di zanzare, topi e umidità) non siano squadre di russi assaltatori che si muovono nel buio più nero».
Volontari provenienti da tutto il mondo ma «il minimo comune denominatore che sottende tutte le motivazioni di chi viene qui a combattere è uno e sempre presente in tutti: non abbiamo accettato di stare a guardare mentre il violento e più forte, pretendeva di piegare il più debole. Questa è l'essenza ultima del foreign fighter».
Ciò che lo colpisce di più, però, sono le notizie degli amici conosciuti in addestramento o al momento dell'arruolamento, che risultano morti, mutilati, scappati o dispersi: «Spezzano il cuore, la mente e lo spirito».
Il dramma dei dispersi nella “nebbia della guerra” ucraina
di Maria Giulia Giordanelli
Le mani di Alina si muovono agitate tra le pieghe del grembiule, come se cercassero qualcosa che non riescono a trovare. Quando parla di suo figlio disperso al fronte, non usa mai il passato. Il tempo per lei non scorre: è fermo lì, in una trincea che non ha mai visto, ma che immagina ogni notte. «È da più di un anno che non ho notizie di Yuri. La mia speranza è che sia prigioniero, perché finché non c’è un corpo, una madre può solo continuare a sperare e ad aggrapparsi anche a una possibilità così dolorosa pur di non pensare al peggio».
Sono passati 23 anni da quando Alina ha lasciato l’Ucraina. Al tempo, il paese attraversava la difficile transizione post-sovietica sotto la presidenza di Leonid Kuchma. Un’epoca segnata da una crisi economica che divorava salari e risparmi, una corsa alle privatizzazioni e un sistema politico sempre più piegato agli oligarchi e alla corruzione, e molte delle grandi strutture che per decenni avevano garantito lavoro e stabilità chiudevano i battenti. «Anche l’albergo di cui ero direttrice è fallito. Poi mi hanno offerto altri posti, ma lo stipendio non bastava per vivere».
Con un marito assente e due figli di 12 e 15 anni, Alina si ritrova sola a reggere il peso delle responsabilità familiari. Decide così di partire per l’Italia, senza sapere quando sarebbe tornata. «Pensavo che venire qui fosse la soluzione. Appena sono partita mi sono pentita, ma dentro di me sapevo che tornare indietro non era possibile». I figli restano in Ucraina, con la nonna. «Separarmi da loro è stato il dolore più grande della mia vita. Ho pianto per mesi, ogni sera. Non riuscivo a smettere».
Quando arriva in Italia, Alina si sente sopraffatta da una realtà che non riesce a decifrare. «Il primo ricordo che ho è il rumore di tutte le parole che non capivo. Mi sentivo sola e persa». Lavora come collaboratrice domestica, si sposta da una casa all’altra, impara la lingua. «All’inizio contavo i giorni» ma, col tempo, il legame con l’Italia diventa profondo. «Ho incontrato persone
«Pensavo che venire qui fosse la soluzione. Appena sono partita mi sono pentita, ma dentro di me sapevo che tornare indietro non era possibile»

meravigliose che mi hanno aiutata a costruirmi una vita qui». Poi, nel 2022, la guerra irrompe nella quotidianità della sua famiglia. Alina la guarda da lontano, attraverso lo schermo del televisore, dove le immagini delle città sventrate si confondono con i ricordi dei luoghi della sua giovinezza. I suoi figli partono per il fronte. Uno dei due, Ivan, torna ferito e ottiene il congedo permanente: è vivo, ma porta con sé i segni indelebili, fisici e psicologici, di ciò che ha vissuto. Di Yuri invece si perdono le tracce. «Da quando ho saputo che è disperso ho smesso di vivere. Non so se è vivo o morto, non so niente di niente».
La storia di Alina si intreccia con quella di decine di migliaia di famiglie, condannate a un’incertezza assoluta sul destino dei propri cari, caduti o catturati dall'inizio del conflitto. Reperire dati affidabili in tempo di guerra è un'impresa quasi impossibile: quella che in gergo militare si chiama "Fog of war", la nebbia della guerra, non copre solo i campi di battaglia, ma anche gli archivi e le statistiche. Informazioni frammentarie, spesso contraddittorie e protette dal segreto militare trasformano i numeri in un terreno instabile, continuamente riscritto.
I dispersi possono riapparire come prigionieri, i prigionieri essere dichiarati morti, i morti restare senza nome. Le liste si sovrappongono senza combaciare, aggiorna-
te con ritardo, quando non restano del tutto opache. In questa confusione, l’identità di una persona si frantuma in categorie burocratiche che non restituiscono verità, ma solo ipotesi. La Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2025, dedicata al costo umano della guerra russa contro l'Ucraina, fornisce uno dei quadri più recenti. Secondo il documento, «più di 70 mila ucraini, tra cui civili, bambini e personale militare, figurano ufficialmente nell'elenco delle persone scomparse». Un numero a cui si aggiunge quello dei detenuti: circa 16 mila civili attualmente prigionieri «in Russia e nei territori ucraini temporaneamente occupati».
Si tratta di un sistema di oltre 280 centri di detenzione, spesso inaccessibili alla Croce Rossa Internazionale o ad altri osservatori indipendenti, dove, secondo le denunce delle organizzazioni umanitarie, le condizioni violerebbero sistematicamente i principi delle Convenzioni di Ginevra sui diritti umani in guerra. Ma, come sottolinea il testo, il numero reale dei prigionieri «potrebbe essere notevolmente più elevato».
Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, Amnesty International ha documentato - oltre ai costanti attacchi deliberati contro obiettivi civili - crimini di guerra come arresti arbitrari, sparizioni e trasferimenti forzati, deportazioni e torture. «La maggior parte dei prigionieri di guerra ucraini è isolata dal mondo esterno e le loro famiglie sanno poco o nulla su dove si trovino, sul loro attuale status e in generale sul loro destino», denuncia l’organizzazione.
Per Alina, come per tante altre madri come lei, l'assenza di notizie si traduce in una "perdita ambigua”: uno stato di sospensione in cui una persona è fisicamente assente ma continua a essere psicologicamente presente, perché non esiste una conferma della morte né la certezza di un possibile ritorno.
È la condizione di chi non può celebrare un funerale né prepararsi al ricongiungimento. È una sedia che non può essere tolta dalla tavola, un telefono che deve restare acceso anche di notte, l'impossibilità di decidere cosa fare dei vestiti nell'armadio di un figlio. «È straziante non sapere nulla. Ogni giorno spero che possa essere l’ultimo senza risposte».
Alina guarda l'orologio. Deve tornare al lavoro. C’è una casa da tenere in ordine, una vita che deve continuare. Si asciuga le lacrime, poi si alza. Liscia le pieghe del vestito e si stringe i lacci del grembiule dietro la schiena. Mentre si avvia verso la porta, le sue dita ricominciano a tormentare compulsivamente l'orlo del tessuto bianco, come se in quelle pieghe potesse davvero nascondersi una risposta.
«Da quando ho saputo che è disperso ho smesso di vivere. Non so se è vivo o morto, non so niente di niente»
Luci
e ombre della lotta al
crimine nella megalopoli brasiliana
di Costanza Saporito
Un teschio trafitto da un pugnale e, sullo sfondo, due pistole incrociate. È questo il simbolo del BOPE (Battaglione per le operazioni speciali di Polizia), il reparto d’élite della Polizia militare di Rio de Janeiro, specializzato in operazioni ad alto rischio e in prima linea nella lotta al narcotraffico.
L’unità, nata nel 1978 con l’obiettivo di gestire i casi in cui fossero coinvolti ostaggi, è stata in seguito riorganizzata più volte, perfezionandosi nel combattimento urbano ravvicinato. I suoi membri, i “caveiras” (teschi in portoghese), sono chiamati a fronteggiare situazioni di crisi nelle favelas, aree sottratte al controllo dello Stato, in cui vive un abitante su quattro e in cui i reparti regolari di polizia sono restii a intervenire.
«Il reclutamento avviene su base volontaria. Bisogna superare una selezione molto dura: la resistenza fisica è necessaria, ma è la tenuta psicologica a fare la differenza. Operiamo in scenari complessi: nelle favelas lo Stato è sostituito dalle organizzazioni criminali che esercitano un potere parallelo e crudele sui cittadini che vi abitano» spiega Raphael Rodrigues (nome di fantasia), ex membro del BOPE che risiede all’estero.
Questo reparto speciale si è imposto nell’immaginario collettivo in seguito all’uscita, nel 2007, del film “Tropa de Elite”, che segue le vicende quotidiane di un capitano del BOPE. «Il film è molto efficace nel restituire l’immagine, fedele alla realtà, di una società al collasso, in cui una forza altamente addestrata viene costantemente chiamata ad intervenire in uno scenario che assomiglia in tutto e per tutto ad una guerra. In qualità di forze speciali operiamo in contesti in cui il tempo per prendere decisioni è per forza di cose limitato ed essere supportato dalla squadra giusta è fondamentale.»
Dalla fiction alla realtà, questa unità d’élite è stata protagonista, nel tempo, di operazioni che ne hanno rivelato la natura controversa. L’intervento condotto lo scorso ventotto ottobre da duemilacinquecento agenti del BOPE ad Alemão e Penha, favelas nella zona nord di Rio, finalizzato alla cattura dei narcotrafficanti del Comando Vermelho- una delle fazioni criminali più influenti del Brasile- si è concluso con ottantuno ar-

resti e oltre centotrenta morti, tra i quali numerosi civili e quattro membri delle forze dell’ordine, e ha riportato al centro della scena nazionale ed internazionale il dibattito sulle modalità di intervento di questo reparto di polizia speciale. La morte di civili in seguito ad operazioni del BOPE non costituisce infatti un’eccezione e le diverse reazioni che hanno accompagnato quella che è stata definita «l’operazione di polizia più letale della storia brasiliana», riflettono i differenti modi di valutare le politiche di sicurezza del governo.
Molti cittadini di Rio «stanchi del silenzio delle autorità, esausti dalla paura imposta dal crimine», sostengono senza riserva l’operato di questo reparto. Altri, invece, si fanno portatori di una visione opposta, che ne contesta la legittimità. È il caso, ad esempio, di Dani Monteiro, deputata federale del partito Socialismo e Libertà, secondo la quale «operazioni di questo tipo si traducono troppo spesso in un massacro di fatto e vanno dunque fermate.»
«Quando le altre istituzioni falliscono, il peso delle conseguenze di questo fallimento, che si traduce in un diffuso sentimento di ingiustizia, tende a ricadere quasi sempre sulle forze di polizia. In una società complessa e divisa come quella di Rio il BOPE resta un’unità capace di operare con successo in scenari di estrema violenza» conclude invece Raphael.
Il mondo ha finalmente iniziato a parlare delle atrocità del conflitto sudanese, ma alcune notizie false sono diventate virali sui social
di Lorenzo Gironacci
Le fake news non risparmiano neanche la violenza della guerra. La conquista, da parte delle RSF (Forse di Supporto Rapido), di El-Fasher, capitale del Darfur settentrionale, segna uno spartiacque nella narrazione del conflitto sudanese.
Dopo questo evento, infatti, l’attenzione mediatica per la guerra civile, scoppiata nel 2023, è cresciuta vertiginosamente, in particolare sui social media: influencer e giornalisti hanno iniziato a denunciare le atrocità del conflitto, come stupri, fucilazioni di massa e torture. Questa nuova attenzione mediatica ha reso il terreno fertile per fake news e sensazionalismi, e spesso delle legittime denunce sociali sono scadute nella mera condivisione di foto e video senza un’adeguata verifica delle fonti. Il caso più esemplare è quello delle immagini satellitari, prese da fonti come Google Earth, che mostrerebbero corpi, terreno bruciato e strade insanguinate. Un account di X, in data 3 novembre 2025, ha scritto su un'immagine satellitare «SPEAK ON THE GENOCIDE OF SUDAN»
La foto è stata rilanciata da molti account, soprattutto su Instagram e Reddit. Secondo alcuni utenti, l’immagine, che ha ricevuto 15 milioni di visualizzazioni sul singolo post su X, mostrerebbe diversi corpi di civili sudanesi, immersi in una pozza di sangue. Benjamin Stirck, esperto di analisi Open Source Intelligence (OSINT), ha subito confutato questa tesi, affermando che si trattasse, in realtà, di un abbeveratoio con del bestiame.
Questo caso è solo uno tra i tanti esempi di una “corsa” digitale, iniziata dopo la conquista di Al-Fasher, per trovare delle immagini satellitari che ritraggono presunte



atrocità in Sudan. Infatti, durante il mese di novembre 2025 sono stati aggiunti su Google Maps dei segnaposto, visibili a tutti, con la dicitura «Save Sudan», dagli stessi utenti, per segnalare anomalie sul terreno o presunti corpi.
Le varie segnalazioni seguono la stessa logica dell’immagine satellitare condivisa su X: mostrano un terreno rossastro e oggetti non meglio identificabili ma che, a un osservatore inesperto e carico di emotività, possono apparire rispettivamente come sangue e corpi umani. Non si tratta di deep-fake o contenuti generati dall’IA, ma di fonti reali gestite da un pubblico amatoriale, la cui spinta morale di comunicare le atrocità della guerra offusca le necessità di analisi e approfondimento. Al contrario, un rigoroso studio delle immagini satellitari dopo la conquista di El-Fasher è stato condotto dallo Yale Humanitarian Research Lab. Il paper, pubblicato in data 16 dicembre 2025, analizza il periodo che va dal 26 ottobre al 28 novembre, concludendo che «le RSF hanno condotto uccisioni di massa diffuse e sistematiche di persone che erano rimaste intrappolate all'interno della città e avevano tentato di fuggire da El-Fasher».
A più di mille giorni dal suo inizio, il conflitto sudanese ha causato più di centocinquantamila morti e ventidue milioni di sfollati, con entrambi gli eserciti (RSF e SAF) accusati di crimini contro l’umanità. Data l’insufficiente copertura giornalistica sul campo, le immagini satellitari sono uno dei pochi strumenti a disposizione per portare gli occhi del mondo su uno dei peggiori disastri umanitari del pianeta.
1. Immagine satellitare di Google Maps dell’area del Darfur settentrionale, Sudan
2. L'immagine satellitare pubblicata su X. Coordinate: 10.961076, 26.414408, Kumia, Sudan
3. Tre donne sudanesi all’ospedale Salam Center di Khartoum, Sudan. Foto dell’inviato Rai Giammarco Sicuro 1
Marcello Mangolini e Livia Bonacini raccontano il loro ruolo a fianco dei vertici dei partiti italiani
di Valerio Forte
Rassegna stampa e telefono acceso appena svegli. Marcello Mangolini e Livia Bonacini sono due giovani militanti politici. Prima di fare politica si occupano di gestire quella degli altri. Mangolini, oltre a essere assistente al Parlamento europeo, cura la comunicazione digitale di Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico. Bonacini, responsabile comunicazione di Forza Italia Giovani, si occupa dei social di Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia. Ideali diversi ma stesso ruolo: tradurre la politica in contenuti per i social network.
Bonacini sottolinea che il social media manager è un lavoro in equilibrio tra pianificazione e imprevisto: «Il mio mantra è programmare il programmabile». Emerge la necessità del calendario editoriale, ma la comunicazione, come del resto la politica, vive soprattutto d’attualità. «Su base annua direi 40% pianificazione e 60% alla giornata. La rassegna stampa è fondamentale al mattino per proporre temi da trattare sulla pagina».
Mangolini racconta una comunicazione che aiuti a disegnare la persona dietro al politico: «Devi essere pronto a fare tutto, ovunque. Canva e CapCut sono strumenti quotidiani che serve avere a portata di mano sul telefono. Non sai mai dove sei quando bisogna pubblicare».
TikTok, il social network che negli ultimi anni ha accolto la politica nel suo algoritmo, entra nella comunicazione dei politici in modo diverso. «Abbiamo aperto il profilo da poco, lo stiamo usando per spiegare la politica in maniera semplice. Le richieste di adesione al movimento giovanile nei messag-


gi della pagina sono aumentate nettamente», spiega Bonacini. Mangolini analizza la scelta ragionata sul social cinese: «Bonaccini lo utilizza poco, è una scelta consapevole. Non tutte le piattaforme sono adatte a tutte le figure politiche».
Per un social media manager il rischio di sbagliare è alto. «Ricordo un errore su un post uscito poco prima. Sono stati attimi molto intensi. Poi, riguardando i messaggi, quasi ci ridi. Ma sul momento no» racconta la responsabile della comunicazione di Benigni. Anche Mangolini racconta di un errore recente: «Bonaccini pubblica anche in autonomia e i suoi post funzionano, nonostante abbiano delle imperfezioni. Poco tempo fa ha pubblicato uno screenshot, si vedeva chiaramente che non era un contenuto pensato. E sotto quella foto ha discusso direttamente con un'utente. Ho dovuto rimuovere il post. Ogni cosa che pubblichi ha un impatto».
Il linguaggio da utilizzare varia a seconda del contenuto e della piattaforma. «Benigni parla in forma istituzionale. Io cerco sempre di spronarlo a creare contenuti che non risultino costruiti. Puoi usare un linguaggio tecnico ma arrivi a pochi, devi trovare il modo giusto di semplificare» spiega Bonacini. Mangolini si sofferma sull’importanza delle parole: «Se sbagli, diventa notizia nazionale. Ogni frase va letta, riletta e interpretata».
Il futuro, per entrambi, resta aperto. «La comunicazione politica mi piace molto ma fare politica attiva mi appassiona. A volte, però, sto montando un contenuto mentre dovrei preparare un mio discorso per un evento. Le due strade non potranno correre a lungo assieme» ammette Bonacini.
Mangolini guarda invece al futuro della professione: «Se oggi mi chiedi che lavoro faccio, ho difficoltà a rispondere. Non posso dire che faccio il giornalista, ma non faccio nemmeno solo il social media manager. È un ruolo che per lo Stato non esiste, eppure è centrale. La verità è che, senza questo lavoro, oggi la comunicazione politica sui social non potrebbe funzionare».
2
Dalla satira alla propaganda istituzionale il dibattito pubblico si costruisce su formati rapidi e reazioni immediate
di Davide Bertusi
L’attualità si consuma prima in un meme che in un articolo. Tra scroll compulsivi e slogan virali, sono questi contenuti a offrire una cornice interpretativa immediata dell’attualità, capace di orientare reazioni, giudizi e appartenenze. In un ecosistema informativo saturo, questo formato rapido e riconoscibile sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella costruzione del senso comune e nell’orientamento del dibattito pubblico.
Nati come espressione informale della cultura online, i meme hanno progressivamente assunto una funzione ben più incisiva: condensare eventi complessi in immagini riconoscibili, fornendo chiavi di lettura immediate e cambiando il modo in cui temi pubblici vengono percepiti e discussi. La loro diffusione li rende strumenti potenti di partecipazione e accesso all’informazione, ma anche veicoli di semplificazione e polarizzazione che finiscono talvolta per favorire narrazioni radicali ed aggressive. Tra pratiche spontanee, strategie di marketing e nuove forme di propaganda, questo linguaggio sta contribuendo a rimodellare profondamente l’ecosistema informativo e il rapporto tra comunicatori e lettori.
Come scritto nel Media Literacy Brief (marzo 2025) del Parlamento europeo, la trasformazione dell’informazione, dominata da contenuti veloci, visivi e fortemente emozionali, favorisce modalità di fruizione sempre più passive e istintive, che rendono possibile sfruttare vulnerabilità e bias preesistenti. In un contesto segnato dall’infodemia, ovvero

la circolazione rapida e incontrollata di informazioni, il meme diventa una scorciatoia cognitiva. È questa capacità di fornire una prima interpretazione, rapida e riconoscibile, a renderlo un elemento centrale nella formazione dell’opinione pubblica.
A confermare questa dinamica è l’esperienza diretta di chi lavora ogni giorno con il linguaggio dei meme. Ranpo Fahrenheit, nome di penna del direttore di Blast, blog/zine di cultura pop e attualità nato online e costruito sul linguaggio della rete, individua un momento di svolta: «Nel 2016, con l’elezione di Trump, frequentando ambienti online come 4chan, ho visto persone organizzarsi a partire da meme, immagini e slogan condivisi, fino a intervenire concretamente su eventi reali. È in quel momento che ho capito che i meme non stavano più solo commentando la realtà, ma contribuivano a costruirla».

I meme parlano soprattutto a un pubblico giovane, spesso distante dai media tradizionali, offrendo una forma di partecipazione che passa attraverso il riconoscimento simbolico più che attraverso l’approfondimento. Il rischio è che l’adesione a una posizione prevalga sulla comprensione dei temi. Eppure, secondo Ranpo, questa è una caratteristica strutturale del mezzo: «Il meme non sostituisce l’analisi, la rimanda. Sta a chi lo riceve decidere se fermarsi alla superficie o andare a spacchettarne i significati». La questione non è stabilire se i meme siano “buoni” o “cattivi”, ma riconoscere il ruolo che hanno assunto.
In un ambiente informativo dominato dalla velocità e dalla saturazione, questi frammenti visivi sono diventati uno dei principali filtri attraverso cui eventi e conflitti vengono percepiti. Ignorarli significa rinunciare a comprendere una parte decisiva del presente; accettarli senza strumenti critici equivale a delegare la costruzione del senso comune a un linguaggio che privilegia l’impatto sull’argomentazione. Tra questi due estremi si gioca una sfida culturale che riguarda non solo chi comunica, ma soprattutto chi osserva, condivide e interpreta.
1. Distracted boyfriend meme: Fotografia stock di Antonio Guillem, diventata virale nel 2017, è un meme riutilizzato in molti contesti 2. Power of memes: illustrazione generata con AI che mostra un dibattito politico invaso dall’estetica dei meme 1

L'influencer si racconta: dalla nascita della passione per l'armocromia al successo raggiunto sui social
«All’inizio molte persone venivano perché era il trend del momento. Si tratta in realtà di una ricerca molto più interiore e profonda per capire che cosa si vuole comunicare al mondo» racconta Ferdinando Schetti, giovane consulente d'immagine che ha iniziato ad interessarsi al mondo del colore «per puro caso» appena prima dell’arrivo della pandemia Covid. L’armocromia, analisi che mira a individuare le tonalità che valorizzano l’aspetto estetico della persona armonizzando con carnagione e tratti somatici, è esplosa come fenomeno pop poco tempo fa. La sua esistenza risale però a inizio Novecento: negli anni Venti del secolo scorso la tecnica cinematografica del technicolor veniva utilizzata per dare sfumature cromatiche alle immagini dei film dell’epoca. Negli ultimi anni, grazie alla viralità di questa nuova moda sui social media, sempre più persone hanno iniziato a rivolgersi a consulenti d’immagine per capire quali colori avrebbero messo maggiormente in risalto il loro volto, rendendolo più luminoso e valorizzato.
«Nel 2019 ho scoperto questa materia attraverso video americani sui social. In quel periodo l’armocromia non era ancora in voga in Italia. Ho sempre amato il mondo della moda, dell’estetica, del colore e della comunicazione. Studiare è stato molto naturale, ma non immaginavo assolutamente una futura pro -
fessione». Al contrario delle aspettative iniziali, con il tempo Ferdinando si rende conto che le cose sarebbero potute andare diversamente: «è stato quando ho iniziato a percepire che le persone si stavano davvero fidando di me e di quello che facevo, che ho realizzato per la prima volta che avrei potuto fare di questa passione il mio lavoro».
Ferschetty, questo il nickname scelto per le sue pagine social, è riuscito negli anni a crearsi una solida community che ad oggi conta su Instagram oltre centomila follower. «I social media sono stati il canale che mi ha portato più lavoro. All’inizio è difficile capire come approcciarsi, ma anche a piacerti vedendoti in camera ogni giorno». Tuttavia, ammette che la parte più complessa in assoluto è «affrontare la parte negativa delle persone, combattere con chi ti accusa di essere un fallito o un truffatore. Con il tempo ho imparato a prendere consapevolezza che la mia energia non può arrivare a tutti».
La sfera social è però solo un pezzo della sua vita lavorativa, che consiste soprattutto nella consulenza d’immagine con il cliente in forma diretta. «Molte persone si affidano a me per semplificarsi la vita. Per esempio, nel mondo dello shopping, sapere quali colori comprare. Se invece l’obiettivo è rimodellare la tua immagine a 360º per caratterizzarti, quindi darne una sensazione più potente, si può andare a lavorare per disarmonia: se a una persona sta bene il blu, io consiglio l’arancione, che è l’esatto opposto».
Oggi, con alle spalle oltre sei anni di esperienza, Ferdinando afferma: «La cosa che mi piace di più di questo lavoro è il creare grande empatia con i clienti. Le persone sanno come lavoro e
mico e Ida Di Filippo, agenti immobiliari molto popolari grazie
Ferschetty è stato inserito dalla rivista Fortune Italia tra i top 25
gine capace di creare un impatto a livello comunicativo, la cui


La comunità letteraria nata su TikTok sta influenzando il mercato editoriale, le librerie e il rapporto tra lettori e libri. Un fenomeno che nasce online e trova nel mondo reale la sua evoluzione più concreta
Le librerie cambiano il modo di organizzare gli scaffali, le case editrici collaborano con i creator e i libri tornano a circolare attraverso il passaparola. Al centro di questa trasformazione c’è BookTok, la community di TikTok che ha trasformato la lettura in un fenomeno condiviso.
Proprio all’interno della piattaforma spesso associata a contenuti di intrattenimento leggeri e immediati, i libri hanno trovato uno spazio inatteso. Scorrendo la for you page, la schermata principale dell’app con contenuti personalizzati in base ai gusti dell’utente, può capitare di entrare in una zona in cui l’algoritmo non propone balletti o sketch, ma video di lettori appassionati che raccontano le loro esperienze di lettura.
Così come TikTok, anche Instagram funziona come luogo dell’incontro casuale con una storia. YouTube, invece, con i suoi video lunghi e un sistema basato su una ricerca autonoma dei contenuti, è meno accessibile per la fase di scoperta ma favorisce una relazione continuativa e una maggiore fidelizzazione sul lungo termine. Nell’era in cui c’è un social per tutto, ognuno con un linguaggio specifico, è TikTok a rivelarsi il più efficace nel far emergere nuovi titoli e nel portarli all’attenzione di utenti che, spesso, non stavano cercando un libro. Il vero merito della piattaforma è proprio quello di aver trasformato i
libri in oggetti popolari, di tendenza, e quindi desiderabili anche agli occhi di chi non ne aveva mai sentito la necessità. A osservare questo cambiamento dall’interno è Gaia Lapasini, book content creator attiva tra YouTube, Instagram e TikTok, che da anni racconta i libri sui social intercettando pubblici diversi: «BookTok ha spostato la lettura da dovere a puro piacere: non si legge perché si deve imparare qualcosa, ma perché si vuole vivere una storia».
Questa community funziona perché non propone semplicemente titoli da acquistare, ma crea un senso di appartenenza: leggere quel libro significa, come racconta Lapasini, entrare in una conversazione già avviata, riconoscersi negli stessi riferimenti. Non a caso, i romanzi più popolari sulla piattaforma sono proprio quelli che generano forti emozioni e che permettono ai lettori di vivere un’esperienza immersiva.
Più di recente anche il mondo dell’editoria ha cominciato a confrontarsi con questa trasformazione. Molti autori si iscrivono a TikTok per avere interazioni dirette con i lettori, altri pubblicano il loro primo romanzo proprio grazie al seguito raggiunto sulla piattaforma. Le case editrici, invece, hanno iniziato a collaborare direttamente con i content creator, riconoscendo in loro il mezzo più efficace per raggiungere il target desiderato.
Anche i negozi fisici si stanno adattando al cambiamento: da qualche anno, entrando in libreria, è probabile ritrovarsi davanti la sezione BookTok, dedicata ai libri di tendenza sulla piattaforma. L’esempio più recente è l’inaugurazione della Feltrinelli Book Bubble a Milano a dicembre 2025. Nella nuova sede della catena i libri non sono organizzati per genere o in ordine alfabetico, ma secondo categorie che richiamano direttamente il linguaggio di BookTok: accanto a sezioni emotive divise per intensità, come lacrimuccia, singhiozzo o devasto, compaiono categorie come i mattoni o quanto tempo hai? con sottosezioni pensate per una sera, per un weekend o per una settimana. Si tratta di una scelta che asseconda il cambiamento e che aiuta il lettore ad orientarsi seguendo le logiche di scoperta già familiari sui social.
Anche coloro che si occupano di recensire e parlare di libri online ci tengono a restituire la passione per la lettura al mondo reale. Nel 2023 è nato, da un’idea di Giulia Buzzoni e Gaia Lapasini, il progetto Viaggiare coi libri: «A un certo punto ci siamo rese conto che l’online non bastava più ed era necessario incontrarsi anche dal vivo».
Da reading party e picnic letterari fino a veri e propri ritiri di lettura di un fine settimana, è forse qui che si coglie meglio il senso del fenomeno BookTok: incontrarsi dal vivo e trasformare ciò che prende forma tra video e commenti in un’esperienza condivisa e tangibile. Proprio la generazione che sembrava destinata a sostituire i libri con gli schermi ha usato quegli stessi schermi per riportare al centro la lettura. In questo modo i libri, seppur passando per il digitale, ritornano tra le mani delle persone e non vengono percepiti dai più giovani come dovere ma come forma di piacere e intrattenimento.

La storia del fondatore di IdentifAI, start-up che vende sistemi di riconoscimento di immagini, audio e video generati dall’intelligenza artificiale
di Michelangelo Mecchia
Marco Ramilli si ricorda di quel giorno. La foto di Papa Francesco avvolto in un piumino griffato sta inondando i social. I giornali di tutto il mondo la rilanciano; da marzo 2023 la parola deepfake irrompe nel dibattito pubblico. Ramilli intuisce il pericolo; come cittadino, si preoccupa per il futuro della democrazia e della corretta informazione. Ma è anche un imprenditore. E in quella foto vede un’opportunità di business: si chiama IdentifAI, una start-up che in appena un anno ha raccolto 7,2 milioni di euro.
Nella sua vita precedente Ramilli era un ricercatore nel campo della cybersicurezza. Prima una laurea in informatica all’Università di Bologna, poi un dottorato di ricerca all’UC Davis, in
California, nel regno della tecnologia: «Sono ed erano avanti anni luce sul digitale». A dodici anni ha posato per la prima volta lo sguardo su un monitor: «Mio padre aveva acquistato un 286 di IBM, con il quale gestiva il magazzino di famiglia, una piccola azienda nel settore calzaturiero». Comincia a compulsare il computer, tra mensole polverose e scaffali colmi di lacciuoli e solette.
Nel suo settore, la cybersecurity offensiva, devi pensare e agire come un hacker. Ci sono società che ti pagano per bucare i loro siti e testarne le difese. Lo fanno anche gli Stati; Ramilli ha lavorato per il National Institute of Standards and Technology, un’agenzia del governo federale degli Stati Uniti d’America: «Quello che facevo era guardare i sistemi di voto elettronico. Sono sicuri?
Oppure ci può essere qualcuno che lo può violare e di conseguenza può compromettere un’elezione»? Ormai «saranno sistemi antiquati», ma preferisce non scendere nei dettagli. Ramilli è passato anche per Palantir. Oggi è una corporazione che genera miliardi di ricavi e accumula commesse con il Dipartimento della Difesa, ma al tempo era ancora una start-up, di quelle in cui si respira «la bellezza del garage». Eppure Peter Thiel (già co-fondatore di PayPal, eminenza grigia di Palantir) pianificava l’espansione oltreoceano: «Quando hanno scoperto che parlavo l’italiano mi hanno chiesto di tornare a casa, per aprire una filiale».
L’informatico rientra in Italia con un percorso già definito davanti a sé: «Era una start-up in crescita e avevo un ruolo apicale in Italia, quindi avrei potuto ambire a un ruolo apicale in Europa». Ma per la prima volta Ramilli ragiona da imprenditore: si rende conto che l’Italia ha accumulato ritardi sul fronte cybersecurity. Lascia Palantir - «una mossa da pazzo» - e fonda Yoroi, azienda che sviluppa e gestisce sistemi di difesa informatica. Nel 2024 il gruppo italiano Tinexta/Cyber ha completato l’acquisizione della società; per rilevarne la proprietà ha versato, in due tranche, più di quaranta milioni di euro.
Ora Ramilli si occupa a tempo pieno di IdentifAI, la sua nuova creatura. Con l’avanzare dello sviluppo tecnologico le tecniche deepfake vengono affinate e il confine che separa realtà e finzione, di riflesso, si fa sempre più labile. Le immagini suscitano emozioni forti, possono spostare opinioni; i social media fanno il resto, amplificandone la diffusione (perché l’algoritmo premia contenuti divisivi, che polarizzano). L’imprenditore insiste su un punto: «La tua mente non può competere contro questa tecnologia». Si tratta di riequilibrare i rapporti di forza: «Solo nel momento in cui tu sai che quel contenuto è stato creato artificialmente diventa un confronto equo. Altrimenti è una lotta impari».
Ramilli si intesta una missione civica, va oltre il tradizionale paradigma d’impresa (orientato esclusivamente al profitto): non pretende di risolvere il problema - «è troppo grande» - ma di contribuire. «Se poi la disinformazione sarà più grande di noi d’accordo», dice con un filo di rassegnazione, «però quello che vogliamo fare è offrire gli strumenti per poterci difendere; le conseguenze altrimenti potrebbero essere devastanti».
Così mentre Big Tech punta tutto sulla tecnologia generativa Ramilli ha deciso di scommettere sull’«IA degenerativa»: i sistemi sviluppati da IdentifAI scompongono il contenuto (ad esempio, un’immagine) e lo esaminano a fondo, alla ricerca di tracce (come regolarità innaturali o altri dettagli che provano l’origine artificiale del prodotto). L’algoritmo non ti restituisce una risposta univoca (sì/no) ma quantifica la probabilità che il contenuto sia stato realizzato dall’IA. Al netto delle tecnicalità informatiche alla base c’è un’intuizione semplice: «se l’IA è così brava da illudere l’occhio umano, proviamo ad addestrare l’IA a riconoscere i deepfake».
In teoria gli organi d’informazione sono i clienti naturali della start-up. Eppure i media - ad eccezione de Il Sole 24 Ore, che ha siglato una partnership con IdentifAI - hanno manifestato scarsa attenzione verso il tema.

Ritratto di Marco Ramilli, Ceo e fondatore di IdentifAI
«Ci aspettavamo di più; l’idea era di lavorare con i giornalisti», confessa Ramilli, «però mi rendo conto che oggi il settore è in difficoltà, quindi capisco che possono fare fatica a dotarsi di nuove tecnologie». Dunque chi acquista i servizi di IdentifAI? «Principalmente banche o assicurazioni: se fai un incidente in macchina con un danno da 300 euro, fotografi il graffio e lo fai diventare un danno da 1700 euro... è fondamentale effettuare verifiche, per evitare frodi».
E anche se i media tradizionali adottassero questi strumenti potrebbe non essere sufficiente; si dovrebbe intervenire sulle piattaforme social effettuando «controlli a monte». In concreto, «verifiche sui contenuti» - attraverso l’ausilio di sistemi degenerativi - non appena vengono caricati, in maniera automatica, di modo che agli utenti venga segnalato, fin dal principio, che si tratta di un deepfake. Perché una notizia falsa corre più velocemente della sua smentita. Ramilli è ottimista: «ci si arriverà. Altrimenti le persone perderanno interesse per il digitale».
«I deepfake sono foto, video e audio creati grazie a software di intelligenza artificiale che, partendo da contenuti reali, riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce»
Garante per la protezione dei dati personali
La Commissione Integrata Pari Opportunità del Cnf ha avviato dei gruppi di studio per indagare i rischi di un uso indiscriminato delle nuove tecnologie nella professione. «Ci siamo accorti che la magistratura spesso si affida agli algoritmi per emettere sentenze»
di Sofia Vegezzi
Anche gli avvocati iniziano ad interrogarsi sull’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di deliberare delle linee guida che aiutino la categoria ad orientarsi in una tecnologia tanto preziosa quanto piena di pericoli. «Si tratta di diritto e democrazia: è in gioco il modo stesso in cui si amministra la giustizia e si tutela la persona».
«Ci siamo accorti che anche la magistratura spesso si affida agli algoritmi addirittura per emettere delle sentenze», racconta Domenico Rocco Lombardo, componente della Commissione Integrata Pari Opportunità. «Leggo frequentemente menzioni di norme, leggi o precedenti giurisprudenziali che non c’entrano nulla con un caso specifico, ma in cui l’uso degli algoritmi non è dichiarato. Se non diamo una coscienza etica all’immissione dei dati e alla revisione critica del risultato, si rischia di andare incontro a delle distorsioni evidenti».
L’idea è nata durante il Congresso Nazionale Forense tenutosi a Torino nel 2025, la massima assemblea dell’avvocatura italiana, dove si delibera su temi cruciali riguardanti giustizia, professione forense e tutela dei diritti fondamentali. «Questa volta il Congresso si è posto il macro tema “L’avvocato nel futuro. Pensare da legale, agire in digitale”», racconta Lombar-
do, la cui Commissione funge da raccordo tra i Comitati Pari Opportunità territoriali e il Cnf per promuovere formazione ed iniziative per una professione più inclusiva e rappresentativa legate a fattori quali età, genere o abilità fisica. Proprio da Lombardo e dalla collega Pina Rifiorati è arrivata una mozione, convertita in raccomandazione, per chiedere al Cnf e ad altri organi istituzionali di eliminare discriminazioni e disuguaglianze sia nell’uso sia nell’accesso all’IA.
I rischi sono diversi. «Un legale di provincia che lavora in uno studio monovalente ha una possibilità di accedere alle strumentazioni dell’IA ridotta rispetto a quella di uno studio composto da numerosi avvocati che operano in grandi città, con maggiori risorse economiche», nota Lombardo.
Si apre così una discriminazione interna alla categoria: se prima la formazione accademica e l’esperienza sul campo erano alla base della professione, ora questo accesso non controllato apre ulteriori dubbi. Un altro pericolo riguarda l’incorporazione nell’IA di data set che replicano disuguaglianze linguistiche. «Possono farci tornare indietro nel tempo, riproponendo stereotipi e pregiudizi che con tanta

fatica stiamo superando, in cui, ad esempio, i ruoli di potere sono quasi sempre declinati al maschile». È per approfondire questi temi che la Commissione Pari Opportunità ha istituito quattro gruppi di studio, coordinati da Lombardo. Le potenziali discriminazioni interne alla professione sono affrontate dal primo nucleo, coordinato dall’avvocato Fabio Farruggia.
Il secondo, gestito da Lombardo, guarda alla creazione di un approccio etico per diffondere nella categoria un occhio critico a questi strumenti. La giuslavorista Tatiana Biagioni coordina il terzo gruppo, finalizzato alla prevenzione dei bias cognitivi in ambito pari opportunità. Infine il quarto gruppo, gestito da Rifiorati, studia il modo in cui l’IA può influenzare linguaggio e stereotipi di genere.
I gruppi raccoglieranno gli approfondimenti e gli accordi degli avvocati e delle avvocate dei Comitati Pari Opportunità, «con l’obiettivo di restituire entro fine anno un testo o di un vademecum che possa diventare un riferimento nell’approccio all’IA per l’intera categoria forense».


Mercy: Sotto Accusa (2026)
Regista: Timur Bekmambetov
L’intelligenza artificiale non è un protagonista nuovo nella cinematografia. Da decenni registi e sceneggiatori si interrogano sul ruolo di robot ed entità ambigue che incarnano di volta in volta utopie o distopie generate dall'evoluzione tecnologica, capaci di portare l'umanità verso un idillio dove chiunque può diventare ricco e felice, o verso un inferno in cui le persone sono ridotte a schiavi dalle macchine. Solo recentemente, però, queste rappresentazioni hanno lasciato gli immaginari futuristici ambientati a secoli di distanza da noi, per assumere una prospettiva sempre più vicina.
È il caso di Mercy, thriller fantascientifico del 2026 diretto da Timur Bekmambetov e basato sull'esistenza di Maddox (Rebecca Ferguson), un sistema di giustizia automatizzato e basato sull'IA. Nella Los Angeles del 2029, chiunque sia accusato di un reato viene portato davanti a Maddox, dove avrà solo 90 minuti per dimostrare la propria innocenza, pena la condanna a morte. Nonostante l'idea dalle grandi potenzialità, il film fa vestire all'IA i panni dell'archetipo del cattivo a cui siamo abituati nei film fantascientifici. Non solo non vengono esplorate le motivazioni che hanno portato gli umani a progettare l'ologramma del giudice con queste modalità, ma non viene esplorata la complessità etica della delega giudiziaria all'IA, che viene invece normalizzata come arbitro finale del destino umano.
Il sistema progettato in Mercy unisce il tema dei dati personali e della sorveglianza digitale senza mai interrogarsi davvero sulle implicazioni morali e sui bias che un algoritmo di questo tipo potrebbe avere, specialmente in un futuro così prossimo a quello attuale. Il messaggio finale è quello tipico dei film sci-fi: la fallibilità tanto degli umani quanto delle macchine, senza offrire un'analisi più sfumata del perché e di come queste ultime possano amplificare o mascherare determinate ingiustizie.
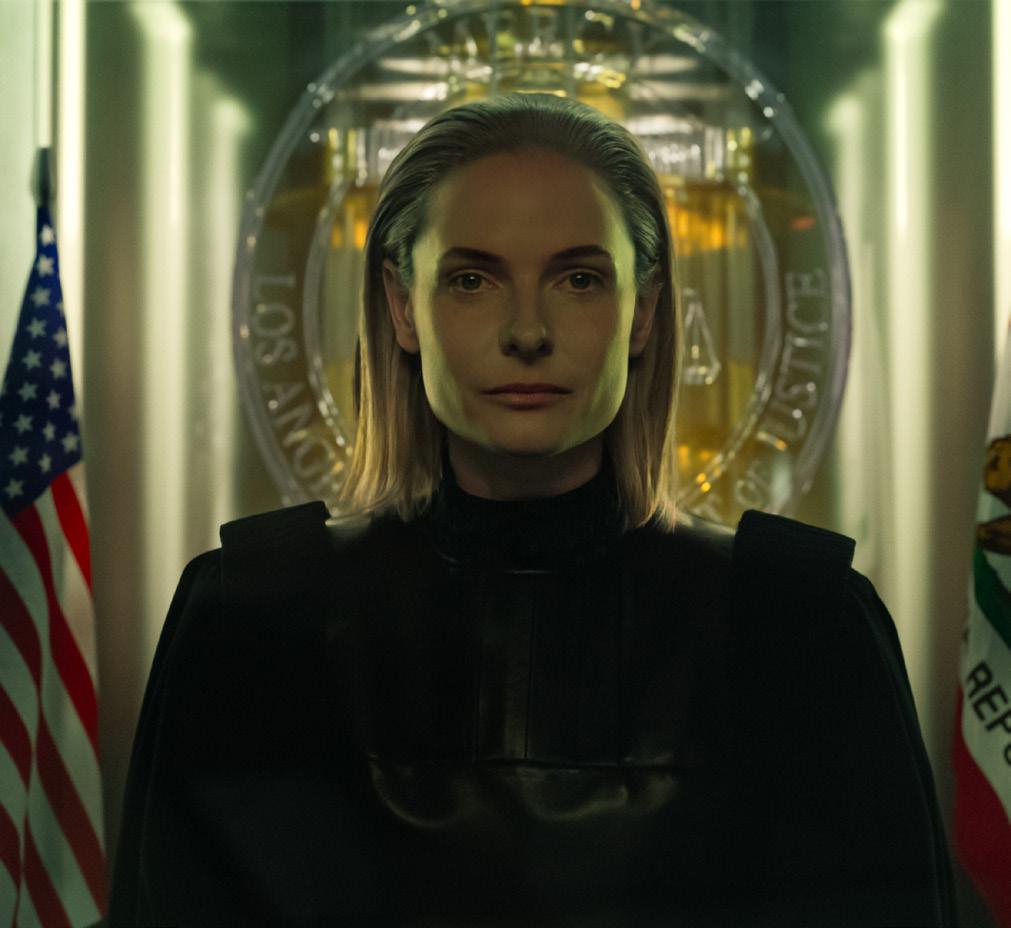
L’indice GDPval dice che l’AI può superare i migliori esperti umani in metà dei loro compiti lavorativi
di Gianluca Brazzioli
Siamo passati dalla fase dello stupore a quella del calcolo. Se fino a un anno fa ci chiedevamo se un’Intelligenza Artificiale potesse scrivere un testo credibile, oggi la domanda è molto più diretta: questi modelli possono fare il mio lavoro?
Per rispondere, l’industria tecnologica si affida ai benchmark: test standardizzati pensati per misurare l'intelligenza dei modelli linguistici (LLM). I test a risposta multipla di matematica, logica o comprensione del testo (come il famoso MMLU) non bastano più. È in questo contesto che si inserisce lo sviluppo di GDPval (Gross Domestic Product validation) da parte di OpenAI. Un nuovo standard di riferimento progettato per testare gli utilizzi reali dei modelli nell’economia.
A differenza dei test accademici, GDPval simula attività lavorative tratte da 44 diverse occupazioni nei 9 settori principali che contribuiscono al prodotto interno lordo americano. Si chiede all'AI di svolgere attività selezionate tra quelle eseguibili interamente in digitale: analizzare fogli di calcolo finanziari, scrivere report o debuggare codice.
L’output viene poi confrontato con una soluzione fornita da esperti umani del settore specifico. I risultati di GDPval rilasciati da OpenAI indicano che il miglior modello attuale, GPT-5.2, riesce a superare la qualità del lavoro umano in quasi il 50% delle attività proposte dal benchmark.
Un output di qualità pari o superiore a quello umano è fornito in più del 70% dei casi. Altri LLM che offrono ottime prestazioni sono i modelli Claude di Anthropic e Gemini di Google.
L'introduzione di GDPval solleva un evidente conflitto di interesse: OpenAI si trova nella doppia veste di creatore della tecnologia e arbitro che ne misura l’efficacia. Non stupisce che i risultati indichino proprio il loro modello (GPT-5.2) come il più performante.
A questo si somma la “Legge di Goodhart”, formulata dall'economista britannico Charles Goodhart, un principio statistico secondo cui “quando una misura diventa un obiettivo, cessa di essere una buona
misura". Se gli sviluppatori sanno di essere giudicati su specifiche attività del benchmark, tenderanno inevitabilmente ad addestrarli per performare nel test. Il rischio è creare modelli che eccellono sulla carta ma che possono disattendere le aspettative nell’utilizzo reale.
C'è poi un problema di contesto. I benchmark valutano l'AI in un ambiente controllato, ed esiste una differenza sostanziale tra eseguire un compito singolo e svolgere una mansione lavorativa completa. Un modello può risolvere perfettamente i quesiti di GDPval, ma fallire se la richiesta devia dai parametri standard o richiede una comprensione del contesto più ampio.
Infine, l'adozione reale si scontra con l'affidabilità. L'esperienza utente è spesso minata dalle cosiddette "allucinazioni" – errori fattuali esposti con estrema sicurezza – e dalla difficoltà dei modelli di mantenere coerenza su lunghi periodi.
Quando il modello sbaglia non si blocca, ma fornisce risposte errate, danneggiando l’utilizzatore e divergendo dal suo scopo. L’onere finale ricade sull'umano, generando un problema di fiducia e responsabilità.
GDPval dimostra tecnicamente che il carico di lavoro cognitivo umano può essere svolto da una macchina. In molti settori la "sostituzione" dell’uomo è tecnicamente plausibile sui singoli compiti ma il cambiamento non è esente da rischi e attriti. Per ora, i benchmark ci dicono che abbiamo costruito degli strumenti prestanti ed efficaci, il problema è che molte aziende stanno ancora cercando di capire come utilizzarli.
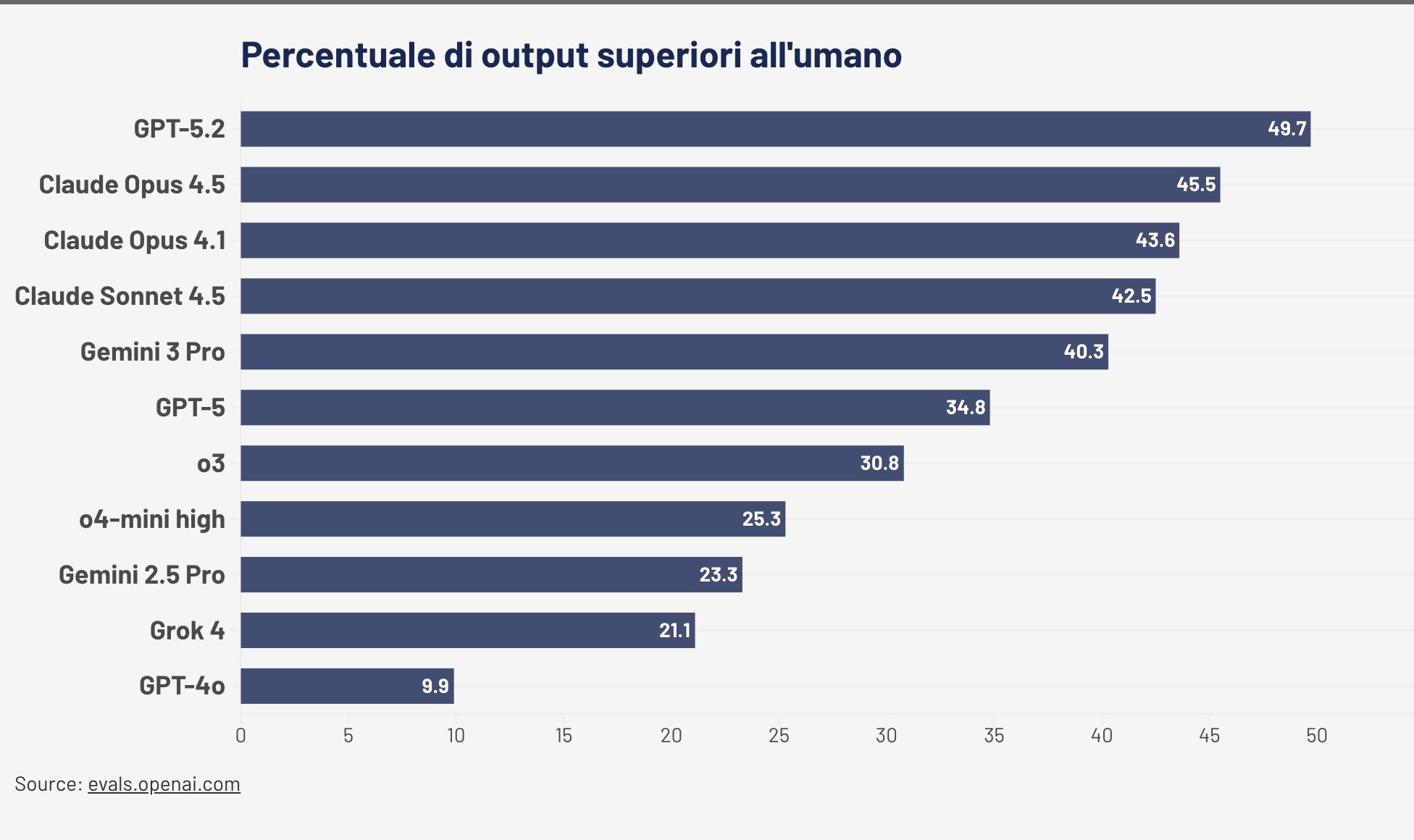
Un lavoro di analisi condotto da giovani ricercatori mette in evidenza come le fonti aperte, se usate con metodo, possano contribuire alla comprensione di scenari di rischio complessi. Mirko Lapi richiama l’importanza di competenze analitiche e rigore interpretativo
di Gianmaria Oroni
Sette studenti, cinque settimane di lavoro, migliaia di chilometri percorsi e decine di migliaia di dati analizzati. L’inchiesta realizzata dagli allievi dell’Axel Springer Academy for Journalism and Technology ha portato alla luce un quadro inquietante: navi mercantili con equipaggi russi che stazionano senza apparente logica commerciale al largo delle coste tedesche e olandesi, in coincidenza temporale con sciami di droni sopra basi militari e infrastrutture sensibili. Nessuna prova definitiva, ma un insieme coerente di indizi che le autorità faticano, o scelgono, di non chiarire.
Il punto di forza del lavoro non sta tanto nella tecnologia quanto nel metodo. L’indagine si è basata sull’analisi continuativa dei tracciati AIS/GPS delle imbarcazioni, utilizzando serie storiche per identificare anomalie operative come loitering, rotte circolari e variazioni improvvise di velocità o destinazione. Questi pattern sono stati poi correlati con finestre temporali sensibili e verificati tramite riscontri sul campo, seguendo fisicamente le navi per validare le evidenze emerse dai dati open source. È ciò che sottolinea Mirko Lapi, analista ed esperto di Open Source Intelligence (OSINT). «Non è una somma di ricerche online», spiega. «È un processo analitico che mette in relazione dati eterogenei nel tempo e nello spazio, cercando pattern, sincronizzazioni e anomalie». In altre parole, dati che da soli dicono poco, ma che insieme costruiscono una narrazione plausibile. Le cifre emerse dai documenti riservati della polizia federale tedesca, il Bundeskriminalamt, rafforzano l’allarme: centinaia di episodi, droni quasi sempre non identificati, spesso sopra installazioni militari. Un fenomeno che non può più essere liquidato come l’opera di appassionati o curiosi. È qui
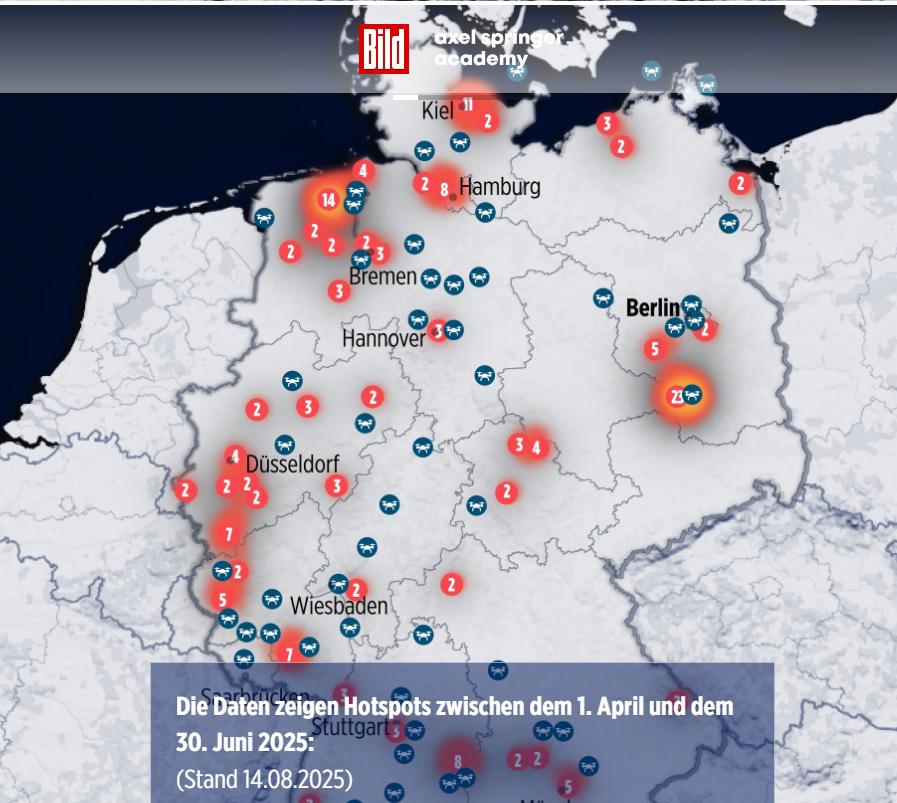

che il caso tedesco smette di essere una storia locale e diventa una questione europea. Per l’Italia il parallelismo è inevitabile. «Condividiamo le stesse vulnerabilità strutturali», osserva Lapi. «Un Paese a forte proiezione marittima, con porti strategici, basi militari costiere, terminal energetici, cavi sottomarini. Tutti elementi che rientrano pienamente nelle logiche della minaccia ibrida». In questo contesto, OSINT può svolgere un ruolo chiave soprattutto in chiave preventiva: non per “scoprire il colpevole”, ma per aumentare la consapevolezza del contesto e ridurre l’effetto sorpresa per chi deve decidere.
Resta però un nodo culturale. In Italia l’OSINT è ancora spesso percepita come una versione sofisticata di Google. Un errore che rischia di svuotarla di senso. «Non è la fonte a qualificarlo, ma l’uso che se ne fa», insiste Lapi. Senza solide competenze analitiche, conoscenza geopolitica e capacità di gestire i bias cognitivi, i tool diventano amplificatori di errori e false correlazioni. L’inchiesta tedesca offre anche una lezione di prudenza. Gli autori dichiarano apertamente i limiti del loro lavoro: correlazioni non sono causalità. «L’OSINT è sempre gestione dell’incertezza», ricorda Lapi. «La sua forza sta nell’equilibrio tra raccontare una storia credibile e non trasformare un’ipotesi ben costruita in una verità non dimostrata».
È forse questa la sfida più attuale per il giornalismo investigativo italiano. In un ecosistema informativo sovraccarico e facilmente manipolabile, la tecnologia non basta. Servono metodo, responsabilità e trasparenza. Il caso tedesco dimostra che le fonti aperte possono colmare vuoti lasciati dalle istituzioni. Tuttavia, senza una solida cultura analitica, il rischio non è l’ignoranza, bensì l’over-interpretazione. Una lezione che l’Italia farebbe bene a non ignorare.
1. Mappa dei droni identificati dall’inchiesta “They Droned Back”, condotta dall’Axel Springer Academy. Crediti: BILD – Aktuelle Nachrichten | BILD.de
2. Mirko Lapi, analista ed esperto di OSINT

Dalle vittime innocenti alla costruzione di comunità la memoria viva di Libera trent’anni dopo la sua nascita
di Desirèe Palombelli
Francesco Marcone è ad un passo dal portone di casa, quando sua figlia Daniela e sua moglie Pia lo trovano riverso a terra. È stato freddato da due colpi di pistola alle spalle, in quella che fin da subito appare come un’esecuzione mafiosa. Nessuno, però, ha visto né sentito nulla. È un orario di punta, la strada è frequentata, ma in quegli anni a Foggia è più sicuro farsi i fatti propri. Le indagini avanzano a fatica e solo nel 2002 si risale a chi, con ogni probabilità, ha fornito l’arma del delitto. Poco dopo, però, il sospettato muore in un misterioso incidente stradale e l’inchiesta viene archiviata nel 2004 per decesso dell’indagato.
Paolo Borsellino, omonimo del giudice e per questo rimasto nell’ombra per molto tempo, ha poco più di trent’anni quando decide di investire tutto nell’impresa di famiglia a Lucca Sicula, nell’agrigentino. Insieme al padre Giuseppe rileva un’azienda di movimento terra, lavorando in prima persona per farla crescere. Ma per sopravvivere servono nuovi soci e, in un territorio segnato da intrecci opachi tra affari e criminalità, l’ombra
«Il racconto dei vissuti dei nostri parenti è il modo di Libera per recuperarne la parte viva, per ricordare che sono persone prim’ancora che vittime»
della mafia diventa sempre più ingombrante. Costretti dall’indebitamento, padre e figlio accettano l’ingresso nell’azienda di un esponente della mafia locale. Paolo, però, continua a opporsi alle pressioni e alle richieste illegali. Non arretra, non si piega. Il 21 aprile 1992 viene ucciso con un colpo al cuore e trovato senza vita nella sua auto proprio dal padre Giuseppe, che pochi mesi dopo andrà incontro allo stesso destino.
Vite sospese, storie rimaste incomplete come un puzzle di cui si è perso l’ultimo pezzo. È in questo vuoto – di verità, di giustizia, di riconoscimento – che prende forma Libera.
A metà degli anni Novanta l’Italia è un Paese attraversato da profonde trasformazioni. Tangentopoli ha travolto il sistema politico tradizionale, la fiducia nelle istituzioni è fragile, mentre la violenza mafiosa ha assunto una dimensione nazionale. Le stragi di Capaci e via D’Amelio del 1992 e la stagione stragista del 1993 rendono impossibile continuare a considerare la mafia un problema distante o locale. Non più solo Francesco, Paolo o Giuseppe, ma centinaia come loro in tutta Italia.
In questo contesto cresce l’esigenza di nuove forme di partecipazione civile. Associazionismo, terzo settore e impegno dal basso diventano strumenti per ricostruire legami e responsabilità condivise. È qui che si inserisce l’intuizione di Don Luigi Ciotti, sacerdote nato fra le montagne di Pieve di Cadore e cresciuto nella Torino operaia, già fondatore del Gruppo Abele.
Il 25 marzo 1995 nasce infatti proprio grazie a Don Ciotti “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, con un obiettivo chiaro: coinvolgere la società civile nella lotta alle mafie e costruire alternative concrete alla criminalità organizzata.
Fin dai primi anni appare chiaro come per molte persone Libera non sia solo un’associazione, ma uno spazio di riconoscimento. «Incontrare Libera, appena un anno dopo la morte di mio padre, mi ha fatta sentire meno sola», racconta Daniela Marcone, figlia di Francesco Marcone e oggi referente del settore Memoria di Libera. «Mi ha fatto pensare che la mia storia potesse camminare fuori da Foggia».
Per Antonella Borsellino, a cui la mafia ha portato via il fratello Paolo e il padre Giuseppe, Libera rappresenta una possibilità di riscatto personale: «Dopo i loro omicidi ho vissuto momenti di profonda depressione. Libera mi ha aiutata a rientrare nel mondo e a sentirmi utile». Uno dei tratti distintivi di Libera, fin dalla sua nascita, è la capacità di tradurre l’indignazione in proposta. Emblematica la campagna che porta alla raccolta di oltre un milione di firme per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, diventata legge nel 1996. Oggi l’associazione è presente su tutto il territorio nazionale con presìdi, progetti educativi e percorsi di formazione, lavorando nelle scuole, nelle università e nelle carceri.
«Libera nasce nel 1995 per rispondere a un vuoto, come racconta anche la mia storia: quello lasciato dallo Stato e dalla società dopo le stragi e gli omicidi di mafia», commenta Marcone. «Ad oggi, il lavoro svolto dall’Associazione rimane più necessario che mai perché ci
sono vuoti che permangono. Le legislazioni non si sono evolute e dal punto di vista culturale, il fenomeno mafioso è sottovalutato. Ci sono territori ancora sotto scacco e Libera lì offre un’alternativa».
Ma uno dei pilastri più profondi dell’azione di Libera è il lavoro sulla memoria “viva”. Dal 1996 l’associazione cura l’elenco delle vittime innocenti delle mafie, restituendo un nome e una storia a chi per anni è rimasto solo un numero. Sono i familiari, supportati da Libera, a portare queste storie nelle piazze e nelle scuole.
«Il racconto dei nostri vissuti, per quanto estremamente faticoso, è il modo di Libera per recuperare la parte viva di queste storie. Quei bisogni, progetti e desideri che i nostri parenti avevano, per ricordare che sono persone prim’ancora di essere vittime. Memoria viva significa avere la capacità di riportare al presente quel passato e capirne la sua rilevanza oggi», racconta Marcone.
Ogni 21 marzo, Giornata della Memoria e dell’Impegno, quei nomi vengono letti nelle piazze insieme ai familiari. «Quando li sentiamo pronunciare, è un momento di riappacificazione», racconta Borsellino, familiare di due vittime che non hanno mai trovato giustizia. «Li ci sentiamo tutti uguali e uniti». Un gesto semplice, ma carico di significato: ricordare per riconoscere, riconoscere per non lasciare sole le famiglie.
A trent’anni dalla sua nascita, Libera continua a muoversi su questo crinale: tra memoria e futuro, tra denuncia e proposta. Un lavoro che non promette soluzioni facili, ma chiede responsabilità, continuità e partecipazione. Perché la lotta alle mafie non è solo una questione giudiziaria, ma una scelta quotidiana che riguarda tutti.

Il racconto di chi ha combattuto il contrabbando in prima linea

La notte del 16 gennaio 1998, alle porte di Polignano a Mare, quattro finanzieri furono travolti dai blindati dei contrabbandieri. Stavano per intercettare un grosso carico di sigarette. Sulla divisa di un brigadiere ancora oggi operativo, una barretta diagonale d’argento, concessa ai feriti in servizio, racconta di quell’operazione in cui rischiò la vita.
«Sei mesi di convalescenza, costole e gambe fratturate». Il fuoristrada che si schiantò a fari spenti contro l’autopattuglia aveva il paraurti rinforzato da due travi in ferro usate come ariete. «Guadagnavano una percentuale per ogni agente ferito». Poi l'“Operazione Primavera”, la più grande mai messa in campo contro il traffico di tabacchi, mise fine a quella stagione, ma non al contrabbando.
Da almeno due anni, secondo i dati dell’ultimo report della Guardia di Finanza, il contrabbando di tabacchi è tornato a crescere in Italia. Se un tempo i trafficanti potevano contare su una piccola flotta di velocissimi gommoni che sbarcavano sulle spiagge pugliesi o campane, oggi si assiste a un aumento delle fabbriche clandestine. Attive 24 ore su 24, impiegano centinaia di operai, costretti a dormire in alloggi di fortuna, con una capacità produttiva impressionante. Nel solo 2024 le fiamme gialle hanno complessivamente sequestrato oltre mille tonnellate di tabacchi lavorati, più del triplo rispetto
alla media degli otto anni precedenti. E il trend è proseguito nel 2025: nei primi nove mesi dell’anno i sequestri avevano già sfiorato le 740 tonnellate.
La Puglia è ancora un crocevia strategico nelle rotte del contrabbando. A luglio un’indagine dei finanzieri di Palermo ha permesso di scovare a Stornara, nel Foggiano, una delle maggiori fabbriche europee di produzione clandestina di sigarette, dove macchinari all’avanguardia sfornavano circa 2 milioni di esemplari al giorno. A novembre, poi, la scoperta a San Michele Salentino di una fabbrica simile, con una linea di montaggio complessa che impiegava fino a dieci persone, tutte arrestate.
Secondo il sociologo e scrittore Leonardo Palmisano, docente all’Università di Foggia, i tabacchi lavorati non sarebbero destinati al mercato locale, se non in minima parte, ma a quello estero: «In particolare Nord Africa e Europa dell’Est».
Dietro ai traffici ci sarebbe la mano del crimine organizzato, che secondo la Guardia di Finanza tende a concentrare la produzione di tabacchi illeciti «nel territorio nazionale e unionale, avvicinandosi al mercato di sbocco e riducendo i costi di trasporto». Nonostante i sospetti degli investigatori si concentrino su bande di romeni, moldavi e ucraini, Palmisano scommette su un coinvolgimento
delle mafie pugliesi e della camorra: «Sono loro i veri specialisti: sanno produrre, vendere e controllare le rotte marittime. E non disdegnano la manifattura, importando anche prodotti semilavorati».
«Oltretutto – aggiunge il sociologo – le indagini hanno rilevato una dimensione occupazionale: questo fa presupporre che esista una domanda rilevante di tabacchi di contrabbando». Un ritorno agli anni ’90, quando gli sbarchi notturni di sigarette erano una forma di lavoro per centinaia di persone che altrimenti non avrebbero avuto di che vivere.
Nel 2000 la morte di due finanzieri convinse il governo di allora a un’azione straordinaria anticontrabbando, l’“Operazione Primavera”. Furono inviati in Puglia 1900 uomini delle forze dell’ordine. Uno di loro era proprio il militare ferito a Polignano, che ha subito altri quattro speronamenti e quattro colluttazioni coi malviventi, intercettato numerosi sbarchi e blindati. «Parlavano via radio, noi li ascoltavamo. Ci chiamavano “i brutti”». Furono introdotte leggi e pene più severe, ma non è bastato.
Secondo l'ultimo report della Guardia di Finanza, il contrabbando di tabacchi è tornato a crescere
Il volto nascosto delle baby gang milanesi, tra disagio urbano, bisogno di appartenenza e percorsi di recupero ancora fragili
di Matilde Risi
«Ognuno parla la sua lingua, ma a ceffoni ci capiamo tutti meglio», racconta J., un ragazzo del quartiere Barona di Milano, che fino a qualche anno fa faceva parte di una baby gang della zona. Ha 17 anni, ma dalla statura e dai lineamenti sembra averne di più. Tiene il viso teso, lo sguardo diffidente; alla vista del registratore si irrigidisce, mostrando un evidente disagio. Un atteggiamento che contrasta con il suo passato giudiziario: una condanna per furto aggravato e lesioni, con due anni trascorsi in un istituto penale minorile.
Milano convive da anni con il fenomeno delle baby gang: gruppi di minorenni, che dalla ricerca di un’identità condivisa scivolano rapidamente verso episodi di aggressione e microcriminalità urbana. A confermare la persistenza del fenomeno sono anche i dati del Dipartimento per la Giustizia Minorile Italiana: nel 2022-2023, su un campione di minori e giovani adulti presi in carico dagli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni perché coinvolti in procedimenti penali, il 44% risultava interessato da più procedimenti e il 16% aveva commesso un nuovo reato dopo la prima presa in carico.
Per il pediatra Luca Bernardo entrare a far parte di una gang si tratta di un fenomeno che «intercetta fragilità profonde dell’età adolescenziale»; mentre la psicologa Federica Bertin sottolinea come le baby gang rispondano spesso a «ansie interiori» come frustrazione e impotenza riguardo al futuro, aiutando così i ragazzi a esorcizzare paura e solitudine attraverso un forte bisogno aggregativo.
Come evidenziato dalla ricerca di Transcrime del 2022 sulle gang giovanili in Italia, Milano, con la sua struttura urbana e le sue contraddizioni sociali, offre un contesto favorevole all’emersione del fenomeno delle babygang. La città cresce per accelerazioni e disuguaglianze: quartieri iperconnessi e vetrine della modernità convivono con periferie segnate da densità abitativa elevata, spazi di aggregazione
ridotti e un’offerta educativa e culturale frammentata. In questo contesto, l’urbanizzazione rapida e la pressione sociale legata al successo economico amplificano il senso di esclusione di una parte degli adolescenti. Le grandi infrastrutture di mobilità, come metropolitane e stazioni, diventano luoghi di passaggio e di presidio simbolico, facilmente appropriabili da gruppi giovanili in cerca di visibilità e controllo del territorio.
«Se c’è una cosa che insegna il carcere è prendersi le proprie responsabilità: io so cosa ho fatto e so di essere stato io a farlo, non il gruppo, non la città. Ma quando ci sei dentro è difficile afferrare questo concetto: sei troppo arrabbiato col mondo per poter capire che non gira intorno al tuo dolore», queste le parole di J., orfano di padre cresciuto solo con la madre e l’aiuto della nonna. In Italia ha sempre trovato il suo posto tra i figli degli immigrati e tra i ragazzi di periferia, a scuola non ha mai avuto voti alti perché comunque «ho sempre passato più tempo in piazza che tra i banchi, e nessuno se ne è mai preoccupato». Come si comprende dalle sue parole, il senso di abbandono riassume il motivo per cui J., e tanti altri come lui, scelgano il branco piuttosto che una vita in solitaria, lontano dalla violenza. «Nel gruppo trovi sicurezza,
nessuno ti giudica, ti senti intoccabile di fianco ai tuoi fratelli; poi, quando ti beccano, capisci che dietro le sbarre sarai da solo, esattamente come sei sempre stato prima del gruppo».
Dopo la detenzione, J. ha avviato un graduale allontanamento dalla baby gang, tentando di ricostruire la propria identità al di fuori della logica del gruppo. Un percorso complesso: come evidenziano Pyrooz e Decker, i legami sociali ed emotivi con la gang tendono a persistere, rendendo l’uscita difficile e il reinserimento nella vita ordinaria lento e fragile, spesso ostacolato da un “codice interno” che scoraggia la defezione.
«La prima rottura non è con il reato, ma con il gruppo», spiega Eugenio, educatore volontario al carcere minorile Beccaria. Lasciare la banda significa perdere protezione, status e relazioni, un passaggio profondamente destabilizzante. Il reinserimento avviene attraverso il supporto dei servizi sociali e della giustizia minorile: colloqui psicologici, accompagnamento educativo e rientro graduale in percorsi scolastici o formativi, talvolta in comunità educative. «All’inizio lavori sul presente», racconta J., «impari a stare lontano dalla strada e ad accettare aiuto».

Il Parlamento di Strasburgo ha approvato l'iniziativa "My voice my choice". Entro marzo la Commissione dovrà decidere. Laiga racconta la situazione in Italia
di Alice Pavarotti
«Questo voto rappresenta una grande vittoria per tutte le donne in Europa». Con queste parole la relatrice Abir Al-Sahlani (Renew, Svezia) ha commentato l’approvazione in Parlamento di “My Voice, My Choice”, un’iniziativa dei cittadini europei che chiede l’accesso all’aborto sicuro, legale e gratuito in tutti gli Stati membri. La proposta ha superato il milione di firme valide in tutta l’Unione europea, requisito necessario affinché la Commissione possa valutarla. Si tratta infatti di un’iniziativa dei cittadini europei (ICE), lo strumento che consente ai cittadini dell’Unione di invitare la Commissione a intervenire sul piano legislativo. Dall’introduzione dell’ICE con il Trattato di Lisbona, sono 13 le iniziative che hanno raggiunto questo traguardo.
La votazione si è tenuta il 17 dicembre e si è conclusa con 358 voti favorevoli, 202 contrari e 79 astensioni. I deputati chiedono alla Commissione di istituire un meccanismo finanziario volontario, sostenuto da fondi UE, su modello “opt-in”: gli Stati aderenti riceverebbero risorse europee per coprire i costi delle IVG effettuate a favore di donne da Paesi con accesso problematico. Sarebbe un cambiamento notevole: gli Stati contrari all’aborto non sarebbero obbligati a contribuire economicamente né a fornire il servizio sul proprio territorio, ma le loro cittadine potrebbero comunque spostarsi verso un paese aderente all’iniziativa, grazie a un sostegno economico dell’UE per le spese di viaggio, procedura e soggiorno.
Secondo i promotori, i costi potrebbero essere coperti dal programma "EU4 Health", che dispone di 5,3 miliardi di euro e include tra i suoi obiettivi il sostegno all’accesso alla salute sessuale e riproduttiva, ramo in cui potrebbe essere inserita proprio questa proposta. La Commissione europea dovrà ora valutare i prossimi passi: ha tempo fino a marzo 2026 per indicare se e come intende intervenire. Le ICE non sono giuridicamente vincolanti, dunque la Commissione dovrà decidere se intervenire con misure legislative o non (per esempio linee guida o programmi pilota).
L'aborto in Italia: Laiga racconta difficoltà, costi e accessibilità
Secondo l’European Abortion Policies Atlas 2025, una mappatura di leggi, politiche e accesso all’aborto in 49 paesi e territori europei, prodotto dal European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights (EPF) con un gruppo di esperti, l’Italia si colloca nella

metà più bassa della graduatoria. Per analizzare le criticità del sistema italiano, Laiga (Libera Associazione Italiana Ginecologi non obiettori per l’Applicazione della Legge 194) ha parlato con Zeta, delineando un quadro complesso: «Gli ostacoli in Italia sono molti e variano da ospedale a ospedale, da regione a regione. In alcuni casi non ci sono, in altri sono tempi di attesa, obiezione di coscienza, distanza da un ospedale che davvero effettui il servizio». Un altro aspetto cruciale è l’obiezione di coscienza: «I dati ufficiali fanno fatica a essere esattamente allineati alla realtà, perché vengono rilevati una volta all’anno e comunicati al pubblico in notevole ritardo (di anni), ma la situazione fotografata una volta all’anno dal report consegnato al Parlamento (tra il 60 e il 100%, a seconda dell’ospedale) è reale. Esistono ospedali italiani con il 100% di obiezione di coscienza, che, contrariamente alla legge, non si organizzano nemmeno per ricevere personale medico da ospedali della stessa regione» spiegano.
Infine, guardando al ruolo attuale dell’UE sul tema, commentano: «Speriamo che l'interruzione volontaria di gravidanza venga sempre più ufficialmente riconosciuta come servizio indispensabile per la salute pubblica».

Francesco Pacifico ci consegna una lettura antropologica sulla violenza di genere: un'intervista che verte sui temi del patriarcato, raccontato da La voce del padrone, del femminismo odierno e della decostruzione
«Poi è arrivato l’incontro con mia moglie, un’attivista femminista, e ho cominciato a ragionare sul mio vissuto», dichiara Francesco Pacifico, scrittore italiano. È autore de La voce del padrone, un libro-monologo che racconta le relazioni di dominanza e la subalternità delle donne, modellate sulla prospettiva maschile. Accennando alla sua storia personale, racconta: «Sono sempre stato scandalizzato dall’educazione ricevuta fin da bambino. Tanta violenza e controllo mi hanno cambiato per sempre. Con la scrittura da subito ho iniziato ad interrogarmi sulla religione, sulla mia vita, sul ruolo del denaro, delle classi sociali».
Dialogare con un uomo sulle questioni di violenza di genere è assai singolare. Questo perché, tra le molteplici declinazioni di femminismo, molte trovano una propria configurazione nel separatismo, una forma di associazionismo femminile che esclude l’altro sesso dalla narrazione. Pacifico, però, non assume una posizione giudicante. Vuole risalire a ciò che ha normalizzato. In termini di studi di genere, questa postura è rilevante: sposta il discorso dalla condanna esterna, alla responsabilità interna.
Lo scrittore nega l’idea di neutralità: «Sono scandalizzato da quanto io mi riconosca in tutte le definizioni di violenza sulle donne e, quando vado in giro, agli incontri, ormai sono abituato a definirmi misogino. Sono stato formato per modificare il mio atteggiamento quando sono con le donne, e ad averne un altro quando sono con gli uomini» È proprio questo uno dei meccanismi fondanti della mascolinità egemonica, spesso inconsapevoli: la doppia grammatica relazionale, che consente empatia e parità tra uomini, ma oggettivazione e paternalismo verso le donne.
L’appropriazione del potere avviene anche con la rottura dell’orizzontalità conversazionale, quando si interviene a mozzare un discorso cominciato da una donna poiché ritenuto irrilevante: «Di fronte alla continua interruzione», scrive nel libro-monologo, «(le donne) sembrano avere davanti due scelte, e l’una spesso non esclude l’altra: soffocare la rabbia oppure esprimerla sgraziatamente. Uno dei modi in cui le mettiamo a tacere in maniera più sottile è pretendere che si esprimano con grazia».
Pacifico dimostra così, ne La voce del padrone, l’impossibilità di un dialogo alla pari. La richiesta di moderazione e compostezza non è neutra: è una tecnica di silenziamento che sposta l’attenzione dalla sostanza alla forma. La violenza è, tra gli altri, la risultante della mancanza di educazione sessuo-affettiva: «Immaginiamo i carnefici come mostri. Ma a nessuno è mai stato insegnato davvero come avere un rapporto con una donna. Fino agli anni della mia formazione, le donne sono state presentate come oggetti. Nessuno dei miei coetanei è mai stato trattato come un matto perché ossessionato o pedante con una fidanzata. La formazione, oggi, può passare per la decostruzione». Con questo inciso vengono smascherati comportamenti abusanti spacciati per romanticismo e le micro-pratiche persecutorie legittimate.
La conclusione è inquieta, ma schietta e realistica: «Non riesco ad immaginare una società di massa che riprenda un movimento di evoluzione collettiva, come nel secondo dopoguerra». Una semplice ammissione di difficoltà. La decostruzione non fornisce narrazioni consolatorie, ma frizioni e resistenze. La scelta di restare dentro il disagio, di non proclamarsi innocenti, diventa così un atto politico minimo, ma imprescindibile per una transizione sociale di massa.

Mercanzia è un progetto di archivio vintage nato dall’iniziativa di tre fratelli di Caltanissetta, diventato oggi un raffinato negozio online di capi unici
Il copriletto della stanzetta dei maschi era il loro primo bancone. Sopra, una distesa di velluti e cotoni che Miriam, Rosario e Giovanni Criscuoli disponevano con la cura di chi sta allestendo una boutique. «Giocavamo a vendere vestiti. Adesso li vendiamo per davvero». Quei tre bambini sono Mercanzia: un negozio online e archivio di capi vintage nato a Caltanissetta, nel centro della Sicilia.
Non c’è un nastro inaugurale o una data ufficiale. La passione è un’eredità silenziosa, passata dalle mani dei genitori alle loro, tra le pagine delle riviste d'alta moda collezionate dalla madre che sfogliavano fin da piccoli.
Nel 2022, quella curiosità ha preso la forma di un pacco sigillato per Vinted, per poi espandersi in un negozio online e, finalmente, in un luogo fisico fatto di stender e specchi. Mentre la vita a Caltanissetta scorre con i suoi ritmi lenti, nel loro archivio il tempo si ferma «sono quattro mura, ma è il nostro rifugio, dove passiamo la maggior parte della giornata», dice Miriam. Dopo il silenzio del Covid, i tre hanno iniziato a macinare chilometri. Le suole delle scarpe si sono consumate tra i banchi dei mercati vintage di tutta Italia e dell'estero, nelle città dove l'abbigliamento d'epoca è un culto, a caccia di quel pezzo unico che potesse

finire in un armadio contemporaneo. «Ci siamo resi conto che nessuno faceva vivere il vintage come lo sentivamo noi. Abbiamo deciso di far parlare gli abiti, di trasformare il racconto di un'epoca in un modello di business».
Non ci sono lauree per questo: la loro accademia è stata imparare a riconoscere una fibra naturale al tatto e battere la testa contro acquisti sbagliati. Se Milano sembra la città più adatta, loro invece hanno scelto di rimanere a Caltanissetta.
Rosario solleva una giacca degli anni ’50: non guarda solo il taglio, ne scruta le cuciture interne, cercando l'impronta di chi l'ha indossata prima. È un’analisi scientifica, un’autopsia del costume che rifiuta l'approssimazione. È la loro risposta al fast fashion: pezzi unici recuperati da una selezione al dettaglio, – con la stessa cura di scava negli armadi dei nonni per saltare liberamente sulla linea del tempo e fuggire dall'omologazione.
Si sente solo il suono del metro a nastro e il fruscio delle riviste. «Cataloghiamo ogni pezzo per tipologia, ne ricostruiamo la storia e poi lo carichiamo sul sito. I capi non arrivano in balle da comprare a peso: mancherebbe la magia», racconta Rosario. Sui social, lo zoom si ferma su un'etichetta sbiadita o su una cucitura nascosta.
Miriam è pragmatica: «I pezzi che facciamo parlare nei reel su Instagram sono quelli che vediamo di più». È un linguaggio che funziona: dalle felpe stile Steve McQueen alle magliette che sembrano uscite dal guardaroba di Paul Mescal o Sfera Ebbasta, fino ai capi scelti per gli attori di “Nathan K.”, la serie RaiPlay del 2025. Nel mondo di Mercanzia non ci sono agenzie esterne. I fratelli Criscuoli posano, sbagliano e scattano da soli: ognuno filtra il mondo con la sua lente – dice Giovanni – e tutto resta in famiglia. Inquadrano i fratelli più piccoli che sorridono dietro una giacca oversize o i genitori che indossano spille anni ’80:

modelli naturali nelle vetrine digitali. Ogni membro della famiglia Criscuoli ha un ruolo in Mercanzia. “It’s a family matter” – scrivono sulle magliette.
Insieme al collettivo South Manifesto, hanno anche montato pop-up store (negozi temporanei) tra la folla di Napoli e Milano. Mercanzia è stata toccata, provata e discussa dal vivo per la prima volta fuori casa. Le dita di Miriam scorrono già sulla prossima etichetta, mentre un pacco pronto per la spedizione aspetta sul tavolo. Mercanzia è una metafora potente: quella cameretta dei maschi, oggi, ha i confini indefiniti. Una trama ancora tutta da scrivere, che lega fili senza tempo.
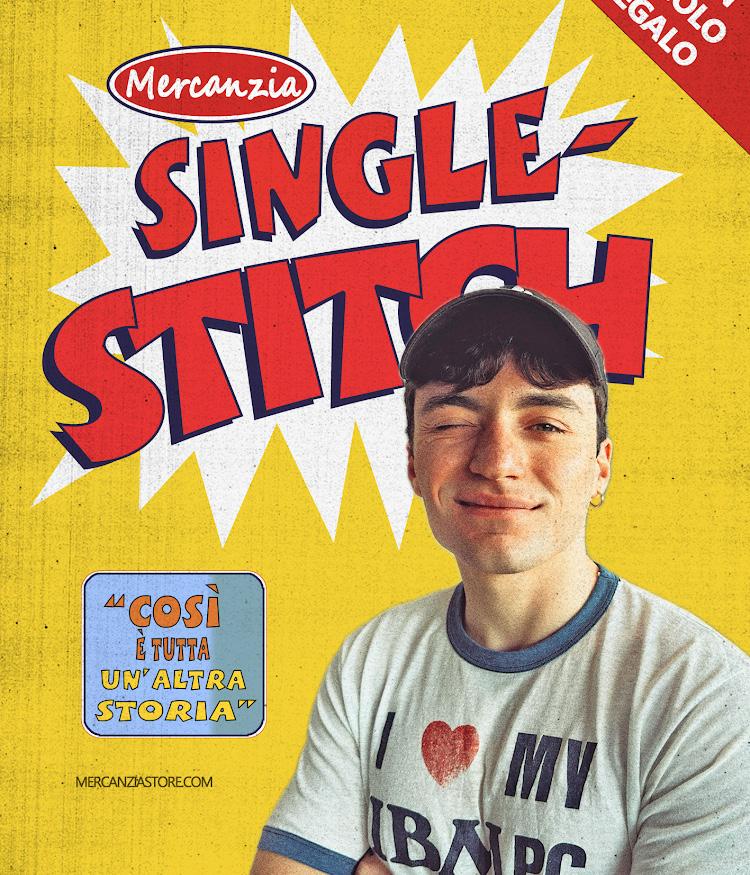
Un ministero poco visibile ma centrale nella vita della comunità parrochiale, il confronto diretto con il male e l'ascolto delle fragilità
di Bianca Bettacci
«Don Alvaro Bardelli, parroco della Cattedrale di Arezzo da oltre trent’anni, è l’unico esorcista ufficialmente incaricato dalla diocesi aretina. Amico e collaboratore di padre Amorth - celebre esorcista della diocesi di Roma e fondatore dell’Associazione Internazionale degli Esorcisti - affronta il tema del male con la freddezza e la semplicità di chi lo conosce bene. «L’esorcismo non è folklore. È parte della vita ordinaria della Chiesa, non bisogna averne paura».
Siede composto, gli occhi chiari sono sempre fermi e vigili. Rifiuta ogni spettacolarizzazione del proprio ruolo e ci tiene a sottolinearlo: «Non lavoro su fenomeni, lavoro sulle persone. Chi arriva da me porta paure, ossessioni, disturbi che non riesce a spiegare. Il mio compito è capire: può essere una malattia, una fissazione, un disagio psicologico». Secondo il sacerdote aretino il male non è mai astratto, ma si manifesta nelle fragilità quotidiane: «La vera battaglia è restituire pace e dignità a chi vive nel tormento.
Senza giudicare né semplificare». Precisa che in molti casi il suo lavoro finisce lì, non sempre capita di avere a che fare con qualcosa di paranormale. L’esorcismo avviene solo quando emergono segni precisi: «Inizialmente si tratta di una preghiera di guarigione. Il rito vero e proprio viene dopo, nei casi più complessi». Don Alvaro lo descrive con naturalezza: «È il momento in cui l’esorcista, in nome di Gesù, comanda allo spirito maligno di allontanarsi. L’autorità non è del sacerdote. È di Cristo. Io sono un suo strumento».
Il suo lavoro non è mai rituale o automatico. «Parto sempre da un’analisi. Devo capire la storia, i traumi più profondi, ciò che tormenta la persona. Solo dopo posso valutare se intervenire con preghiere specifiche». Nei casi più delicati il rito si svolge insieme ad altri sacerdoti. «Non per
mancanza di esperienza, ma perché alcune manifestazioni possono essere fisicamente aggressive. Ho corso dei rischi in passato, quindi preferisco tutelarmi». Don Alvaro racconta che ha avuto a che fare con persone che mostravano chiare alterazioni della voce, che parlavano con toni e accenti completamente diversi dai propri e rivelavano fatti che non potevano conoscere. «A volte è solo paura o confusione», precisa, «altre volte capisci che c’è qualcosa di profondamente oscuro e inspiegabile. Specialmente quando i segni del maligno appaiono come ferite fisiche».
Don Alvaro distingue chiaramente tra problemi psicologici e spirituali: «Molti problemi non hanno origine spirituale. Per questo collaboro volentieri con i medici: penso sia necessario conoscere la realtà dell’uomo prima di intervenire sul lato della fede». La cura delle ferite interiori precede ogni rito: c’è bisogno di accoglienza e rassicurazione. «Non si può improvvisare un esorcismo. Ogni decisione ha conseguenze profonde sulla vita di chi soffre». Il confine tra fede e scienza non è uno scontro, secondo don Alvaro: «La scienza indaga, la fede riconosce. Se

si rispettano i ruoli, non c’è conflitto». La Chiesa è rete di sostegno, non solo luogo di esorcismi: «Bisogna curare l’anima quanto il corpo, ascoltare prima di intervenire, proteggere chi non riesce ad affrontare la vita da solo».
Prima di congedarsi, chiarisce un ultimo punto: «Se qualcuno chiede denaro, non è un esorcista. La grazia è gratuita. Io non sono un salvatore e per questo non potrei chiedere un compenso. Chi viene liberato deve ringraziare solo il Signore. È Lui che entra nella vita delle persone. Io mi limito ad ascoltare e soccorrere».

Mentre il dibattito pubblico si concentra spesso su dati e politiche, le storie dei migranti rimangono spesso invisibili, soprattutto quelle delle persone LGBTQ+

«C’è anche una visione estremamente occidentale delle identità LGBTQ+, che costituisce un enorme ostacolo all'integrazione dei migranti nella società occidentale», spiega Antonella Ugirashebuja, coordinatrice dello sportello interculturale al GayCenter di Roma. Un'organizzazione dedicata alla comunità queer situata nel quartiere di Ostiense.
Secondo la coordinatrice, «ci si aspetta che la persona gay sia in un modo, la donna lesbica in un altro modo, la persona transgender, quando chiaramente non è così, questo chiaramente è per un motivo socioculturale». Così questo punto di vista può essere pericoloso quando rivolge la integrazione dei migranti queer.
La migrazione è un tema ricorrente nella società contemporanea. Vediamo le statistiche, le controversie e le politiche che regolano questo fenomeno. Tuttavia, di rado vediamo le vere difficoltà e tribolazioni dell'esperienza di un migrante. Quella
che troppo spesso è una tragedia non raccontata è quando le persone fuggono a causa di chi sono o di chi amano. I migranti che fanno parte della comunità LGBTQ+ affrontano una serie di sfide uniche legate alla loro identità, visibilità e sicurezza.
Più di essere un centro per la comunità queer, il GayCenter dispone di uno sportello interculturale che aiuta i migranti queer a superare gli ostacoli che si presentano. In questo modo il centro diventa testimone e guida per un gruppo di persone le cui storie rimangono nascoste, sia per scelta, per proteggere la loro privacy, sia per la mancanza di consapevolezza ufficiale e pubblica di questo problema.
La visibilità è spesso un elemento chiave della comunità LGBTQ+, l’intenzione è quella di essere se stessi con orgoglio e a voce alta. Per questi migranti queer, questo tipo di pubblicità può mettere a rischio la loro sicurezza, soprattutto nelle fasi iniziali. «Hanno un enorme bisogno di privacy, temono il rischio di outing, anche solo entrando in questo centro», afferma Ugirashebuja.
La delicatezza della situazione non può essere sottovalutata e il normale processo di accettazione della propria sessualità non è lo stesso per queste persone. Una pratica fondamentale del centro è
quella di andare incontro alle persone che vi si rivolgono, piuttosto che frapporsi tra loro e il loro background culturale. Marco Scaloni, mediatore interculturale e linguistico del centro, contribuisce a colmare il divario tra le due culture in conflitto.
«Il solo modo di salutarsi la prima volta, avvicinarsi fisicamente, dare la mano o guardarsi negli occhi, per noi può essere scontato e di buona educazione, ma magari per una persona che arriva da una cultura diciamo non proprio aperta sul contatto fisico, può essere una difficoltà o un’invasione di campo». Questo impegno, volto a creare uno spazio in cui tutti si sentano a proprio agio, crea un incontro positivo e produttivo con il GayCenter.
Coloro che lavorano presso il centro interculturale del GayCenter svolgono un lavoro essenziale aiutando questi migranti. Attraverso il loro lavoro, sono testimoni di vite e storie che molto spesso rimangono invisibili. Il loro lavoro permette alle persone che si rivolgono a loro di prosperare e amare liberamente e felicemente in un nuovo luogo. La vita di un migrante LGBTQ+ è tutt'altro che facile, ma quelli del GayCenter fanno davvero molto per renderla migliore per chiunque varchi la loro soglia.

Roma concede 90 mila metri quadri di suolo pubblico: 165mila euro l’anno al Comune, ricavi stimati a 32 milioni annui per il privato

Vent'anni di abbandono hanno permesso a rampicanti e fiumi antichi di riconquistare gli ex Mercati Generali nel quartiere Ostiense di Roma. Ora, 90.000 metri quadri di suolo pubblico stanno per cambiare volto. Ma a decidere non sono le persone che abitano il quartiere. È un fondo immobiliare americano del Texas.
Gli ex Mercati Generali, per decenni snodo della logistica alimentare cittadina, sono diventati il terreno di scontro tra Comune e comunità locali sulle priorità della trasformazione urbana. Una convenzione del 2025 ha assegnato a Hines, fondo immobiliare americano, una concessione di 60 anni per la realizzazione del progetto Città dei Giovani, residenze universitarie di lusso, mentre le alternative proposte dai residenti – parchi, servizi, funzioni di comunità – sono state accantonate.
Costruiti nel 1921, gli ex Mercati Generali hanno funzionato fino a settembre 2002, quando le attività sono state trasferite fuori Roma. Dopo la chiusura, i tavoli partecipativi, forum dove residenti, comitati di quartiere e rappresentanti municipali si incontrano, avevano immaginato una riconversione in cui il 60 per cento dell’area sarebbe stato destinato alle attività culturali. Quel progetto non si è mai concretizzato e per vent'anni
cancelli arrugginiti hanno isolato l'area. Nel 2024, l'amministrazione del sindaco Roberto Gualtieri ha rilanciato i piani, presentando l'operazione come un modo per rimarginare una ferita urbana. Alla fine di novembre 2025, la convenzione tra il Comune di Roma e Hines ha permesso un intervento da 380 milioni di euro per 2.056 posti letto in prevalenza destinati a residenze universitarie di lusso, spazi commerciali, una palestra e strutture culturali limitate.
Hines finanzierebbe la costruzione e, in cambio della concessione sessantennale, verserebbe al Comune un canone annuo di 165.000 euro –circa lo 0,04% del costo complessivo dell’operazione – mentre la società stima ricavi per 32 milioni di euro l’anno. Per i critici è un caso emblematico di finanziarizzazione del suolo pubblico: un bene collettivo trasformato in asset capace di generare rendite stabili per un soggetto privato.
«Il corrispettivo è inadeguato rispetto all'enorme impatto di questa costruzione», sostiene il giornalista Giuliano Marotta, che ha seguito la vicenda per la testata online locale Cara Garbatella. I canoni previsti per le stanze, avverte Marotta, «faranno aumentare i prezzi degli affitti nella zona»: 1.200 euro al mese per una singola e 600 euro per una doppia. Anche le unità accessibili del progetto -
25% del totale a 500-600 euro al mese per una stanza condivisa - restano fuori portata per la maggior parte degli studenti. La classificazione come student housing consentirebbe inoltre affitti nei mesi turistici estivi.
La convenzione ha attirato critiche trasversali. I comitati civici parlano di «cessione di sovranità pubblica ai privati» e mettono in dubbio che le funzioni culturali promesse siano davvero pensate per Ostiense e Garbatella. Fratelli d’Italia, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha definito il piano speculativo, parlando di «scollamento dai prezzi di mercato».
La risposta del Comune è stata netta. «Non ci saranno costi per l’Amministrazione e il progetto incorpora i contributi dei residenti», ha dichiarato l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini. «La pianificazione urbana dovrebbe essere fatta dall’amministrazione, non da privati secondo i propri interessi», dice l’urbanista Rossella Marchini, «è necessario riprogettare un sistema di parchi, aree protette e corridoi ecologici per garantire il collegamento tra le aree verdi, anziché continuare a costruire». Secondo Marchini, definire l'area “vuota, abbandonata, degradata” serve all'amministrazione per legittimare l'affidamento ai privati.
I tavoli partecipativi, promessi per gennaio 2026, rappresentano per i residenti un’ultima possibilità di incidere sul progetto prima dell’avvio dei cantieri, previsto nel 2027. Ad oggi, però, non è stata comunicata alcuna data. Con il processo di fatto congelato, i residenti continuano a protestare fuori le mura con una manifestazione organizzata per il 28 febbraio davanti agli ex Mercati Generali. L’esito farà da precedente ben oltre Ostiense: se le città italiane daranno priorità alla resilienza ecologica o se il suolo pubblico continuerà a servire la rendita privata.
La gestione delle aree verdi si trasforma in un processo partecipativo, dove tecnologia e cittadinanza collaborano insieme per tutelare la natura
di Elin Kaasa
Descritto come la ciclovia urbana più significativa d’Italia e «il museo a cielo aperto» più lungo del mondo, il Grande Raccordo Anulare delle Bici (GRAB) porta con sé aspettative altissime per la rigenerazione di Roma. L’obiettivo è ambizioso: un anello ciclabile di 45-50 km che colleghi il centro alle periferie, valorizzando il patrimonio ambientale. Finanziato dal PNRR in vista del Giubileo 2025, il progetto dovrebbe connettere la rete ciclabile a stazioni e metro. Tuttavia, con la scadenza del giugno 2026 all’orizzonte, circa il 35% dell’opera resta ancora da realizzare. La sfida più complessa, però, non è fatto di asfalto o segnalazione, ma di cultura. A Roma, la tendenza a scegliere l’auto per ogni spostamento – che in un terzo dei casi riguarda tragitti inferiori ai 5 km – resta una barriera difficile da abbattere. «L’auto è percepita come un diritto umano: limitare zone per le macchine per dare spazio alle bici è visto come un attacco alla libertà», afferma Sven Scheen, attivista e fondatore di Sentiero Pasolini.
Giovanni Zannola, psicologo e Presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale, approfondisce questo legame viscerale: «Per moltissimi la macchina è quasi una proiezione del corpo». Secondo Zannola, le restrizioni alla viabilità privata attivano meccanismi di difese: «Ci si difende e rimane ancorati a ciò che conosce perché si è spaventati dal cambiamento». Questi schieramenti finiscono inevitabilmente per rallentare l’iter dei lavori, scoraggiando chi si batte per una città diversa. «I volontari perdono entusiasmo», aggiunge Scheen, sottolineando che il GRAB è una prova del nove: «Se non si ha successo con questo progetto a Roma, sarà problematico con tutto il resto».
Oltre alle tempistiche, a sollevare dubbi è il quesito su quanto verrà utilizzata la ciclabile e da chi. Mancini evidenzia: «Il GRAB è più turistico rispetto ad altre strutture che noi abbiamo proposto in passato». Dalla mappa, si osserva chiaramente che il percorso circonda il centro della città, senza diramarsi in percorsi interni o esterni al circuito. Tuttavia, Alessandra Grasso, socia di Salvaiciclisti Roma, accoglie favorevolmente il progetto, affermando: «Nonostante sia un percorso propriamente cicloturistico, sarà utilizzato anche da chi si sposta in bici per tragitti quotidiani». Alberto Fiorillo, coordinatore del progetto, vede GRAB come un acceleratore per ogni necessità: «Va a vantaggio di chi si sposta
per svago, studio o lavoro, creando una rete che prima non esisteva». Il successo dell’infrastruttura dipenderà dalla sua capacità di far sentire i cittadini al sicuro. Stefania Salomone, di Salvaiciclisti Roma, sottolinea: «Il GRAB è importante perché per realizzarlo abbiamo dovuto togliere spazio alle auto. Servono infrastrutture protette; nella situazione attuale le persone hanno ancora paura». Molti attivisti denunciano che troppe piste in città sono scollegate. «L’infrastruttura protetta riduce la percezione del pericolo, ma oggi ci sono buchi ovunque e i percorsi sono frammentati. Come dicono alcune delle nostre socie: sembra la stampante quando finisce il toner», commenta Claudio Mancino.
Ridisegnare gli spazi urbani innesca inevitabilmente polemiche che rallentano i lavori. Salomone spiega il limite degli incontri pubblici: «Partecipano solo gli interessati. Molti si accorgono del progetto solo quando il cantiere arriva sotto casa, reagendo con ostilità perché non si sono informati prima». Secondo Zannola, non si tratta di accontentare tutti, quanto di procedere con decisione: «Bisogna forzare la mano e dimostrare che il cambiamento migliora la qualità della vita. Non ci si può fermare se qualcuno si lamenta».
Salvaiciclisti Roma, tuttavia, accusa l’amministrazione di non avere sempre la «schiena dritta». Grasso cita il caso di Via di San Gregorio: «Mancano cinque metri fondamentali verso Piramide. Serve un intervento su un’intersezione che probabilmente hanno paura di affrontare per non assumersi la responsabilità della sicurezza in quel tratto e per non modificare il flusso automobilistico. È più facile lasciare il lavoro incompiuto». Alberto Fiorilli, coordinatore del progetto GRAB, replica: «Le connessioni verranno fatte. I ritardi sono dovuti alla sovrapposizione con lavori comunali e alla vicinanza al Colosseo: la delicatezza archeologica dell’area è estrema». Una giustificazione che non convince Grasso, secondo cui troppe ciclabili si interrompono bruscamente prima degli incroci. In definitiva, il futuro e successo del GRAB non si giocherà solo sulla puntualità dei cantieri, ma sulla volontà e capacità dei romani di abitare diversamente lo spazio pubblico.
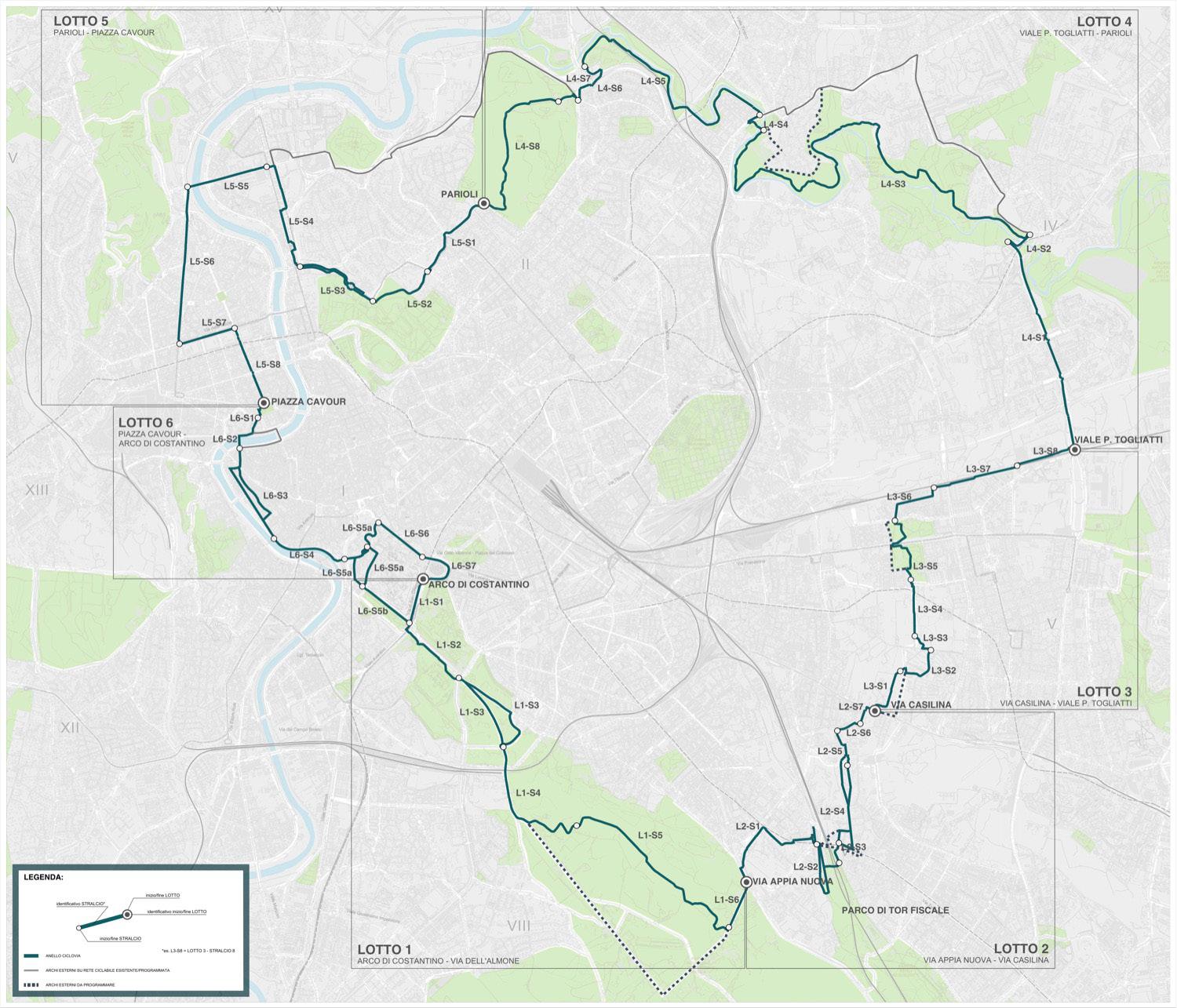
In Italia è in crescita il numero di Comunità energetiche rinnovabili. Tra le grandi città, Roma vuole proporsi come modello
di Tommaso Provera
La transizione energetica può partire anche dal basso, dai tetti delle case e dalle relazioni tra le persone. È la scommessa delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer): gruppi di cittadini, enti pubblici e realtà sociali che si uniscono per produrre e consumare energia pulita. Queste reti si basano sulla condivisione dell’elettricità prodotta da impianti a fonte rinnovabile, come pannelli solari o pale eoliche.
I piccoli comuni sono stati i primi a realizzare comunità energetiche, ma adesso anche i grandi centri urbani si stanno attivando. A Roma ci sono nove Cer costituite e molte altre sono in progettazione. A febbraio 2025 il Comune ha presentato un regolamento per mettere pannelli solari sui tetti di scuole ed edifici pubblici a beneficio delle comunità energetiche.
La prima Cer della Capitale, Le Vele, è un progetto esemplare. Sul tetto dell’Istituto Vaccari, centro per la riabilitazione di persone con disabilità, è stato installato un impianto fotovoltaico da 82 kW che ha ridotto le emissioni di CO2 di circa 43 tonnellate l’anno. È come se fossero stati piantati 1438 alberi.
«L’Istituto grazie all’impianto ha ridotto i costi energetici di oltre il 50%», racconta Valeria Caforio di Scenario b, associazione che ha partecipato al progetto. «I proventi derivanti dagli incentivi statali, erogati per l'energia condivisa, vengono donati a famiglie vulnerabili del territorio», spiega ancora, sottolineando come i ricavi vengano investiti in progetti di inclusione sociale.
Nel 2018 l’Unione europea ha aperto la strada alle Cer con una direttiva dedicata, ma in Italia il decreto attuativo è arrivato solo nel 2024. Da allora qualcosa si è mosso. Secondo i dati del Gestore dei Servizi Energetici, aggiornati a marzo 2025, in Italia sono attive 212 comunità: un numero contenuto, ma in crescita. Il Pnrr aveva stanziato 2,2 miliardi di euro per finanziare i progetti. La misura è stata però tagliata del 64% per rispettare le scadenze europee e non perdere i fondi, tradendo le aspettative del settore. Ciò nonostante, le Cer stanno rivoluzionando il modo di generare e condividere energia a partire dal territorio. Chiunque
può costituirle o prendervi parte come produttore, consumatore o entrambi. L’obiettivo è ridurre le emissioni di CO2, rendere l’energia rinnovabile accessibile a tutti e contrastare la povertà energetica, coinvolgendo direttamente i cittadini. Si tratta di una vera democratizzazione dell’accesso all’energia pulita che mette le comunità al centro.
Il 2025 ha segnato un punto di svolta per le fonti rinnovabili. Per la prima volta, nel mondo, pannelli solari e pale eoliche hanno generato più energia elettrica dei combustibili fossili. Un sorpasso simbolico e insufficiente, ma che dimostra come, con i giusti investimenti, l’energia pulita possa stare al passo con una domanda elettrica crescente. Allo stesso tempo, le crisi geopolitiche mostrano la fragilità dei sistemi centralizzati.
In Ucraina, la guerra ha reso le centrali elettriche obiettivi strategici, ricordando quanto sia vitale investire in soluzioni diffuse e innovative. In questo contesto, la produzione locale di energia può assumere un valore chiave. L’Italia è un paese povero di gas, petrolio e carbone, eppure sole e vento non mancano: le fonti rinnovabili hanno un potenziale inespresso.
Condividere l’energia per molti è una novità. A Roma come altrove, però, le comunità energetiche dimostrano che la transizione ecologica non è solo una questione tecnologica o industriale, ma una scelta delle persone di collaborare per costruire un futuro più giusto e sostenibile.
«È stato installato un impianto fotovoltaico da 82 kW che ha ridotto le emissioni di CO2 di circa 43 tonnellate l’anno. È come se fossero stati piantati 1438 alberi»

Dall’arrivo dell’Empire Windrush alla nuova generazione londinese, settant’anni di diaspora e resistenza riflessi negli album pubblicati nel 2025 dai suoi protagonisti
di Luca Galati
«Se volete conoscere un popolo, dovete ascoltare la sua musica» diceva Platone. Tra le strade di Londra è possibile sentire il suono di una diaspora. La Black British music (musica britannica nera) nasce da una stratificazione di movimenti, tradizioni e scambi che dal 1948 ridisegnano il paesaggio musicale britannico.
La storia dell'immigrazione afro nel Regno Unito inizia dopo la Seconda Guerra Mondiale con l'arrivo dell'Empire Windrush, nave militare che porta migranti dal Commonwealth — Caraibi e Africa — chiamati a ricostruire il Paese. Un’eredità che vive nelle nuove generazioni di musicisti neri britannici. Tra questi Jim Legxacy che apre così father, singolo tratto dal suo ultimo mixtape: «Black British music / We’ve been makin’ asses shake since the Windrush».
James Folorunso Ifeanyi Olaloye, noto come Jim Legxacy, è un artista classe 2000 cresciuto nel sud di Londra a Lewisham da genitori nigeriani, una delle comunità africane più grandi e in più rapida crescita. Dalla fine degli anni Settanta, molti nigeriani hanno cercato lavoro all’estero e si sono stabiliti nel Regno Unito. La situazione politica ha anche spinto molti a chiedere asilo, con un picco nella metà degli anni Novanta durante la dittatura del generale Sani Abacha.
Fin dai primi anni, la comunità afro-caraibica ha incontrato ostilità. «What would you say to your baby girl / When she ask you about white supremacy» rappa Little Simz in Blue, brano che chiude il suo album Lotus. Simz, pseudonimo di Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo, ha 31 anni e racconta l'accoglienza complessa vissuta dai suoi genitori nigeriani, la tensione tra il passato coloniale e le aspirazioni di una società multiculturale. Discriminazione e segregazione non si limitano alla dimensione quotidiana, condizionano anche quella mondana. I neri vengono respinti dai club “solo per bianchi” e dalle ra-
dio mainstream. Così costruiscono la loro scena. Salotti trasformati in sale da ballo, muri di sistemi audio in stile giamaicano e radio pirata che trasmettono musica nera. Ogni genere underground porta la voce della propria epoca. I testi reggae ribelli e quelli romantici dei brani lover’s rock rappresentano la generazione Windrush, il sound da club soul e veloce afferma lo UK garage negli anni Novanta. Dal Duemila, la crescita della musica nera incontra resistenza da parte delle autorità. La polizia vede gli eventi organizzati dai neri come una minaccia. Così la Metropolitan Police di Londra introduce il Modulo 696, una "valutazione del rischio" rivolta alle serate musicali nere, obbligando i promo -


tori a specificare la composizione etnica del pubblico. A subirne le conseguenze sono i concerti garage, R&B e grime. Proprio quest’ultimo genere, rapido e sincopato, rappresenta uno dei pilastri sonori dell’attuale Black British music. Il nome, che tradotto in italiano significa “sporco”, descrive le caratteristiche del genere: sound grezzo e testi che raccontano le zone periferiche di Londra.
Dal campionamento dei brani grime di Skepta e Boy Better Knows nasce black british music (2025) di Jim Legxacy: immaginario da cameretta, rap britannico, chipmunk soul e afrobeat. Evoca personaggi come David Bowie e il calciatore Wayne Rooney. Non solo ispirazione, ma esperienze di vita di un britannico nero da poco prima del 2010 ad oggi.
Se la prima generazione affronta la diaspora, tra gli artisti della nuova scena cresce il bisogno di dare un senso alla loro identità. «Family callin’ me Afam… / Then I end up changing my name / Glad then, but today, I'm ashamed» canta Ashley Afamefuna Nwachukwu, in arte Knucks, in MY NAME IS MY NAME. A Fine African Man, il suo ultimo album, esplora la dualità di un ragazzo africano nato e cresciuto a Londra. Le pressioni sociali, la tensione tra il nome di battesimo e le opinioni altrui: «Big house in the belly of Britain but still eatin' Okra soup / They don't understand I'm an African man, what you want me to do? / I have mine with a spoon, they thinkin' I'm cool or tryna be boujee / I learned it from school».
La tensione identitaria affianca un’altra traiettoria, quella di chi cresce dentro lo stesso contesto e comincia ad osservarne gli esiti. In The Boy Who Played the Harp, Dave non racconta il tentativo di farcela, ma ciò che accade dopo. Da una famiglia nigeriana di Streatham, una periferia nel sud di Londra, alla fama mondiale: «And when they talk on my name in this country / they gon' tell you that I'm already a legend». Il brano che apre il suo ultimo album si intitola History.
Dave si chiede cosa significhi fare la storia senza mettersi su un piedistallo, senza perdere contatto con la realtà. Ha 27 anni, riconosce di non essere più una persona comune ma non tradisce le proprie origini: «I can't speak sideways on grime, jungle or garage / When I know that it's the reason we managed to make history».
Non soltanto colonna sonora della strada o dei club, ma anche spazio di introspezione, memoria e rinascita. In Lotus di Little Simz e Time Flies di dexter in the newsagent l’intimità diventa linguaggio. Entrambe osservano il tempo che passa tra ferite, crescita e incertezza. Simz trasforma il trauma in guarigione, dexter fotografa l’ansia dell’attesa.
Sullo sfondo di questi album, tutti pubblicati nel 2025, resta Londra. Luogo narrativo e spazio di frizione creativa, attraversa i progetti rendendoli “britannici” pur nella loro diversità di suoni, origini e traiettorie. Una città che costringe a fare i conti con chi si è e chi si vuole diventare.
La Black British music è un processo che si riscrive nel tempo. Non fissa le origini, le mette in tensione. Non chiede da dove arrivino questi artisti, ma osserva ciò che stanno modellando: un nuovo linguaggio comune, autentico, nato dall’attrito tra storia, presente e possibilità future.

Luca Sorrentini, diciotto anni, digger e produttore racconta la nascita di una passione che è diventata lavoro
di Marco Chiaradonna
Nel 2018 a Napoli escono due album che portano la città nel titolo. È l’inizio di un movimento culturale che riporta il funk e l’afrobeat nei club italiani, un patrimonio cittadino di suoni che sembrava perduto si ripresenta e spopola. Gli autori sono i Nu Genea, Lucio Aquilina e Massimo Di Lena, dj del Vomero ma di stanza a Berlino. Mentre Nuova Napoli contiene tracce originali, sonorità arabe e ritmi funk con testi in napoletano, Napoli Segreta, realizzato insieme ad altri producer, è una compilation di brani ritrovati, nove tracce rimasterizzate, nove voci perdute.
Quell’operazione di restauro svela un’altra strada della produzione musicale e annuncia una “nuova” tendenza del clubbing in Italia, un sound e un’estetica nascono a partire dai dischi ritrovati nei mercatini delle pulci. Massimo Di Lena e Lucio Aquilina sono innanzitutto “diggers”, cercatori di musica perduta che setacciano fiere e garage. Oggi, a distanza di otto anni, annunciano il loro quarto album e quel movimento di collezionisti e produttori emerso con Nuova Napoli e Napoli Segreta prosegue e si allarga.
L’estate scorsa è uscita Summer of Love, una compilation che recupera suoni e ritmi dall’Italia estiva di fine anni Ottanta. L’autore è Luca Sorrentini, dj e producer avellinese di 18 anni, che fa parte dalla label romana “Maledetta Discoteca”. Aveva già pubblicato, a 16 anni, un’altra compilation, Operazione Sole, che svela le influenze della black music sul pop italiano dei primi anni Ottanta. Le “operazioni” di Sorrentini iniziano proprio con Nuova Napoli dei Nu Genea, uscito quando aveva dieci anni. Già frequentava le fiere ma i suoi acquisti si limitavano a dischi usati.
Un amico più grande gli consiglia Nuova Napoli e subito si rende conto che quel “mondo nascosto”, quelle sonorità d’archivio, potevano arrivare a tutti: «Ricordo nel 2018 in Italia si parlava solo di Napoli. Napoli Segreta, Nuova Napoli, Liberato. Ho capito che era qualcosa di importante quando ho visto chiunque comprare quel disco. Io avevo 10 anni e non andavo nei club quindi mi sono perso la dimensione live dei Nu Genea. Però mi ricordo l’impressione che quel primo disco mi diede. Tutto quel mondo nascosto assumeva ad un certo punto un’immagine chiara. Anche i font, l’art work della copertina, era tutto bilanciato. C’era un universo di influenze che dalla Nigeria arriva a Napoli e tutto suonava autentico». In quel momento Sorrentini ha riconosciu-
«Da piccolo alle fiere mi davano lo sgabellino per sfogliare i dischi. Non ho mai pensato di fare altro»

to che certe sonorità suonavano ancora attuali e che i dischi potevano diventare un mestiere. La sua passione comincia però a casa. Entrambi i suoi genitori ascoltano musica, a sei anni gli regalano un giradischi («non è il regalo che ti aspetti a quell’età») e un dodici pollici di One More Time dei Daft Punk.
Dopo qualche anno arrivano le fiere e il collezionismo: «Ai tempi delle elementari il momento più atteso era il Disco Days al Palapartenope di Napoli dove trovavo di tutto. Ci sono venditori che mi hanno cresciuto, per cercare i dischi mi davano lo sgabellino. Poi c’era il Camarillo Brillo, un negozio di dischi ad Avellino, dove con una delle prime paghette ho comprato Mothership connection dei Parliament. Rapidamente ho iniziato a cercare musica meno conosciuta, volevo avere i dischi
che nessuno aveva. Ho cominciato con il funk italiano, facevo qualche mix su Soundcloud per condividere la poca musica che trovavo». Durante il lockdown, aveva tredici anni, ha iniziato ad esplorare generi nuovi. Passava le giornate su Discogs (il più grande database musicale online) che gli ha aperto le porte all’underground discografico italiano. In quel periodo scopre anche Maledetta Discoteca che è l’etichetta discografica con cui oggi collabora.
Con le riaperture ritorna nei mercatini e inizia ad orientarsi nel mondo dei club e delle feste. I primi dj set che ascolta gli rivelano nuove possibilità creative a partire dalla ricerca di una struttura comune in brani diversi: «ricordo Quantic a Napoli, mi colpì come riusciva a cambiare genere sempre: cumbia, afro, disco, dance. Lì ho capito che ogni pezzo ha una sua texture che può connettersi a qualcos’altro».
Nel 2021 arriva la prima serata con la crew “Maledetta Discoteca” al Trenta Formiche di Roma. Da lì nasce la collaborazione con l’etichetta, che lo coinvolge in Operazione Sole
Due anni di lavoro, copyright e artisti da rintracciare: «Mancava la licenza di una traccia per completare il disco. Sapevamo che i diritti li possedeva il fratello dell’autrice che però era morto e lei risultava irreperibile. Poi un giorno mi trovo a Perugia per un dj set e riesco a mettermi in contatto con lei. Viveva proprio a Perugia e così abbiamo chiuso Operazione Sole».
Sorrentini ha da poco anche cominciato a vendere dischi attraverso un suo “Archivio”. Già vendeva su Discogs, soprattutto residui di grandi lotti. Poi ha iniziato ad accumulare doppie copie di dischi rari e a pubblicare storie su Instagram per venderle. Si è creata una rete di clienti che rapidamente si è estesa e a quel punto è nato “Archivio Sorrentini”, uno spazio digitale che raccoglie il meglio di quei “reperti” (tra i sostenitori del progetto c’è anche Massimo di Lena dei Nu Genea). Oggi è maggiorenne e a Novembre è uscito il suo primo disco, Archivio 001. Inizialmente pensato per cinquanta copie, le richieste sono state migliaia e il disco è esploso fino a diventare “bestseller” su Discogs dopo Geese e Rosalia. Altre novità sono in uscita. Nel frattempo Luca Sorrentini suona in tutta Italia e frequenta ancora il liceo.
La ricerca dietro le operazioni di Sorrentini. Dagli archivi alla produzone in studio
a cura di Marco Chiaradonna






Nei recenti adattamenti cinematografici, il mostro smette di essere una figura da temere e si trasforma progressivamente in oggetto di desiderio
di Sabrina Fasano e Paola del Prete
Da che hanno memoria, tutte le ragazze sognano il vero amore. Baciare un rospo e vederlo trasformarsi nel principe azzurro oppure cadere in un sonno profondo ed essere risvegliate dal bacio del vero amore. Ma se l’affascinante principe fosse in realtà un mostro? Il paradigma estetico è stato ribaltato già a partire dagli anni Duemila con la celebre saga firmata Dreamworks, Shrek. La principessa Fiona si innamora perdutamente dell’orco, rifiutando un matrimonio reale e trasformando sé stessa in orchessa, pur di coronare il suo sogno romantico. I recenti adattamenti cinematografici dei romanzi Dracula di Bram Stoker e Frankestein di Mary Shelley seguono questa tradizione. Il Conte Dracula, pazzo d’amore per sua moglie Mina, perde
il senno dopo la morte prematura della donna. Diventa eretico e stringe un patto con il demonio vendendo la propria anima in cambio dell’immortalità. Trascorrerà i successivi quattrocento anni cercando la reincarnazione di Mina e, finalmente, ritrovandola. Frankestein è lo scienziato che dà vita alla “creatura”: un essere dalle sembianze mostruose, nato dall’assemblaggio di diverse parti del corpo umano. Elizabeth, l’unica protagonista femminile, finirà per innamorarsene perdutamente. Sulla scia di questa narrativa, Tik Tok ha amplificato notevolmente il fenomeno combinando narrazione emotiva, estetica e community. I personaggi mostruosi sono rappresentati sulla piattaforma in modo sensuale, dotati di estrema sensibilità e turbamento. Attraverso video brevi, musica malinconica e fotogrammi, il “mostro” si


2 trasforma in un eroe romantico e il principe azzurro diventa banale, quasi scontato. I valori di perfezione e stabilità incarnati dal principe, così come la stessa mancanza di conflitto, sembrano essere superati. È il dramma emotivo ad essere premiato dalla comunità, insieme alla complessità psicologica e all’idea secondo la quale l’amore possa guarire le ferite più profonde. I personaggi di Dracula e Frankestein offrono esattamente questo: tormento e intensità.
Nei due recenti adattamenti cinematografici, i “mostri” non sono più creature da temere: sono esseri che provano amore, dolore e sofferenza, sognando costantemente una connessione con l’universo che li circonda. Se il grande schermo rappresenta il mostro di Frankestein come una creatura vulnerabile e desiderosa di conoscere il mondo, Dracula appare perennemente tormentato da desideri e rimpianti.
Il cambiamento radicale riguarda le figure femminili. Le protagoniste non sono più l’oggetto del desiderio della creatura, ma il soggetto che la desidera. Il ribaltamento della dinamica classica è evidente. Mentre nel cinema tradizionale la donna è spesso guardata, sedotta e perseguitata, nella riscrittura moderna è lei la prima a guardare. Il “mostro” diventa desiderabile soltanto perché è lei a volerlo. Storicamente, la conseguenza del desiderio femminile era la condanna morale. Nelle nuove narrazioni, il desiderio non è più colpa ma attrazione consapevole. La donna desidera la creatura non per curare le sue ferite, ma perché la ama così com’è, anche nella sua oscurità.
Ciò che diventa attraente non è più la forma, ma la storia che quel corpo racconta: la solitudine, il dolore e il peso dei secoli. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. La bellezza è soggettiva e dipende dalle inclinazioni personali. Non esistono canoni universali e assoluti. È tutta questione di carattere, di carisma, di qualcosa che sfugge alle misurazioni oggettive. Eppure, viviamo in una società che adora e brama l'estetica patinata, costruita e levigata: grandi cartelloni pubblicitari, immagini ritoccate sui social alla ricerca ossessiva del difetto. In questo contesto, sorprende constatare come l’attrazione esercitata da uomini non incasellabili nei canoni classici risulti spesso più forte e duratura. A conferma di ciò, sui social, Tik Tok in primis, sono diversi i video dedicati ai cosiddetti ugly hot men: personaggi famosi che, pur lontani dall’ideale estetico tradizionale, vengono celebrati nei commenti, ricondivisi e idolatrati. A colpire
non è la bellezza in senso stretto, ma una combinazione di fattori: il proibito, il diverso, quel non-so-che che li rende magnetici, insieme a uno savoir-faire indiscutibile. Sembra affermarsi un nuovo paradigma di bellezza, non è più legato all’armonia e alla proporzione codificate dall’arte classica, ma al modo di porsi, alla presenza, a ciò che si ha da offrire sul piano caratteriale. Paradossalmente, ci avviciniamo così a un ideale antico: quello greco della kalokagathía, che lega indissolubilmente il fascino esteriore alla virtù interiore. In questa prospettiva, l’attrattività non è un dato statico, ma un percorso verso la perfezione morale.
Nei personaggi di Dracula e Frankenstein però la kalokagathía è rovesciata. Qui la perfezione morale e quella fisica sono assenti, ma piacciono. L’attrazione per il “brutto” – o per il mostruoso – è particolarmente diffusa nel pubblico femminile e può essere letta da diverse angolazioni.
La cultura dominante appare molto più a suo agio nel raccontare storie in cui una donna si lega a un mostro. In questa narrazione si riafferma spesso un ruolo tradizionale: quello della donna che, attraverso empatia e amore, “domestica” l’alterità, la rende accettabile, la salva. Il mostro viene così inserito in una cornice redentiva che finisce per normalizzarlo.
È pur vero che esistono casi opposti. Letteratura e cinema offrono numerosi esempi di uomini che si innamorano di donne-mostro, accettandone consapevolmente i rischi. Se, per esempio, La Belle Dame sans Merci di John Keats mette in scena l’amore per una figura femminile mostruosa come esperienza liminale e distruttiva; sul piano cinematografico, opere come Spring o When Animals Dream mostrano come la figura maschile possa legarsi a una donna mostruosa senza che questo amore sia ridotto necessariamente a un semplice ammonimento morale.
Dracula seduce perché è proibito, immortale e dannato; la creatura di Frankenstein commuove perché chiede amore senza possedere gli strumenti per ottenerlo. In entrambi i casi, l’alterità si fa specchio: ciò che attrae non è il mostro in sé, ma la possibilità di riconoscere, attraverso di lui, ciò che nella normalità resta invisibile. E forse, se il troppo storpia, a rovinare non è il “brutto”, ma proprio il “bello”.
«Pensi che Dio ci perdonerà per amarci così tanto?» «Dio è amore. Lui capisce. E se non capisce… può pure andare all’inferno»
Heated Rivalry è la serie tv del momento che racconta la relazione segreta tra due campioni di hockey, costretti a nascondere i propri sentimenti per proteggere la loro immagine. Si riapre il dibattito sull’omosessualità nello sport, dove fare coming out per gli atleti è ancora un rischio
di Federico D'Onofrio
Shane Hollander, canadese, e Ilya Rozanov, russo, sono due campioni dell’hockey. Sul ghiaccio sono avversari feroci, simboli di un agonismo ipermaschile. Fuori, costruiscono una relazione che deve restare segreta per non compromettere carriere, contratti e immagine pubblica. Dietro l’odio apparente, tra messaggi inviati di nascosto tra una gara e l’altra, si cela una passione destinata a diventare vero amore. Loro sono i protagonisti della serie del momento Heated Rivalry
«Non mi aspettavo che potesse diventare un fenomeno sociale». Casey Bloys, capo di HBO negli Stati Uniti, riassume così il successo inatteso. In Italia arriverà solo a febbraio, ma in Canada e negli USA è già un caso mediatico. Negli Stati Uniti ha superato i 600 milioni di minuti visti in neanche un mese; in Canada, nei primi giorni di programmazione, la piattaforma Crave ha registrato un aumento degli abbonamenti del 400%, confermando la serie per almeno altre due stagioni.
Il successo di Heated Rivalry non si spiega solo con la storia d’amore. A scatenare l’hype è soprattutto l’ambientazione sportiva, un mondo in cui l’omosessualità resta ancora invisibile. In Italia il fandom (comunità di fan appassionati di una serie o di un personaggio) si è formato prima ancora dell’uscita ufficiale. Scorrendo TikTok, X e Instagram è facile imbattersi in clip virali: baci nascosti, sguardi trattenuti, corpi muscolosi e scene erotiche. Anche in Russia, dove la rappresentazione LGBTQ+ nei media è limitata, la serie viene vista di nascosto e commentata sottotraccia.
«Il sesso è il modo in cui ti catturano, e poi alla fine ti spezzano davvero il cuore», ha spiegato François Arnaud, tra i protagonisti della serie: anche il suo personaggio, Scott Hunter, rivelerà di essere gay. «Siamo stanchi di uomini emotivamente indisponibili. Vedere persone che si aprono davvero in TV è raro. Ed è tempo di storie così». Rhik Samadder, sul The Guardian, ha scritto che Heated Rivalry è «così sexy da rischiare di sciogliere il ghiaccio su cui pattina». Nei sei episodi la tensione sportiva tra i due rivali si alterna a quella sessuale, consumata di nascosto nelle camere d’albergo. L’erotismo non è solo uno strumento di attrazione, ma il modo più diretto per raccontare un’intimità che entra in


conflitto con lo stereotipo dell’atleta: forte, vincente, emotivamente impermeabile. Non è un caso che Heated Rivalry sia ambientata nell’hockey, uno degli sport che più di altri continua a incarnare un’idea di mascolinità fisica e aggressiva.
In una scena chiave, Scott Hunter porta il suo compagno sul ghiaccio durante la celebrazione di una vittoria e lo bacia davanti a migliaia di spettatori. «Non è qualcosa che si vede tutti i giorni», commenta un telecronista in sottofondo. Ma nella realtà della NHL, la lega nordamericana di hockey su ghiaccio, non esistono oggi giocatori apertamente gay o bisessuali in attività. L’unica eccezione recente riguarda le leghe minori: Luke Prokop si è dichiarato nel 2021, spiegando di voler «giocare senza preoccuparsi di chi sa e di chi non sa». Negli ultimi anni la rappresentazione di storie e personaggi LGBTQ+ nelle serie tv è cresciuta in modo costante.
Secondo i report annuali di GLAAD, organizzazione che monitora la rappresentazione della sessualità nei media, le storie queer hanno raggiunto grande visibilità, soprattutto nelle produzioni rivolte a un pubblico giovane e globale. Serie come Heartstopper, Élite o Sex Education hanno dimostrato quanto questo tipo di racconto sia efficace, anche in termini di attenzione e partecipazione sui social.Molte produzioni mainstream sono però accusate di queerbaiting: alludere a trame queer senza mai renderle davvero esplicite. L’obiettivo? Attrarre pubblico senza assumersi fino in fondo il rischio di una presa di posizione chiara.
Heated Rivalry, al contrario, funziona perché mostra una relazione esplicita e racconta il peso psicologico di essere una persona queer in un ambiente di norma eterosessuale come quello sportivo. Hudson Williams, l’attore che interpreta Shane, ha raccontato in diverse interviste di aver ricevuto messaggi privati da atleti professionisti non dichiarati pubblicamente. Nel 2025, su oltre 4mila giocatori delle
principali leghe maschili statunitensi (NFL, NBA, MLB, NHL, MLS), nessuno si dichiara apertamente gay o bisessuale. Un dato che spiega quanto il coming out resti complesso e può costare tantissimo. Uscire allo scoperto significa mettere a rischio contratti e rapporti con compagni di squadra, dirigenti e tifosi. L’accettazione nell’ambiente sportivo resta complessa.
Lo dimostrano i casi di calciatori della Premier League che hanno rifiutato di indossare la fascia arcobaleno e i continui insulti omofobi, come quelli che hanno colpito il calciatore del Celta Vigo Borja Iglesias, noto per le sue battaglie contro l’omofobia. Molti atleti, per questo, scelgono di dichiararsi solo dopo il ritiro. Altri provano ad affrontare il sistema. Negli ultimi anni alcuni sportivi di discipline individuali hanno fatto coming out. Qui l’esposizione mediatica e la dipendenza dal gruppo sono minori.
Negli sport di squadra, invece, è più difficile. In Italia lo ha fatto nel 2023 Jakub Jankto, allora al Cagliari, dichiarandosi gay con un video pubblicato sui social. Come ha raccontato a Cronache di Spogliatoio, quel coming out non è stato il risultato di una scelta meditata, ma la risposta a voci insistenti sulla sua sessualità. Il vero ostacolo non è stato lo spogliatoio, ma media, tifosi e social, dove Jankto è stato bersaglio di insulti omofobi. «Ho passato due mesi molto difficili, poi però mi sono sentito finalmente più libero», ha dichiarato il calciatore ceco. Il suo gesto è stato subito definito storico e, proprio per questo, è rimasto isolato.
Se le serie tv raccontano storie sempre più esplicite e inclusive, lo sport reale resta un ambiente ostile al coming out. «Nessuno deve saperlo», dice Shane a Ilya all’inizio della serie: una frase che appartiene ancora a troppi atleti reali. La loro storia racconta qualcosa che lo sport non è ancora pronto ad accettare.

1. Immagini tratte da Heated Rivalry che ritraggono i personaggi dei giocatori professionisti di hockey Shane Hollander (interpretato da Hudson Williams), a destra, e Ilya Rozanov (interpretato da Connor Storrie), a sinistra. © Warner Bros
2. Immagine di Jakub Jankto, calciatore professionista ceco e centrocampista di livello internazionale, noto per la sua carriera nei principali campionati europei e per essere stato uno dei primi giocatori attivi a dichiararsi pubblicamente omosessuale. Crediti: uso pubblico, Wikimedia Commons
Arbitri dilettanti raccontano la loro passione tra insulti e aggressioni
di Pietro Morolli
Li maltrattano, li aggrediscono, ma senza di loro non si gioca. Spesso a scagliarsi contro di loro sono giocatori, dirigenti e genitori: proprio quelli che senza una figura terza non riuscirebbero nemmeno a stare in campo. Più basso è il livello della partita, maggiore è la violenza. Un controsenso logico che attraversa e definisce la figura più ostinata del mondo dello sport: l’arbitro di periferia.
Persone come Fabio, 59 anni, che racconta la sua passione da uno spogliatoio container prima del fischio di inizio di Asd Gorilla - Eventi Futsal, giocata a zero gradi in un martedì sera. O come Gianmaria, 27 anni, che nella vita vuole fare altro ma che, «autobus dopo autobus», gira la regione arbitrando partite amatoriali di basket. Persone che scelgono di immergersi nel caos dello sport regionale con la consapevolezza che nessuno, durante la partita, farà il tifo per loro.
«L’ambiente del calcio giovanile è tossico. Ricordo che una volta un bambino prese una pallonata forte sul petto e non riusciva più a respirare. Ho fermato subito il gioco e sono intervenuto. Un genitore sugli spalti ha iniziato a insultarmi perché di regola “non era fallo”. Questa è la situazione», spiega Fabio.
«Era uno dei giorni prima di Natale. Sono andato ad arbitrare una partita di basket di bambini di 12 anni. Tutto mi faceva sperare in una situazione tranquilla, ma mi sono ritrovato a ricevere offese anche in quel caso», aggiunge Gianmaria. Si tratta di un gioco delle parti in cui il direttore di gara è sempre il nemico e mai una risorsa: l'ostacolo quando si vince, l'alibi quando si perde. Una distorsione della realtà che trasforma l'arbitro in un bersaglio costante e che, analizzando i dati, produce effetti disastrosi.
Secondo quanto riportato dall’AIA, l’Associazione Italiana Arbitri, nelle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, si sono registrati in totale 870 episodi di violenza ai danni di direttori di gara. Un dato che comprende violenza fisica grave (180 casi), violenza fisica (257), violenza morale (62), tentate violenze (89) e altre condotte (282). Le aggressioni vengono commesse principalmente nei Campionati regionali (579 casi, di cui 126 gravi, per 699 giorni di prognosi), poi nei Campionati giovanili (282 casi, di cui 48 gravi, per 250 giorni di prognosi) e infine in quelli nazionali (9 episodi, di cui 6 gravi, per 29 giorni di prognosi). In un lasso temporale di due anni gli arbitri italiani hanno passato un totale cumulato di 978 giorni in stato di prognosi. La domanda sorge spontanea: ma chi glielo fa fare? Fabio rispon-

de così: «Non è un discorso economico, questo mi sembra evidente. Arbitrare è il mio modo di continuare a vivere il calcio, ora che non posso più giocare. Gli insulti ci sono e fanno parte del mestiere, ma non hanno valore. In campo vado a divertirmi, non a subire». Gianmaria risponde alla domanda facendo un paragone ludico. «È come quando si fa una partita a Lupus in Fabula, il gioco di società. Puoi voler giocare come lupo o come contadino, ma per far sì che si possa andare avanti qualcuno deve fare il narratore. A me piace essere quel qualcuno, anche se devo rimanere fuori».
Nel gioco il narratore è l’unico che non vince e non perde. Serve a far andare avanti la partita. Senza di lui, il lupo non uccide e i contadini non sospettano. L’arbitro di periferia è la stessa figura: non appartiene a nessuna squadra, non difende nessun interesse, ma rende possibile il gioco. Racconta, interrompe, sentenzia. E per questo diventa il nemico. È il paradosso di uno sport che colpisce chi lo tiene in piedi.
Domenica mattina, centro sportivo Casal Palocco. Campionato Pulcini, gioca mio figlio, sono qui solo per questo. Mi dirigo verso gli spalti cercando di identificare la zona più spopolata possibile.
L’orario e la mancanza di affinità col resto del mondo mi rendono poco sociale, sai com’è. Mi accomodo vicino ad una coppia infreddolita, staccata dalle tifoserie, da madri e padri pronti alla guerra, Incrociamo lo sguardo e mi viene spontaneo mettere le mani avanti: «Mio figlio gioca con gli ospiti», dico, «giusto per farvelo sapere». Due paia di occhi mi fissano con la rassegnazione di chi sta pensando: «Ma tu che ne sai, amico».
«Non si preoccupi» dice lui.«Siamo i genitori dell’arbitro».
Improvvisamente mi è passata l’umidità. Bevo il caffè ormai freddo, non è poi così male dai. M.
La Romulea Autistic FC mostra come lo sport possa essere un luogo reale di partecipazione, non un’eccezione
All’ingresso del centro sportivo di Via Farsalo 21 c’è un cancello come tanti. Dentro, per i calciatori del Romulea Autistic FC, c’è molto di più. «Qui noi siamo stati accolti», raccontano: «Per molti di loro questo campo è diventato una seconda casa».
Il progetto parte nel 2015, a Roma, durante un triangolare di calcio a 11 organizzato per la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo. In quell’occasione si improvvisa una squadra mista composta da giocatori nello spettro autistico, familiari, amici, volontari e operatori. Da lì nasce l’idea di trasformare quell’esperienza in qualcosa di stabile, strutturato, continuativo. Nell’autunno successivo prende forma un progetto di inclusione sportiva con il sostegno del Gruppo Asperger Lazio, della cooperativa Giuliaparla onlus e della cooperativa Garibaldi.
Il portiere della squadra, Matteo Capponi ha 25 anni ed è qui da dieci. Per lui il campo da calcio è prima di tutto appartenenza. Uno spazio in cui stare insieme, condividere obiettivi, sentirsi parte di qualcosa. Dopo esperienze difficili nel calcio tradizionale, dove l’interazione con gli altri era complessa e spesso fraintesa, questo contesto ha cambiato tutto. «Qui le regole sociali non sono una trappola, ma un percorso condiviso». Oggi, oltre a difendere la porta, sente una responsabilità verso i più giovani: orientarli, aiutarli a capire il gioco e se stessi. Fuori dal campo si divide tra lavoro, musica, università e sport. Non è semplice, ma riesce a trovare un equilibrio.


Il capitano Pietro Cirrincione, 52 anni, arriva da una storia diversa. Scopre la propria condizione in età adulta e da lì trasforma lo sport in uno strumento di diritti e inclusione. «In Italia il calcio è universale, parla a tutti, aggrega senza chiedere permesso. Il progetto nasce così: non giocare per essere celebrati, ma giocare davvero. Squadre miste, senza categorie speciali, dentro il contesto ordinario.» Il progetto con il tempo cresce e acquisisce una dimensione europea.
Con il programma Sacree, finanziato dal Programma Erasmus+ Sport della Commissione Europea e attivo fino al 2025, l’obiettivo è migliorare la qualità della vita delle persone nello spettro autistico attraverso la pratica sportiva inclusiva. Un modello pedagogico che si fonda su tre principi chiave: transnazionalità, transdisciplinarietà e intersettorialità. Lo sport come strumento educativo, sociale e culturale, capace di generare soluzioni sostenibili e replicabili.
I risultati arrivano anche sul campo. Nel 2024 la Romulea Autistic FC vince la prima edizione della Lega Unica. Ma il trofeo è solo una parte della storia. A vincere sono tutti i giocatori che hanno potuto finalmente partecipare a un torneo organizzato, vivere la domenica mattina come qualsiasi altro calciatore. Famiglie sugli spalti, esultanze, delusioni, sorrisi fuori dal campo. Un’opportunità tutt’altro che scontata per chi, fino a poco tempo fa, poteva contare solo su amichevoli sporadiche.
L’allenatore Valerio De Carli racconta il suo passaggio dalle giovanili della Romulea alla Autistic FC. Qui l’allenamento viene strutturato sulla base di obiettivi tecnici e agonistici. Non solo socialità, ma crescita sportiva. Le competizioni servono, motivano, danno senso al lavoro. L’agonismo come alleato.
Antonio Tommasi, preparatore atletico, è arrivato con un tirocinio universitario e non se n’è più andato: «Quello che ti danno i ragazzi qui non te lo da nessuno, loro tendono a isolarsi, invece con lo sport di gruppo riescono a socializzare e crescere»
In questo campo il calcio non è terapia, né eccezione. È normalità condivisa. È la dimostrazione che l’inclusione non si costruisce creando spazi a parte, ma entrando, insieme, in quelli che già esistono.
1. La Romulea Autistici FC al completo 2.La squadra durante l'allenamento

Due giovani rapiscono la potente amministratrice delegata di una multinazionale, convinti che sia un’aliena pronta a distruggere la Terra. Tra satira sociale e thriller psicologico, Bugonia di Yorgos Lanthimos esplora il confine tra verità e paranoia, dove il sospetto diventa l'unica lente per interpretare il caos del mondo contemporaneo. Con 9 nomination agli Oscar, la pellicola conferma il sodalizio artistico tra il regista greco ed Emma Stone. Un’opera disturbante e divertente per chi vuole interrogarsi su cosa resti della realtà nell'era della post-verità.
In arrivo su Sky Cinema e in streaming su NOW dal 4 febbraio.
Tornati dalla Grande Guerra e dalla malavita di Chicago per aprire un club per la comunità locale, solo per trovarsi a combattere un male oscuro, I Peccatori di Ryan Coogler - candidato a 16 Oscar - segue le vicende dei fratelli gemelli Elijah “Smoke” e Elias “Stack”. Coogler trasforma l’incubo vampiresco di due fratelli in un affresco che parla di identità, lotta e memoria, grazie a un’idea narrativa magnetica e a interpretazioni che non si dimenticano.
Disponibile sulle piattaforme NOW e Sky Tv.


Negli anni Novanta, mentre si parlava di fine dei conflitti e trionfo dell’Occidente, nei centri sociali e negli spazi autogestiti sorgevano forme di resistenza culturale. Nell’underground italiano si pubblicavano riviste come Torazine e Decoder, al Forte Prenestino si esibivano i Fugazi e il collettivo Luther Blisset sabotava dall’interno l’industria televisiva e culturale. Valerio Mattioli racconta un decennio “rimosso”, un’esperienza collettiva ancora utile per ridefinire il futuro.
a cura di Marco Chiaradonna

Classe 2003, belga-marocchina, Ayada firma un progetto da dodici tracce per mezz’ora di musica, con Gunna come produttore esecutivo e unico ospite. L’album è compatto e curato, Dina Ayada rappa e canta. R&B e rap melodico si intrecciano con l’attitudine decisa di una trapper. In un percorso di vita giovane e in continuo cambiamento, parlare di identità non è semplice. Ayada racconta la crescita tra culture e continenti, mettendo a fuoco indipendenza, ambizione e auto-definizione, mentre la sua carriera accelera. Una ricerca di ordine nel caos, alle proprie regole.
Anche il Diavolo sorride quando parte IDK. Il rapper cresciuto nel Maryland torna il 23 gennaio 2026 con e.t.d.s. A Mixtape by .idk., un progetto che ha l’ambizione e la coesione di un album. Le quindici tracce si muovono tra beat alla Timbaland dei primi Duemila, firmati dallo stesso IDK, e le geometrie di Kaytranada. È una riflessione personale sul sistema penale statunitense, nel quale l’artista ha trascorso tre anni. IDK approfondisce la sua incarcerazione attraverso liriche taglienti su colpa, tradimento e fede. I feat di Black Thought e Pusha T, le produzioni di Conductor Williams e i versi postumi di DMX e MF DOOM completano un disco east coast vitale e sorprendentemente attuale.

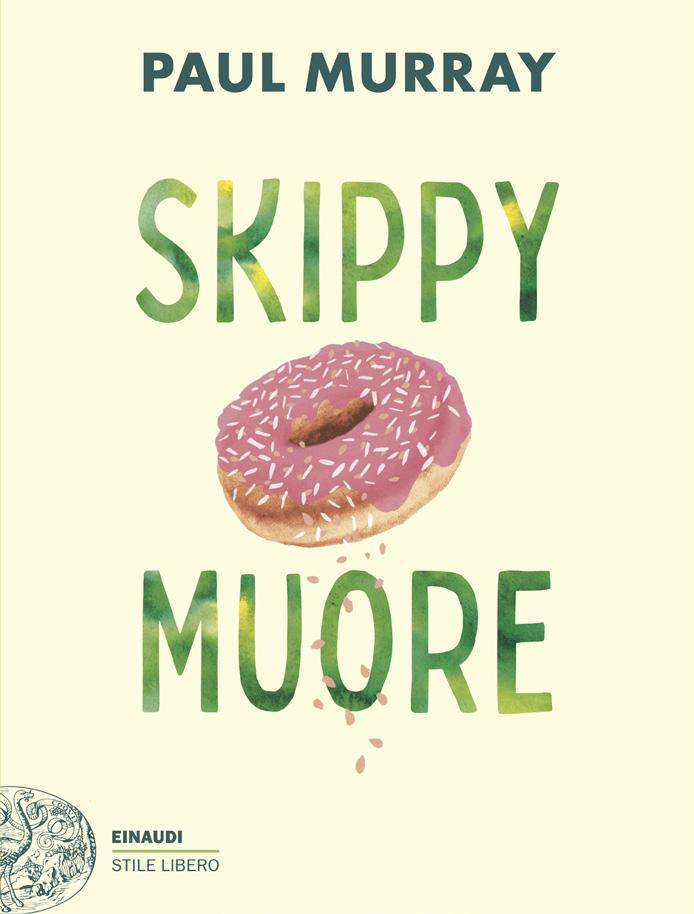
Una gara a chi mangia più ciambelle, Skippy cade a terra. Un ultimo gesto, una scritta tracciata sul pavimento, Skippy è morto. Il prologo dell’esordio letterario di Paul Murray, uscito dieci anni fa e a gennaio ripubblicato da Einaudi, obbliga ad affrontare il romanzo con in mente un’immagine fissa. Non propriamente tragica, in fase di elaborazione, che ha bisogno di settecento pagine per definirsi. Dietro uno strampalato gruppo di ragazzini in collegio, c’è una comunità di adulti che esercita nei loro confronti una forma di risveglio forzato da una grande illusione. Una lunga e veloce narrazione che alterna passaggi comici a momenti drammatici, un flusso emotivo costante che travolge il lettore dall’inizio alla fine.
a cura di Marco Chiaradonna
La posta di Zeta è lo spazio dove puoi raccontare dubbi, paranoie e piccoli (grandi) drammi — di cuore, di vita, di lavoro, di tutto quello che ti tiene sveglio la notte. Qui si chiede consiglio, ci si sfoga, ci si consola e, ogni tanto, si ride anche. Insomma, il posto giusto per sentirsi un po’ meno soli.
Questo mese parliamo di amori a distanza: storie che sopravvivono ai chilometri, ai fusi orari e ai vocali riascoltati mille volte.
Ciao, la distanza che per lunghi anni ha segnato la mia relazione, alcuni mesi fa si è trasformata in distacco. La nostra storia si è conclusa male, fino a trasformarsi in dolore. Sono tre parole chiave che cominciano con la stessa lettera. I chilometri e i mari che ci dividevano non mi hanno permesso di vedere la fine del nostro rapporto. Ci siamo lasciati senza salutarci. Come si accetta una fine che non si è potuta vedere arrivare? È possibile perdonare senza un vero addio? Giuseppe, 23 anni
Caro Giuseppe, sai che c’è? Prova a perdonare te stesso. Hai sofferto, sì, ma non sprecare il tuo tempo prezioso per qualcuno che non ti merita. Esci, vai a cena, ascolta la tua musica a palla, balla se ti va. Smettila con la playlist “Indie Triste”. Scrollati di dosso la polvere del passato, anche se brucia un po’. Fallo senza pensarci troppo, con decisione. Una parola che comincia con quella stessa lettera.


Siamo una coppia che vive tra Roma e Seoul: come si può condividere la quotidianità quando c’è di mezzo un fuso orario così grande?
Maria Chiara, 28 anni
Cara Maria Chiara, mi hai costretto a googlare il fuso orario di Seoul! Se ho capito bene, quando tu vai a dormire, al tuo ragazzo suona la sveglia. Per parafrasare un poeta migliore di me, cerca di trovare nel bel mezzo dell’inverno un’invincibile estate. Il suo pomeriggio e la tua mattina saranno la vostra Tortuga: costruite il vostro rifugio dentro quelle ore. Una relazione si può gestire a qualunque distanza. Potete essere felici anche se non condividete lo stesso CAP. Faccio il tifo per voi. E soprattutto, se puoi, vallo a trovare. E promettimi di scrivermi ancora tutte le meraviglie del Kimchi. Annyeong.
Ciao, con il mio ragazzo sto vivendo un periodo particolare. Lui è in Erasmus in Spagna, mentre io sono rimasto a Roma. Ho paura che possa tradirmi con le persone che conosce in questi contesti festaioli, ma allo stesso tempo ho timore di dirglielo per non sembrare pesante. A volte mi capita di pensare di non avere piena fiducia in lui, e questo mi spaventa perché mi fa temere che la nostra relazione possa essere, in realtà, superficiale. Mi consiglieresti di parlargliene apertamente o di rimandare il confronto a quando tornerà in Italia? Secondo te è giusto che io vada a trovarlo spesso in Spagna? Salvatore, 24 anni
Caro Salvatore, un pizzico di gelosia è normalissimo, soprattutto se è la prima volta che siete lontani. L’importante è non farsi prendere la mano. Attenzione a non confondere la spensieratezza dell’Erasmus – feste, balli e vita sociale (che un po’ tutti abbiamo vissuto) – con la superficialità, sua o della relazione. Se senti che la fiducia sta vacillando, parlane con lui senza troppi giri: se tu sei sincero, è più facile che lo sia anche lui. Non rimandare all’infinito. E sì, vai pure a trovarlo… ma solo se anche lui è d’accordo. L’Erasmus è un periodo speciale: serve a conoscersi meglio, a ritrovarsi o a scoprire lati nuovi di sé. Vivilo così, senza esagerare con il controllo o le paure. È proprio da qui che può ripartire la fiducia.

Secondo te, quanto può durare una relazione a distanza prima di arrivare al punto di decidere se ricongiungersi o lasciarsi? Claudia, 26 anni
Cara Claudia, l’amore non ha tempi fissi e non segue istruzioni. Se ogni relazione ha i suoi dubbi, una a distanza ne ha almeno il doppio. Ma se qualcosa batte tra voi, continuerà a battere: lasciarsi non è davvero un’opzione. Riguardo alla possibilità di ricongiungersi… be’, per noi giovani fare programmi a lungo termine è già difficile di suo, figuriamoci con la distanza. Quindi godetevi il momento, fatela durare finché serve, senza stressarvi troppo sul “quando” o sul “come”. In altre parole: il meno possibile.

Quali argomenti ritieni fondamentali da affrontare con il proprio partner prima di intraprendere una relazione a distanza? Lucrezia, 26 anni
Cara Lucrezia, la formula magica per rispondere a questa domanda non è stata ancora trovata. Lasciati guidare dalle sensazioni, da quello che senti davvero. Se la relazione è pronta a decollare anche con la distanza di mezzo, vuol dire che avrete già affrontato tutto ciò che serve per costruire qualcosa di solido. Se invece non è il momento giusto, pazienza: sarà per un’altra volta. Ma se siete entrambi pronti, il viaggio sarà tranquillo e anche divertente. Preparati alle fatiche delle storie a distanza: quando c’è molto tempo da aspettare, bisogna trovare il modo giusto di riempirlo, a meno di non voler passare quelle ore a sentirsi semplicemente tristi. E preparati anche ai vantaggi: sarete molto onesti l’uno con l’altra, condividerete tutto, faccia a faccia e online. Sai che risate. Buon volo.


Ariete (21 Mar-19 Apr)
Leonardo da Vinci (15 Apr)
In università sei una forza della natura, ma spesso colpisci tutto tranne il bersaglio. Parti fortissimo, poi cambi idea, credenziali Luiss e probabilmente vita. In amore tagli netti.


Toro (20 apr – 20 Mag)
George Clooney (6 Mag)
Studi lento ma inesorabile, come un treno regionale che però arriva sempre a destinazione. Il 2026 premia la tua pazienza. In amore vuoi stabilità vera, non promesse da serie Netflix.
Gemelli (21 Mag – 20 Giu)
Marilyn Monroe (1 Giu)
Hai idee geniali, ma il problema è ricordarti dove le hai lasciate. Il 2026 ti impone una parola chiave: finire. Brilli negli orali e nei lavori di gruppo. In amore sorprendi tutti (te incluso). Spegni il telefono: la vita reale esiste ancora.
Cancro (21 Giu – 22 Lug)


Tom Hanks (9 Lug)
Dici di non studiare mai, ma sai sempre tutto. Il 2026 ti rende più forte emotivamente, anche se l’ansia resta come compagna di banco. In amore vuoi sicurezza, non drammi inutili. Social: smetti di confrontarti con chi finge di avere tutto sotto controllo.
Leone (23 Lug – 22 Ago)
Barack Obama (4 Ago)
Entri in aula come se fosse un palcoscenico. Il 2026 però vuole contenuti, non solo presenza scenica. In amore basta cercare applausi: vuoi qualcuno che ti capisca davvero. Ricorda: i like non sostituiscono i CFU.

Vergine (23 Ago – 22 Set)
Beyoncé (4 Set)
Il 2026 è il tuo anno: tabelle, evidenziatori e risultati. Attenzione solo a non trasformare lo studio in una punizione divina. In amore molli il controllo (ogni tanto). Social tip: non correggere tutti, non è un esame.


Bilancia (23 Set – 22 Ott)
Kim Kardashian (21 Ott)
Devi scegliere. Sì, proprio tu. Esami, relazioni, priorità: niente più “vediamo”. In amore o sì o no. Sui social evita sondaggi esistenziali: non aiutano.
Scorpione (23 Ott – 21 Nov)
Leonardo DiCaprio (11 Nov)
Quando studi, sparisci. Letteralmente. Il 2026 è perfetto per esami tosti e tesi. In amore cerchi profondità, non distrazioni. Instagram può aspettare: stai costruendo qualcosa di serio.

Sagittario (22 Nov – 21 Dic)
Taylor Swift (13 Dic)
Vorresti essere ovunque tranne che in redazione. Il 2026 però ti insegna a restare. Alterni caos e genialità. In amore meno fughe, più presenza. I meme prima dell’esame sono una trappola.

Capricorno (22 Dic – 19 Gen)
Denzel Washington (28 Dic)
Studi come fosse un lavoro e infatti funziona. Il 2026 consolida tutto ciò che hai costruito. In amore vuoi qualcuno che regga il tuo ritmo. Networking sì, ma senza dimenticare i libri.

Acquario (20 Gen – 18 Feb)
Oprah Winfrey (29 Gen)
Idee geniali, orari improbabili. Il 2026 premia chi osa, ma con un minimo di organizzazione. In amore vuoi libertà, ma anche qualcuno che resti. Attenzione ai trend: non sono tutti indispensabili.

Pesci (19 Feb – 20 Mar)
Albert Einstein (14 Mar)
Studi a sentimento, ma incredibilmente funziona. Il 2026 ti insegna a dare forma ai sogni. In amore cerchi connessione vera, non illusioni. Social ottimi per ispirarti, pessimi per rimandare tutto.

Research center specializing in social media, data science, digital humanities, artificial intelligence, digital narrative, and the fight against disinformation
Partners: ZetaLuiss, MediaFutures, Leveraging Argument Technology for Impartial Fact-checking, Catchy, CNR, European Commission, Social Observatory for Disinformation and Social Media Analysis, Adapt, T6 Ecosystems, Harvard Kennedy School, European Parliament

