

LA NUOVA ERA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA
Come digitalizzazione e IA stanno cambiando il settore
A cura di Lucia Angeloni

LA NUOVA ERA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA
Come digitalizzazione e IA stanno cambiando il settore
A cura di Lucia Angeloni
Enrico Finocchi
Presidente
Comitato Centrale
Albo degli Autotrasportatori
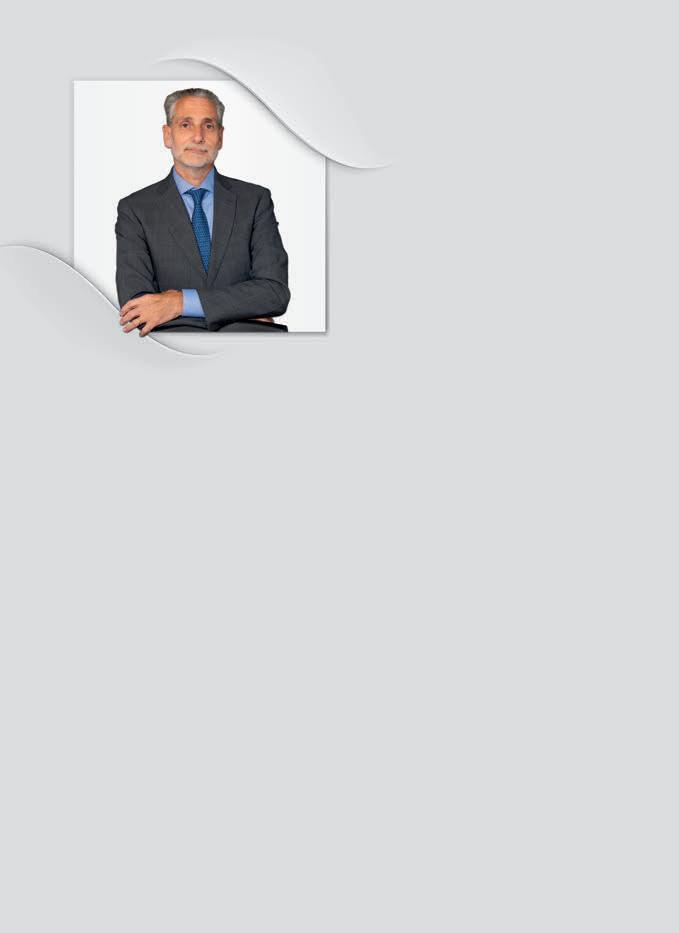
In ogni epoca di transizione, non sopravvive chi resiste al cambiamento ma chi sa interpretarlo e trasformarlo in opportunità. Nel mondo dei trasporti e della logistica questa verità è oggi più attuale che mai.
La digitalizzazione e l’intelligenza artificiale stanno infatti trasformando profondamente questo settore, spina dorsale del commercio globale.
Le tecnologie digitali stanno cambiando il modo in cui si muovono le merci, migliorando la capacità di pianificazione, di previsione e di gestione dei flussi. I dati sono diventati una risorsa strategica: analizzati e interpretati in tempo reale, consentono decisioni più rapide, processi più efficienti e una maggiore sostenibilità economica e ambientale. L’intelligenza artificiale, in particolare, apre prospettive nuove per la gestione predittiva della domanda, l’ottimizzazione dei percorsi, la sicurezza e l’intermodalità.
Questa evoluzione, quindi, rappresenta una grande opportunità per rendere il sistema logistico nazionale più competitivo e resiliente, ma anche più sostenibile e integrato con gli obiettivi della transizione ecologica.
Allo stesso tempo, si tratta di una sfida complessa per le imprese del settore, chiamate a ripensare i propri modelli organizzativi, ad adottare nuove competenze digitali e a investire in innovazione e in formazione per restare protagoniste in un contesto in rapido mutamento.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è pienamente consapevole di questa sfida e del ruolo strategico che la logistica riveste per la crescita del Paese. Per questo sta accompagnando le imprese
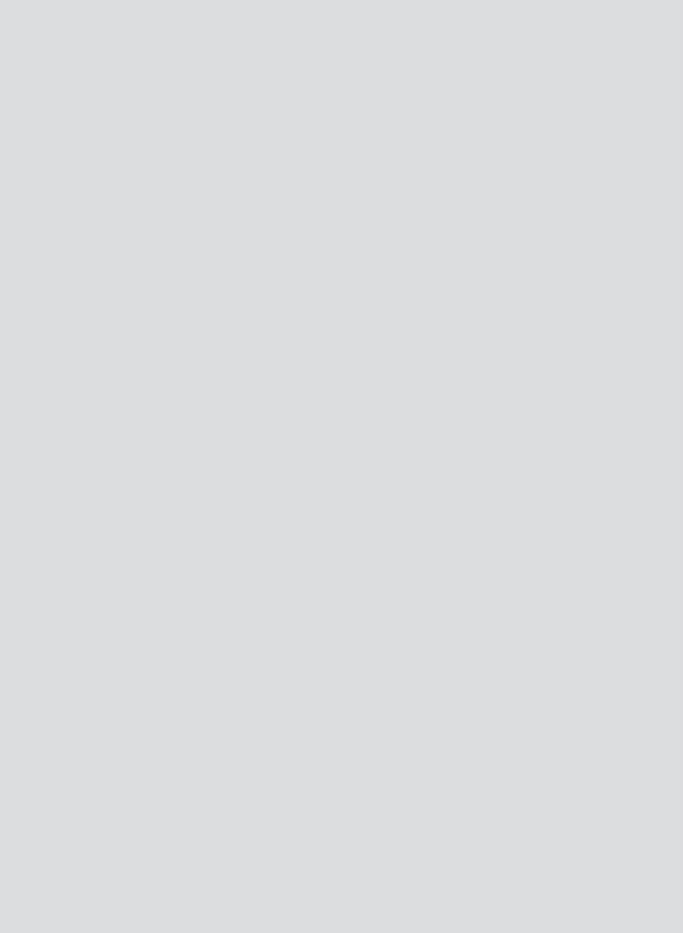
nel loro percorso di trasformazione, adottando politiche in grado di facilitare questo processo e mettendo in campo ingenti risorse per sostenere gli investimenti.
Il PNRR prevede per il programma di digitalizzazione della catena logistica un finanziamento complessivo di 250 milioni di euro; una misura concreta in questa direzione è il recente bando Login Business che ha messo a disposizione delle imprese di trasporto e logistica 157 milioni di euro per la loro trasformazione digitale.
Anche l’Albo degli Autotrasportatori non è esente da questo processo evolutivo. Negli ultimi anni abbiamo fatto sforzi ingenti per digitalizzare tutti i processi e per consentire alle imprese di autotrasporto e agli utenti abilitati di effettuare tutti i servizi anche online, attraverso il portale www.alboautotrasporto.it. È stato creato, ad esempio, un applicativo pedaggi, che consente di poter presentare online la domanda per ottenere la riduzione compensata del costo sostenuto per i pedaggi autostradali nell’anno di riferimento.
O ancora il servizio per il pagamento della quota annuale, tramite l’applicativo ad esso dedicato. Senza dimenticare il servizio Regolarità imprese che permette agli utenti registrati e abilitati di poter consultare online la regolarità contributiva di una impresa iscritta all’Albo. È stato anche introdotto un applicativo informatico per la “gestione istruttoria” delle imprese iscritte, che supporta la verifica dei requisiti delle imprese tramite sistema digitale.
Insomma, anche l’Albo degli Autotrasportatori ha compiuto il processo digitale a cui sono chiamate adesso tutte le imprese. Perché solo così la logistica potrà continuare a svolgere il suo ruolo strategico, garantendo sviluppo, competitività e sostenibilità per le generazioni future.
1 Digitalizzazione e IA: il mondo sta cambiando
La rivoluzione silenziosa
Il mondo in cui viviamo sta attraversando una trasformazione profonda e irreversibile.
Ogni ambito della società - dall’economia alla sanità, dall’istruzione alla comunicazione - sta sperimentando da cambiamenti profondi, che si stanno verificando a una velocità senza precedenti.
E al centro di questa rivoluzione ci sono due forze trainanti: la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale.
Parole che sono ormai entrate nel lessico comune ma su cui vale la pena soffermarci qualche secondo. La digitalizzazione è il processo di conversione dei dati dal formato analogico, ad esempio dei documenti cartacei, a quello digitale, ovvero un formato in grado di essere elaborato da un computer.
La digitalizzazione ha completamente ridefinito il modo in cui produciamo, condividiamo e utilizziamo le informazioni. Processi che un tempo richiedevano giorni o settimane ora si svolgono in tempo reale, rendendo il mondo più interconnesso che mai. L’elaborazione dei dati permette inoltre di integrare le informazioni che arrivano da diverse fonti in un’unica piattaforma, automatizzando i processi, riducendo i tempi e i costi operativi e minimizzando gli errori umani. Dagli enti pubblici alle imprese, nessun settore può ormai prescindere da una presenza digitale solida e ben strutturata.
L’intelligenza artificiale (IA) è invece un ramo dell’informatica che si occupa di creare macchine o sistemi in grado di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività. La Comunicazione della Commissione europea sull’IA, del 2018, la definisce così:“L’intelligenza artificiale (IA) si riferisce a sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando l’ambiente che li circonda e
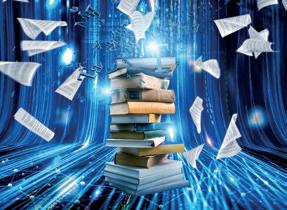

compiendo azioni – con un certo grado di autonomia – per raggiungere obiettivi specifici. I sistemi basati sull’IA possono essere interamente software, operando nel mondo virtuale (ad esempio assistenti vocali, software di analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale), oppure possono essere integrati in dispositivi hardware (come robot avanzati, auto a guida autonoma, droni o applicazioni dell’Internet delle cose)”.
Quindi l’intelligenza artificiale permette al sistema di capire il proprio ambiente, di mettersi in relazione con quello che percepisce, risolvere problemi e agire verso un obiettivo specifico.
Il computer riceve i dati (già preparati o raccolti tramite sensori, come una videocamera), li processa e risponde. I sistemi di IA sono capaci di adattare il proprio comportamento analizzando gli effetti delle azioni precedenti e lavorando in autonomia.
Alcuni tipi di intelligenza artificiale esistono da più di 50 anni, ma negli ultimi anni, grazie ai progressi nella potenza dei computer e allo sviluppo di nuovi algoritmi, sono stati fatti passi da gigante. Molte volte non ci accorgiamo neppure quanto l’intelligenza artificiale sia diffusa intorno a noi. Quando chiediamo qualcosa a Siri o ad Alexa, stiamo chiedendo aiuto all’intelligenza artificiale. Quando usiamo i software di traduzione automatica, stiamo utilizzando l’intelligenza artificiale. Lo stesso vale per i motori di ricerca o per i sistemi di riconoscimento facciale.
Quando poi digitalizzazione e intelligenza artificiale collaborano è possibile interpretare grandi quantità di dati in modo davvero innovativo. Pensiamo ad esempio al settore sanitario. La digitalizzazione ha permesso di creare enormi archivi elettronici di dati clinici: cartelle sanitarie digitali, immagini radiologiche, referti, dati genetici e parametri vitali. Questa mole di informazioni, un tempo difficile da gestire,
oggi è accessibile in tempo reale da più centri, grazie a sistemi digitali interconnessi. L’intelligenza artificiale entra in gioco analizzando questi dati in modo rapido ed estremamente preciso. Un esempio concreto è l’utilizzo dell’IA per l’analisi automatica di immagini mediche, come mammografie, TAC o risonanze magnetiche. Algoritmi addestrati su milioni di casi sono in grado di individuare in pochi secondi anomalie o segnali precoci di malattie, anche minime, spesso prima che siano visibili a occhio umano.

Anche il settore dei trasporti e della logistica, naturalmente, sta beneficiando di queste due realtà e della loro connessione. La digitalizzazione ha reso possibile la tracciabilità in tempo reale di ogni spedizione: grazie a sensori GPS, RFID, e piattaforme digitali integrate, è possibile sapere in ogni momento dove si trova un carico, in quali condizioni viaggia (temperatura, umidità, urti) e quando arriverà a destinazione. E su questi dati può agire l’intelligenza artificiale, ad esempio ottimizzando i percorsi di consegna, prevedendo ritardi (causati da traffico, meteo, guasti) e riducendo i costi operativi.
Insomma, quello che stiamo vivendo è un cambio epocale, con la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale che sono diventate leve concrete di cambiamento in ogni ambito economico, sociale e produttivo. Vediamo quindi come il mondo sta cambiando e come sta cambiando in particolare il mondo dei trasporti e della logistica, quali sono le sfide che attendono le imprese e quali le opportunità da cogliere.
Ma partiamo dalla visione dell’Europa e da come la Commissione europea sta promuovendo questo cambiamento.

La strategia digitale dell’Europa
L’Unione europea ha individuato nella digitalizzazione e nell’intelligenza artificiale due pilastri fondamentali per garantire autonomia strategica, sostenibilità e innovazione. Iniziative come il Digital Europe Programme e le linee guida sull’intelligenza artificiale vanno appunto in questa direzione.
Vediamole nel dettaglio, partendo dalla strategia sulla digitalizzazione definita nella Comunicazione emanata dalla Commissione il 9 marzo 2021 “2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade”.
Nella comunicazione la Ue definisce quattro aree prioritarie, con obiettivi da raggiungere entro il 2030:
• assicurare ad almeno l’80% della popolazione adulta il possesso di competenze digitali di base;
• costruire infrastrutture digitali idonee a garantire l’accesso per tutti i cittadini ai servizi digitali;
• prevedere che almeno i tre quarti delle imprese facciano uso di cloud computing, big data e intelligenza artificiale;
• garantire l’accessibilità online a tutti i principali servizi pubblici e l’utilizzo dell’identificazione digitale.


Per sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell’economia, dell’industria e della società, l’Europa ha varato il programma Digital Europe (Europa Digitale), operativo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. Le risorse messe a disposizione dal programma ammontano a 7,5 miliardi di euro per cinque ambiti di intervento:
- 2,2 miliardi per l’high performance computing;
- 2,06 miliardi per l’IA;
- 1,6 miliardi per la cyber security;
- 577 milioni di euro per lo sviluppo di competenze digitali di base;
- 1,072 miliardi per le azioni rivolte a promuovere il miglior utilizzo di queste tecnologie.
Un programma molto vasto e articolato che si intreccia con altri progetti europei volti a promuovere l’innovazione digitale quali, ad esempio, Horizon Europe, il programma quadro per la ricerca e l’innovazione, sempre per il periodo 2021-2027, che con un budget di circa 95 miliardi finanzia anche molti progetti legati al digitale (intelligenza artificiale e robotica, industrie digitali e manifattura intelligente, tecnologie quantistiche, integrazione tra scienza, tecnologia e società).
Altri fondi arrivano inoltre dal programma Connecting Europe Facility – Digital (CEF Digital), che finanzia infrastrutture digitali transfrontaliere, come le reti 5G lungo i corridoi di trasporto o i progetti per l’interoperabilità tra i sistemi digitali dei vari Paesi, dal Next Generation EU, che prevede che almeno il 20% dei fondi di ogni Paese sia dedicato alla transizione digitale. C’è poi il programma InvestEU, che non dà contributi a fondo perduto, ma garanzie finanziarie e strumenti di investimento per progetti innovativi, anche nel settore digitale.
L’Europa ha anche varato alcune leggi strategiche per creare un ecosistema digitale aperto, sicuro e competitivo.
Una di queste è il Digital Markets Act (DMA) che stabilisce delle norme specifiche per i principali attori del mercato digitale, detti gatekeeper, quali ad esempio Google, Apple o Amazon, ed è volto a garantire concorrenza e trasparenza.
Vi è poi il Data Governance Act (DGA), volto a favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati all’interno dell’Ue, in settori chiave come la
Legislazione per un mercato digitale equo e sicuro
I fondi Ue

salute, l’ambiente, l’energia, la mobilità, la finanza; o ancora il Digital Services Act (DSA), che regola le piattaforme online per garantire trasparenza, sicurezza e lotta alla disinformazione.
Di grande importanza anche la Direttiva NIS2 sulla sicurezza informatica nell’Ue, che mira a elevare il livello di cybersicurezza negli Stati membri, che nei mesi scorsi è stata recepita anche in Italia.
Si tratta di un passo avanti rispetto alla precedente NIS perché istituisce un quadro giuridico unificato e invita gli Stati membri sia a definire strategie nazionali (in Italia questo compito spetta all’ACN, dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale), misure di gestione dei rischi e obblighi di segnalazione a soggetti di più settori, sia a collaborare e a condividere le informazioni (vedi approfondimento al capitolo 4).
La Direttiva amplia anche i settori sottoposti agli obblighi in questo senso, individuandone 18: energia; trasporti; settore bancario; infrastrutture dei mercati finanziari; sanità; acqua potabile; acque reflue; infrastrutture digitali; gestione dei servizi TIC (business-to-business); Pubblica amministrazione; spazio; servizi postali e di corriere; gestione dei rifiuti; fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche; produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti; fabbricazione in altri settori (vedi capitolo 4); fornitori di servizi digitali; ricerca.
La normativa prevede soglie minime in termini di fatturato, numero di dipendenti o volume di dati trattati, al fine di individuare le organizzazioni più significative per la continuità dei servizi essenziali.
La sfida dell’intelligenza artificiale
Oltre alla digitalizzazione, l’Unione europea ha riconosciuto l’intelligenza artificiale come un’area di estrema importanza. Il documento “Intelligenza artificiale per l’Europa”, pubblicato dalla Commissione europea il 25 aprile 2018, è stato la prima comunicazione ufficiale che ha definito la strategia dell’Ue sull’intelligenza artificiale.
L’IA viene riconosciuta come una tecnologia rivoluzionaria, con il potenziale di trasformare profondamente la società e l’economia, come è accaduto in passato per il motore a vapore o l’elettricità.
Il documento indica quindi le priorità e le iniziative da intraprendere, a partire da un aumento degli investimenti, indicati in “almeno 20 miliardi di euro entro la fine del 2020” e di oltre 20 miliardi nel decennio successivo. La Comunicazione invitava inoltre a una cooperazione tra gli Stati membri, coordinando le proprie strategie nazionali, a investire nella formazione di specialisti in IA, e ad assicurare un quadro etico e giuridico adeguato, fondato sui valori dell’Unione e coerente con la Carta dei diritti fondamentali.
Nel 2020, poi, la Commissione europea ha presentato il “Libro bianco sull’intelligenza artificiale - Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia”, nel quale discute l’impatto dell’IA su vari aspetti della società, con l’obiettivo di definire le opzioni politiche per la promozione dello sviluppo dell’IA, garantendo al contempo la fiducia, il rispetto dei valori europei e la tutela dei diritti fondamentali. Anche questo documento evidenzia la necessità di aumentare gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione in materia di IA per posizionare l’Europa come ecosistema di eccellenza.
Dal punto di vista normativo, il Libro bianco sottolinea l’importanza di un piano comune europeo per l’IA e soprattutto in-

Le categorie di rischio dell’IA
dividua quando l’intelligenza artificiale deve essere considerata ad alto rischio, facendo così da preludio all’emanazione della proposta dell’Artificial Intelligence Act, nel 2021, la prima legge completa al mondo sull’intelligenza artificiale emanato da un importante ente regolatore.
Le norme stabiliscono obblighi per fornitori e utenti in base a diverse categorie di rischio dell’IA: rischio inaccettabile, alto rischio, rischio limitato e rischio minimo.
Approccio basato sul rischio
RISCHIO INACCETTABILE (art. 5)
Banditi i sistemi di IA che minacciano la sicurezza i mezzi di sussistenza e i diritti delle persone
RISCHIO ALTO (art.6 e ss.)
I sistemi di IA ad alto rischio includono l’utilizzo di IA in settori o attività critici come il sitema giudiziario, l’educazione o l’occupazione
RISCHIO LIMITATO (art. 52)
Sistemi di IA con obblighi di trasparenza speci ci
RISCHIO MINIMO (art. 69)
Garantito l’uso di applicazioni a rischio minimo per i diritti o la sicurezza dei cittadini
Social scoring da parte dei giovani
Smistamento CV per reclutamento
Chatbot
Videogiochi abilitati dall’intelligenza arti ciale o ltri antispam
Le applicazioni di intelligenza artificiale considerate inaccettabili, e quindi vietate nell’Ue includono: - manipolazione cognitivo-comportamentale di persone o gruppi vulnerabili specifici: ad esempio giocattoli attivati vocalmente che incoraggiano comportamenti pericolosi nei bambini;
- IA con punteggio sociale: classificazione delle persone in base al comportamento, allo stato socioeconomico o alle caratteristiche personali; - identificazione biometrica e categorizzazione delle persone; - sistemi di identificazione biometrica in tempo reale e da remoto, come il riconoscimento facciale negli spazi pubblici.
Sono invece considerati ad alto rischi, e quindi soggetti a specifici requisiti legali, i sistemi di intelligenza artificiale che incidono negativamente sulla sicurezza o sui diritti fondamentali.
Quelli ad alto rischio sono divisi in due categorie: sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in prodotti soggetti alla legislazione Ue sulla sicurezza dei prodotti (tra cui rientrano giocattoli, aviazione, automobili, dispositivi medici e ascensori) e sistemi di intelligenza artificiale che rientrano in aree specifiche che dovranno essere registrate in una banca dati dell’Ue. Tra questi rientrano: gestione e funzionamento delle infrastrutture critiche; istruzione e formazione professionale; occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo; accesso e godimento di servizi privati essenziali e di servizi e benefici pubblici; applicazione della legge; gestione delle migrazioni, dell’asilo e del controllo delle frontiere; assistenza nell’interpretazione giuridica e nell’applicazione della legge.
Tutti i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio devono essere valutati prima di essere immessi sul mercato e durante tutto il loro ciclo di vita.
La produzione e l’utilizzo di sistemi di IA che presentano invece un rischio limitato saranno soggetti soltanto a obblighi di trasparenza.
Infine, la quarta categoria che include sistemi con un impatto minimo o nullo sui diritti o la sicurezza delle persone, come calcolatrici o videogiochi semplici.
Oltre alla classificazione del rischio, l’IA Act sottolinea l’importanza della supervisione umana nell’intelligenza artificiale, in particolare per quanto riguarda i sistemi ad alto rischio, e soprattutto l’importanza dell’etica: lo sviluppo e l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale devono essere guidati da principi come l’equità, la non discriminazione, la responsabilità e la privacy.
A febbraio 2025 è iniziata la prima fase di applicazione pratica dell’AI Act, con l’entrata in vigore del divieto delle pratiche di IA a rischio inaccettabile. Da agosto 2025 sono inoltre applicabili le sanzioni per la violazione di tali norme; coloro che non rispettano le disposizioni dell’AI Act rischiano infatti sanzioni severe, con multe che possono raggiungere i 35 milioni di euro o il 7% del fatturato globale annuo, a seconda di quale valore sia maggiore. Ad agosto 2026 scatteranno poi gli obblighi per i sistemi ad alto rischio mentre per tutti gli altri sistemi ci sarà tempo fino al 2 agosto 2027.
Le tappe dell’AI Act

AI Continent Action Plan
La strategia Apply AI
Ad aprile di quest’anno la Commissione europea ha poi lanciato ufficialmente l’AI Continent Action Plan, un programma ambizioso che aspira a fare dell’Europa il primo polo mondiale di intelligenza artificiale. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’Unione in un hub tecnologico globale, capace di competere con le grandi potenze, Stati Uniti e Cina in testa, e di affermare un modello europeo basato su regole, trasparenza e diritti fondamentali. Nel 2024, solo il 13,5% delle aziende nell’Ue ha adottato l’IA, secondo i dati della Commissione. Per questo, il piano d’azione deve essere forte e svilupparsi lungo cinque filoni chiave: investimenti in infrastrutture di calcolo su larga scala (gigafactory di IA), dotate di circa 100mila chip di IA all’avanguardia (un numero quattro volte superiore rispetto alle attuali fabbriche); miglioramento dell’accesso ai dati; promozione dell’adozione dell’IA nei settori strategici dell’Ue; rafforzamento delle competenze e dei talenti in materia di IA e semplificazione normativa.
Infine, a ottobre 2025, l’Europa ha presentato Apply AI, che integra l’AI Continent Action Plan sempre con lo scopo di diffondere l’intelligenza artificiale in tutti i settori produttivi e istituzionali.
La strategia si sviluppa su tre pilastri principali. Il primo punta a stimolare l’uso dell’IA in undici settori chiave, tra cui mobilità e trasporti; il secondo introduce misure di supporto trasversali, come le AI Factories e le Gigafactories mentre il terzo pilastro è dedicato alla governance, con la creazione dell’Apply AI Alliance, un forum che riunisce imprese,
università, centri di ricerca e istituzioni pubbliche per favorire il dialogo politico e condividere buone pratiche.
Per implementare queste strategie la Commissione mobiliterà un miliardo di euro da programmi di finanziamento esistenti.
Tra le moltissime applicazioni dell’intelligenza artificiale per il settore dei trasporti c’è anche la guida autonoma e i veicoli automatizzati, strettamente collegati con lo sviluppo di città e infrastrutture intelligenti, in grado di dialogare con i mezzi di trasporto. Il quadro normativo della mobilità intelligente è rappresentato dalla Direttiva Ue 2661/2023 che modifica la Direttiva 2010/40 e riguarda la diffusione dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale. Ogni Stato Membro deve recepirla entro dicembre 2025.
Tra i nuovi trend della mobilità individuati nella Direttiva c’è la mobilità connessa e autonoma. La prima si riferisce all’uso di tecnologie di comunicazione avanzate che permettono ai veicoli di scambiarsi informazioni tra loro e con le infrastrutture circostanti (come semafori, segnali stradali, centri di controllo). Questo scambio di dati consente di ottimizzare i percorsi, ridurre il traffico, prevenire incidenti e migliorare l’esperienza di viaggio.
La mobilità autonoma si riferisce a veicoli in grado di muoversi senza intervento umano, grazie a sensori, intelligenza artificiale e sistemi di percezione ambientale avanzati. L’unione di queste tecnologie crea sistemi di trasporto intelligenti e altamente automatizzati, come veicoli autonomi e connessi tra loro e con le infrastrutture, capaci di coordinarsi in tempo reale per migliorare la fluidità del traffico e ridurre gli incidenti.
In questo ambito, l’Europa ha approvato nel 2021 il Regolamento Unece n. 157, che nel corso degli anni è stato emendato più volte, che rappresenta il primo passo normativo per un sistema di guida automatizzata. Con l’ultimo aggiornamento, in vigore da quest’anno, il Regolamento consente l’utilizzo della guida autonoma di livello 3 sulle

Guida autonoma
strade europee, seppure solo in determinate condizioni. In Italia, al momento, il riferimento normativo principale è il Decreto Smart Road del 28 febbraio 2018, che permette l’omologazione di veicoli con sistemi di guida autonoma fino a Livello 2.
Ricordiamo che la classificazione dei livelli di guida autonoma è composta da sei categorie, dal livello 0 al livello 5, definiti dalla Society of Automotive Engineers (SAE). Questi livelli aiutano a distinguere le funzionalità automatizzate che un veicolo può svolgere, fino ad arrivare alla guida completamente autonoma.
Livello 0: guida totalmente affidata al conducente
Livello 1: sistemi di guida assistita di base, come l’ABS e il Cruise Control, che operano durante la frenata, accelerazione e rilevamento di corsia
Livello 2: a guida autonoma parziale, con intervento in frenata e accelerazione in caso di pericolo, ad esempio la frenata automatica di emergenza
Livello 3: automazione condizionale, in cui il mezzo può sostituire il guidatore in alcune situazioni, ma richiede la prontezza del guidatore per intervenire
Livello 4: elevata automazione, in cui il mezzo è in grado di monitorare l’ambiente circostante tramite sensori e compiere istruzioni di guida
Livello 5: piena automazione, il mezzo può gestire completamente la guida senza alcun intervento umano, adattandosi a scenari complessi.
In Italia il riferimento normativo principale è il Decreto Smart Road del 28 febbraio 2018, che permette l’omologazione di veicoli con sistemi di guida autonoma fino a Livello 2.
I livelli di automazione
definiti dalla Society of Automotive Engineers (SAE)
Livello 2
Livello 3
Livello 4
Livello 5
2 L’evoluzione digitale del trasporto merci e della logistica
Verso una logistica digitale: regolamenti e innovazioni
Negli ultimi anni la digitalizzazione è diventata il motore silenzioso, ma inarrestabile di una trasformazione che sta attraversando tutti i settori dell’economia e della pubblica amministrazione. Dalla manifattura ai servizi, dall’agricoltura alla sanità, l’adozione di strumenti digitali, piattaforme interoperabili e sistemi di raccolta dati in tempo reale sta ridefinendo modelli organizzativi, processi decisionali e relazioni tra imprese e istituzioni.
In questo scenario di profondo cambiamento, naturalmente, il trasporto merci e la logistica non potevano restare esclusi. La digitalizzazione del settore - attraverso la tracciabilità elettronica delle merci, la dematerializzazione dei documenti di trasporto e l’interconnessione delle piattaforme logistiche - è infatti un passaggio fondamentale per arrivare ad una logistica più efficiente, sicura e sostenibile.

L’evoluzione tecnologica, sostenuta anche dal PNRR e dalle politiche europee per la transizione digitale, infatti, non risponde solo a un’esigenza di modernizzazione, ma anche a quella di garantire maggiore sicurezza, semplificazione amministrativa e riduzione dei costi. La possibilità di seguire ogni fase del trasporto in tempo reale, di condividere dati in modo sicuro e automatizzato tra operatori e autorità pubbliche, e di disporre di informazioni integrate sull’intera filiera, rappresenta un salto di qualità che può migliorare la competitività del sistema logistico italiano nel suo complesso.
Un ruolo chiave nella trasformazione digitale del settore dei trasporti è svolto dal Regolamento Ue 1056/2020, noto come Regolamento eFTI (Electronic Freight Transport Information). Approvato dal Parlamento europeo nel luglio 2020, nell’ambito del terzo Pacchetto mobilità, il Regolamento costituisce un passo decisivo verso la dematerializzazione delle informazioni e la digitalizzazione dei flussi logistici in tutta l’Unione europea.
Con questo Regolamento, la Commissione europea ha inteso colmare un vuoto normativo introducendo un quadro giuridico uniforme che consente agli operatori economici - in particolare alle imprese di trasporto e logistica - di condividere con le autorità competenti le informazioni relative ai trasporti di merci in formato elettronico, per qualsiasi modalità di trasporto utilizzata: strada, ferrovia, vie navigabili interne o via aerea.
Oltre ad uniformare la trasmissione dei dati, il Regolamento eFTI ridurrà i costi e i tempi legati alla gestione cartacea, migliorerà la sicurezza dei dati e favorirà controlli più rapidi da parte delle autorità.
Per rendere possibile questa comunicazione digitale uniforme in tutti gli Stati membri, il Regolamento prevede l’adozione di specifiche tecniche comuni, da definire attraverso appositi atti delegati e di esecuzione. I primi due, che stabiliscono le procedure, le norme e le specifiche tecniche armonizzate per consentire alle autorità dei Paesi dell’Ue di accedere alle piattaforme digitali degli operatori del trasporto merci, sono già stati pubblicati quest’anno. A luglio 2027 le autorità pubbliche avranno l’obbligo di accettare le informazioni e i documenti elettronici, mentre le imprese potranno scegliere se continuare a utilizzare il formato cartaceo. Dopo il 2029 la Commissione valuterà se introdurre o meno l’obbligo anche per gli operatori. Cuore del nuovo

ecosistema sarà l’eFTI Gate, la piattaforma che garantirà l’interoperabilità tra i vari soggetti coinvolti - imprese, autorità e operatori logistici - e consentirà alle amministrazioni pubbliche di accedere in modo sicuro e standardizzato ai dati messi a disposizione dai privati.
Cronologia
Sono entrati in vigore i primi atti delegati e di attuazione dell’eFTI.
Gennaio 2025
Dicembre 2025
Gli Stati membri possono iniziare a sviluppare i sistemi informatici necessari per consentire alle autorità di veri care le informazioni sui trasporti conformi all’eFTI.
La Commissione prevede di adottare le restanti speci che di attuazione eFTI.
In questi documenti saranno de niti i requisiti funzionali e tecnici dettagliati per i sistemi e i servizi IT che le aziende dovranno utilizzare (piattaforme eFTI e fornitori di servizi eFTI) e le regole per la loro certi cazione.
A partire da gennaio 2026
9 luglio 2027
Le piattaforme e i fornitori di servizi eFTI possono iniziare a prepararsi per le operazioni.
Le autorità degli Stati membri possono iniziare ad accettare i dati archiviati su piattaforme eFTI certi cate per l’ispezione.
Il regolamento eFTI si applicherà integralmente.
Le autorità degli Stati membri devono accettare le informazioni condivise elettronicamente dagli operatori tramite piattaforme eFTI certi cate.
L’Italia ha un ruolo importante nell’implementazione del Regolamento eFTI. Il nostro Paese partecipa infatti, insieme ad Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania e Portogallo, al progetto eFTI4EU, ideato per attuare le disposizioni del Regolamento 1056/2020.
L’obiettivo del progetto è quello di implementare un’architettura di riferimento per lo scambio di dati logistici e di trasporto e di sperimentarla attraverso una serie di progetti pilota attuati nei 9 Stati partecipanti. I casi pilota servono anche a testare l’integrazione dell’eFTI Gate con l’eCMR, con la Piattaforma logistica nazionale, con i Port Community Systems. Il progetto è stato finanziato nell’ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF2) con 28,3 milioni di euro e ha una durata di 36 mesi, fino a marzo 2026. La sperimentazione riunisce 22
Il progetto eFTI4EU
partner provenienti dai diversi Stati membri e per l’Italia vede la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di RAM come ente attuatore e di Circle Group.
Nel nostro Paese sono stati avviati diversi casi pilota con l’obiettivo di validare il flusso digitale dei dati tra i vari soggetti coinvolti nel trasporto merci. Uno di questi è il “cross-border italo-austriaco”, attuato grazie a una collaborazione tra Italia e Austria per la gestione digitale dei flussi di import ed export su gomma, dalla partenza fino al destinatario finale.
Il test operativo, condotto su un trasporto internazionale dall’Italia all’Austria, ha coinvolto la Polizia Stradale di Verona - oltre a due operatori associati a Fedespedi e Anita – ed è stata verificata con successo la documentazione elettronica tramite l’applicazione pilota collegata al nodo nazionale eFTI Gate Italy, interoperabile con le piattaforme europee. È stato inoltre testato l’utilizzo della eCMR, strumento chiave per aumentare l’efficienza operativa.
Altri due casi pilota hanno riguardato invece i porti, nello specifico quello di La Spezia e di Trieste, con l’obiettivo di validare il flusso digitale dei dati tra sistemi logistici e piattaforme pubbliche.

Il progetto pilota di La Spezia si è focalizzato su un trasporto intermodale dal porto ligure verso l’interporto di Bologna, relativo a un container di merce, gestita da Gruber Logistics. Durante la sperimentazione sono stati verificati la trasmissione automatica dei dati di ETA (Estimated Time of Arrival) dal sistema Tms di Gruber Logistics alla piattaforma Keystone, la generazione e condivisione del documento eCMR in formato elettronico e la piena interoperabilità tra sistemi EFTI platform ed eFTI gate Italy, nonché il Port Community System del Porto di La Spezia. Il tutto ha permesso di eliminare inserimenti manuali e ridondanze di dati permettendo alle autorità di controllo un check digitale semplificato e automatizzato.
L’altro caso pilota ha visto protagonista il porto di Trieste e ha interessato un trasporto transnazionale dall’Austria all’Italia, passando per la Slovenia, con un’operazione poi di export extra Ue. Durante la speri-
Porto di La Spezia
I casi pilota in Italia

mentazione è stato effettuato un controllo della Polizia Stradale presso l’interporto di Trieste a Fernetti, nel corso del quale è stata verificata la documentazione elettronica tramite l’applicazione pilota collegata all’eFTI Gate Italy. Quest’ultimo ha comunicato con l’eFTI Platform, recuperando i dati del trasporto attraverso l’utilizzo della eCMR, creata dallo spedizioniere-mittente e firmata dall’autista incaricato del ritiro.
Il flusso digitale completo delle informazioni tra operatori privati e autorità pubbliche è stato sperimentato con successo: la documentazione elettronica del viaggio è stata generata, firmata e condivisa digitalmente lungo tutta la catena logistica che ha potuto ricevere e validare i dati in tempo reale. Anche il controllo finale della Stradale ha confermato la solidità del processo e la possibilità di sostituire integralmente i documenti cartacei con flussi digitali sicuri e verificabili, che poi hanno consentito anche i flussi digitali per l’esportazione verso un paese extra Ue.
Porto di Trieste
La strategia italiana e il ruolo del PNRR
L’Italia ha inserito la digitalizzazione della logistica tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 3 “Infrastrutture per la Mobilità sostenibile”.
Lo scopo principale è quello di aumentare la competitività logistica nazionale attraverso la realizzazione di un ecosistema digitale per il trasporto merci e la logistica, interoperabile tra attori pubblici e privati, in grado di semplificare procedure, processi e controlli puntando sulla dematerializzazione documentale e sullo scambio di dati e informazioni.
In particolare, viene data priorità a quattro ambiti fondamentali:
• dematerializzazione della documentazione legata al trasporto, con particolare riferimento alle lettere di vettura CMR e alla gestione autorizzativa e amministrativa dei trasporti in condizioni di eccezionalità e per le merci pericolose;
• efficientamento della gestione digitale dei porti e degli interporti italiani, attraverso il raggiungimento di una efficace implementazione dei Port Community Systems (PCS) in tutti i porti italiani, omogenea per requisiti funzionali e con spiccate caratteristiche di interoperabilità sia orizzontale sia verticale, e di sistemi informativi analoghi presso gli interporti;
• informatizzazione delle relazioni tra soggetti pubblici e privati, identificando una centrale di standardizzazione dei linguaggi e dei moduli (PLN) e una serie di piattaforme informatiche pubbliche e private federate con la centrale;
• riconoscimento che la messa a sistema “centralizzata” di informazioni sul trasporto merci e la logistica rappresenti un necessario passo per la creazione di valore, per il monitoraggio della politica dei trasporti e per lo sviluppo di politiche innovative. Vediamole nel dettaglio.
Un tassello fondamentale nel processo di digitalizzazione del trasporto merci è costituito dall’eCMR, ovvero la versione elettronica della lettera di vettura. Ricordiamo che il trasporto internazionale delle merci
su strada è regolamentato dalla Convenzione CMR (Convention de Marchandises par Route), siglata negli anni ‘50 con l’obiettivo principale di armonizzare le condizioni contrattuali per le merci trasportate su strada. Nel 2008, in seguito alla firma di un Protocollo addizionale alla Convenzione, è stato dato il via libera all’uso di una lettera elettronica, aggiungendo la “e” alla CMR. La CMR è stata lanciata ufficialmente a gennaio 2017 con il primo viaggio transfrontaliero compiuto dalle merci attraverso due Stati membri Ue, Spagna e Francia.
In Italia la piena operatività della lettera di vettura elettronica è arrivata invece solo nel 2024, dopo l’adesione a marzo al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale merci su strada.
Con l’eCMR la firma per la presa o l’avvenuta consegna della merce avviene digitalmente, il che consente una serie di benefici, dalla riduzione dei costi di emissione a una maggior trasparenza e facilità nei controlli, fino ad una maggiore competitività delle imprese di autotrasporto italiane nell’acquisizione di contratti di trasporto internazionale. I dati del trasporto possono essere condivisi in tempo reale tra tutti gli attori della filiera, sono protetti da accessi non autorizzati e verificabili in ogni momento.

Il nostro Paese intende utilizzare l’architettura eFTI come componente centrale della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) e stabilire una forte interoperabilità tra i vari sistemi, con lo scopo di monitorare e semplificare tutto il processo logistico, sia per l’importazione sia per l’esportazione di merci in una catena di trasporto multimodale, dal porto al destinatario delle merci tramite trasporto stradale e ferroviario.
La PLN si presenta quindi come un ecosistema digitale interoperabile e protetto, in grado di integrare processi, funzioni e database, dando un accesso unico agli operatori e alle istituzioni coinvolte. La PNL inoltre comunicherà con porti, interporti, centri merci, piastre logistiche. Anche i Port Community System (PCS), i sistemi informatici che abilitano lo scambio di informazioni tra gli attori delle comunità portuali (operatori economici ed enti pubblici), rientrano nella PNL.
All’interno della Missione 3, il programma di digitalizzazione della catena logistica prevede un finanziamento complessivo di 250 milioni di euro, per interventi a supporto dell’ammodernamento e della digitalizzazione del sistema della logistica.
Piattaforma Logistica Nazionale
Il bando Login
Si tratta in dettaglio di tre subinvestimenti: Login center, Reti portuali e interportuali e Login Business.
Per il Login Center, che ha lo scopo di realizzare la piattaforma e di prevedere la migrazione sul Cloud del Polo Strategico Nazionale, sono stati stanziati 40 milioni di euro; per le Reti Portuali e Interportuali 50 milioni, di cui 16 milioni destinati alle Autorità di Sistema Portuale per la realizzazione ed implementazione dei PCS, 10 milioni per gli interporti e la parte restante per la migrazione dei Port Community System sul cloud Polo Strategico Nazionale. Infine, 157 milioni di euro sono destinati al Login Business, ovvero agli investimenti in digitalizzazione per le imprese di trasporti e logistica, a cui si aggiungono altri 3 milioni per la gestione della misura.
Il bando Login Business è stato pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a luglio 2025 e a settembre le imprese che operano nel trasporto merci e nella logistica hanno potuto presentare la domanda di ammissione al cofinanziamento o al contributo in regime “de minimis” per la digitalizzazione.
Dei 157 milioni di euro a disposizione, una parte, pari a 97,5 milioni, è riservata ai progetti con costi inferiori a 150mila euro; la restante, di 59,5 milioni, è destinata alle iniziative con investimenti pari o superiori a tale soglia. Le imprese possono accedere ai fondi scegliendo tra due modalità di sostegno. La prima, in regime di cofinanziamento, prevede un contributo fino al 40% delle spese ammissibili, Iva esclusa; in questo caso le imprese richiedenti sono tenute a dimostrare, tramite una relazione dedicata, la performance intermodale dell’investimento. La seconda, in regime de minimis, permette di coprire fino al 100% dei costi, sempre al netto dell’Iva, rispettando i limiti imposti dalla normativa europea.

Tra gli interventi finanziabili rientrano ad esempio l’acquisto o la realizzazione di piattaforme informatiche per lo scambio di informazioni con clienti, caricatori e con la Piattaforma Logistica Nazionale; l’adozione di sistemi avanzati per l’ottimizzazione dei carichi e la pianificazione dinamica delle rotte, anche con il supporto dell’intelligenza artificiale; la dematerializzazione dei documenti di trasporto attraverso strumenti digitali conformi agli standard europei; i progetti finalizzati all’acquisto o alla realizzazione di piattaforme per la dematerializzazione documentale (eCMR) in coerenza con eFTI nazionale; progetti per implementare sistemi avanzati di pianificazione dei carichi, route planning e interoperabilità; moduli formativi in modalità e-learning, a supporto degli investimenti tecnologici.
L’obiettivo del bando era quello di coinvolgere 8.350 imprese,å ma in realtà la domanda è stata presentata da 1.200 aziende. Tuttavia, la misura ha ottenuto il via libera dell’Europa poiché i progetti presentati, seppur in numero inferiore, hanno un valore complessivo pari a 208 milioni di euro, che supera di gran lunga il budget previsto. RAM ha pubblicato sul proprio sito l’elenco delle imprese ammesse al bando sottolineando che l’importo medio del finanziamento richiesto è di quasi 300mila euro e si contano 16 progetti di valore superiore al milione di euro.
Al momento le 1.200 aziende sono state ammesse alla misura “con riserva” poiché l’ok definitivo arriverà dopo i controlli previsti nella fase di rendicontazione, durante la quale verranno verificate la conformità dei progetti e la completezza della documentazione presentata.
A breve seguiranno le disposizioni operative da parte della Direzione Generale per i porti, la logistica e l’intermodalità per consentire alle imprese di procedere con la dichiarazione di inizio attività e lo stato di attuazione degli interventi.
Ma, come dicevamo, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti intende dare una spinta verso la modernizzazione anche agli interporti. A febbraio 2024 un bando ha messo sul piatto 10 milioni di euro per lo sviluppo e all’implementazione dei sistemi informatici secondo gli standard di interoperabilità funzionali definiti dalla Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN) e con particolare riguardo all’interconnessione con i Port Community System. Risorse che sono state distribuite per un totale di 8,2 milioni di euro tra i seguenti interporti: Bologna (841.498 euro); Cervignano (66.850); Trento-Interbrennero (117.149); Campano-Nola (373.994); Livorno (379.498,50); Novara (232.248); Orte (115.250); Padova (2.720.000); Pescara (324.448); Portogruaro (307.500); Prato (548.222); Torino (609.749); Venezia (400.448); Verona (512.250) e Trieste (347.500).
Digitalizzazione degli interporti

A luglio 2025 il MIT ha poi riaperto il bando per assegnare 2,2 milioni che derivano da rinunce di precedenti assegnatari, per tre tipologie di interventi: connettori per l’interoperabilità (entro il 30 dicembre 2025), moduli base FVS (entro il 15 febbraio 2026) e moduli avanzati FVS (entro il 31 marzo 2026). L’istruttoria sui progetti presentati si è conclusa il 20 ottobre e, al momento in cui scriviamo, lo schema di decreto ministeriale per l’assegnazione dei contributi è all’esame dell’unità di missione per il PNRR.
Digitalizzazione dei porti

E naturalmente in questa trasformazione digitale non possono mancare i porti, infrastrutture vitali per l’economia nazionale e per la catena logistica europea. L’attività consiste nello sviluppo dei Port Community System (PCS), piattaforme digitali interoperabili che mettono in rete operatori pubblici e privati per migliorare l’efficienza e la sostenibilità del trasporto merci e della logistica, in quei porti dove non sono ancora presenti. Inoltre è prevista l’omogeneizzazione funzionale dei sistemi informatici già esistenti presso le Autorità di Sistema Portuale, con lo scopo di promuovere servizi standard di interfaccia con gli operatori marittimi, gli operatori a terra, i gestori di infrastrutture nodali e lineari di connessione (gestori dell’infrastruttura ferroviaria, interporti e retroporti ed aeroporti) e sviluppare i moduli di interoperabilità con la Piattaforma Logistica Nazionale.
Una linea di finanziamento ad hoc riguarderà anche altri interventi in materia di digitalizzazione e quindi di smart ports quali progetti per la digitalizzazione degli accessi e uscite dai varchi portuali, l’implementazione di sistemi di cybersecurity nelle AdSP e l’informatizzazione dei processi amministrativi rientranti nell’ambito di operatività dello Sportello Unico delle AdSP.
Il MIT ha messo sul piatto, nel 2023, 16 milioni di euro dei quali, almeno il 40%, destinati ai porti del Mezzogiorno. A ciascuna Autorità di Sistema Portuale è stato assegnato un contributo pari a un milione di euro. A breve dovrebbe arrivare un ulteriore finanziamento per le AdSP di circa 300mila euro per ciascuna Autorità.
Ad oggi, secondo i dati diffusi dal MIT, oltre il 70% delle Autorità di Sistema Portuale ha adottato i PCS.
3 L’IA nella logistica: vantaggi e applicazioni dalla strada al mare
L’IA al servizio della logistica
Nel 2025 l’intelligenza artificiale non è più un concetto futuristico legato ai laboratori di ricerca, ma una tecnologia operativa che guida camion, coordina flotte, gestisce magazzini e controlla i flussi di merci in porti e interporti. Dopo decenni di sperimentazioni, i programmi dimostrativi si sono trasformati in sistemi di produzione pienamente funzionanti, capaci di innalzare il livello di efficienza, sicurezza e sostenibilità all’interno della filiera logistica mondiale.
Nel contesto europeo, le politiche promosse dal Meccanismo per Collegare l’Europa, unitamente ai programmi Horizon, Digital Europe e alla doppia strategia europea per l’IA - nell’industria e nella scienza - presentata a ottobre dalla Commissione Ue, stanno incentivando l’adozione dell’IA per la digitalizzazione di trasporti e infrastrutture, con l’obiettivo di contenere i costi operativi e di ridurre l’impatto ambientale.
Un processo che, d’altra parte, preme l’Unione a riconsiderare il proprio ruolo in un contesto internazionale sempre più competitivo, caratterizzato dal predominio di nazioni come la Cina e gli Stati Uniti, dove questa nuova realtà tecnologica è da tempo integrata, manifestandosi in magazzini completamente automatizzati e in mezzi pesanti a guida autonoma che stanno già trasportando merci, viaggiando autonomamente in tratte prestabilite, principalmente autostrade.
Tra gli Stati membri, anche l’Italia si sta inserendo in questo scenario di profondo rinnovamento, portando avanti bandi e progetti nazionali per supportare la trasformazione digitale delle imprese di trasporto merci (vedi capitolo 2).

Le evoluzioni tecnologiche nel settore sono trainate soprattutto dalla crescita esponenziale dell’e-commerce e dalla conseguente necessità di ottimizzare la rapidità della logistica per garantire un processo fluido e senza interruzioni. In questa fase, offrire opzioni di spedizione veloci e pienamente affidabili non rappresenta più un valore aggiunto, bensì
un requisito essenziale per mantenere la competitività industriale. Oltre alla rapidità, la domanda attuale esige chiarezza e sicurezza, ricercate in sistemi di tracciamento precisi, finestre di consegna personalizzate e nella certezza dell’integrità della merce.
Per soddisfare le complesse necessità del mercato, il cuore della logistica si sta così evolvendo in un ecosistema sempre più digitalizzato alimentato da algoritmi, analisi di grandi quantità di dati in tempo reale e meccanismi di automazione. Strumenti che operano in sinergia con l’intelligenza umana per rendere l’intero iter più efficiente, più rapido e calibrato sulle singole esigenze.

Nel trasporto merci e nelle grandi aree logistiche, l’IA sta diventando un potente motore di trasformazione industriale. I suoi componenti, che spaziano dall’internet delle cose (IoT) alla robotica avanzata, sono già pienamente operativi e rappresentano i pilastri di una nuova infrastruttura operativa intelligente, interconnessa, profondamente integrata, ma soprattutto, destinata a crescere.
Tra le funzioni logistiche che oggi hanno raggiunto il più alto grado di digitalizzazione vi sono la manutenzione predittiva delle flotte, la pianificazione dinamica dei mezzi pesanti, la gestione intermodale che combina rotaia, mare e strada, l’automazione di magazzini e porti grazie all’impiego di robot intelligenti e il miglioramento della sicurezza nelle aree di sosta dedicate agli autotrasportatori.
Negli ultimi anni, inoltre, si sta assistendo al consolidamento delle tecnologie che abilitano i cosiddetti “self-driving trucks”. Si tratta di camion completamente autonomi che, proprio grazie all’aggiornamento tecnologico e normativo, in alcuni Paesi sono già autorizzati a percorrere le strade pubbliche, completando missioni di trasporto senza la necessità di intervento umano a bordo.
Il nuovo paradigma digitale nel trasporto merci mira ad accrescere il valore dell’intera filiera, offrendo al contempo soluzioni per affrontare sfide reali come la mancanza di autisti, la sicurezza del carico e la sostenibilità ambientale. Compreso lo scenario attuale, passiamo ora all’approfondimento delle numerose possibilità tecnologiche che stanno ridefinendo la logistica, menzionando i casi d’uso più importanti in Italia, in Europa e nel resto del mondo.
La guida autonoma: scenari e applicazioni
L’evoluzione più straordinaria e con gli effetti più immediatamente percepibili sull’asfalto è quella relativa ai mezzi pesanti autonomi di livello 4; livello che, come abbiamo specificato nel primo capitolo, rappresenta uno dei più avanzati nell’automazione di guida secondo la scala SAE.
Nel 2025 questi veicoli non sono più fantascienza, ma già tecnologia operativa su strada.
La loro applicazione, tuttavia, risulta ancora segmentata a seconda della nazione e del contesto operativo; al momento trovano principalmente impiego nei piazzali circoscritti, come miniere, hub e snodi intermodali; in specifiche tratte supervisionate e, in prospettiva, nei grandi corridoi internazionali aperti al traffico.
Nel panorama logistico mondiale, la Cina e gli Stati Uniti hanno già integrato questa trasformazione mentre l’Europa adotta un approccio più prudente, focalizzato sull’armonizzazione degli standard di sicurezza e delle normative tra gli Stati membri, un fattore che inevitabilmente ne rallenta l’implementazione su larga scala.

Gli Stati Uniti stanno portando avanti da tempo sperimentazioni in ambito commerciale dei camion autonomi; progetti sostenuti da un ambiente normativo decisamente più flessibile e da una vasta rete autostradale ideale per il modello logistico hub-to-hub.
A dieci anni dal lancio del Freighliner Inspiration Truck in Nevada, il primo truck autonomo autorizzato a operare sulle strade statunitensi, le operazioni commerciali driverless sono ora diventate realtà. L’azienda Aurora, ad esempio, ha inaugurato consegne commerciali senza conducente tra Houston e Dallas, in Texas, impiegando veicoli di Classe 8 in partnership con Uber Freight, accumulando oltre 1.900
I progetti europei
km e aprendo così la strada a una diffusione progressiva del trasporto automatizzato su percorsi controllati e ripetitivi.
Anche la Cina sta rapidamente ampliando le sue capacità nel trasporto pesante autonomo, beneficiando di un solido sostegno governativo, strategie di sviluppo tecnologico e investimenti in programmi pilota su strade pubbliche.
Ultimamente, politiche e fondi comunitari stanno trasformando i diversi corridoi europei in laboratori a cielo aperto per la guida autonoma.
Un esempio è il progetto MODI, un’iniziativa finanziata dall’Ue e coordinata da ITS Norway, che coinvolge 34 partner provenienti da otto nazioni. Nell’ambito di questo programma, l’azienda svedese Einride ha completato il 25 settembre un evento storico: il primo attraversamento transfrontaliero al mondo tra Svezia e Norvegia utilizzando un camion elettrico autonomo privo di cabina di guida. Questo truck elettrico cabless ha dimostrato la capacità della guida pesante automatizzata di integrarsi con i sistemi doganali digitali e la gestione del traffico transfrontaliero, operando grazie a machine learning, visione artificiale e comunicazione V2X (Vehicle-to-Everything).

La guida autonoma sta trovando un terreno di applicazione particolarmente fertile in ambienti circoscritti e controllati come le aree logistiche e i porti. A settembre, nel Porto di Anversa-Bruges è stata effettuata la prima dimostrazione in Belgio di un mezzo pesante di livello 4, completamente autonomo e privo di cabina, supervisionato da un operatore remoto attraverso una torre di controllo basata sull’IA, allo scopo di incrementare la sicurezza, ottimizzare i tempi di attesa e ridurre le emissioni.
Un approccio simile è stato adottato anche nel Regno Unito, presso il Porto di Felixstowe, il più grande hub container del Paese, dove i test con truck autonomi puntano a diminuire i costi operativi e i tempi di trasbordo, spingendo il gestore Hutchison Ports a commissionare altri 34 nuovi veicoli automatizzati (ATs). Un’espansione che è stata abilitata dalla realizzazione, completata intorno alla metà di luglio 2025, di una delle reti private 5G più estese del Regno Unito, tecnologia fondamentale per la comunicazione a bassa latenza richiesta dalla gestione simultanea dei dispositivi autonomi.
Un altro luogo di applicazione sono le miniere, dove le sperimentazioni di guida autonoma proseguono da decenni. Un caso recente riguarda l’azienda svedese Epiroc AB, che ad ottobre ha annunciato di aver convertito con successo tutti i 78 camion della miniera Roy Hill, in Australia, in veicoli completamente autonomi, realizzando la più grande miniera autonoma al mondo. Utilizzando il sistema LinkOA, che funziona con marchi diversi come Caterpillar e Hitachi, 60 dei 78 camion sono già operativi. Questi camion hanno movimentato oltre 250 milioni di tonnellate di materiale; l’obiettivo è rendere pienamente operativa l’intera flotta entro dicembre 2025.
Anche l’Italia si sta inserendo in questo scenario di profonda trasformazione, sebbene il quadro normativo non consenta ancora la piena operatività dei veicoli senza conducente, malgrado l’esistenza di infrastrutture e competenze idonee. Una limitazione che ha spinto alcune associazioni di settore a richiedere misure urgenti e aggiornamenti sul piano normativo per sostenere lo sviluppo di tecnologie di automazione nazionali, rafforzare la competitività del settore, migliorare la sicurezza stradale e contenere le emissioni.
Nonostante i limiti normativi, il Paese riveste un importante ruolo industriale.
A maggio, Iveco, in collaborazione con la statunitense Plus e i partner dm e DSV, ha ultimato test in Germania della durata di diversi mesi su camion semi-autonomi equipaggiati con il software IA PlusDrive.
Questi veicoli sono operativi in modalità driver-in, con l’autista a bordo, ma sfruttano la guida automatizzata per le tratte principali, con l’obiettivo di preparare future sperimentazioni driverless.
Inoltre, l’introduzione obbligatoria degli ADAS avanzati dal 2024 ha aperto la strada a forme superiori di automazione e al platooning per i mezzi pesanti, una tecnica di guida in convoglio.
Il truck platooning è stato sperimentato in Italia già nel 2021 sull’A22, dove un convoglio di quattro tir Iveco ha viaggiato in colonna - guidato solo dal primo veicolo - ma in grado di interagire in sicurezza con il resto del traffico autostradale grazie alla connettività 5G; un’automazione che consente di ridurre rischi ed emissioni.
La situazione in Italia

Più nel dettaglio, questa sperimentazione ha visto l’Autostrada del Brennero (A22) e le tratte gestite dalle Autovie Venete e dalla CAV (Concessioni Autostradali Venete) operare come il laboratorio italiano
Le tecnologie di livello 4
pionieristico per il progetto europeo smart road C-Roads. Sulla sola A22 sono stati completati oltre 300mila km di test, benché le autorizzazioni richiedessero la presenza di un conducente su ogni mezzo per garantire la sicurezza durante lo svolgimento delle prove. Per assicurare la connettività, invece, sono state installate circa un centinaio di Road Side Unit (RSU) sulle tratte: dispositivi essenziali per garantire la comunicazione integrata a corto e lungo raggio tra veicoli e infrastrutture. Questa specifica soluzione, sviluppata da Autobrennero e implementata da Tim, è riconosciuta come lo standard italiano per la comunicazione ibrida e già oggi consente di trasmettere ai computer di bordo la presenza di cantieri, incidenti, condizioni meteo e simili.
Ma quali sono le principali tecnologie a bordo di un camion di Livello 4? Un veicolo L4 è solitamente dotato di sensori come Lidar (light detection and ranging) radar e telecamere che consentono di interpretare l’ambiente circostante. I sistemi di localizzazione, invece, utilizzano il GPS ad alta precisione, spesso potenziato dalla correzione RTK (real time kinematic), insieme a mappe HD 3D e l’IMU (Inertial Measurement Unit) per determinare la posizione esatta e l’orientamento. Sempre a bordo, inoltre, specifiche architetture di IA e unità di calcolo dedicate elaborano in tempo reale i dati dei sensori. Questi sistemi impiegano generalmente reti neurali e deep learning, ovvero algoritmi che imitano il funzionamento del cervello umano per riconoscere ostacoli e corsie, analizzare il traffico e pianificare le manovre necessarie tramite decision making predittivo.

In questo scenario, la connettività è vitale: il V2X (Vehicle-to-Everything), già menzionato in precedenza, permette la comunicazione con infrastrutture e altri veicoli, supportato da reti 5G e cloud computing. Infine, data l’assenza di intervento umano diretto, ogni componente essenziale (sterzo, freni, accelerazione) è duplicato per garantire la ridondanza e i sistemi sono protetti da rigorosi meccanismi di cybersecurity.
Robot e cobot nei magazzini automatizzati
Mentre la strada diventa simbolo di connettività, il magazzino si trasforma nell’epicentro dell’automazione avanzata, dove l’IA sta progressivamente rimodellando l’attività lavorativa e logistica. Questi spazi non sono più semplici strutture con scaffali e bancali, ma si configurano come veri ecosistemi cibernetici in cui robot mobili autonomi, bracci di picking intelligenti e sistemi di stoccaggio automatico ad alta densità comunicano con piattaforme di IA che ottimizzano in tempo reale percorsi, priorità e sequenze di prelievo.
Tra le più rilevanti innovazioni tecnologiche nel settore della logistica spiccano gli Agenti IA, ovvero sistemi intelligenti, sia software che robotici, che operano in modo indipendente, progettati per eseguire azioni, prendere decisioni e interagire con l’ambiente senza la necessità di una supervisione umana costante, grazie all’integrazione di sensori e sistemi avanzati a livello informativo e organizzativo.

Nelle strutture di stoccaggio è sempre più comune incontrare robot dedicati al carico e scarico della merce, i quali sfruttano la computer vision, la visione artificiale, una tecnologia che applica il machine learning e le reti neurali (modelli di intelligenza artificiale ispirati al cervello umano), per identificare e ottenere dati dall’ambiente circostante per leggere codici, misurare le dimensioni dei pacchi e rilevare eventuali difformità.
L’automazione di compiti complessi è resa possibile anche grazie al perfezionamento degli algoritmi integrati nei corpi robotici, in particolare quelli dei sistemi di deep lerning, come gli algoritmi Transformer,
le Graph Neural Network (GNN) e le Generative Adversarial Networks (GAN), ognuno progettato per gestire diversi tipi di dati e risolvere specifici problemi.
Il funzionamento di questi programmi è descritto dal concetto di rete neurale, che simula le reti biologiche per acquisire schemi e regolarità dai dati. Un meccanismo che rende la macchina più indipendente e accurata nelle scelte operative. Tale competenza è essenziale per la guida autonoma all’interno dei grandi poli logistici, per ottimizzare gli itinerari e per trovare soluzioni rapide in presenza di imprevisti.
A questi si aggiunge anche l’evoluzione del Deep Reinforcement Learning, che unisce l’apprendimento profondo con l’apprendimento per rinforzo per consentire agli agenti IA di apprendere compiti complessi per tentativi ed errori. Ulteriori progressi riguardano anche gli agenti digitali che usano il RAG (Retrieval-Augmented Generation), che combina un motore di ricerca con un modello generativo, come i Large Language Models, per migliorare la coerenza e la pertinenza delle risposte.
Dalla teoria alla pratica

La maturità di queste tecnologie è già visibile nell’operato di alcuni player del settore. DHL, per esempio, ha confermato nel 2025 la distribuzione a livello globale di oltre mille robot Stretch, sviluppati da Boston Dynamics; dispositivi specificamente ideati per gestire i compiti più gravosi e ripetitivi all’interno del magazzino, come lo scarico dei colli dai rimorchi, anche quelli refrigerati.
In pratica, Stretch è capace di manipolare fino a 700 colli ogni ora senza richiedere l’intervento umano diretto, liberando così gli operatori da mansioni fisicamente impegnative e velocizzando i tempi di scarico.
A testimonianza di questa evoluzione, in Italia, DHL Supply Chain ha inaugurato a luglio 2025 l’automazione avanzata presso l’Health Logistics Campus di Livraga, in provincia di Lodi, un polo dedicato alla logistica sanitaria. In un’area di oltre 7mila metri quadrati sono attivi 138 robot che si basano su un sistema per la gestione automatizzata dello stoccaggio e del prelievo; l’obiettivo è garantire un’elevata velocità nell’evasione degli ordini, un controllo critico delle scorte - essenziale per il settore farmaceutico – e una completa tracciabilità dei lotti, raggiungendo livelli di accuratezza e continuità operativa che sarebbero difficili da ottenere con procedure manuali.
Un altro elemento distintivo del 2025 è l’emergere dei robot collaborativi (cobot) in grado di svolgere una pluralità di mansioni. Ama-

zon, per esempio, ha reso noto di essere impegnata nello sviluppo di robot capaci non solo di movimentare pallet o contenitori, ma anche di prelevare singoli componenti e identificare rapidamente gli oggetti da manipolare, come dimostra il suo prototipo di automazione tattile Vulcan. L’azienda, inoltre, sta associando questa robotica evoluta anche a sistemi di mappatura IA destinati ai corrieri dell’ultimo miglio: il progetto, in via di sviluppo, prevede l’utilizzo di occhiali intelligenti che forniscono indicazioni di spedizione direttamente agli occhi agli autisti, liberandoli così dall’utilizzo dello smartphone. L’intento è ridurre i tempi di consegna, limitare gli errori e minimizzare gli sprechi, ottimizzando la disposizione dell’inventario in funzione della domanda locale prevista dall’IA.
L’automazione logistica ha preso spazio anche in Europa, specialmente nell’ambito dell’e-commerce. A ottobre il retailer tedesco Zalando, ad esempio, ha ampliato la sua collaborazione con la società polacca Nomagic, installando nove robot IA per il picking automatizzato. Nel settore alimentare, invece, l’azienda britannica Ocado ha realizzato per la catena spagnola Bon Preu un nuovo centro di distribuzione automatizzato vicino a Barcellona, dove i robot si muovono su una griglia tridimensionale, coordinati da un software IA che ottimizza i loro spostamenti in base alla domanda in tempo reale e alla priorità degli ordini.
Anticipare le problematiche
Il monitoraggio e la gestione delle flotte
L’introduzione della tecnologia avanzata, in particolare l’intelligenza artificiale e l’Internet of Things (IoT), sta definendo una profonda trasformazione nella gestione della catena di approvvigionamento, mirando a una visione completa, predittiva e proattiva dell’intera catena logistica. Tutto questo è possibile grazie alle cosiddette control tower, centri di comando che raccolgono e interpretano dati dai sistemi aziendali, utilizzando l’IA per offrire una panoramica previsionale completa.
L’obiettivo primario di questi sistemi è stabilire le priorità, risolvere i problemi e anticipare pericoli o colli di bottiglia con settimane di anticipo, attivando automaticamente azioni correttive, come la modifica di un percorso o la sostituzione di un fornitore. Contestualmente, modelli basati sull’IA migliorano la previsione dinamica della domanda, analizzando non solo i dati di vendita, ma anche fattori esterni come le condizioni meteorologiche e le tendenze di mercato, generando stime in tempo reale per contenere gli sprechi e prevenire l’esaurimento delle scorte.
Tutte queste funzionalità sono oggi utilizzate anche nel campo del fleet management, ovvero nella gestione delle flotte, dove l’implementazione dell’IA predittiva rappresenta la nuova frontiera per ottimizzare i costi, aumentare la sicurezza e migliorare la sostenibilità nel mondo della logistica.
Le centraline telematiche di ultima generazione consentono oggi di tracciare la posizione GPS del mezzo, integrando in un unico flusso dati fondamentali come la velocità, l’approccio di guida dell’operatore, la temperatura del carico e le condizioni meccaniche complessive del veicolo.
La funzione primaria di questi dati non è la localizzazione, ma l’anticipazione, consentendo di prevedere quando il veicolo richiederà assistenza tecnica o se lo stile di frenata incide negativamente sui consumi e sulle emissioni. In questo contesto, il monitoraggio costante dei
veicoli industriali contribuisce a diminuire il rischio di fermi macchina inattesi, a migliorare il rispetto dei tempi previsti e a limitare sanzioni relative alla conformità normativa sui periodi di guida e di riposo.
Parallelamente, si sta affermando in modo deciso la tendenza verso la connettività edge, un modello dove una parte dell’analisi dei dati avviene in locale, direttamente sul mezzo o presso il varco d’ingresso di un hub logistico, permettendo al sistema di reagire in pochi millisecondi e senza dipendere costantemente dall’infrastruttura cloud.
Senza questa vasta e distribuita infrastruttura, nessun algoritmo sarebbe capace di ottenere una visione completa e reale della dinamica della rete logistica.
Tra gli strumenti dell’IoT che contribuiscono ad aumentare l’efficienza delle flotte spicca la Telematics Control Unit (TCU), che aggrega dati cruciali – GPS, tachigrafo e sensori – e li invia alla piattaforma di gestione tramite rete mobile 4G/5G. Altre tecnologie riguardano il Geofencing, che crea recinti virtuali per inviare allarmi automatici all’ingresso o all’uscita dei camion da aree definite, e il Driver Behavior Monitoring, che valuta lo stile di guida per aumentare la sicurezza e diminuire i consumi. Questo monitoraggio, spesso accompagnato da dashcam e telecamere integrate con l’IA, come quelle lanciate di recente da Geotab, può essere collegato anche a sistemi di Real-time Data Analytics per l’ottimizzazione di rotte e consumi.
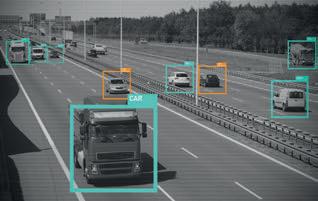
Grazie a specifiche piattaforme IA è possibile incrociare i dati telematici con lo storico dei guasti, al fine di identificare i segnali di usura ancor prima che si manifestino come un fermo improvviso, permettendo interventi proattivi. Tale approccio consente di minimizzare i costi e i tempi di inattività e ha portato a vantaggi diretti per i clienti, inclusa una significativa diminuzione delle soste non programmate.
Altri sistemi avanzati guidati dall’IA ottimizzano i trasporti su gomma coniugando la localizzazione, le caratteristiche di guida, il carico utile e la situazione del traffico; un approccio che permette di calibrare i percorsi in modo ottimale e di ottenere una significativa riduzione delle emissioni.
Porti e parcheggi intelligenti
Questa profonda trasformazione sta rivoluzionando anche l’intera gestione delle operazioni portuali, portando alla creazione dei cosiddetti porti intelligenti. Questi luoghi si affermano come veri centri di innovazione, capaci di ottimizzare la logistica grazie all’adozione di soluzioni avanzate che includono l’Internet of Things, la connettività ad alta velocità, come il 5G, essenziale anche per l’invio di dati telematici aggregati e l’intelligenza artificiale (IA), spesso integrate con sistemi di guida autonoma.

In questo ecosistema digitale, l’IA è la tecnologia che agisce nell’ombra, assumendo un ruolo centrale nell’organizzazione e nell’interpretazione dei dati. Nello specifico aggrega le informazioni provenienti in tempo reale da una vasta gamma di dispositivi, tra cui sensori, telecamere, radar e sistemi logistici. Questa complessa organizzazione dei dati permette di operare su base previsionale, consentendo di stabilire, ad esempio, l’orario esatto delle imbarcazioni, ottimizzare dinamicamente le rotte e gestire in modo più efficace i flussi di merce nelle operazioni logistiche.
L’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale anche nell’evoluzione e nell’efficacia dei gemelli digitali (digital twin). Queste rappresentazioni virtuali dinamiche sono in grado di simulare l’intero comportamento della rete, e l’integrazione dell’IA spinge le loro capacità a un livello completamente nuovo, consentendo l’esecuzione di test di scenario e ottimizzazioni predittive. Queste funzionalità, integrate alle altre tecnologie, sono essenziali per migliorare i flussi, gli accessi e ridurre l’impatto ambientale, garantendo una significativa ottimizzazione delle prestazioni e dell’efficienza operativa.
Nell’era dell’IA, dunque, anche i porti diventano smart. Il porto di Rotterdam, il più grande d’Europa, per esempio, ha investito in infrastrutture IoT e sistemi di digital twin per simulare le operazioni portuali,
migliorando l’allocazione delle risorse e il traffico navale. A Singapore, il porto di Tuas utilizza veicoli a guida autonoma e gru controllate da remoto tramite un sistema centrale che apprende costantemente per perfezionare ogni singola operazione. Analogamente, negli Stati Uniti, il Port of Corpus Christi utilizza una soluzione IA chiamata Optics per la simulazione 3D e il machine learning al fine di incrementare la sicurezza delle navi e addestrare il personale a gestire le emergenze.
L’approccio digitale si concretizza anche come soluzione per la gestione delle aree di sosta, trasformando gli stalli tradizionali in parcheggi intelligenti, dotati di sensori, telecamere e intelligenza artificiale per monitorare la disponibilità dei posti, agevolare gli spostamenti e facilitare i pagamenti.
La sosta sicura per gli autotrasporti è oggi un tema riconosciuto come urgente dall’Unione europea, che sottolinea un deficit strutturale di aree di parcheggio sicure e protette (SSTPA): oggi solo 4.943 dei 380mila parcheggi disponibili nell’Unione sono certificati come sicuri e protetti. Questa mancanza non è solo un problema sociale, che mina la dignità e la sicurezza dei conducenti durante le pause obbligatorie, ma è anche un grave problema di sicurezza del carico, con furti e aggressioni che possono generare ritardi a catena e costi assicurativi elevati.
Ed è proprio qui che l’approccio digitale si concretizza come soluzione nei parcheggi intelligenti. Oggi stiamo assistendo all’emergenza di nuove aree di sosta, spesso integrate con gli interporti, dove la tecnologia agisce da supervisore e ottimizzatore degli spazi. Queste strutture combinano telecamere per la videosorveglianza continua, sistemi di riconoscimento delle targhe, controllo degli accessi automatizzato, sensori per l’occupazione degli stalli e piattaforme digitali che mostrano in tempo reale la disponibilità agli autotrasportatori in arrivo.
L’efficacia dell’IA nel migliorare l’uso dello spazio è visibile in progetti come quello del parcheggio digitale per camion nel porto di Duisburg in Germania, dove il sistema telematico chiede ai conducenti l’orario di partenza previsto e, usando scanner laser per monitorare l’occupazione, assegna i posti in modo da disporre i veicoli nell’ordine delle partenze, riuscendo così a ospitare fino a un terzo in più di camion rispetto alle soluzioni convenzionali. In totale, la struttura può ospitare 89 veicoli pesanti e 28 trattori stradali.

Aree di sosta
Attraverso questi sistemi, i dati relativi alla sosta, precedentemente invisibili e disorganizzati, vengono integrati nel flusso digitale della supply chain. L’obiettivo finale, perseguito da progetti europei come Pass4Core, è creare una rete di parcheggi certificati con standard omogenei che utilizzino dashboard unificate per la gestione simultanea, consentendo prenotazioni e pagamenti senza contanti, trasformando così la sosta in un punto chiave per la sicurezza e l’efficienza logistica.
La stessa logica di ottimizzazione tramite sensori IoT e piattaforme di smart parking viene applicata anche alla sosta urbana per i veicoli commerciali leggeri, abbattendo la congestione cittadina.
L’espansione dell’intelligenza artificiale nella logistica non è solo una questione tecnologica.
Dietro ogni veicolo autonomo, camion, robot o algoritmo predittivo, si aprono sfide giuridiche, assicurative e morali complesse.
L’adozione dell’automazione a livello comunitario, ad esempio, richiede sul piano normativo la definizione di obblighi di trasparenza e sicurezza per i sistemi ad alto rischio, come la guida autonoma e la robotica industriale. In ambito assicurativo, invece, la questione della responsabilità diventa cruciale: chi paga in caso di incidente causato da un veicolo driverless o da un robot di magazzino?
Sul fronte etico, come vedremo anche nel capitolo sulla cybersicurezza, la gestione dei dati rappresenta il punto più delicato, considerato che i sistemi di IA nella logistica raccolgono e analizzano ogni giorno enormi quantità di informazioni su conducenti, merci e percorsi. Inoltre, l’automazione avanzata solleva diversi interrogativi sul futuro del lavoro, con cambiamenti già in atto nei magazzini dei principali player mondiali, dove l’IA sta progressivamente ridisegnando la forza lavoro.
Definire questi aspetti, garantire la privacy dei lavoratori e l’uso responsabile di tutte queste informazioni è essenziale per guardare con fiducia al futuro digitalizzato del trasporto merci.

Una sfida ancora aperta
4 Cybercrime: il lato oscuro della digitalizzazione
Trasporti e logistica: un settore ad alto rischio
Come sempre accade, la diffusione di una nuova tecnologia o di un nuovo strumento oltre agli aspetti vantaggiosi rivela anche l’altro lato della medaglia, con le potenziali insidie che sono uguali e contrarie ai benefici.
Questo è senza dubbio il caso della digitalizzazione, che ci ha aperto a un universo apparentemente più vasto e connesso che, moltiplicando le possibilità di attingere a dati e informazioni, ha anche spalancato le porte alle minacce del mondo virtuale; minacce molto reali e concrete.
Il cybercrime è, in senso generale, l’azione di chi, spinto da motivazioni criminose, effettua attacchi al fine di estorcere denaro o di trafugare informazioni rilevanti attraverso l’uso di internet o di strumenti connessi alla rete.
Il settore dei trasporti e della logistica è uno di quelli ad alto tasso tecnologico e di informatizzazione e, per questo, è anche ad alto rischio di attacchi cyber.
Attacchi che possono avere fini economici o anche politici, dal mo-

Le minacce digitali
mento che le infrastrutture di trasporto sono fra i settori critici e centrali per la sicurezza di una nazione.
Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo, innanzitutto, di capire di che tipo di minacce stiamo parlando.
Più cresce l’utilizzo di strumenti digitali, più crescono le minacce ad essi connesse. Con la pandemia da Covid-19, quasi tutti i cittadini dell’Unione europea hanno scoperto la dimensione digitale, sia per ragioni di lavoro, sia per l’utilizzo massiccio dell’e-commerce.
Tutto questo ha offerto maggior campo di azione ai criminali informatici. A questo bisogna aggiungere poi l’instabilità geopolitica legata, per quel che riguarda l’Europa, all’aggressione russa dell’Ucraina che ha aperto un fronte di guerra a pochi chilometri da casa; guerra combattuta anche attraverso la cosiddetta cyber warfare che si caratterizza per il ricorso ad attacchi informatici come strumento strategico che mira a destabilizzare Stati, compromettere infrastrutture critiche e influenzare l’opinione pubblica.

Secondo la classificazione dell’agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (Enisa) le principali tipologie di minaccia sono otto. Partiamo dalla prima: attacchi che impediscono agli utenti di accedere a dati o servizi. Si tratta di attacchi che si attuano sovraccaricando l’infrastruttura di rete per rendere il sistema non disponibile; poco costosi da attuare e sempre più estesi e complessi. Molto utilizzati durante i conflitti tra Russia e Ucraina o Israele e Palestina.
Seguono i ransomware che prevedono che i criminali prendano il controllo dei dati e, come conseguenza, un pagamento del riscatto per ripristinare l’accesso.
Questi attacchi colpiscono un’ampia gamma di settori causando gravi perdite economiche, interruzioni operative e danni reputazionali. Nel 2024, gli attacchi ransomware hanno continuato a rappresentare una delle principali minacce informatiche.
Ci sono poi le minacce ai dati, intese come violazioni dei dati (attacchi intenzionali da parte di un criminale informatico, quali ad esempio i furti di identità) e fughe di dati (rilascio non intenzionale di dati). In questo senso, i chatbot basati sull’intelligenza artificiale sono uno strumento potente per commettere le violazioni.
Un altro tassello di questa lista è rappresentato dall’ingegneria sociale, una tecnica basata sulla manipolazione degli utenti per carpirne informazioni confidenziali e dati sensibili o indurre le vittime ad aprire documenti, file o e-mail dannosi, visitare determinati siti web e concedere così l’accesso non autorizzato a sistemi o servizi. L’attacco più noto e comune è il phishing, tramite posta elettronica o lo smishing, tramite messaggi di testo.
L’Enisa ha segnalato anche il rischio del vishing, quando i criminali informatici si spacciano per entità affidabili tramite telefonate. Una pratica facilitata ancora una volta dall’intelligenza artificiale generativa.
Nella macrocategoria del malware sono inclusi, invece, i virus, worm, trojan e spyware, diverse tipologie per una minaccia elevata. Il malware può diffondersi, ad esempio, tramite e-mail o essere incorporato persino in annunci pubblicitari online.
In Europa è il Threat Landscape dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione a monitorare la situazione della sicurezza informatica. Nell’ultima edizione, pubblicata nel mese di ottobre, si analizzano gli incidenti avvenuti fra 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025, offrendo una panoramica dell’ecosistema comunitario basata su quasi 4.900 incidenti selezionati e analizzati.
Il report evidenzia un contesto di minaccia sempre più maturo e una crescente complessità nel tracciamento degli avversari che hanno decentralizzato le proprie operazioni, adottando tattiche di estorsione più aggressive.
Le attività di intrusione risultano essere significative. Il ransomware è protagonista degli attacchi.
Allo stesso tempo, i gruppi allineati a Stati hanno intensificato le loro campagne di cyber spionaggio a lungo termine contro i settori delle telecomunicazioni, le reti logistiche e la manifattura Ue.
Le reti delle amministrazioni pubbliche restano l’obiettivo principale (38%), mentre i trasporti emergono come settore ad alto valore, soprattutto quello marittimo e logistico.
Attacchi ransomware hanno interrotto servizi di trasporto merci, mentre le infrastrutture sono bersagli strategici anche del cyber spionaggio oltre che del ransomware.
Il phishing rimane il principale metodo di intrusione (nel 60% dei casi) evolvendosi attraverso tecniche impiegate in campagne su larga scala.
Tutto questo grazie alla disponibilità di piattaforme di phishing-as-a-service che permettono di accedere a questi servizi criminosi, una chiara evidenza dell’industrializ-
I dati sugli attacchi in Europa

I trasporti tra i settori più colpiti
zazione di queste operazioni. In questo contesto, l’intelligenza artificiale è diventata un elemento chiave del panorama delle minacce.
I dati del report chiariscono come all’inizio del 2025 le campagne di phishing supportate dall’IA rappresentassero già oltre l’80% delle attività di ingegneria sociale osservate a livello globale.
Nel periodo analizzato da Enisa, il 28,5% del totale degli incidenti non è risultato associato ad alcun settore specifico. Escludendo questa quota significativa, i cinque settori più colpiti in Europa sono:
• amministrazione pubblica (38,2%)
• trasporti (7,5%)
• infrastrutture e servizi digitali (4,8%)
• finanza (4,5%)
• manifattura (2,9%).
Settori che sono anche quelli coperti dalla Direttiva NIS2 di cui parleremo nel paragrafo successivo.
Complessivamente, gli attacchi DDoS sono stati la minaccia più diffusa, interessando molteplici settori (81,4%).
I trasporti restano al secondo posto rispetto al precedente report, con un numero di incidenti che ha rappresentato il 7,5% di tutti quelli registrati.
Analizzando meglio questo segmento emerge che il 12% degli incidenti con impatto significativo segnalati nel 2024 ai sensi della Direttiva NIS ha riguardato proprio il settore dei trasporti. La distribuzione degli incidenti che hanno colpito questo settore - si spiega nel documento - mostra una concentrazione nel trasporto aereo (58,4%), seguito dalla logistica (20,8%) che verosimilmente comprende entità coinvolte nel trasporto aereo, marittimo, stradale e ferroviario.
Il comparto è stato ampiamente colpito da attacchi DDoS condotti da gruppi di hacktivisti (87,6). Sono tre i gruppi più coinvolti: NoName057 (36,4% dei casi), DarkStorm Team (il 15,4%) e Mysterious Team Bangladesh (il 6,2%).
Le attività criminose sono legate a eventi specifici, come chiarito anche dal gruppo NoName057, in relazione agli attacchi contro Repubblica Ceca, Lettonia e Polonia scaturiti in seguito agli accordi siglati con l’Ucraina.
Anche nel dicembre 2024, i portali degli aeroporti di Malpensa e Linate in Italia sono stati temporaneamente irraggiungibili a causa di attacchi rivendicati da NoName057 e probabilmente in relazione alla decisione del Governo italiano di autorizzare il trasferimento di mezzi, materiali ed equipaggiamenti all’Ucraina.
Nel 4,1% dei casi il settore ha subito minacce da parte di gruppi legati ad entità statuali affiliate alla Cina e alla Russia.
Nel primo caso si sono concentrati nel settore marittimo, navale e logistico in vari Stati membri; un’attività che riflette l’interesse strategico di Pechino nel garantire la sicurezza delle catene di approvvigio-
namento marittime e dei corridoi di trasporto legati alla Belt and Road Initiative
I gruppi legati alla Russia, in particolare APT28, si sono invece focalizzati sul trasporto aereo, la logistica e le merci, con attività concentrate in Germania, Francia e Belgio, in linea con la strategia di Mosca di colpire le infrastrutture critiche dei Paesi alleati della Nato, soprattutto nel contesto della guerra in Ucraina.
Quote minori di attività sono attribuite al gruppo Lazarus, affiliato alla Corea del Nord (6,7%), probabilmente volto a raccogliere informazioni strategiche utili all’elusione delle sanzioni.
Settori più colpiti
Pubblica Amministrazione
Generico
Trasporti
Infrastrutture digitali e Servizi
Dati: Clusit
Le tre principali varianti di ransomware che hanno colpito il settore dei trasporti in Europa sono state Akira (12,9%), INC Ransom (9,7%) e Cl0p (9,7%). Nonostante rappresentino una quota ridotta degli eventi complessivi, gli attacchi ransomware hanno avuto effetti particolarmente dirompenti in alcuni casi. Ad esempio, a seguito di un incidente attribuito al ransomware Akira, l’aeroporto di Spalato (Croazia) ha subito la compromissione del sistema informativo di accoglienza passeggeri, con conseguenti ritardi negli arrivi e nelle partenze e una sospensione temporanea di tutti i voli.
Cybersecurity: il caso italiano
L’Italia rappresenta un caso abbastanza emblematico per comprendere l’evoluzione delle minacce informatiche. A evidenziare il trend nel nostro Paese, in relazione a ciò che accade nel resto del mondo, è Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica che monitora gli eventi a livello globale, con particolare attenzione all’Italia, appunto, e pubblica ogni sei mesi un report per fare il punto della situazione.
L’ultimo rapporto, del 5 novembre 2025, analizza il periodo che va da gennaio a giugno ed evidenzia innanzitutto una crescita generale sia degli incidenti rilevati sia della loro gravità. In tutto il mondo, infatti, sono aumentati in modo significativo gli attacchi che passano da una media mensile di 337 a 459. Nel nostro Paese si registra una crescita inferiore, ma costante e progressiva, che si assesta al 13% (inferiore rispetto ai dati mondiali, pari al +36%), con 280 incidenti noti di particolare gravità.
Dati: Clusit
Il dato interessante è che gli incidenti gravi sono il 75% del totale, ciò significa che gran parte degli episodi rilevati sono particolarmente considerevoli. Dato ancora più significativo è che l’Italia si colloca fra i Paesi che nel mondo sanno meno contenere gli attacchi (in questo caso è importante distinguere fra incidenti e attacchi: i primi sono quelli andati a buon fine mentre i secondi comprendono tutti i tentativi, anche quelli non riusciti).
In virtù di questa evidente fragilità, nei primi sei mesi del 2025 nel nostro Paese è stato registrato il 10,2% degli incidenti a livello globale (nel 2024 era il 9,9%, nel 2020 il 7,6% e nel 2021 il 3,4%).
Luca Bechelli, membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico di Clusit, ci spiega che “a parità di attacchi, l’Italia tendenzialmente risulta un pochino più debole strutturalmente di altri Paesi e di questo abbiamo un riscontro anche abbastanza diretto, perché molte delle campagne di attacchi di cui siamo a conoscenza attraversano i confini dei singoli Stati. Gli hacker fondamentalmente diffondono dei virus un po’ per tutto il mondo in modo incontrollato; quindi, è lo stesso tipo di attacco che colpisce 100 volte in tutto il mondo, di cui 10 volte nella sola Italia. Quindi vuol dire che le nostre aziende proporzionalmente e percentualmente risultano essere, evidentemente, un pochino più fragili”.
In proporzione al dato globale, la situazione risulta quindi anomala, sia rispetto alla dimensione della popolazione sia al Pil nazionale. Un fatto che fa riflettere sulla capacità di difesa di fronte a queste minacce.
Vittime in Italia I semestre 2025
Dati: Clusit

Questo accade anche per una ragione strutturale.
“La nostra economia – spiega ancora Bechelli – è caratterizzata da un tessuto imprenditoriale fatto di aziende piccole e medie che competono nel mondo, ma che per dimensioni hanno meno risorse per rafforzare le proprie difese al pari di quello che può avvenire in Paesi con tessuti produttivi diversi, che hanno maggiore forza per resistere alla pressione di questi attacchi”.
Tale situazione si riflette anche nel settore dei trasporti e della logistica che è, fra l’altro, uno dei più colpiti.
Questo è un altro elemento peculiare.
Se si confrontano i dati italiani di questo segmento con quelli del resto del mondo emerge infatti una chiara disparità: in Italia trasporto e logistica sono i secondi soggetti più attaccati, mentre a livello globale sono all’ottavo posto.
Più nel dettaglio, nel primo semestre di quest’anno i settori più bersagliati sono nell’ambito Governativo/militare/forze dell’ordine (38% del totale). La crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è pari a oltre il 600%. Come dicevamo, ci sono poi Trasporti/logistica che segnano il 17% del totale e una crescita del 10% rispetto a un anno fa (in sei mesi è avvenuto oltre una volta e mezzo il numero degli incidenti di tutto l’anno precedente).
Un dato collegabile anche all’aumento del fenomeno Hacktivism, cioè di attacchi compiuti da cyber attivisti di tipo dimostrativo con finalità politiche o geopolitiche.
Luca Bechelli chiarisce che “vedendo come è stato aggredito il settore, emerge che si vuole colpire un anello molto importante della catena di produzione e distribuzione che attraversa tantissimi altri settori che dipendono dai trasporti e dalla logistica, colpendo così più segmenti di mercato contemporaneamente e limitando la capacità di garantire approvvigionamento e distribuzione”.
A supporto di questa analisi ci sono i dati sulle tecniche utilizzaI trasporti al secondo posto
te: crescono nel comparto gli attacchi DDOS, cioè Distributed Denial-of-Service, che, sovraccaricando un server, un sito web o una rete con un enorme volume di traffico, li rendono non disponibili per gli utenti legittimi. Questa tipologia è tipicamente utilizzata dagli attivisti ed è molto diffusa in Italia a livello trasversale.
“Sono tecniche tutto sommato banali, finalizzate a rendere indisponibili i servizi informatici delle vittime. In Italia, è un tipo di attacco che supera il 50% dei casi, a differenza di quello che accade nel mondo, dove arriva solo al 9% degli attacchi”.
I dati del 2025 mostrano come, ad esempio, l’Italia sia stata molto più colpita da incidenti di gruppi come NoName057 – sabotatori coordinati riconducibili a strutture governative russe, pur trattandosi di incidenti con impatti di livello tipicamente medio-basso.
Questo per quel che riguarda i trasporti e la logistica si traduce in un vero e proprio cambio di paradigma. Nel passato (anche fino al Rapporto Clusit 2024) gli incidenti, infatti, erano di natura cybercriminale ovvero con finalità principalmente economiche da parte degli attaccanti.
“Nel rapporto scorso avevamo registrato un aumento degli attacchi più tradizionali verso questi settori. In Italia il settore era quinto nel 2024, nel primo semestre del 2025 è diventato secondo”.
In linea generale, nei primi sei mesi del 2025, gran parte degli incidenti noti si riferisce proprio alla categoria Hacktivism, che si attesta al 54%, superando a livello nazionale il peso percentuale del Cybercrime che causa del 46% del totale degli incidenti. In questa categoria, si è tuttavia verificato un numero superiore di eventi rispetto a quelli rilevati nello stesso periodo dello scorso anno (130 nel primo semestre 2025 contro 89 nel primo semestre 2024)”.
Attacchi nel mondo
Dati: Clusit
In risposta alla continua evoluzione delle minacce informatiche il Parlamento europeo ha adottato una nuova direttiva (vedi anche capitolo 1), con l’obiettivo di rendere uniforme la strategia comunitaria contro il cybercrime. La Network and Information Security Directive 2, meglio conosciuta come NIS 2, recepita in Italia nel settembre del 2024 e in vigore dal mese successivo, è l’aggiornamento della NIS1, la prima legislazione unitaria per rafforzare la cybersicurezza delle reti e dei sistemi informativi e per salvaguardare servizi vitali per l’economia e la società Ue. La NIS 2 è frutto di un lavoro di revisione iniziato a fine 2020 proprio per elevare la protezione e la capacità di reazione e istituire un quadro giuridico unificato per sostenere la cybersicurezza in 18 settori critici e, allo stesso tempo, spingere a definire strategie nazionali in materia.
L’Unione impone agli Stati membri di rafforzare le loro capacità in materia di cybersicurezza, introducendo misure di gestione dei rischi, obblighi di segnalazione, norme per la cooperazione, condivisione delle informazioni.
La Direttiva NIS

In quest’ottica, la direttiva chiama ciascuno Stato membro ad adottare una strategia nazionale in materia di cybersicurezza, che comprenda politiche per la sicurezza della catena di approvvigionamento, la gestione delle vulnerabilità e l’educazione e la sensibilizzazione in materia di cybersicurezza. Gli Stati membri devono inoltre redigere e aggiornare regolarmente un elenco di operatori di servizi essenziali, garantendo che tali soggetti rispettino i requisiti della direttiva.
Oltre ai settori già inclusi nella precedente legge, quali energia, trasporti, assistenza sanitaria, finanza, gestione delle risorse idriche e infrastrutture digitali, le nuove norme ampliano il perimetro di applicazione.
L’applicazione degli obblighi dipende dalla dimensione delle imprese dei settori coinvolti.
La direttiva comprende anche disposizioni in materia di vigilanza e introduce, inoltre, la responsabilità dell’alta dirigenza per il mancato rispetto delle misure di gestione dei rischi.
E, ancora, istituisce la CSIRTs Network, una rete di squadre di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente per scambiare informazioni sulle minacce informatiche e rispondere agli incidenti. Su vasta scala, c’è invece EU-CyCLONe, la rete europea di organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche che coordina e garantisce lo scambio regolare di informazioni tra gli Stati membri e le istituzioni dell’Ue in caso di incidenti e crisi di livello più ampio.
L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
In Italia, è l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale l’autorità che si occupa di proteggere i nostri interessi strategici in questo campo e, in questa prospettiva, anche della piena attuazione della NIS 2.
Il prefetto Milena Antonella Rizzi, capo dei servizi di regolazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale spiega il ruolo dell’ACN in questo scenario.
“Nella rimodulazione dell’architettura nazionale di cybersicurezza - dice -, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha accentrato competenze che in precedenza erano distribuite tra diversi attori.
L’obiettivo con la nascita di ACN era proprio quello di creare un motore al centro di questa architettura nazionale nel dominio cybernetico finalizzato a concentrare le competenze e ad affrontare le sfide dell’evoluzione della minaccia cybernetica nel nostro Paese”, spiega, concentrandosi sull’importanza della nuova norma.
“La NIS 1 risale al 2016 ed è stata recepita in Italia nel 2018 - chiarisce il prefetto Rizzi -. Nel 2020, sull’onda generata dalla pandemia da Covid, che ha fatto emergere quanto siamo diventati dipendenti dalla dimensione digitale, si è sentita la necessità di rimettere mano all’impianto regolatorio per superare le disarmonie che si erano venute a verificare nella fase di implementazione della NIS 1 che voleva raggiungere un livello uniforme di applicazione della sicurezza informatica su tutto il territorio dell’Unione, ma che in realtà ha lasciato mano troppo libera agli Stati membri. Questo ha determinato un’applicazione veramente a macchia di leopardo, creando - come riconosciuto in alcuni considerando sulla direttiva NIS 2 - delle difficoltà per il mercato interno e dei danni per gli operatori transfrontalieri, quindi, in particolare a chi svolge attività nel mondo del trasporto”.
Con la NIS 2, invece, il paradigma è completamente cambiato: “Non è più lo Stato membro che individua il soggetto, ma c’è un criterio oggettivo ed è il carattere dimensionale, ovvero se il soggetto ha le
dimensioni finanziarie di una media o di una grande impresa che opera in almeno uno dei settori presi in considerazione dalla direttiva”.
“Dopodiché ci sono alcune particolari tipologie di soggetti che sono attratte nell’ambito dell’applicazione della direttiva, indipendentemente dal criterio dimensionale proprio per la criticità del servizio offerto”, continua ancora il capo del servizio di regolazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.
Ma quali sono nel dettaglio i settori a cui si applica la NIS 2?
I 18 settori critici o a criticità elevata sono: energia; trasporti; settore bancario; infrastrutture dei mercati finanziari; sanità; acqua potabile; acque reflue; infrastrutture digitali; gestione dei servizi TIC (business-to-business); Pubblica Amministrazione; spazio; servizi postali e di corriere; gestione dei rifiuti; fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche; produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti; fabbricazione (di computer e prodotti di elettronica e ottica; di apparecchiature elettriche; di macchinari e apparecchiature non classificati altrove; di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; di altri mezzi di trasporto); fornitori di servizi digitali; ricerca.
La normativa prevede soglie minime in termini di fatturato, numero di dipendenti o volume di dati trattati, al fine di individuare le organizzazioni più significative per la continuità dei servizi essenziali.
I soggetti che rientrano nel perimetro della direttiva sono chiamati a registrarsi e aggiornare ogni anno la propria registrazione su una piattaforma digitale ad hoc dell’ACN e sono tenuti ad adottare misure tecniche, operative e organizzative per la gestione dei rischi, e soprattutto a comunicare, senza ingiustificato ritardo, ogni incidente che ha avuto un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi. La comunicazione va fatta entro 24 ore e comunque non oltre le 72 ore.
I 18 settori della NIS 2

Per quel che riguarda il settore trasporti, ci sono diversi sottosettori. Nel trasporto aereo, sono coinvolti i vettori, i gestori aeroportuali, gli aeroporti, i soggetti che gestiscono impianti situati in aeroporti, gli operatori attivi nel controllo della gestione del traffico. Nel trasporto
Il settore dei trasporti
La prevenzione
ferroviario, invece i gestori dell’infrastruttura, gli organismi o le imprese responsabili dell’esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, le imprese ferroviarie. Per il trasporto su strada, i soggetti compresi sono qualsiasi autorità pubblica responsabile della pianificazione, del controllo o della gestione delle strade, i gestori di sistemi di trasporto intelligenti. Infine, per il trasporto marittimo o su vie interne navigabili sono incluse le compagnie di navigazione, gli organi di gestione dei porti, i gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo.
Ci sono poi altri settori critici che chiamano in ballo il trasporto su strada: i fornitori di servizi postali, tra cui i corrieri; il settore gestione dei rifiuti, di cui fanno parte le imprese di trasporto nelle diverse fasi e, ancora, il settore produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti che comprende le imprese che si occupano della distribuzione all’ingrosso.
Fra i compiti dell’ACN c’è anche la crescita di consapevolezza delle potenziali vittime.
“La prevenzione è fondamentale. Purtroppo, la minaccia è immanente. Gli attacchi ci sono e continueranno ad esserci ma grazie anche all’attività di ACN abbiamo imparato a difenderci meglio. E come abbiamo fatto? Intanto attraverso una fortissima azione di innalzamento del livello di consapevolezza perché prima della formazione c’è la consapevolezza. Io mi posso formare se però sono consapevole delle mie lacune. Quando è stata istituita l’Agenzia – continua Rizzi – c’era da fare tanto lavoro per innalzare il livello di sensibilizzazione verso questa tematica. Ad esempio, era frequente sentire la frase ‘tanto a me non capiterà mai’. Era il 2021; adesso siamo nel 2025 e quello che dicono gli operatori è ‘purtroppo mi è successo e mi potrebbe ricapitare’. Quindi, il panorama è completamente cambiato.
Per potersi difendere è quindi fondamentale essere più consapevoli e ovviamente più formati. ACN ha istituito sotto la stretta direzione del vicedirettore generale due specifiche divisioni: una che si occupa di awareness e un’altra che si occupa di formazione. Si tratta di divisioni che portano avanti i contenuti della strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 – conclude il prefetto – che prevedono, tra le altre, proprio l’attività di sensibilizzazione nei confronti delle piccole e medie imprese”.
5 Competenze digitali, priorità per la logistica
Il settore chiede personale sempre più qualificato
Alla luce di quanto raccontato finora, risulta evidente come la profonda rivoluzione tecnologica dei trasporti e della logistica stia ripensando le stesse modalità di lavoro. Un fenomeno che si avverte particolarmente in un settore come questo, caratterizzato da un basso turn-over e da una conseguente forte carenza di nuove leve.
Ciò vuol dire che è necessario investire nella formazione del personale, sia per permettere di utilizzare al meglio le numerose opportunità offerte dalla tecnologia e dalla grande disponibilità di dati, sia per consentire di riconoscere ed evitare i rischi legati a queste nuove possibilità (vedi capitolo precedente).
In linea generale, in tutto il mondo del lavoro le trasformazioni in atto in chiave digitale stanno delineando nuove necessità nella richiesta del personale. Un approfondimento realizzato nell’ambito del progetto Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rileva quali sono state le principali competenze richieste dalle aziende in tutti i settori del mercato del lavoro lo scorso anno.

Nel 2024, si è evidenziato un sensibile incremento del mismatch fra domanda e offerta di competenze digitali: circa il 60% delle imprese che hanno realizzato investimenti digitali ha dichiarato infatti di avere difficoltà nel trovare figure professionali con simili caratteristiche, in sensibile aumento rispetto al 58,1% dell’anno precedente.
Le capacità richieste
Tra le diverse capacità, quella maggiormente richiesta è la capacità di utilizzare le tecnologie internet e di gestire e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, seguita dalle competenze relative all’utilizzo di linguaggi e metodi matematici e informatici e alla gestione di soluzioni innovative.
Le conoscenze digitali più avanzate sono sempre più richieste dai gruppi professionali altamente qualificati. Le skill che prevedono l’utilizzo delle tecnologie internet, di altri strumenti di comunicazione e dei linguaggi e dei metodi matematici ed informatici sono richieste dalle imprese per quasi la totalità delle entrate dei dirigenti (rispettivamente al 98,4% e al 95,8%). All’84,3% è inoltre richiesto il possesso di competenze nell’applicazione ai processi aziendali delle tecnologie digitali, della robotica, dei big data analytics. Al contrario, nel caso delle professioni non qualificate, il possesso di competenze digitali è richiesto in misura inferiore. Resta alta però la richiesta di utilizzo di internet (39,5%); capacità pretesa in più della metà dei conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili (51,6%).

Gli autotrasportatori, ad esempio, sono alle prese con veicoli sempre più tecnologici e con strumenti digitali per gestire il lavoro (vedi anche capitolo 3).
Tornando al quadro generale, lo studio evidenzia che sono le imprese operanti nel settore manifatturiero a riscontrare le maggiori difficoltà nel reperire i profili richiesti (62%) e che le criticità nel trovare profili adeguati crescono con la classe dimensionale delle imprese (il 65,1% delle aziende con oltre 500 dipendenti e il 62,5% di quelle con 50-499 dipendenti).
Indipendentemente dalla dimensione aziendale, la mancanza di candidati rappresenta ancora il principale ostacolo per più di un’impresa su tre.
Le competenze per trasporti e logistica
Entriamo ora più nel dettaglio del nostro settore. C’è da fare innanzitutto una premessa importante: i dati del report di Unioncamere riguardano non solo le nuove assunzioni, ma anche i rinnovi dei contratti a termine.
Scopriamo così, ad esempio, che per 17.890 addetti ai magazzini (su un totale di 22.690) è stata richiesta la capacità di utilizzare lin-
guaggi e metodi matematici e informatici, pari al 78,8% del totale. Stessa situazione per gli autisti di camion. Nel 2024 si reclamava l’ingresso nel mercato del lavoro di 214.390 conduttori di mezzi pesanti e camion e per 75.320 di loro è stata richiesta la medesima capacità (il 35,5%).
Nel caso del personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino questa cifra arriva a 109.450 su 266.360 entrate previste.
Quando si parla dell’uso di tecnologie internet e di capacità di gestire e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale la percentuale sale.
Ad esempio, su 7.080 ingressi richiesti dalle aziende di spedizionieri e tecnici della distribuzione a solo 180 non veniva domandato di possedere queste competenze.
Per i conduttori di mezzi pesanti la proporzione cambia: su 214.390 richieste, il 60,9% deve possedere tali abilità. Una percentuale in linea con quella del personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino, del 60,4%.
Si analizza, poi, la capacità di applicare tecnologie digitali per innovare e automatizzare i processi. In questo caso si tratta di competenze più specifiche e quindi la richiesta cala. È così nel caso degli autisti. Nella categoria dei conduttori di mezzi pesanti e camion, su 214.390 entrate previste ci si aspetta che le possegga solo il 30,2%; fra il personale non qualificato dei magazzini si scende al 26,3% e fra gli addetti alle consegne si cala ancora (19%).
Questo restituisce un quadro di un settore ancora variegato dal punto di vista del ricorso alla digitalizzazione, all’automazione e alle nuove tecnologie che è destinato però ad accrescere queste componenti.

L’automazione nelle imprese
Una recente ricerca realizzata dall’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, dal titolo “Intelligenza (artificiale e umana) per il futuro della logistica”, si è posto l’obiettivo di identificare i possibili ambiti di adozione dell’IA nel settore della logistica e il grado di adozione da parte delle aziende committenti e dei fornitori di servizi logistici. Un’analisi realizzata su casi di studio, sull’osservazione approfondita di startup, internazionali e nazionali, operanti nel settore e su un sondaggio realizzato su 7.187 aziende committenti.

Un dato centrale su cui riflettere sono innanzitutto i fattori di successo per l’introduzione dell’IA: disponibilità e qualità dei dati (valutata 7,7, in un punteggio da 1 a 10), disponibilità delle risorse IT (7,7), propensione all’adozione di nuove tecnologie (7,7) e infine disponibilità di competenze (7,6).
Un sistema di intelligenza artificiale svolge le sue funzioni mediante diverse capacità che, in teoria, potrebbero essere integrate fra loro ma che, nella pratica, non lo sono. Infatti, le soluzioni usate ad oggi dalle imprese sfruttano una o poche capabilities principali, in base alle esigenze specifiche.
Per identificare quelle più rilevanti nella logistica, è stata compiuta una mappatura delle startup che sviluppano o applicano sistemi di IA in questo campo. Si tratta di un campione composto da 175 realtà, con sede in 34 Paesi, che sviluppano sistemi software o hardware basati sull’intelligenza artificiale.
L’IA NELLA GESTIONE DEI TRASPORTI
Più della metà delle startup internazionali mappate che utilizzano l’IA nel settore della Logistica operano nel settore del trasporto.
175 startup internazionali operanti nel settore della Logistica che utilizzano soluzioni di IA
109
nell’ambito del trasporto
2.141MLN DI $
nanziamento startup internazionali operanti nel settore del trasporto che utilizzano l’IA
Emerge che nella gran parte dei casi - il 53% - si adotta il Learning (per raccogliere, elaborare e analizzare continuamente i dati), nel 30% il Natural Language Processing (per consentire ai computer di comprendere e comunicare con il linguaggio umano come fanno i chatbot), nel 21% i Computer vision (per ricavare informazioni da immagini e altri input visivi e formulare raccomandazioni o intraprendere azioni). Seguono poi la Robotica (19%) e l’Automated Reasoning (17%) – che utilizza le informazioni disponibili per fare previsioni e collegamenti e trarre conclusioni dalle startup.
La survey sulle aziende rileva, invece, che ad oggi più della metà delle imprese committenti di servizi logistici è coinvolta in progetti di IA (il 53%) e quasi un terzo (il 30%) applica l’intelligenza artificiale ai processi logistici. Guardando al futuro emerge che nei prossimi tre anni si arriverà al 44%.
Ma come viene utilizzata l’IA dalle imprese? La logistica include diverse attività che, al di là della gestione del magazzino o dei trasporti, prevedono impieghi più trasversali come la previsione della domanda o l’analisi del sentiment dei clienti.
Gli ambiti dove vi è un maggior ricorso all’uso dell’IA sono quelli riservati a coloro che svolgono lavoro d’ufficio (il 26% dei casi), mentre è meno diffusa fra gli operativi (16%). Nel primo caso, spiccano parimerito la gestione degli ordini e la previsione della domanda e il riordino materiali (entrambi al 14%). Nella gestione delle relazioni di filiera, che include la valutazione, selezione e gestione dei fornitori, l’intelligenza artificiale è adottata invece nel 10% dei casi.
Per quel che riguarda l’attività sul campo, emergono mansioni tipiche del magazzino (12%), come quelle affidate a carrellisti e pickeristi, oltre ad operazioni di trasporto (7%), che coinvolgono direttamente gli autisti.
Cresce l’adozione dell’IA
Dati: OSSERVATORIO FREIGHT INSIGHTS
La percentuale del ricorso all’IA varia sensibilmente in base alla dimensione aziendale.
Il 46% delle imprese che ha un fatturato superiore a 250 milioni di euro ha già implementato soluzioni di IA per la Logistica; lo stesso vale per il 42% di quelle di media dimensione (con un fatturato tra 50 e 249 milioni di euro). La percentuale cala drasticamente al 19% per le imprese più piccole con un fatturato tra 10 e 49 milioni di euro 19%.
BENEFICI DALL’ADOZIONE
DI SOLUZIONI IA
Miglioramento del livello di servizio Aumento della produttività
Aumento della qualità dei processi
Riduzione dei costi
Miglioramento della sostenibilità ambientale
Dati: OSSERVATORIO FREIGHT INSIGHTS
6 La voce delle associazioni di categoria

AITI
Alessandro Russo
La trasformazione digitale sta cambiando radicalmente il modo in cui le imprese operano, e il settore dei traslochi non fa eccezione. Per anni considerata un’attività prevalentemente manuale e logistica, oggi il nostro settore si trova al centro di un’evoluzione che mette al centro dati, automazione e nuovi strumenti digitali. Noi di Aiti, associazione nazionale di riferimento per le aziende di trasloco, riteniamo che la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale non rappresentino solo un’opportunità, ma una necessità strategica per garantire efficienza, sicurezza e qualità del servizio.
Uno dei primi fronti su cui la digitalizzazione sta portando valore è la gestione dei preventivi.
Grazie a piattaforme digitali e applicazioni di video-survey, i clienti possono effettuare sopralluoghi virtuali direttamente dal loro smartphone, riducendo i tempi di attesa e consentendo agli operatori di valutare volumi e complessità con maggiore precisione. L’intelligenza artificiale può analizzare le immagini, stimare ingombri, prevedere la durata dell’intervento e suggerire il numero ottimale di addetti e mezzi necessari. Questo si traduce in una pianificazione più accurata e in un miglior utilizzo delle risorse.
La digitalizzazione sta migliorando anche l’organizzazione dei trasporti. Sistemi di routing intelligenti consentono di individuare i percorsi più rapidi e sostenibili, riducendo tempi di viaggio, consumi e impatto ambientale. La gestione smart delle flotte permette inoltre di monitorare in tempo reale la posizione dei mezzi, prevenire guasti grazie alla manutenzione predittiva e ottimizzare la distribuzione dei carichi. Tutti elementi che migliorano l’efficienza operativa e la puntualità, aspetti cruciali per la soddisfazione del cliente.
Un’altra frontiera dell’innovazione è la sicurezza. Sensori integrati in casse e contenitori possono monitorare vibrazioni, umidità e tem-
peratura, garantendo condizioni ottimali durante tutto il trasporto. Gli algoritmi di IA, analizzando i dati raccolti, possono segnalare anomalie e suggerire interventi immediati, proteggendo beni particolarmente delicati o di alto valore.
Dal punto di vista della relazione con il cliente, chatbot e assistenti virtuali migliorano l’accessibilità ai servizi, offrendo risposte immediate su preventivi, disponibilità e fasi operative. Allo stesso tempo, le piattaforme digitali permettono di tracciare ogni fase del trasloco, offrendo trasparenza e fiducia.
Tuttavia, la digitalizzazione non riguarda solo la tecnologia, ma anche le competenze. Aiti ha il compito di supportare le imprese nella formazione del personale, affinché gli strumenti digitali diventino un alleato quotidiano e non un ostacolo. Investire in competenze digitali significa aumentare la professionalità del settore e renderlo più competitivo.
In conclusione, digitalizzazione e intelligenza artificiale stanno ridefinendo il mondo dei traslochi, rendendolo più efficiente, sicuro e orientato al cliente. Le aziende che sapranno cogliere questa trasformazione saranno protagoniste di un mercato più moderno e innovativo. Il nostro obiettivo, come associazione, è accompagnare tutte le imprese in questo percorso, affinché l’innovazione diventi un patrimonio comune.

Anita
Riccardo Morelli
“Oggi, in un contesto competitivo in continua evoluzione, l’innovazione è motore di sviluppo per il settore dell’autotrasporto merci e della logistica. Le nuove tecnologie ridefiniscono i modelli di crescita e competizione determinando opportunità inedite per le imprese che scelgono di integrarle nei processi operativi e di affrontare insieme ad esse le sfide del mercato. Per questo Anita promuove e sostiene l’utilizzo di soluzioni tecnologiche digitali tra le aziende del comparto, certa che per il loro tramite si possa aumentare la performance, riducendo i costi operativi e gestionali, affermando la tracciabilità lungo i flussi logistici e favorendo al contempo l’adozione di pratiche sostenibili e ecologiche.
Attualmente, l’attenzione posta in materia di innovazione da aziende e Istituzioni rappresenta la cornice adatta per imprimere un’accelerazione strategica alla digitalizzazione del settore, che, pur essendo un asset cruciale per l’economia, non ha ancora pienamente beneficiato delle potenzialità offerte dalla rivoluzione in atto. Per questo, le politiche e gli investimenti promossi dal PNRR sono stati funzionali ad immaginare un ecosistema digitale anche per la logistica, in grado di semplificare gli scambi informativi tra imprese e PA. Dalla ratifica del Protocollo eCMR all’avvio della sperimentazione per il suo utilizzo, passando per il sostegno pubblico offerto agli operatori della mobilità delle merci, soprattutto attraverso il Bando LogIN Business. Una misura efficace nata per promuovere l’integrazione, favorendo la dematerializzazione documentale e l’ottimizzazione dei percorsi in una logica di interoperabilità e miglioramento intermodale.
L’impegno dell’associazione rimarrà fermo anche oltre il target PNRR fissato per il 2026, al fine di garantire alle imprese un ambiente digitale proficuo e durevole che possa effettivamente concretizzarsi. In questo senso, Anita ha prodotto alcune proposte, già presentate
nel corso della Assemblea pubblica del 19 settembre scorso, che spera possano trovare accoglimento da parte delle Istituzioni. In primo luogo, la digitalizzazione del DDT, ancora oggi prevalentemente cartaceo e non standardizzato, rappresenta una priorità. L’introduzione di un formato digitale nazionale favorirebbe l’efficienza lungo la supply chain e aprirebbe la strada a uno standard unico europeo.
In secondo luogo, la creazione di un sistema centralizzato per integrare digitalmente i portali di gestione dei fornitori, connesso agli enti di riferimento come l’Albo dell’Autotrasporto. Questo permetterebbe alle imprese di accedere a dati affidabili sui sub-vettori, migliorando la reportistica e la conoscenza dei provider. In tal senso, la Piattaforma Logistica Nazionale potrebbe ospitare tali servizi, in linea con la sua missione e a beneficio dell’intero sistema logistico.

Assotir
Claudio Donati
Digitalizzazione e intelligenza artificiale sono parole entrate in ogni settore della nostra vita. Il loro impatto è già oggi straordinario, ma nessuno è in grado di prevedere quali sviluppi ci attendono. Farei al riguardo due considerazioni. La prima è che l’IA è figlia di internet e della tecnologia digitale che, attraverso la fornitura di enormi quantità di dati, ne alimentano lo sviluppo. La seconda è che siamo di fronte a una rivoluzione che, come tale, è destinata a sconvolgere le nostre abitudini, sia in senso positivo sia problematico. I rischi di spaesamento sono più che probabili. Tutto ciò ci obbliga a un monitoraggio e un approfondimento continui, una sorta di “educazione digitale” per provare a governare questa straordinaria strumentazione messa a disposizione dalla tecnica.
Ciò detto, nel settore del trasporto e della logistica, sono già evidenti molte applicazioni delle nuove tecnologie. Nella logistica, l’introduzione dall’IA è già oltre la sperimentazione, trovando applicazione sia nella gestione dei magazzini che, in generale, nell’ottimizzazione della programmazione.
Nell’autotrasporto, si va dalle dotazioni strumentali destinate al miglioramento delle condizioni di guida e alla maggiore sicurezza sulla strada, fino ai software per l’ottimizzazione dei traffici o dei costi aziendali.
È, tuttavia, singolare che in un contesto in cui la tracciabilità dei dati diventa quasi banale (dalle ore di guida al consumo del gasolio, al pedaggio autostradale, etc.), sia stata prestata scarsissima attenzione alla tracciatura delle merci trasportate; vale a dire, al percorso che un qualsiasi prodotto compie, dettagliato in ogni singolo passaggio, dall’origine alla destinazione finale.
Proprio partendo da questa elementare constatazione, abbiamo proposto, lo scorso mese di ottobre, di far intervenire la digitalizza-
zione per tracciare la merce trasportata. Si tratterebbe di estendere l’esperienza (molto positiva) dell’eCMR - la lettera di vettura elettronica per i trasporti internazionali -, a livello nazionale. Questo sarebbe un esempio molto concreto di applicazione della tecnologia digitale, per portare trasparenza nel mercato nazionale del trasporto e della logistica, in cui, come è noto, il fenomeno dell’abuso della subvezione, nonostante sia vietato dalla legge, è dilagante.
Infatti, oggi è impossibile effettuare controlli su strada, dal momento che la vecchia scheda di trasporto (cartacea) è stata soppressa nel 2015, con l’argomento che avrebbe rappresentato un eccessivo onere amministrativo, specie per i piccoli vettori. Per cui, attualmente, in Italia la merce viaggia senza documentazione accompagnatoria, impedendo così di verificare se la stessa sia trasportata da un primo vettore o da un secondo, o da un quinto vettore. L’inserimento di un QR Code sarebbe sufficiente per individuarne la tracciabilità in ogni momento. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, quello che potrebbe essere un contributo enorme alla trasparenza e all’accorciamento della filiera logistica, ètecnicamente - di semplice attuazione, senza particolari aggravi burocratici per il trasportatore.

Cna-Fita
Michele Santoni
La rivoluzione digitale sta ridisegnando in profondità tutti i settori produttivi e quello dei trasporti non fa eccezione. Era dall’avvento dell’automobile e dei veicoli pesanti a motore che non si viveva un cambiamento così epocale del modello di mobilità. Oggi, con l’intelligenza artificiale, gli algoritmi avanzati e i sistemi di analisi predittiva, il mondo dell’autotrasporto e della logistica ha infatti a disposizione strumenti senza precedenti per innalzare i livelli di sicurezza, ottimizzare i processi, migliorare concretamente le condizioni di lavoro degli autisti e degli operatori. Strumenti di cui deve assolutamente approfittare. Nonostante le innovazioni tecnologiche abbiano fatto compiere passi da gigante in termini di sicurezza, il settore vive ancora oggi all’interno di un quadro regolatorio rigido e in molti casi datato. Dall’articolo 6 del Codice della Strada, che prevede la predisposizione di un calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti nei giorni festivi o in altri giorni particolari, al Regolamento sui tempi di guida e riposo, molte norme sono nate in un contesto completamente diverso dall’attuale.
I dati della Commissione per la sicurezza stradale nel settore dell’autotrasporto parlano chiaro: ogni anno il tasso di incidentalità dei mezzi pesanti diminuisce, a dimostrazione della grande professionalità raggiunta dagli operatori. Una situazione che stride con delle imposizioni che, seppur mosse da sani principi di sicurezza, appaiono quantomeno eccessive.
Basti pensare che il calendario dei divieti, nel 2025, ha sottratto alle imprese oltre 981 ore di lavoro, con una perdita di oltre centomila euro a veicolo.
Gli autotrasportatori percorrono quotidianamente settemila chilometri di rete autostradale applicando regole pensate per la sicurezza almeno trent’anni fa, mentre oggi le nuove tecnologie e la digitalizza-
zione offrono strumenti che possono incidere in maniera molto più efficace di norme ormai datate. La circolazione, ad esempio, può essere modulata in modo dinamico grazie a sistemi digitali in grado di leggere il traffico in tempo reale.
L’IA sta già trasformando la gestione del traffico, rendendo le strade più sicure ed efficienti: gli algoritmi predittivi sono utilizzati per analizzare i dati del traffico e per prevedere incidenti e congestioni, mentre i sistemi di navigazione intelligenti suggeriscono percorsi in base ai flussi e alle condizioni del traffico, evitando ingorghi e ritardi. Estendere questi strumenti ai veicoli pesanti significherebbe mettere davvero la tecnologia al servizio della sicurezza.
Non meno importante è l’impatto che l’IA potrebbe avere sull’organizzazione del lavoro: prevedere i rischi legati a un tragitto, calcolare i tempi effettivi per completarlo consentirebbe di programmare, con cognizione di causa, di volta in volta, una specifica organizzazione dei tempi di lavoro e riposo. Questo consentirebbe di migliorare le condizioni degli autisti, ridurre lo stress e aumentare l’attrattività della professione.
L’IA rappresenta anche un’opportunità per colmare ritardi storici del sistema infrastrutturale nazionale: il catasto nazionale delle strade, previsto dal Codice della Strada sin dal 1992, non è ancora pienamente operativo. Il monitoraggio digitale automatico del manto stradale, dello stato tecnico delle opere e dei flussi di traffico consentirebbe una programmazione più puntuale della manutenzione e l’individuazione di percorsi alternativi e sicuri in caso di eventi eccezionali.
In estrema sintesi, l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il trasporto merci, rendendolo più efficiente e sicuro. Gli straordinari effetti sul settore si possono riassumere in tre punti:
- ottimizzazione logistica e costi: l’IA riduce i costi e le emissioni ottimizzando in tempo reale i percorsi (traffico, meteo) e la gestione della flotta, inclusa la pianificazione dinamica dell’ultimo miglio;
- sicurezza e manutenzione predittiva: i sensori sui veicoli e gli algoritmi di machine learning prevedono i guasti prima che accadano (manutenzione predittiva), riducendo i fermi macchina imprevisti e aumentando la sicurezza stradale;
- tutela del fattore umano e tempi: l’IA funge da “copilota” rilevando stanchezza e distrazione del conducente, e ottimizza i processi amministrativi e i tempi di attesa per carico/scarico (pianificazione degli slot), migliorando la produttività e il benessere degli autisti.

Confartigianato Trasporti
Amedeo Genedani
Ci sono momenti in cui un settore cambia passo senza fare rumore: nella logistica sta accadendo adesso, grazie alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale. E a guidare questa trasformazione non sono solo i grandi gruppi, ma anche le piccole imprese artigiane.
Il recente bando Login Business del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha messo a disposizione 157 milioni di euro per accompagnare le aziende nel percorso di digitalizzazione, ne è la prova più concreta. Nonostante la presenza di 16 progetti di valore superiore al milione di euro, la maggior parte delle domande sono state infatti presentate da piccole e medie imprese, a dimostrazione che le imprese artigiane sono pronte al cambiamento; semplicemente devono essere aiutate in questa fase di transizione con incentivi e strumenti adeguati.
Le piccole e medie imprese sono tradizionalmente più esposte alle difficoltà di programmare investimenti onerosi, ma se accompagnate sono in grado di rispondere adeguatamente al cambiamento. Nonostante i tempi stretti, le domande sono state infatti molte. Sarebbe quindi opportuna una riapertura del bando per consentire anche a quelle aziende che non sono riuscite a cogliere l’attimo di poter partecipare.
L’interesse dimostrato suggerisce che esiste un potenziale ancora inespresso, fatto di imprese che vogliono innovare, ma hanno bisogno di un quadro di sostegno più stabile e continuativo.
L’innovazione, però, non riguarda solo i software gestionali o la digitalizzazione: sempre più imprese stanno puntando sull’intelligenza artificiale. Nel mondo della logistica, l’IA consente di ottimizzare i percorsi, limitare i chilometri a vuoto, prevedere la manutenzione dei mezzi e migliorare la sicurezza. Tecnologie che fino a pochi anni fa sembravano accessibili solo ai grandi operatori, ma che oggi diventano strumenti alla portata delle realtà artigiane. In molte aziende si stanno
già sperimentando soluzioni basate sui dati, capaci di aumentare l’efficienza e di incrementare la sicurezza, dimostrando che l’IA è un alleato concreto per la competitività.
Oggi la digitalizzazione è una leva strategica di sviluppo per tutte le Pmi della logistica. E se ci saranno altri bandi che seguiranno questa strada tracciata, gli artigiani continueranno a dimostrare che innovare non è una sfida riservata ai grandi, ma un’opportunità per chiunque voglia restare competitivo.

Confcooperative Lavoro e Servizi
Massimo Stronati
Sostenibilità, transizione ecologica e digitale, innovazione. Sono le parole che oggi sentiamo ripetere ovunque, ma per le nostre imprese cooperative non sono solo slogan: rappresentano sfide concrete, che richiedono impegno, investimenti e una nuova mentalità. Chi saprà affrontarle con coraggio e visione potrà continuare a crescere e a competere in un mercato in rapido cambiamento. E la transizione ecologica e digitale non rappresenta solo un insieme di obblighi normativi o tecnologici, ma una straordinaria occasione per ripensare i modelli organizzativi e produttivi, mettendo al centro la persona e la qualità del lavoro. È un percorso impegnativo, che richiede risorse e coraggio, ma che può rafforzare il nostro ruolo di protagonisti di un’economia sostenibile e inclusiva.
Le nostre cooperative hanno nel DNA la capacità di adattarsi e innovare, mettendo sempre al centro le persone e il valore del lavoro da esse generato e la transizione ecologica e digitale non si risolve esclusivamente in un passaggio tecnologico, ma in un vero cambiamento culturale che implica una modalità di produrre, di organizzarsi e di costruire relazioni con il territorio.
La sfida è complessa, ma costituisce un’enorme opportunità per rendere il nostro sistema produttivo più sostenibile, efficiente e giusto.
L’Europa e il Governo italiano stanno investendo molto per accompagnare questo percorso. Dal Green Deal al PNRR, le politiche attuali mirano a ridurre le emissioni, migliorare la logistica e rendere più moderne e interconnesse le infrastrutture: autotrasporto, porti e ferrovie. L’obiettivo è costruire una mobilità che sia davvero integrata, digitale e sostenibile.
In questo contesto, la digitalizzazione dei trasporti gioca un ruolo decisivo. L’introduzione dell’eCMR e il nuovo Regolamento eFTI cambieranno il modo di gestire i documenti e le informazioni lungo
la filiera, rendendo i processi più rapidi, sicuri e trasparenti. Allo stesso tempo, l’intelligenza artificiale sta già trasformando il settore: dal monitoraggio dei traffici in tempo reale alla gestione delle flotte, fino ai veicoli autonomi e alla robotica per la logistica. Tecnologie che, se usate bene, possono rendere le imprese più competitive e migliorare la qualità del lavoro.
Ma non dobbiamo dimenticare che l’innovazione parte dalle persone. La formazione continua, la riqualificazione professionale e la valorizzazione delle competenze diventano fattori chiave per accompagnare il cambiamento e garantire che nessuno resti indietro. È necessario investire nelle persone, affinché la transizione digitale ed ecologica non si traduca in nuove disuguaglianze, ma in nuove opportunità di crescita e occupazione di qualità.
Per questo serve investire in conoscenza, aggiornamento e partecipazione, valorizzando i lavoratori e le lavoratrici che ogni giorno contribuiscono alla crescita delle nostre cooperative. La transizione sarà affrontabile solo se sapremo accompagnare tutti in questo cambiamento.
Come mondo cooperativo, abbiamo il dovere e la possibilità di guidare questa trasformazione. Abbiamo radici solide, ma anche la capacità di guardare avanti, con responsabilità e spirito di innovazione. Essere sostenibili significa proprio questo: costruire un futuro in cui economia, ambiente e società possano crescere insieme, senza lasciare indietro nessuno.
La transizione ecologica e digitale è già iniziata. Sta a noi renderla un’occasione di progresso condiviso, capace di coniugare sviluppo, solidarietà e partecipazione. Le cooperative, ancora una volta, sono pronte a fare la loro parte, mettendo al centro il lavoro, le persone e la comunità.

Fai
Carlotta Caponi
La logistica e i trasporti stanno vivendo una trasformazione senza precedenti. Digitalizzazione e intelligenza artificiale (IA) non sono più concetti astratti o riservati ai grandi gruppi internazionali: stanno diventando strumenti concreti di competitività, sostenibilità e sicurezza per tutto il comparto, inclusa la miriade di piccole e medie imprese che rappresentano l’ossatura del trasporto italiano.
Negli ultimi anni, la gestione dei flussi di merci si è fatta più complessa. L’aumento dell’e-commerce, l’instabilità geopolitica, la transizione ecologica e la carenza di personale viaggiante hanno imposto un ripensamento profondo dei processi. In questo contesto, la digitalizzazione è la chiave per rendere il sistema logistico più efficiente, trasparente e integrato.
Le nuove piattaforme digitali permettono oggi di pianificare in tempo reale i viaggi, monitorare le flotte, ridurre i tempi di carico e scarico e garantire la tracciabilità dei beni lungo l’intera filiera. Attraverso l’IA, questi dati vengono analizzati per ottimizzare i percorsi, prevedere la domanda, ridurre i consumi di carburante e limitare le emissioni. Si tratta di strumenti che non sostituiscono l’autotrasportatore, ma ne valorizzano il lavoro, liberandolo da burocrazia e inefficienze.
L’uso dell’intelligenza artificiale apre anche nuove frontiere nella sicurezza stradale. Sistemi avanzati di assistenza alla guida, sensori e algoritmi predittivi permettono di prevenire incidenti e migliorare il comfort di guida. L’IA può analizzare in tempo reale le condizioni del traffico, del meteo o dello stato del veicolo, suggerendo le migliori soluzioni per evitare rischi e ritardi.
Tuttavia, la transizione digitale non può essere lasciata al caso.
Servono investimenti, formazione e soprattutto un quadro normativo che accompagni le imprese in questo percorso. Come Federazione, la Fai è impegnata nel promuovere una cultura digitale diffusa, soste-
nendo progetti di innovazione accessibili anche alle realtà più piccole. Non possiamo permettere che la digitalizzazione diventi una barriera o un nuovo fattore di disuguaglianza nel settore.
Le risorse del PNRR e i fondi europei offrono un’occasione unica per modernizzare infrastrutture, reti e processi. Ma la vera sfida è culturale: far comprendere che l’innovazione tecnologica non è un fine in sé, bensì uno strumento per rendere il lavoro più efficiente, sicuro e sostenibile.
In un momento storico in cui il trasporto su gomma continua a rappresentare la spina dorsale della logistica italiana, l’adozione consapevole della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale può garantire al settore un futuro più competitivo, verde e umano.
Fai continuerà a lavorare affinché l’innovazione sia alla portata di tutti, perché solo un autotrasporto moderno, digitale e responsabile potrà affrontare le sfide del domani con la forza e la dignità che da sempre contraddistinguono la nostra categoria.

Fedit
Alfredo D’Ascoli
La digitalizzazione sta ridefinendo in profondità la logistica e la supply chain, trasformando i modelli operativi tradizionali: l’integrazione tra tecnologie digitali e sistemi di intelligenza artificiale rappresenta oggi uno dei principali fattori di competitività per le imprese che vogliono affrontare mercati globali.
Infatti, già da tempo, grazie alla digitalizzazione della documentazione e dei processi logistici, è possibile raccogliere, elaborare e condividere, in tempo reale, enormi quantità di dati, velocizzando lo scambio di informazioni e migliorando l’integrazione operativa dei singoli soggetti della filiera, dall’autotrasportatore al committente e così via.
Parallelamente, le tecnologie installate sui veicoli ne hanno migliorato la sicurezza, il comfort, l’efficienza e la possibilità di gestione e della relativa organizzazione dei viaggi; per mezzo della digitalizzazione, molte operazioni logistiche vengono automatizzate: dall’elaborazione degli ordini alla gestione del magazzino, fino al monitoraggio delle consegne.
L’uso di software gestionali integrati consente una visione centralizzata e aggiornata di tutta la catena di distribuzione: attraverso sistemi IoT e intelligenza artificiale, oggi, è possibile tracciare le spedizioni in ogni fase, migliorando la visibilità, la sicurezza e la gestione degli imprevisti. I clienti, inoltre, possono ricevere aggiornamenti automatici sullo stato delle consegne; ciò comporta un aumento della qualità del servizio offerto e il rafforzamento del rapporto di fiducia tra impresa e cliente.
Digitalizzare significa quindi abbattere gli sprechi: l’ottimizzazione dei percorsi riduce il consumo di carburante e la gestione intelligente dei carichi permette di sfruttare al meglio i mezzi disponibili. Tutto questo si traduce in un risparmio concreto per le aziende. L’uso dell’intelligenza artificiale nei trasporti non solo migliora l’efficienza e
la sicurezza, ma promuove anche la sostenibilità: riducendo il consumo di carburante attraverso la gestione ottimizzata dei percorsi, l’IA contribuisce a ridurre le emissioni di gas e a promuovere una mobilità più green.
La digitalizzazione e l’intelligenza artificiale sono leve strategiche per la competitività anche perché sono tra i fattori che maggiormente impattano sulla produttività delle aziende. Secondo analisi svolte da TEHA Group sulla quantificazione degli impatti dell’IA sul mercato del lavoro, per la logistica è stimato un aumento medio della produttività del 18,5% differenziato fra occupazioni manuali, impiegatizie e manageriali con un aumento del valore aggiunto di 13 miliardi di euro.
L’implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale e digitalizzazione nella logistica presenta alcune sfide: richiede importanti investimenti per le aziende in termini di infrastrutture, formazione digitale e cultura dell’innovazione per il proprio personale, implementazione di ulteriori misure di sicurezza informatica e di conformità normativa, soprattutto in ambito privacy.
Affinché questo cambiamento si traduca in un reale volano di sviluppo per le imprese occorre, ora più che mai, ragionare in termini di filiera e di collaborazione tra aziende, associazioni e istituzioni e risulterà essenziale che queste ultime accompagnino il percorso di cambiamento, offrendo alle imprese strumenti concreti per sostenere i necessari investimenti e un quadro normativo e regolatorio chiaro e stabile nel tempo.

Alessandro Peron
Nel trasporto e nella logistica la digitalizzazione non è più un’opzione, ma una necessità per restare competitivi. Velocizzare i processi, ridurre gli errori, aumentare la trasparenza e disporre di dati affidabili sono oggi elementi fondamentali per rispondere alle richieste dei clienti e per operare in un mercato sempre più complesso. Tuttavia, la tecnologia da sola non basta. A fare la differenza sono le persone, le competenze e la capacità di interpretare gli strumenti, perché il vero valore nasce da chi sa porre le domande giuste e guidare l’innovazione.
L’intelligenza artificiale sta accelerando in modo deciso questa trasformazione. Non va temuta, ma compresa con curiosità e apertura mentale. L’IA non elimina il lavoro: può diventare un alleato potente per migliorare produttività, qualità e rapidità delle attività quotidiane. Può supportare la pianificazione dei viaggi, l’analisi dei costi, la gestione documentale e la creazione di report, permettendo alle imprese di concentrarsi sulle decisioni strategiche. La paura nasce spesso dal non conoscere: per questo il primo passo è semplice e alla portata di tutti. Basta scaricare un’app di intelligenza artificiale, provarla e sperimentare. Solo toccando con mano si supera davvero il timore del nuovo.
Nel nostro settore i benefici della digitalizzazione sono concreti.
Fiap ha spinto con forza l’adozione dell’eCMR, che consente una gestione più moderna e sicura dei documenti di trasporto, riducendo tempi e inefficienze. Allo stesso modo abbiamo sostenuto l’implementazione del Rentri, convinti che la tracciabilità digitale dei rifiuti rappresenti un passo fondamentale verso la semplificazione, la legalità e la competitività delle imprese. Innovazioni di questo tipo non portano solo benefici operativi, ma costruiscono fiducia lungo tutta la filiera. Fiap crede talmente in questo percorso che, già da anni, ha introdotto nella propria struttura un project manager dedicato a supportare le aziende nell’implementazione delle soluzioni digitali. Non parliamo
solo di strumenti, ma di accompagnamento concreto: scelta delle tecnologie, avvio dei sistemi e, soprattutto, formazione del personale. Senza formazione, nessun investimento digitale porta risultati duraturi. Il nostro slogan lo ricorda con chiarezza: “Se continuiamo a fare sempre le stesse cose, non possiamo pretendere che le cose cambino”. Mai come oggi questo vale per la digitalizzazione. Il settore affronta margini stretti, nuove norme, richieste crescenti e una forte competizione internazionale. Restare fermi significa perdere terreno. Sperimentare, formarsi e innovare significa costruire il proprio futuro. Fiap vuole continuare a essere uno stimolatore di cambiamento, sostenendo gli imprenditori che scelgono di evolvere. Perché la digitalizzazione non è solo tecnologia: è mentalità, coraggio e visione.

Legacoop Produzione e Servizi
Daniele Conti
Negli ultimi anni l’Unione europea ha imboccato con decisione la strada della trasformazione digitale, mettendo al centro della propria agenda temi cruciali come la digitalizzazione dei processi, la cybersicurezza e l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale. Con normative come l’AI Act e il Digital Services Act, l’Europa non vuole solo regolare l’uso delle nuove tecnologie, ma anche costruire un modello di innovazione “a misura d’uomo”, fondato su trasparenza, etica e sostenibilità.
In questo scenario, anche le imprese cooperative sono chiamate a un salto di qualità: trasformare la loro tradizionale forza comunitaria in una leva per affrontare il cambiamento digitale in modo condiviso e inclusivo.
Nel mondo del trasporto merci, l’innovazione corre veloce anche per le imprese cooperative. Piattaforme digitali, sistemi di tracciabilità in tempo reale e soluzioni per la gestione intelligente dei flussi logistici stanno rivoluzionando il settore.
Per questo, il recente bando Login Business ha registrato una significativa partecipazione da parte delle nostre associate, rappresentando una grande opportunità per modernizzare le flotte, i processi e i modelli di collaborazione. Le cooperative e i consorzi che raggruppano le piccole e medie imprese di autotrasporto possono diventare protagoniste di questa evoluzione, unendo risorse e competenze per adottare tecnologie comuni e migliorare l’efficienza dei servizi.
L’intelligenza artificiale è già una realtà nei magazzini e sulle strade: algoritmi che prevedono la domanda, software che ottimizzano i percorsi, robot che assistono nella movimentazione delle merci e, in prospettiva, veicoli a guida autonoma che promettono di trasformare radicalmente la logistica. Per le cooperative, investire in IA significa non solo restare competitive, ma anche garantire maggiore sicurezza a
lavoratrici e lavoratori e ridurre l’impatto ambientale attraverso un uso più intelligente delle risorse.
Con la digitalizzazione, però, cresce anche l’esposizione ai rischi informatici. La cybersecurity diventa quindi un tema centrale: proteggere dati, infrastrutture e persone è essenziale per mantenere la fiducia di soci e clienti. Le cooperative possono rispondere con la loro arma migliore: la collaborazione. Creando reti di sicurezza condivise, piattaforme comuni e percorsi di formazione mirati.
Ed è proprio la formazione la chiave del futuro. Nessuna tecnologia può funzionare davvero senza competenze. Le cooperative, per la loro natura partecipativa, hanno la possibilità di costruire percorsi di crescita condivisa, capaci di rendere soci e lavoratori protagonisti consapevoli della trasformazione digitale.
Innovare, per le cooperative, non significa solo adottare nuove tecnologie, ma farlo insieme, mantenendo al centro le persone, i valori e la sostenibilità del sistema.

TrasportoUnito
Maurizio Longo
La trasformazione digitale sta ridefinendo la competitività dell’autotrasporto merci, soprattutto nel rapporto con porti e piattaforme logistiche. Oggi, oltre l’80% dei flussi di import/export italiani transita per i porti e la loro capacità di dialogare digitalmente con il trasporto su gomma incide direttamente su costi, tempi e qualità del servizio.
Nei principali scali europei, l’adozione di Port Community System evoluti ha ridotto fino al 30% i tempi di attesa dei mezzi. In Italia, dove la congestione in alcune aree portuali può generare fino a tre ore di fermo veicolo, accelerare l’interoperabilità dei sistemi significa liberare produttività e ridurre emissioni. Le piattaforme logistiche stanno introducendo prenotazione slot, gestione automatizzata: non agganciarsi a questi processi significa rischiare di rimanere esclusi dal mercato dei trasporti.
L’intelligenza artificiale porta vantaggi già misurabili: algoritmi di pianificazione riducono i viaggi a vuoto fino al 15%, mentre sistemi predittivi di manutenzione permettono alle flotte strutturate di abbattere del 20% i fermi tecnici. Le imprese di autotrasporto che hanno investito nella digitalizzazione dei processi stanno toccando con mano i benefici organizzativi ed economici.
Questa evoluzione comporta una selezione competitiva. Oggi il 40% delle flotte italiane non utilizza strumenti digitali avanzati di gestione e monitoraggio; queste imprese rischiano un progressivo isolamento, soprattutto nei rapporti con committenze industriali e logistiche che richiedono tracciabilità in tempo reale e certificazioni di sostenibilità. Al contrario, le aziende che investono diventano nodi affidabili nella filiera, ottenendo maggiore continuità dei contratti.
Il fattore critico rimane la competenza. Secondo indagini effettuate presso le imprese nostre associate, la carenza di competenze digitali interessa oltre il 50% degli operatori. Senza formazione, sensori e al-
goritmi restano scatole vuote. È necessario sostenere percorsi professionali che valorizzino l’autotrasportatore come operatore di sistema, non semplice esecutore di trasporti.
Infrastrutture e standard nazionali sono un altro pilastro. Il fallimento del progetto Uirnet, che purtroppo non ha prodotto i risultati programmati, pesa perché la frammentazione informativa che ne è conseguita ha generato inefficienze. Creare piattaforme interoperabili tra porti, interporti e imprese significa aumentare trasparenza, sicurezza e velocità di scambio dati. Il PNRR rappresenta una leva importante, ma va accompagnato da un coordinamento stabile e da una governance pubblica credibile che al momento le imprese di autotrasporto non stanno ricevendo.
La digitalizzazione non sostituisce il lavoro umano: lo rende più sicuro e produttivo, riducendo la pressione burocratica. È una sfida culturale prima che tecnologica, che selezionerà le imprese più pronte ma che può innalzare l’intero comparto.
TrasportoUnito ritiene che la programmazione degli interventi debba puntare su tre direttrici: sostenere investimenti in tecnologie interoperabili lungo l’intera catena logistica; promuovere formazione digitale continua per imprese e lavoratori; rafforzare il dialogo tra autotrasporto, porti e piattaforme logistiche, definendo standard nazionali condivisi. Solo così eviteremo la frammentazione, accompagneremo la transizione delle piccole realtà e consolideremo la competitività dei nostri operatori sui mercati internazionali.
Il futuro del trasporto merci è già digitale. Il nostro compito è governarlo affinché l’autotrasporto continui a essere competitivo e strategico per il Paese.

Unitai
Emanuela Bertoni
La digitalizzazione e l’intelligenza artificiale stanno rivoluzionando la logistica e i trasporti, ottimizzando i processi, riducendone i costi, aumentando l’efficienza e migliorando la sostenibilità.
Queste tecnologie stanno trasformando radicalmente il modo in cui operiamo: permettono, infatti, di analizzare grandi quantità di dati in tempo reale per ottimizzare le rotte, gestire le scorte, automatizzare i magazzini e monitorare le merci lungo tutta la filiera. Prima la gestione di questi processi era difficile e complessa e richiedeva l’uso di innumerevoli software per scambiare dati tra clienti, trasportatori, dogane e tutti gli attori coinvolti; oggi invece la digitalizzazione permette di velocizzare e semplificare l’intero flusso. I dati diventano facilmente intercambiabili e convertibili, massimizzando il loro valore per ogni esigenza organizzativa.
Nonostante questi evidenti benefici, i costi di implementazione continuano a rappresentare un ostacolo non indifferente per le nostre aziende. In questo contesto, l’adesione alle misure di sostegno appare cruciale. Eppure, solamente 1260 aziende hanno presentato domanda per accedere ai contributi del bando Login Business, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha messo a disposizione 157 milioni di euro di fondi PNRR per promuovere la digitalizzazione delle imprese di trasporto e logistica. Un numero decisamente più basso rispetto alle 8350 domande previste come soglia minima che ha rischiato di compromettere il proseguimento del bando e quindi l’assegnazione dei contributi.
Tuttavia, seppure in numero inferiore, i progetti presentati hanno un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro; una cifra che supera il budget previsto e che ha consentito di ottenere l’approvazione dell’Europa. Vedersi togliere i fondi assegnati direttamente dal PNRR sarebbe stato infatti un clamoroso autogol per il nostro settore.
È quindi assolutamente necessario compiere un salto culturale e fare un passo avanti deciso su questo fronte per rendere le nostre aziende più forti e capaci di affrontare i cambiamenti rapidi del mercato globale, la cui evoluzione procede a una velocità un tempo inimmaginabile. Solo abbracciando l’innovazione potremo rendere le nostre realtà più competitive, all’altezza della sfida e garantire che rimangano un punto di riferimento in un settore in costante trasformazione.
LA NUOVA ERA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA
Allegato a Tir
La rivista dell’autotrasporto Periodico del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi
COMITATO SCIENTIFICO PRESIDENTE Enrico Finocchi
DIRETTORE RESPONSABILE
Massimo De Donato dedonato@rivistatir.it
CAPO REDATTORE
Lucia Angeloni angeloni@rivistatir.it
REDATTORI
Antonella Vicini vicini@rivistatir.it Carolina D’Elia delia@rivistatir.it
GRAFICA
Marco Banci
SEGRETERIA
Giuditta Lopardo segreteria@rivistatir.it
DIREZIONE-REDAZIONE
Via C. B. Piazza, 8 - 00161 ROMA Tel. 06 69308055
CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PUBBLICITÀ
HP 10 Srl Tel 02.48.003.799 mirta.barbeschi@hp10.it
REALIZZAZIONE e STAMPA
AGE Srl
Stabilimento Via Vaccareccia, 57 00071 Pomezia (Roma)
EDITORE e PROPRIETARIO
Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi, via Giuseppe Caraci, 36 00157 Roma
Registrazione Tribunale di Roma n° 547 del 18/11/98
Finito di stampare nel mese di novembre 2025
Testi di:
Lucia Angeloni, Carolina D’Elia, Antonella Vicini


LA RIVISTA DELL’AUTOTRASPORTO
PERIODICO DEL COMITATO CENTRALE dell’ALBO NAZIONALE
DEGLI AUTOTRASPORTATORI
DI COSE PER CONTO DI TERZI Allegato a TIR
