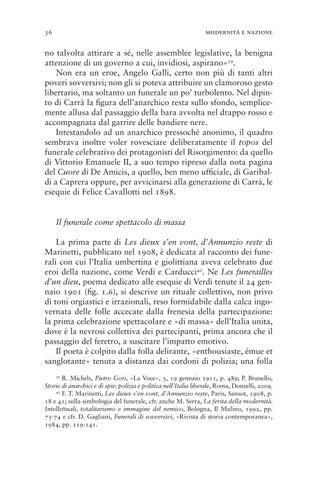modernità e nazione
36
no talvolta attirare a sé, nelle assemblee legislative, la benigna attenzione di un governo a cui, invidiosi, aspirano»39. Non era un eroe, Angelo Galli, certo non più di tanti altri poveri sovversivi; non gli si poteva attribuire un clamoroso gesto libertario, ma soltanto un funerale un po’ turbolento. Nel dipinto di Carrà la figura dell’anarchico resta sullo sfondo, semplicemente allusa dal passaggio della bara avvolta nel drappo rosso e accompagnata dal garrire delle bandiere nere. Intestandolo ad un anarchico pressoché anonimo, il quadro sembrava inoltre voler rovesciare deliberatamente il topos del funerale celebrativo dei protagonisti del Risorgimento: da quello di Vittorio Emanuele II, a suo tempo ripreso dalla nota pagina del Cuore di De Amicis, a quello, ben meno ufficiale, di Garibaldi a Caprera oppure, per avvicinarsi alla generazione di Carrà, le esequie di Felice Cavallotti nel 1898.
Il funerale come spettacolo di massa La prima parte di Les dieux s’en vont, d’Annunzio reste di Marinetti, pubblicato nel 1908, è dedicata al racconto dei funerali con cui l’Italia umbertina e giolittiana aveva celebrato due eroi della nazione, come Verdi e Carducci40. Ne Les funerailles d’un dieu, poema dedicato alle esequie di Verdi tenute il 24 gennaio 1901 (fig. 1.6), si descrive un rituale collettivo, non privo di toni orgiastici e irrazionali, reso formidabile dalla calca ingovernata delle folle accecate dalla frenesia della partecipazione: la prima celebrazione spettacolare e «di massa» dell’Italia unita, dove è la nevrosi collettiva dei partecipanti, prima ancora che il passaggio del feretro, a suscitare l’impatto emotivo. Il poeta è colpito dalla folla delirante, «enthousiaste, émue et sanglotante» tenuta a distanza dai cordoni di polizia; una folla R. Michels, Pietro Gori, «La Voce», 3, 19 gennaio 1911, p. 489; P. Brunello, Storie di anarchici e di spie: polizia e politica nell’Italia liberale, Roma, Donzelli, 2009. 40 F. T. Marinetti, Les dieux s’en vont, d’Annunzio reste, Paris, Sansot, 1908, p. 18 e 41; sulla simbologia del funerale, cfr. anche M. Serra, La ferita della modernità. Intellettuali, totalitarismo e immagine del nemico, Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 73-74 e cfr. D. Gagliani, Funerali di sovversivi, «Rivista di storia contemporanea», 1984, pp. 119-141. 39