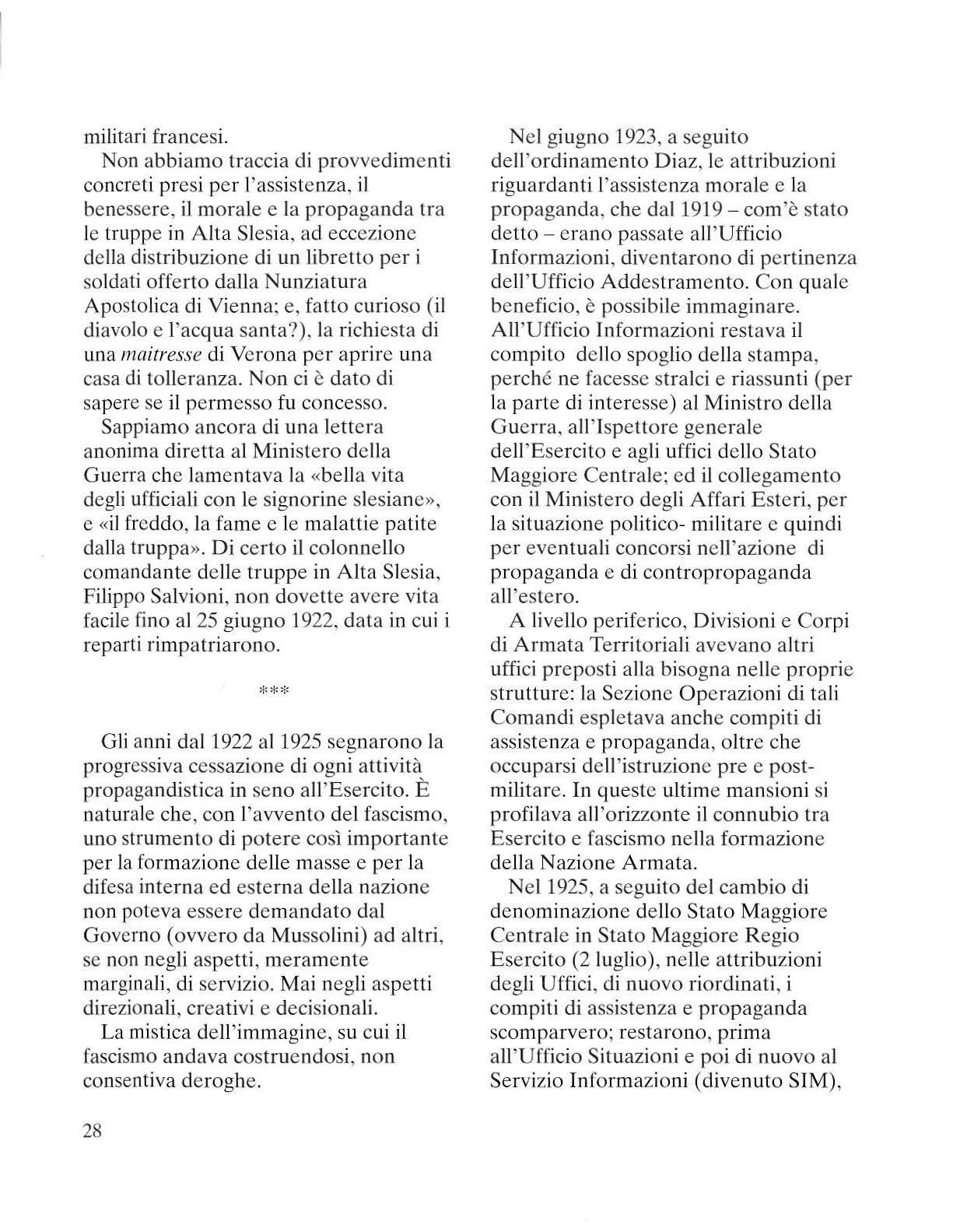
31 minute read
Capitolo II: 1925-1935
militari francesi.
Non abbiamo traccia di provvedimenti concreti presi per l'assistenza, il benessere, il morale e la propaganda tra le truppe in Alta Slesia, ad eccezione della distribuzione di un libretto per i soldati offerto dalla Nunziatura Apostolica di Vienna; e, fatto curioso (il diavolo e l'acqua santa?), la richiesta di una maitresse di Verona per aprire una casa di tolleranza. Non ci è dato di sapere se il permesso fu concesso.
Advertisement
Sappiamo ancora di una lettera anonima diretta al Ministero della Guerra che lamentava la «bella vita degli ufficiali con le signorine slesiane», c «il freddo, la fame e le malattie patite dalla truppa». Di certo il colonnello comandante delle truppe in Alta Slesia, Filippo Salvioni, non dovette avere vita facile fino al 25 giugno 1922, data in cui i reparti rimpatriarono.
Gli anni dal 1922 al1925 segnarono la progressiva cessazione di ogni attività propagandistica in seno all'Esercito. È naturale che, con l'avvento del fascismo, uno strumento di potere così importante per la formazione delle masse e per la difesa interna ed esterna della nazione non poteva essere demandato dal Governo (ovvero da Mussolini) ad altri, se non negli aspetti, meramente marginali, di servizio. Mai negli aspetti direzionali, creativi e decisionali.
La mistica dell'immagine, su cui il fascismo andava costruendosi, non consentiva deroghe.
28
Nel giugno 1923, a seguito dell'ordinamento Diaz, le attribuzioni riguardanti l'assistenza morale e la propaganda, che dal1919 - com'è stato detto - erano passate all'Ufficio Informazioni, diventarono di pertinenza de11'Ufficio Addestramento. Con quale beneficio, è possibile immaginare. All'Ufficio Informazioni restava il compito dello spoglio della stampa, perché ne facesse stralci e riassunti (per la parte di interesse) al Ministro della Guerra, ali 'Ispettore generale dell'Esercito e agli uffici dello Stato Maggiore Centrale; ed il collegamento con il Ministero degli Affari Esteri, per la situazione politico- militare c quindi per eventuali concorsi nell'azione di propaganda e di contropropaganda all'estero.
A livello periferico, Divisioni e Corpi di Armata Territoriali avevano altri uffici preposti alla bisogna nelle proprie strutture: la Sezione Operazioni di tali Comandi espletava anche compiti di assistenza e propaganda, oltre che occuparsi dell'istruzione pre c postmilitare. In queste ultime mansioni si profilava all'orizzonte il connubio tra Esercito e fascismo ne11a formazione della Nazione Armata.
Nel 1925, a seguito del cambio di denominazione dello Stato Maggiore Centrale in Stato Maggiore Regio Esercito (2 1uglio ), nelle attribuzioni degli Uffici, di nuovo riordinati, i compiti di assistenza e propaganda scomparvero; restarono, prima all'Ufficio Situazioni e poi di nuovo al Servizio Informazioni (divenuto SIM),
vaghi accenni alla recensione della stampa; all'Ufficio Storico fu destinata una generica «propaganda culturale», non meglio identificata.
T n sintesi, in un momento in cui si stabilizzava definitivamente l'avvento della dittatura (a dicembre Mussolini non fu più Presidente del Consiglio dci Ministri, ma Capo del Governo, con la facoltà di assumere in proprio più dicasteri), non era più consentito all'Esercito di produrre propaganda; allo stesso modo in cui, già qualche anno prima, gli era stata tolta la facoltà di avere ingerenze sulla stampa e di dialogare con essa. Mussolini infatti, conscio dell'importanza che i mezzi di informazione avevano in campo pubblicistico, già ne11923 aveva costituito un Ufficio Stampa che aveva posto alle sue dirette dipendenze; e che in seguito diventerà prima Sottosegretariato (1934) e poi Ministero della Stampa e Propaganda. Per essere, nel1937, definitivamente il «famigerato» MINCULPOP (Ministero della Cultura Popolare).
Prima di chiudere questa fase della storia della propaganda fra le due guerre, sembra doveroso ricordare anche perché più volte indirettamente richiamato - l'evento cruciale di tale periodo, l'avvento del fascismo, anche se non è questa la sede per una disamina storico-politica del fenomeno. Occorre comunque accennarne, per le implicazioni che ebbe sulla propaganda, al punto da cambiarne i connotati.
L'aspetto fondamentale che specificamente ci riguarda del fascismo è il consenso che esso ottenne. Anni or sono il professore Renzo De Felice sollevò un vespaio nell'affrontare il tema, in quanto le sue tesi- rimettendo in discussione una Italia che si era riscoperta e consolidata come resistente e antifascista - contrastavano la lettura storiografica ricorrente, fortemente critica e decisamente negativa del fascismo. Eppure sulle capacità politiche c tattiche dei Capi, anzi del Capo del «movimento», erano stati tutti d'accordo, esponenti della sinistra compresi.
Mussolini, in prima persona, riuscì ad attivare e a coagulare intorno a sé le masse, quelle masse che dalla storia c dal potere decisionale erano state sempre escluse: offrendo loro un'illusione vestita di realtà.
Masse composte dalla media c piccola borghesia, ma anche dal proletariato e dal sottoproletariato (mancano, nella storiografia sul fascismo, ricerche di ampio respiro e studi statistici sulle componenti sociali dei nazionalisti, dei fasci di combattimento, dei volontari fiumani, degli squadristi, dei partecipanti alla marcia su Roma, dci volontari della Milizia; c pertanto non è ancora possibile stabilire fino a che punto l'indice della «bilancia masse» sia fermo alla piccola borghesia e/o graviti decisamente verso il proletariato), schiacciate tra intellighenzia, borghesia e aristocrazia da un lato e rivoluzionarismo di sinistra dall'altro. Non bisogna, infatti, dimenticare che il contadino, il manovale, il piccolo artigiano, era escluso da ogni forma

partecipativa non solo dall'alto, ma tagliato fuori anche dal basso, dai suoi stessi simili: in alcune zone d'Italia fortemente politicizzate, ad esempio, non esisteva nessuna possibilità autonoma di lavoro e di sopravvivenza se non si era iscritti a leghe e cooperative. Senza parlare dell'isolamento in cui era tenuto il Sud. Masse che avevano vissuto gli indescrivibili orrori della guerra, che avevano superato il terrore della morte e le indicibili sofferenze della trincea solo in virtù di un atavico fatalismo c nella speranza di ottenere, qualora sopravvissute, qualche segno di gratitudine e di riconoscenza; c che invece erano state abbandonate e ancora umiliate.
Quale meraviglia se aderirono a un'idea c credettero a uomini che vendevano il «prodotto» che esse, nel loro stesso intimo, cercavano ed al quale, inconsciamente, fin allora avevano anelato?
Al punto che nel giro ·di tre anni poche decine di uomini riuscirono a serrare intorno a sé, con metodi rozzi e violenti - altra meraviglia di alcuni storici - centinaia di migliaia, milioni di uomini. Guardando a Roma, esclusivamente come fonte del bene, di cui erano alla ricerca: da prendere, a tutti i costi, con la violenza se necessano.
Il gesto eclatante, la marcia su Roma dell'ottobre 1922, non fu altro che l'acquisizione del «prodotto», sia pure se consentita - quale esplicazione mitigante - dalle incapacità, dalle

30 insipienze e dalle connivenze.
Connivenze addebitate anche ai militari. Altro dibattuto e spinoso problema. L'Esercito ebbe parte ·determinante nella marcia su Roma? E cosa avrebbe fatto se Vittorio Emanuele III avesse firmato lo stato di assedio? Interrogativi che hanno appassionato molti studiosi dell'evento: al punto tale che alcuni di essi, utilizzando ed analizzando gli stessi documenti, sono arrivati a conclusioni opposte! A dimostrazione che quando le letture critiche delle fonti diventano strumentali, si finisce con l'invalidarle. Eppure la storia dovrebbe leggere solo i fatti, e dall'analisi di essi trarre obiettive considerazioni. Nel nostro caso, riteniamo che esse si possano così riassumere: molti militari, capi e gregari, aderirono al fascismo e alle sue manifestazioni. Un'adesione il più delle volte nata per l'atteggiamento fortemente denigratorio - è stato già detto - che partiti politici c stampa assunsero nei confronti dell'Esercito. Altri, tennero a precisare la loro posizione: per il giuramento di fedeltà prestato alla monarchia, non avrebbero consentito azioni violente contro di essa, o sovvcrtimenti dell'autorità legalmente costituita.
Moltissimi ancora - la maggior partenon ebbero atteggiamenti decisi, anche se occasionalmente espressero il loro consenso di massima al fascismo. Una possibile lettura scaturisce proprio dalle considerazioni esposte: consenso, ma non partecipazione, almeno della maggioranza. E se è vero che le
rivoluzioni si possono vincere con l'entusiasmo o con il consenso di un esercito, è altrettanto vero che difficilmente esse si vincono contro un esercito, specialmente in momenti in cui esso è particolarmente agguerrito per gli efficaci addestramenti e per le esperienze maturate sui campi di battaglia; così come era l'Esercito italiano al termine della grande guerra.
Né, infine, ci aiuta a scoprire cosa avrebbe fatto l'Esercito, qualora avesse avuto l'ordine di aprire il fuoco, la documentazione ufficiale: nessuna relazione è più asettica delle memorie storiche del Corpo d'Armata di Roma, interessato all'avvenimento, che per curiosità riportiamo alla lettera:
«Nel mese di ottobre, si svolge progressivamente un vasto e complesso movimento fascista che porta alla caduta del Governo Facta ed alla successiva instaurazione del Governo Mussolini.
Nella giornata dei 27 ottobre fu indetta dal Partito Nazion"ale Fascista la mobilitazione di propri squadristi allo scopo di assumere il Governo dello Stato. Successivamente anche il Partito Nazionalista ordinò la mobilitazione delle camicie azzurre.
Nella nolfe sul28 s'iniziarono i movimenti di trasferimento alle vicinanze di Roma e gli squadristi si concentrarono nei giorni 28 e 29 nelle località adiacenti a Roma.
Il29 si formò il nuovo Ministero ed il 30 i fascisti ed i nazionalisti- circa 60.000 - entrarono a Roma.
Durante il periodo del movimento fascista si verificarono vari incidenti; notevoli, per quanto riguarda l'Esercito, quelli dell'asportaz ione di armi nelle Caserme di Siena-Spoleto-PerugiaOrvieto- restituite poi successivamente.
N ei primi giorni di Novembre hanno luogo in Roma numerose manifestazioni patriottiche organizzate dai fascisti quali una importante sfilata di camicie nere ed azzurre davanti al Quirinale alla presenza di S.M. ii Re e L'omaggio solenne reso alla tomba del Milite Ignoto da parte di tutti i membri del nuovo Governo».

1925 1935 Nel decennio • 1925-1935la propaganda divenne linfa esclusiva e vitale del regime.
Lo studio e l 'analisi di tale periodo sono importanti, e complessi allo stesso tempo, poiché toccano da vicino i rapporti- non sempre facili - tra Esercito e fascismo.
Sul passaggio di mano della propaganda, sulla via in cui si incamminò, sul suo sviluppo, furono determinanti la costituzione dell'Ufficio Stampa del Capo del Governo nel1923, la legge per l'Organizzazione della Nazione per la Guerra (n. 969 dell'8 giugno 1925), i continui riordinamenti dell'Esercito c dei suoi organi centrali.
Dell'Ufficio Stampa si è già fatto cenno; Mussolini ben conosceva il ruolo c l'importanza che la stampa aveva nella manipolazione dell'informazione, e quindi sulle masse; nato giornalista, continuò ad esserlo fino alla caduta. Non avrebbe mai potuto fare a meno di uno strumento che possedeva una presa così immediata e un palese potere di credibilità sulle masse, inimmaginabile e non paragonabile neanche lontanamente a quello di oggi. Le notizie sui giornali erano vangelo specialmente quando i giornali, a colpi di «direttive», diventarono sempre più simili l'un l'altro nella veste e nei contenuti -: pochi i lettori disincantati e gli spiriti critici che riuscivano a cogliere le verità omesse, distorte o celate dentro e dietro le notizie (ancora non molti anni fa era luogo comune sentir dire «è scritto sul giornale», quasi con

32 religiosità).
Per evitare interferenze, nell926 fu soppresso l'analogo ufficio del Ministero degli Esteri, che entrò a far parte dell'Ufficio Stampa come sezione estera. Fu così eliminata ogni possibilità di divergenza fra i due Gabinetti (Presidenza ed Esteri). Gli ambienti giornalistici degli Esteri mal accettarono il provvedimento, per la perdita di autonomia e per la scarsa considerazione che avevano dei giornalisti «disoccupati e fuori ruolo» in servizio presso l'Ufficio Stampa.
E tale fu l 'importanza di comunicare, di colloquiare direttamente con le masse per il capo del Governo, che ben presto egli si appropriò anche del nuovo mezzo tecnico, che gli avrebbe consentito di stabilire un contatto ancora più immediato dei giornali, di penetrare personalmente nelle case degli italiani, in presa diretta: la radio.
Con l'avvento dellUfficio Stampa i militari finirono per perdere l'utilizzazione di quello strumento pubblicistico che aveva loro consentito di orientare le opinioni durante la guerra; già a partire dal l919 la loro ingerenza sulla stampa fu di irrilevante efficacia. Tolte le interviste delle grosse personalità, alcuni interventi essenzialmente tecnici più che di opinione, accorate difese sempre suscettibili di critiche perché troppo spesso personali o personalizzate, l'informazione e il pensiero militare non ebbero più a disposizione la carta stampata per sostenere il proprio operato, né tantomeno ad essi furono
lasciati spazi. Le grandi firme del giornalismo di guerra, come Ojetti, Civinini, Simoni, che pure avevano prestato la loro opera a favore del Comando Supremo, con una certa disinvoltura mutarono rotta, restando gli artefici del giornalismo durante il fascismo; i giovani cronisti, relegati a collaborare con fogli e giornaletti di secondaria importanza, riuscirono a sfondare soltanto quando furono presi sotto l'ala protettrice c mecenatica delle grandi firme.
Ai militari fu consentito di avere alcuni fogli c pubblicazioni con contenuti tecnici, che peraltro avevano tiratura, diffusione e circolazione limitata. Gli argomenti affrontati non ebbero più riscontri diretti sulla realtà, eccezione fatta -e non sempre -per i dibattiti su problemi di natura squisitamente dottrinale. In pratica, nell'operazione di accentramento presso l'Ufficio Stampa di tutta la pubblicistica, anche quella di politica militare ricadde sotto l'egida dell'Ufficio, c agli Stati Maggiori fu permesso solo il controllo delle riviste specialistiche; nonostante che la Commissione Difesa, nel 1924, parlando di tutela del patrimonio morale, avesse incaricato gli Stati Maggiori e il Ministro dell'Interno di concordare una idonea legislazione sulla stampa, al fine di tutelare nel Paese il più profondo senso di disciplina e ogni azione idonea a sostenere i due fronti, quello di guerra e quello interno.
Non a caso alcuni periodici, palestra di dibattito e di formazione anche politico e culturale dell'ufficialità, furono soppresse. «A lere Flammam», edita dalla Scuola di Guerra, iniziò le pubblicazioni nel 1923 e chiuse i battenti tre anni dopo, nel1926. La «Rivista Militare», che dal 1856 al1918 aveva dato notevole apporto al progresso degli studi militari e una preziosa testimonianza di idee, dopo aver ripreso le pubblicazioni nel 1927 le interruppe nel1933, per l'impossibilità dei collaboratori di esprimere un pensiero autonomo. La decisione di sopprimere la rivista fu firmata dal sottosegretario alla Guerra, generale Baistrocchi; in sua sostituzione fu pubblicata, c curata direttamente dal Dicastero militare, la «Rivista di Fanteria». L' «Esercito Italiano», periodico trisettimanalc, subentrato nel 1880 a «Esercito» e divenuto nell923 «Esercito e iV!arina», ebbe vita fino a11926.
Chiusero anche «Rassegna dell'Esercito Italiano» (1925) diretta da Eugenio Barbarich, la «Cooperazione delle A rmi» (1926) delle Scuole Centrali Militari, il «Bollettino dell'Ufficio Storico» (1934), dello stesso Ufficio Storico.
Accrebbero, per contro, le riviste tecniche nel biennio 1934-1935 («Rivista dei Carabinieri Reali», «Rivista giuridica delle Forze Armate», «Bollettino dell'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio», «Rivista dei Servizi di Commissariato e Amministrazione»).
Un ruolo politico-militare, dopo l'esperimento di «L 'Italia in grigioverde» (1929-1934), fu tenuto da «Esercito e Nazione», fondata nel 1926
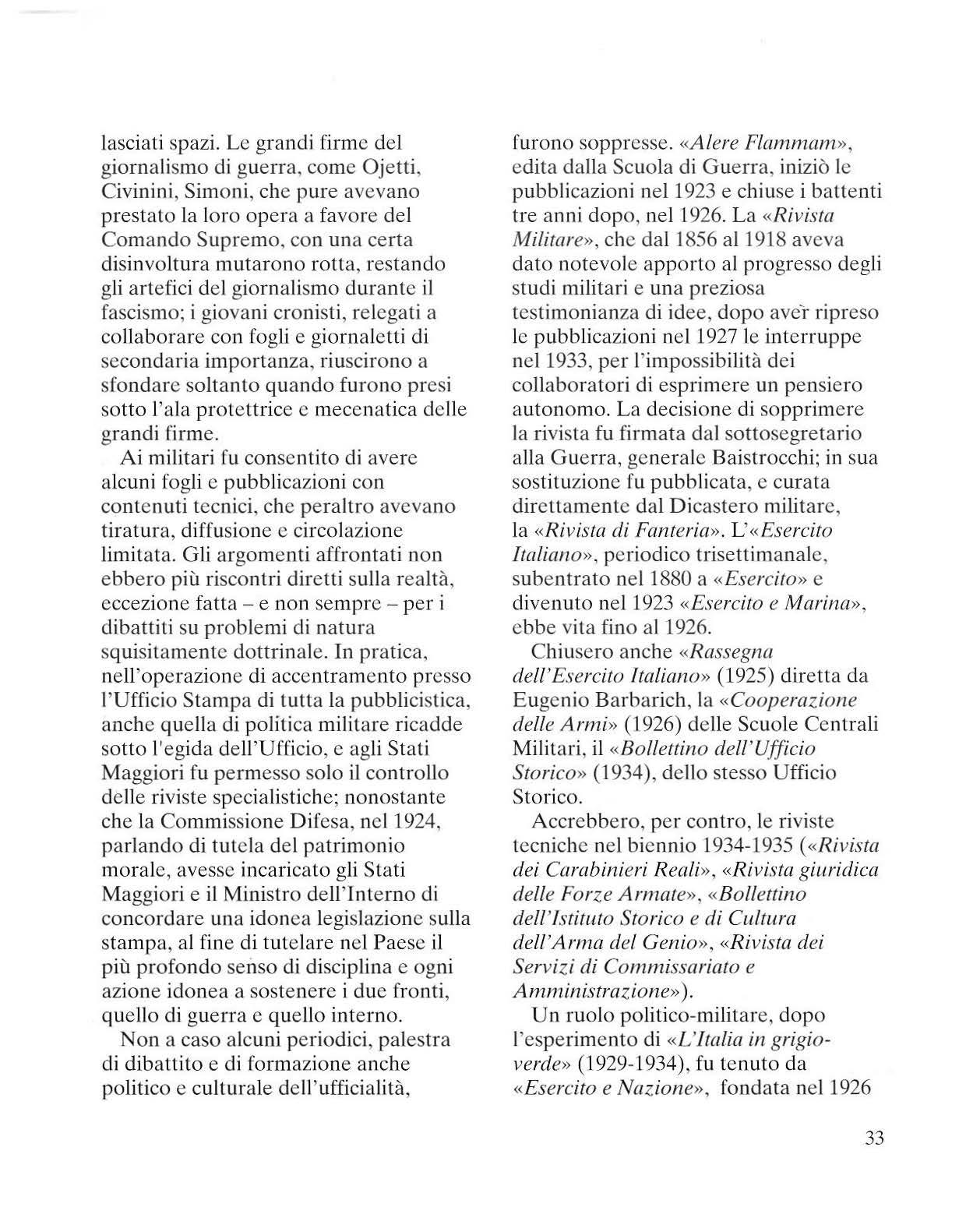
ed edita dal Ministero della Guerra; essa, ncll935, mutò la denominazione della testata in << Nazione Militare», quasi a sottolineare il passaggio del compito della difesa, non più prerogativa dell'Esercito, ma dell'intera nazione organizzata. La rivista finì presto per essere uno strumento di propaganda del Regime, e cessò le pubblicazioni con esso; anche se durante il percorso non mancò di agitare colpi di coda (nel dicembre·1937 entrò in aperta polemica con «Regime Fascista», che la accusava di dedicare poco spazio alla guerra di Spagna e a quella cinogiapponese). Anche il bisettimanale «L e Forze Armate», nato con intenti propagandistici nel 1926, chiuse con la caduta del fascismo. Umoristica la precisazione contenuta in una circolare del 1933, firmata da Baistrocchi, che mentre da un lato esortava gli ufficiali alla collaborazione con il giornale, dall'altro precisava che essa doveva consistere «nella obiettiva esposizione del proprio pensiero vincolata, è ovvio, dalla voluta disciplina formale e sostanziale». Un pasticcio di parole, perché fosse ben chiaro che nessuno poteva esprimere idee contrarie al «pensiero ufficiale».
In definitiva l'Esercito, oltre a perdere la stampa come strumento di informazione, di comunicazione, di circolazione di idee, fu costretto anche a subirla come mezzo di penetrazione dell'idea fascista, nel processo più ampio eli «fascistizzazione» totale che dovette patire e eli cui il più accanito promotore fu sempre il Baistrocchi,

34 coadiuvato da capi militari via via più accondiscendenti. Le circolari da lui emanate, relative alla pubblicistica, sono altamente chiarificatrici e istruttive in merito. Volle che gli ufficiali progredissero «fascisticamentc» seguendo l'evoluzione del pensiero militare - quale, l'abbiamo già accennato - sulle riviste militari; che leggessero «lvfilizia Fascista» , «brillante periodico» che «simpaticamente e con passione» si era adoperato a rinsaldare i vincoli camerateschi tra Esercito e Milizia; che fosse diffuso tra i militari «Il Contro A ereo», con l'auspicio di collaborazioni secondo i noti criteri. Baistrocchi sollecitò, ancora, la lettura delle opere più disparate, dalle «Memorie». del Maresciallo Joffre, sempre per «l'auspicata mentalità (fascista) tipicamente guerriera», alle «Manifestazioni agricole del Decennale» (?);dal «Davanti a San Martino del Carso con la Brigata Pisa», «stimolante» per l'emulazione che avrebbe suscitato nei giovani ufficiali, a «La Nuova Italia d'oltremare», campione di «conto morale» dell'azione svolta dal Regime nelle colonie durante il primo decennio di vita. Pubblicazioni ben diverse dalla citata «Rivista Militare» e dai pur modesti c ingenui «Tricolore» e «Tesoretto», che negli anni venti venivano acquistati per la truppa, con funzioni educative, inizialmente con i fondi del Ministero ed in seguito con gli utili degli spacci cooperativi. Gli ultimi, rarissimi tentativi di esprimere un pensiero autonomo, in contrasto con le direttive ufficiali, avvennero nel 1934.
È pur vero che, a partire da11935, molta parte dell'ufficialità fu impegnata in ben altre attività, quali la guerra italaetiopica e la campagna di Spagna: «impegni» che lasciarono scarsi spazi alle accademiche discussioni teoriche, dottrinarie e letterarie, e agli esercizi di penna. Al più, consentirono ad alcuni di produrre agiografiche opere, di dubbio valore «ammaestrativo», derivanti dalle esperienze delle campagne.
L'opera di penetrazione messa in atto dal Baistrocchi non si limitò, ovviamente, ai suggerimenti di edificanti letture. Lo stillicidio di direttive e di circolari, emanate in un brevissimo arco di tempo, restano a testimonianza del suo frenetico impegno promozionale a favore dell'idea fascista: basta esaminarne un campionario, valutarne gli oggetti e compendiarne i testi. «Massime di S.E. il Capo del Governo»: il pensiero del Duce è sempre chiaro, preciso, incisivo, e.non è possibile fraintenderlo; «Cameratismo militare» : fraternizzare fascisticamente è alla base di un sano cameratismo; «Circoli militari»: esplicare «azione fascista» anche nei circoli per farne centri di propaganda militare c guerriera; «Conferenze sullo Stato Fascista»: la parola di uomini del Regime è determinante per una maggiore consapevolezza e partecipazione; «Canti corali»: l'inno «Giovinezza» è base di ogni canto in marcia (attenzione, però, quando si canta la «Leggenda del Piave>> bisogna sostituire, nella seconda strofa, «tradimento» con << fosco evento» e «Onta consumata a Caporetto» con «poiché il nemico irruppe a Caporctto ); «Stile militare-fascista»: chi parla c scrive trova il suo vangelo nella parola del Duce, incisiva c vibrante; «Discorso del Duce a Cuneo»: un programma di vita da tenere sempre presente, illuminante per i Quadri; «Addestramento sportivo nell'Esercito»: la gioventù di Mussolini non deve generare campioni, ma plasmare guerrieri in modo omogeneo, in massa; «Simboli»: il ritratto del Duce, la parola del Duce, il saluto alla voce, sono segni imprescindibili e insostituibili dell'animo fascista.
Un bombardamento continuo, che ben si addice al progetto di Stato fascista e airorganizzazione della Nazione per la guerra, di cui l'Esercito doveva rappresentare l'apice. Forse fu proprio questo obiettivo a tradire Baistrocchi, fino a farne il vertice istituzionale c allo stesso tempo il capro espiatorio della sua fascistizzazione. Ricordiamo, tuttavia, per imparzi.alità, che molte delle benefiche innovazioni dello strumento militare furono dovute a lui.
Nei rapporti fra Esercito c Fascismo ebbe peso determinante la legge sull'organizzazione della Nazione per la guerra, che faceva tesoro delle esperienze tratte dalla grande guerra e fissava le norme per mettere lo Stato in condizione di affrontare e superare l 'inevitabile momento di crisi, all'atto della mobilitazione generale. Una legge importante per la preparazione del Paese al conflitto, e per il potenziamento delle Forze Armate, che però finì con l'essere svuotata di ogni
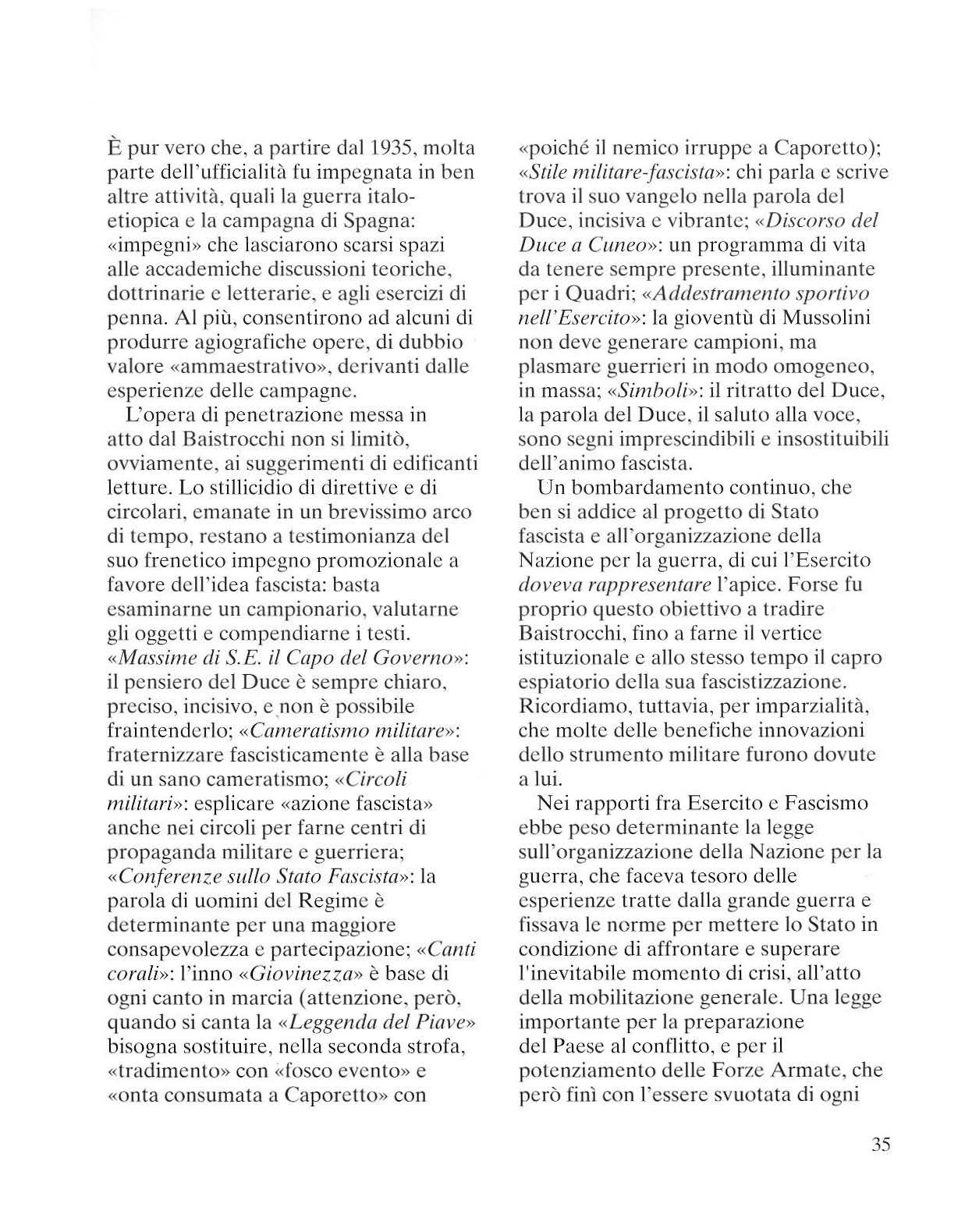
efficacia e svilita di fronte all'imprevisto sviluppo degli eventi c alle necessità contingenti, di natura soprattutto finanziaria.
La mobilitazione nazionale, cui la legge guardava, era nel suo complesso costituita dalla mobilitazione militare e da quella civile. La mobilitazione civile era quella che rientrava nelle espresse finalità legislative, e fu attuata con l'istituzione di una serie di organi (posti alle dipendenze dei Dicasteri rispettivamente competenti, e sottoposti, per la coordinazione, alla Commissione Suprema di Difesa), aventi l'incarico di: importare le materie prime, occuparsi delle fabbricazioni di guerra, assicurare l'alimentazione, fare opera di propaganda e di assistenza civile.
Comitati regionali e sottocomitati avrebbero assunto la direzione di tutte le attività civili mobilitate, nei limiti della propria giurisdizione territoriale.
Nel 1927 la Commissione Suprema di Difesa si occupò per la prima volta dell'Organo di propaganda e assistenza civile, tracciando quelle che sarebbero state, in caso di mobilitazione, le linee di azione. Dispose che i compiti dovevano essere suddivisi tra il Ministero degli Esteri (Propaganda all'estero) e il Ministero degli Lnterni (Propaganda all'interno ed assistenza civile); quest'ultimo si sarebbe avvalso, oltre che dei suoi uffici, del!' ausilio dell'Associazione Nazionale Mutilati.
I due Dicasteri dovevano operare in stretto contatto, al fine di ottenere unità di indirizzo e di lavoro.

36
La lettura del verbale presentato nell'anno successivo - nel1927 nulla di concreto fu fatto - ci fa comprendere, fra l'altro, come fossero vaghe le idee in materia di ideaz:ionc e organizzazione della propaganda. Le seriose considerazioni generali, di introduzione all'argomento, già di per se stesse partivano da alcuni presupposti superflui, scontati e, senza volerlo essere, umoristici. La propaganda e l'assistenza nella grande guerra - diceva la relazione - erano state condotte male, affidate ad una pletora di enti e comitati, e avevano prodotto un'infinità di inconvenienti, che neanche la tardiva istituzione del Commissariato Generale per l'assistenza civile e la propaganda interna (febbraio 19l8) era riuscito ad eliminare. Senza un preordinato indirizzo, si era verificata una dispersione di mezzi c di energie, e soprattutto una disparità di interventi e di trattamenti, che avevano finito con il provocare danni.
Fin qui si potrebbe essere d'accordo. È, però, soltanto retorica l'affermazione che «molti dei sistemi che si ravvisarono indispensabili durante la guerra, non appaiono più utili; giacché quel che riguarda t obiettivo sostanziale della propaganda, tendente a richiamare i cittadini a stringersi in un sol partito per la salvezza della Patria, è ora insito e persistente nella stessa anima nazionale, scevra ormai da tutte le passioni di parte, per sempre sepolte».
In sintesi, dopo tutte le belle parole sulla necessità di avere un organo di propaganda ed una direzione
centralizzata per attuarla, si affermava che non era necessario produrne, in quanto i cittadini non ne avevano bisogno, essendo nell'intimo già profondamente motivati e persuasi: la forza e lo spirito nuovo che palpitavano dovunque, erano garanzie sufficienti perché, al momento opportuno, la macchina si mettesse in moto da sola per automatismi congeniti.
Né c'era bisogno- almeno per il momento - di prevedere l'organizzazione dei vari Comitati e Sottocomitati, postulati dalla legge per l'assistenza ai civili. Prefetti c autorità locali avrebbero avuto il maggior onere prima e dopo l'eventuale conflitto, poiché i Comitati c Sottocomitati non avrebbero potuto che vivere per il contenuto periodo guerreggiato. Si poteva, quindi, attendere.
Della propaganda e dell'assistenza avrebbero dovuto occuparsi, naturalmente, uomini «genialissimi» - nessun accennò alla preparazione professionale eli tali tec n i. ci- e l'Associazione Nazionale Mutilati, che annoverava nelle sue fi le «coloro che hanno già impresso nella carne i segni della gloria» c pertanto «elementi formidabili di propaganda morale delle masse». Vi avrebbero, inoltre, concorso Province e Comuni (pagamento eli sussidi, richieste di notizie, ricerche di lavoro), e gli altri Enti che avevano già insiti, nei propri compiti, quelli di assistenza, come l'Opera Nazionale Invalidi eli Guerra, il Comitato Nazionale Orfani di Guerra, la Croce Rossa, l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, l'Opera Nazionale Dopolavoro, le organizzazioni sindacali c giovanili, ecc.
La relazione, dopo aver riconosciuto nella premessa la necessità eli una organizzazione, concludeva, ancora una volta, affermando che di essa non c'era alcun bisogno, che la Patria era già sufficientemente organizzata, sia per il periodo di pace sia per quello di guerra, sia per l'assistenza ai civili, sia ai militari; riconosceva al tempo stesso, contraddicendosi ulteriormente, che persisteva in materia quel carattere di frammentarietà - che sarebbe stato meglio definire di improvvisazione-che aveva prodotto danni in passato: era pertanto indispensabile ottenere, in caso di guerra, un coordinamento delle varie forme di assistenza per avere risultati armonici nel campo dell'assistenza c della propaganda militare e civile. Ma, la relazione non diceva come. Niente di più sconclusionato poteva essere scritto.
Nessuna proposta seria veniva avanzata, né si metteva allo studio alcun progetto. Le conclusioni riportavano la bozza generica di uno schema dell'Organo di propaganda all'interno ed assistenza civile in caso di guerra, che si prefigurava articolato in una Direzione dell'Organo - con Segreteria, Ufficio di Coordinamento, Servizio di Propaganda all'interno, Servizio dell'assistenza civile, Servizio lspettivo e di Controllo - e che tracciava i lineamenti dei tre servizi (propaganda, assistenza e ispettivo ), come di seguito riportato:
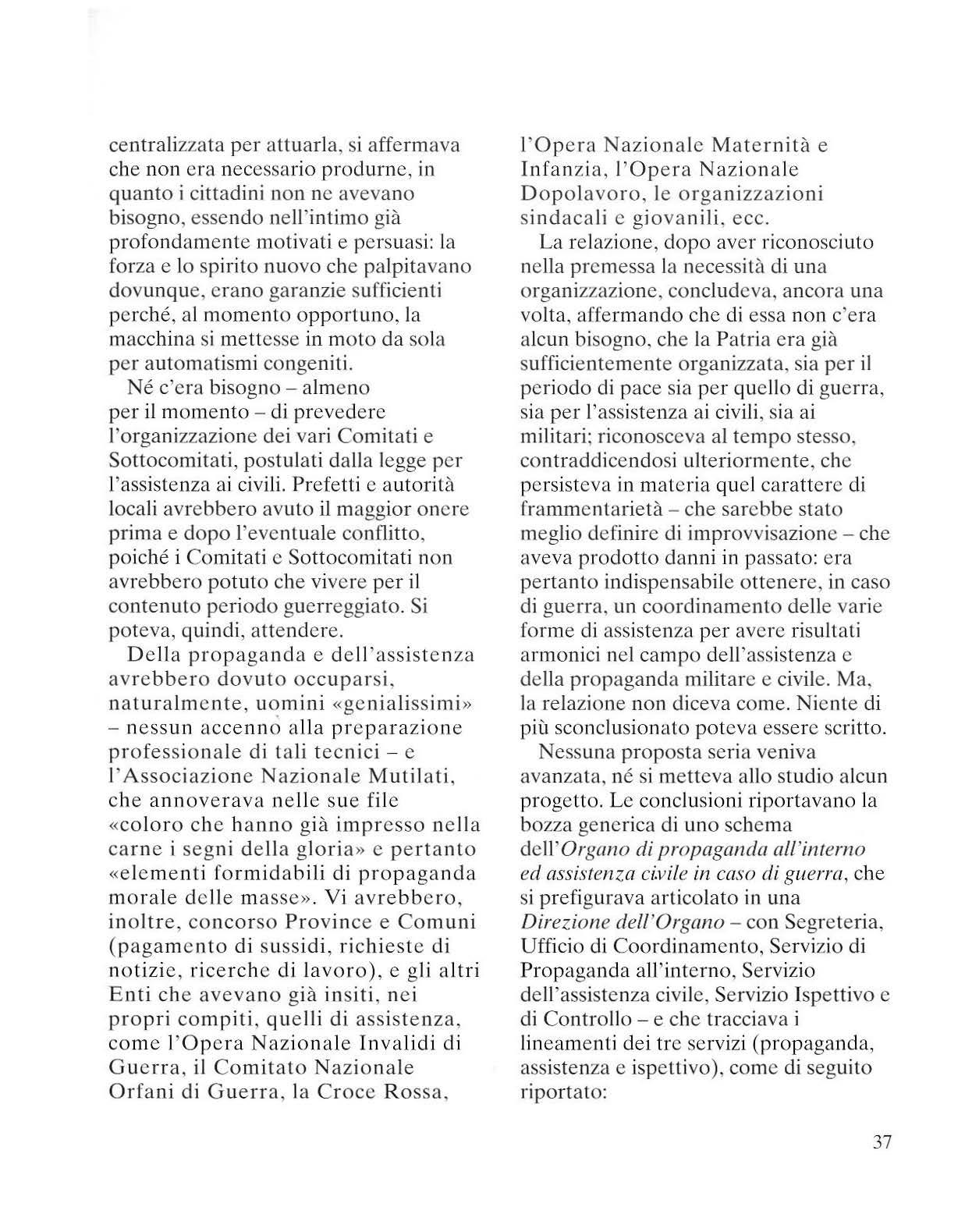
-Servizio della propaganda all'interno.
Costituito da: Direzione del Servizio; Segreteria della Direzione Propaganda; Ufficio Conferenze di Propaganda; Ufficio Informazioni (stato di animo della popolazione); Ufficio Stampa (diffusione notizie e comunicati). -Servizio dell'assistenza civile.
Costituito da: Direzione del Servizio; Segreteria della Direzione Assistenza; Ufficio per l'Assistenza alle famiglie dei combattenti; Ufficio per l'Assistenza degli emigrati rimpatriati; Ufficio per la sistemazione dei minorati di guerra; Ufficio per la sistemazione delle pensioni di guerra. - Servizio Ispettivo e di Controllo.
Costituito da: Direzione del servizio ispettivo di controllo, avente a disposizione un congruo numero di ispettori -entità commisurata alla ripartizione compartimentale regionale del Regno -con sede presso la Direzione dell'organo, e comandati presso i dipendenti organici periferici per ispezione e controllo dell'andamento della propaganda e del funzionamento reale delle opere assistenziali, in relazione alle disposizioni impartite dagli Uffici centrali.
La Commissione Suprema di Difesa, nell'esaminare la relazione, accettò la schematizzazione proposta dal Comitato per la Mobilitazione Civile, suggerendo però di tener presente la proposta avanzata da Turati sul contributo che potevano dare i Fasci femminili nell'opera di assistenza.
Per la propaganda all'estero venivano

38 ribadite le linee direttive del servizio, affidato al Ministero degli Affari Esteri, attraverso il Corpo diplomatico consolare e i Fasci dell'estero. La realizzazione di ogni programma c di ogni attività era lasciata alla completa discrezione degli Esteri.
Nella stessa seduta, il Comitato si occupò anche del servizio di propaganda da sviluppare nel progetto di difesa passiva controacrea del territorio nazionale. Il servizio doveva proporsi di: preparare moralmente la Nazione ad affrontare «con animo virile» il periodo dell'offesa aerea; convincere la collettività sulla necessità di predisporre le difese comuni cd individuali; diffondere tra la popolazione le nozioni più elementari sulle possibilità offensive degli aerei; divulgare i mezzi della difesa passiva.
Il Ministero dell'lnterno doveva costituire la Direzione del servizio, propagandando e coordinando tutta l'attività all'interno del Paese; organi esecutivi erano i Ministeri, gli Enti pubblici, il Partito Nazionale Fascista, le scuole, la stampa, le associazioni varie, le direzioni degli stabilimenti industriali, le case cinematografiche, le parrocchie. l mezzi di propaganda per la formazione della «coscienza controaerea» erano i corsi d'istruzione e gli esperimenti pratici (obbligatori per sanitari, vigili del fuoco, agenti dell'ordine, enti di pubblica assistenza), le conferenze pubbliche illustrative, le proiezioni cinematografiche, gli opuscoli speciali, gli articoli di giornali e riviste, i manifesti ecc.
Nel1930 l'Organo Centrale l ntcrministcriale per la Protezione Antiaerea, creato ad hoc e posto alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno, grazie all'azione svolta, fra mille difficoltà, dal generale Alfredo Giannuzzi Savelli, riuscì ad avviare una capillare opera di propaganda. Nel1932 esso diventò Comitato e fu posto alle dipendenze del Ministero della Guerra. Le continue difficoltà finanziarie, nelle quali trovò a dibattersi, indussero il Savelli a proporre l'istituzione di una lega nazionale della protezione antiaerea. La proposta restò inascoltata fino al1934, anno in cui, sempre il Savelli, riuscì a far riconoscere giuridicamente l'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.PA.), sorta nel frattempo a Milano come associazione privata.
L'U.N.P.A. fu un'occasione mancata; pur prodigandosi nella preparazione della Nazione all'offesa aerea, fu costretta alla sopràvvivenza per la scarsa lungimiranza di politici e militari, mentre all'estero analoghe organizzazioni furono sostenute con dovizia di uomini, mezzi e danari.
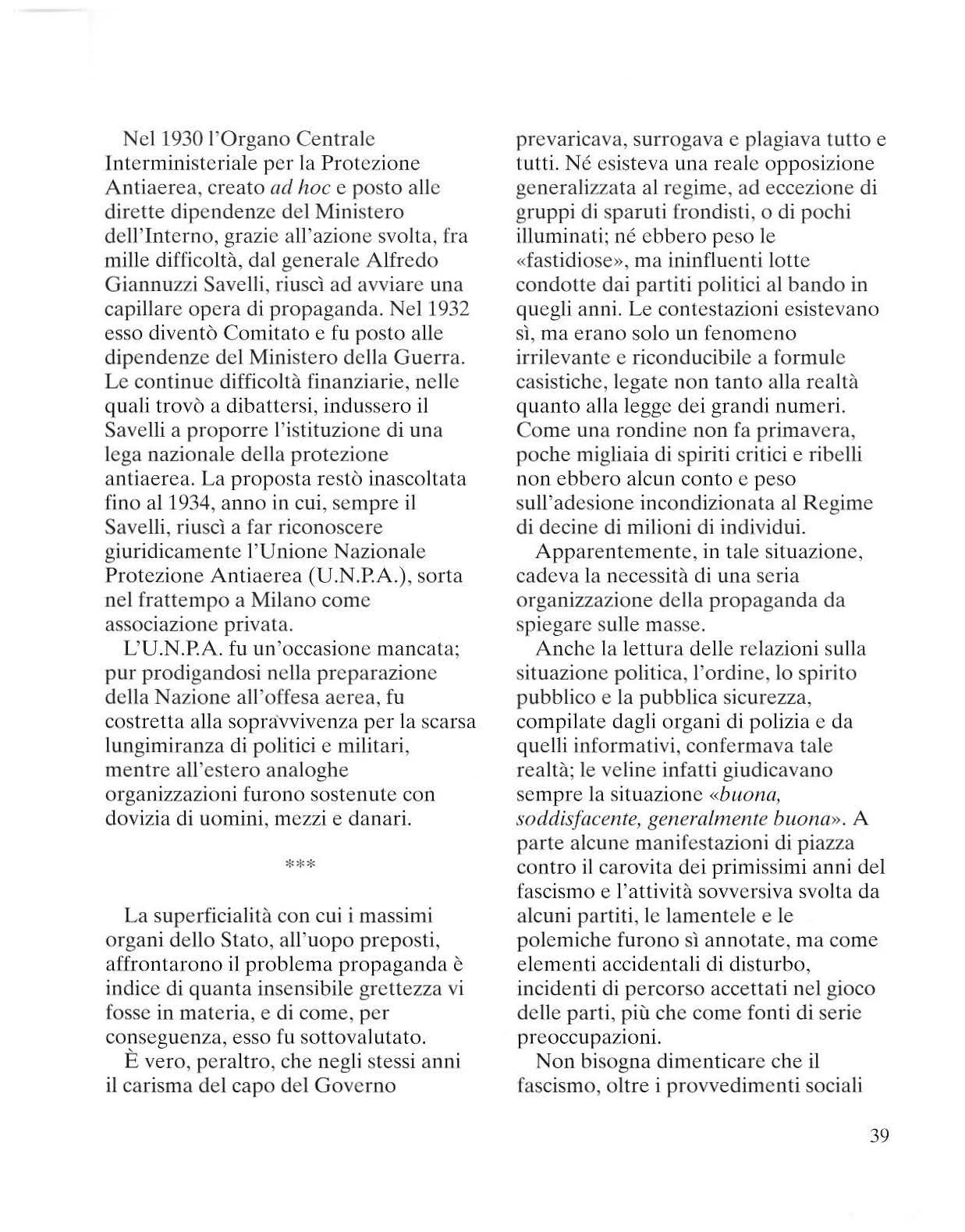
La superficialità con cui i massimi organi dello Stato, ali 'uopo preposti, affrontarono il problema propaganda è indice di quanta insensibile grettezza vi fosse in materia, e di come, per conseguenza, esso fu sottovalutato.
È vero, peraltro, che negli stessi anni il carisma del capo del Governo prevaricava, surrogava e plagiava tutto e tutti. Né esisteva una reale opposizione generalizzata al regime, ad eccezione di gruppi di sparuti frondisti, o di pochi illuminati; né ebbero peso le «fastidiose», ma ininfluenti lotte condotte dai partiti politici al bando in quegli anni. Le contestazioni esistevano sì, ma erano solo un fenomeno irrilevante e riconducibile a formule casistiche, legate non tanto alla realtà quanto alla legge dei grandi numeri. Come una rondine non fa primavera, poche migliaia di spiriti critici e ribelli non ebbero alcun conto e peso sull'adesione incondizionata al Regime di decine di milioni di individui.
Apparentemente, in tale situazione, cadeva la necessità di una seria organizzazione della propaganda da spiegare sulle masse.
Anche la lettura delle relazioni sulla situazione politica, l'ordine, lo spirito pubblico e la pubblica sicurezza, compilate dagli organi di polizia e da quelli informativi, confermava tale realtà; le veline infatti giudicavano sempre la situazione «buona) soddisfacente) generalmente buona». A parte alcune manirestazioni di piazza contro il carovita dei primissimi anni del fascismo e l'attività sovversiva svolta da alcuni partiti, le lamentele e le polemiche furono sì annotate, ma come elementi accidentali di disturbo, incidenti di percorso accettati nel gioco delle parti, più che come fonti di serie preoccupazioni.
Non bisogna dimenticare che il fascismo, oltre i provvedimenti sociali
39
concreti- quali le mutue- e la realizzazione di grandi opere pubbliche - come quelle di bonifica -che incontrarono i favori delle masse, mise in atto tutta una politica di irreggimentazione e di acculturazione che si protrasse nel tempo e i cui frutti alla vista di tutti - furono colti fino alla seconda guerra mondiale.
Una politica intelligente, almeno nei propositi, che partiva dalla formazione del cittadino, considerato una tahula rasa tutta da incidere.
Già nel1923, infatti, con la sanzione da parte della Commissione Difesa del principio che gli studi scolastici dovessero essere coordinati ed adeguati alle necessità della Difesa, si iniziava il cammino «mentale» dell'allievo cittadino verso la Nazione Armata di stampo fascista.
Il sintetico concetto di base, secondo il quale ciascuno doveva concorrere con tutte le proprie energie, non solo fisiche ma anche intellettuali, alla difesa del Paese, ne presupponeva un secondo: che il cittadino, come soldato, doveva procurarsi in anticipo tutte le cognizioni necessarie per assolvere, in futuro, il proprio mandato nel miglior modo possibile. Su tale connubio insisteva quindi la necessità di introdurre nella scuola di ogni ordine e grado, e nelle Università, determinate materie attinenti la militarità: balistica, radiotelegrafia, chimica eli guerra, topografia, aerodinamica ecc.
Per evitare dispersioni di forze, inoltre, fu predisposto il coordinamento degli esperimenti scientifici nelle

40
industrie e nelle Università.
Nel 1925, in aderenza con i postulati eli principio, furono istituite, presso gli Istituti di Ingegneria e le Università, scuole specifiche di perfezionamento, corsi di storia militare e di cultura militare tecnico-scientifica. Nella programmazione della preparazione culturale del Paese, fu data priorità alle Università, per evitare che i giovani più avanti negli studi e più aperti a recepire ideologie «fuorvianti» sfuggissero ali 'indirizzo che si intendeva dare loro.
Fu, però, proprio a livello universitario che alle intenzioni non fecero seguito i risultati. Eccettuati quelli di storia militare, il rendiconto dei corsi fu scarno per partecipazione e rendimento, per cui la Commissione Difesa progettò eli inserire obbligatoriamente le materie di attinenza militare nei normali corsi universitari. Il fallimento parziale del programma fu dovuto al fatto che i corsi non erano obbligatori e valutativi, costituivano un aggravio di lavoro e di orario per gli studenti, non fornivano vantaggi per il conseguimento di lauree e diplomi, e ne concedevano molto pochi per l'adempimento degli obblighi militari. Una sconfitta inaspettata se si pensa che gli universitari erano già organizzati nel1926; e che nel1929 erano confluiti nei Gruppi Universitari Fascisti (GUF).
La Commissione Difesa ritenne quindi necessaria la riforma dei corsi di cultura militare; riforma che restò, per difficoltà finanziarie, allo stato di progetto fino agli anni 1932-1933. Solo
in questi anni fu possibile far sorgere, presso il Politecnico di Torino, la Scuola di balistica e di costruzioni di armi e artiglierie.
Se l'Università sfuggì in un primo momento all'indirizzo voluto dal Regime, diversamente avvenne, per la preparazione scolastica artatamente finalizzata, nelle scuole medie e primarie, laddove era ben chiaro che dovesse continuare la «preparazione morale» iniziata in famiglia e dove l'azione del Regime fu sostenuta dall'atteggiamento, in genere accondiscendente, del corpo docente.
Base della «preparazione morale» era l'esempio dell'educatore, coadiuvato dall'indispensabile contributo dei libri di testo, da scegliere con estrema cura per mantenere, nelle masse giovanili, «calda e viva la fiamma del sentimento nazionale».
Gli insegnanti dovevano essere incentivati con l'istituzione di opportuni premi di bcnemerènza, perché avvertissero anche tangibilmente l'importanza del compito. Fatto più importante, l'educazione morale doveva estrinsecarsi in educazione <iformale disciplinare, infondendo i concetti di disciplina, di obbedienza e di responsabilità, e sviluppando l 'attitudine al comando col senso dei doveri che da esso derivano».
Nel1934 tre leggi (n. 2150, 2151 e 2152), definite Leggi sulla Nazione Militare, codificavano organicamente l'iter che il cittadino doveva compiere per concorrere alla difesa morale e materiale della Nazione. Fu introdotta, infatti, accanto all'insegnamento della cultura militare, l'istruzione pre e postmilitare, un'idea che fra gli addetti ai lavori e fra i sostenitori della Nazione Armata aveva suscitato dibattiti fin dal 1919, c di cui il fascismo tentò di realizzarne l'attuazione, utilizzando il Partito, la Milizia e l'Esercito.
Il ciclo educativo avveniva in tre fasi progressive che cadenzavano le tre tappe fondamentali di formazione dcll'«uomo fascista»: balilla (8-14 anni), avanguardista (14-18 anni), giovane fascista (18-21 anni), per arrivare al servizio militare e all'istruzione postmilitare (fino al32° anno), intesa a mantenere inalterate le capacità di guerrieri e specializzati in. quanti le Forze Armate avevano formato.
T programmi dell'istruzione pre e post-militare erano dettagliati e l'idea in sé era ottima per uno Stato che faceva della forza la sua stessa ragione d'essere; ma al fervore dei programmi fecero riscontro lentezze burocratiche, scarsi entusiasmi, difficoltà finanziarie, nonostante la creazione di un Ispettorato apposito, cui fu preposto l'energico generale Grazioli.
L'Esercito ebbe il compito di fiancheggiare e sostenere gli obiettivi educativi del regime e di partecipare, a tal fine, all'opera di propaganda nel Paese: recuperando, con questo tramite, la sua partecipazione a tale attività, sia pure in assenza di appositi organi e di compiti specifici. Fatto che voleva sottolineare il divieto formale di non promuovere alcuna impresa per proprio conto. Va colta, però, una differenza

4.1
cellule e agitatori comunisti, anche in seno all'Esercito, non ebbe frutti. Più volte, negli anni dal 1926 al 1930, gli organi informativi ebbero a segnalare la diffusione di manifestini e di opuscoli contro il fascismo, tra i militari e all'interno delle caserme; ma parimente, quasi con soddisfazione, gli stessi organi annotavano come tali mezzi non avessero nessuna presa negli animi: sovente etano gli stessi militari a denunciare ai propri Comandi il ritrovamento di biglietti e giornaletti sovverstvL
L'inutilità dei tentativi di penetrazionc dell'ideologia comunista nel tessuto militare dovette risultare evidente anche ai promotori, che finirono con il desistere dalle loro iniziative, almeno fino allo scoppio della guerra civile spagnola.
L'educazione della Nazione all'idea fascista, la propaganda di Regime, l'arrivo alle armi di giovani che nelle scuole avevano respirato aria e cultura «guerriera», avevano sortito i loro effetti con il passar degli anni.
Più serie preoccupazioni destavano, anche se limitati e sporadici, i casi di diserzione, che avvenivano specialmente tra gli alpini e nei reparti di frontiera; cinque casi, segnalati nell'agosto 1930, fecero scattare severe punizioni nei confronti dei diretti comandanti «responsabili», e provocarono una dura cd allargata reprimenda del generale Pietro Gazzera, Sottosegretario alla Guerra, agli ufficiali, sollecitati a riflettere dell'altezza della loro missione e delle responsabilità derivanti dal
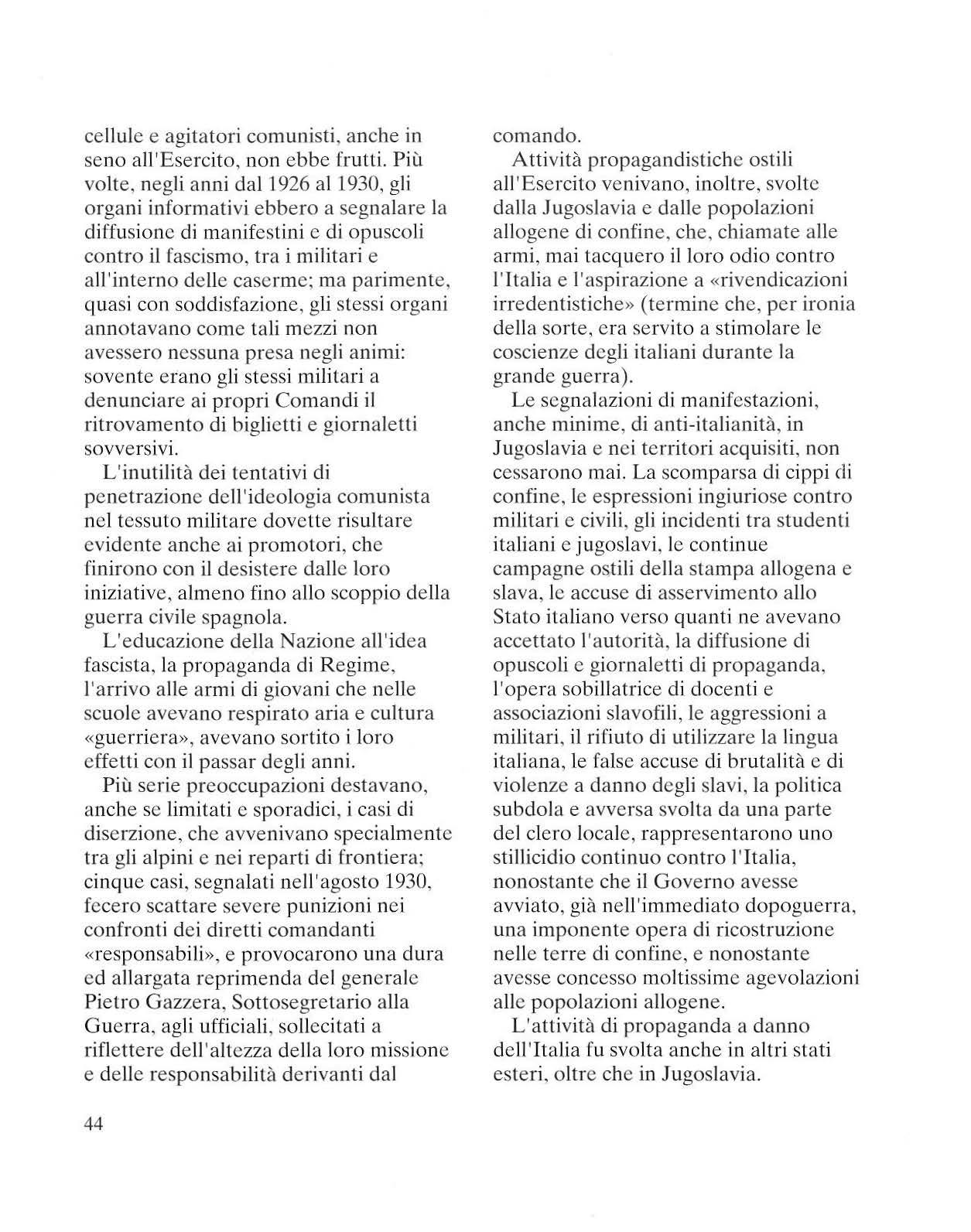
44 comando.
Attività propagandistiche ostili all'Esercito venivano, inoltre, svolte dalla Jugoslavia e dalle popolazioni allogene di confine, che, chiamate alle armi, mai tacquero il loro odio contro l'Italia e l'aspirazione a «rivendicazioni irredentistiche» (termine che, per ironia della sorte, era servito a stimolare le coscienze degli italiani durante la grande guerra).
Le scgnalazioni di manifestazioni, anche minime, di anti-italianità, in Jugoslavia e nei territori acquisiti, non cessarono mai. La scomparsa eli cippi di confine, le espressioni ingiuriose contro militari e civili, gli incidenti tra studenti italiani e jugoslavi, le continue campagne ostili della stampa allogena e slava, le accuse di asservimento allo Stato italiano verso quanti ne avevano accettato l'autorità, la diffusione di opuscoli e giornaletti di propaganda, l'opera sobillatrice eli docenti e associazioni slavofili, le aggressioni a militari, il rifiuto di utilizzare la lingua italiana, le false accuse di brutalità c di violenze a danno degli slavi, la politica subdola e avversa svolta da una parte del clero locale, rappresentarono uno stillicidio continuo contro l'Italia, nonostante che il Governo avesse avviato, già nell'immediato dopoguerra, una imponente opera di ricostruzione nelle terre di confine, e nonostante avesse concesso moltissime agevolazioni alle popolazioni allogene.
L'attività di propaganda a danno dell'Italia fu svolta anche in altri stati esteri, oltre che in Jugoslavia.










