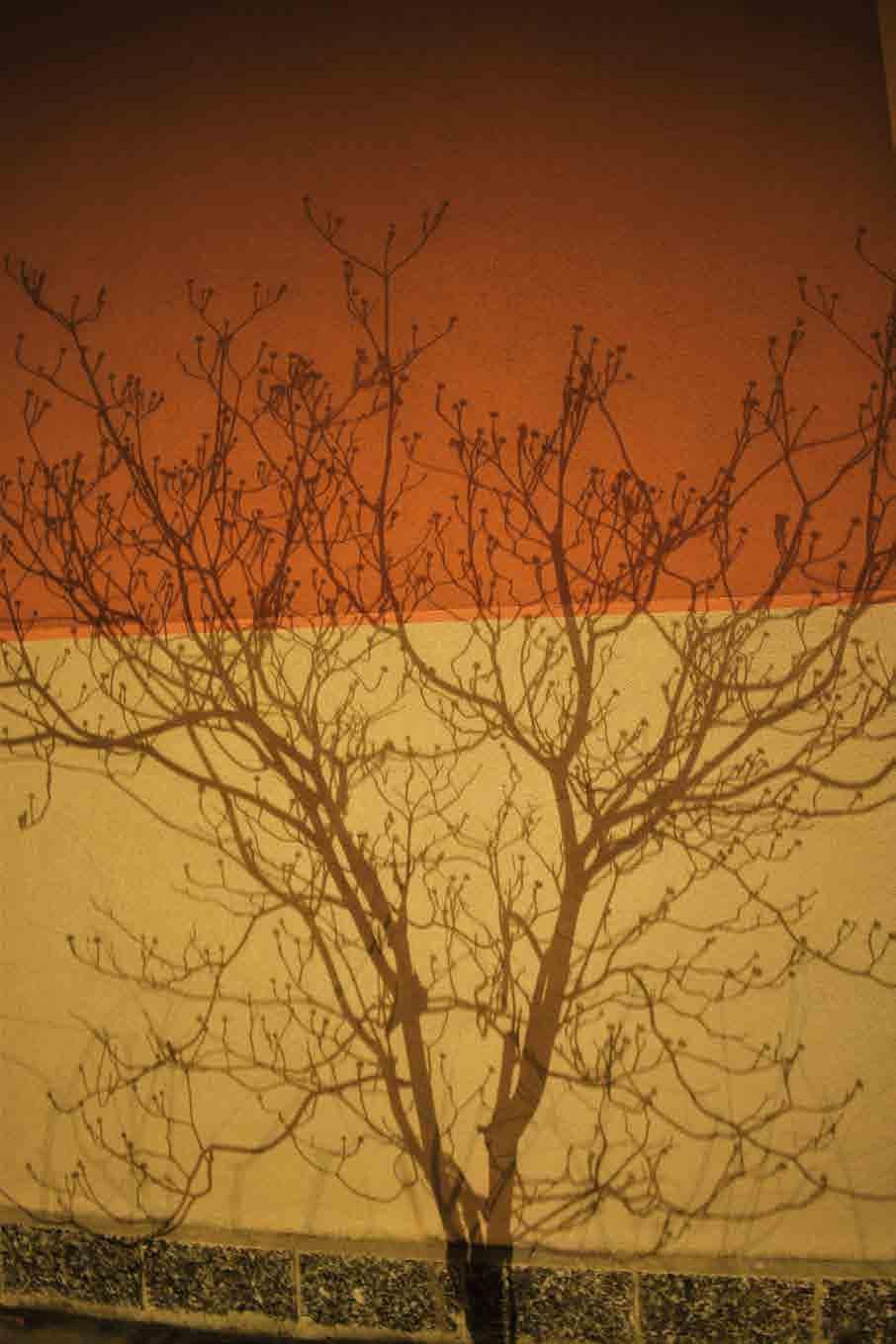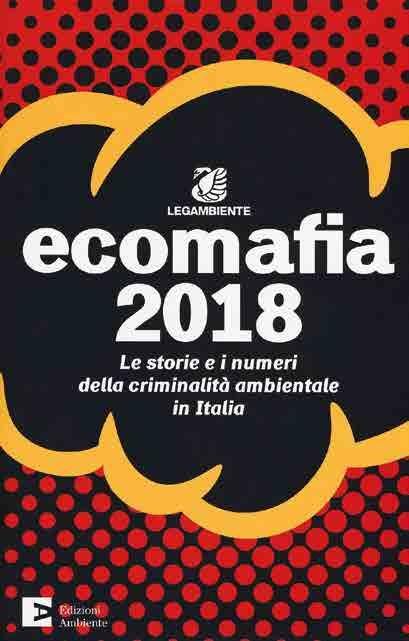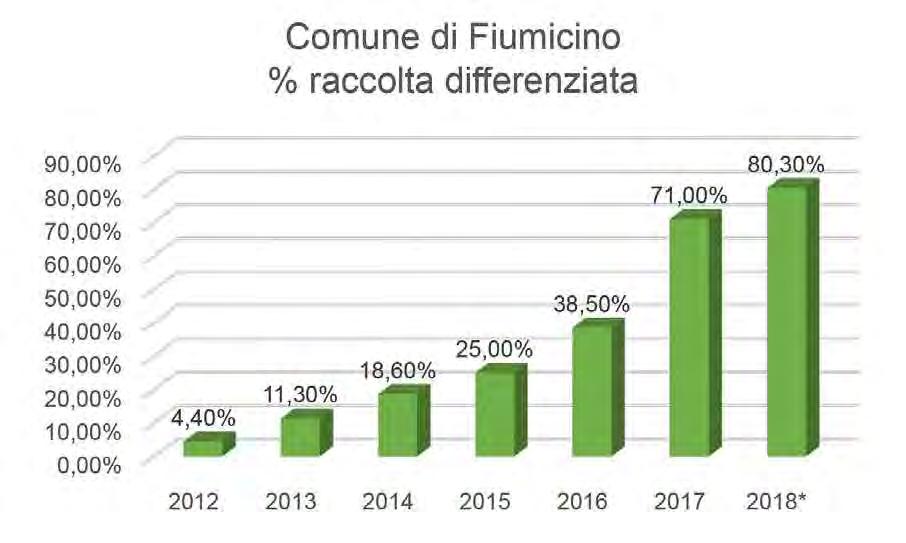GESTIONE
ECO-IMPRERSA
D.lgs. 231/2001: il modello dell’eco-impresa organizzata tra obblighi e opportunità (prima parte) di Antonio Di Cristofaro
76 igiene urbana igiene urbana ottobre-dicembre 2018
Cresce il fenomeno dei reati dei colletti bianchi, anche negli enti mossi da fini leciti. Un “viaggio” nel regime della responsabilità amministrativa degli enti e nelle opportunità offerte dal decreto legislativo 231/01, che persegue l’intento di sensibilizzare gli stessi operatori economici sui fenomeni della criminalità d’impresa e “disegna” un ente-garante. Il crescente fenomeno dei cosiddetti “white collar crimes” (reati dei colletti bianchi, vale a dire di criminalità economica), registrato fin dagli anni ’70, ha reso pressante per l’Unione Europea l’esigenza di introdurre un efficace sistema di contrasto dell’attività criminale, non di matrice individuale, ma riferibile agli Enti intesi come persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sul finire degli anni ’90 rispondere a tale esigenza è divenuto indispensabile vista la gravità e la frequenza degli scandali imprenditoriali internazionali quali quelli di Enron, Worldcom, Vivendi, e quelli italiani di Cirio, Parmalat ed altri.
Un fenomeno generalizzato Il fenomeno considerato ha riguardato non solo le imprese intrinsecamente illecite, cioè operanti per il perseguimento di un fine criminale, ma anche gli enti mossi da fini in sé leciti, ma perseguiti con policies aziendali aperte a pratiche illecite quali la corruzione, la truffa finanziaria, di lesione di interessi patrimoniali pubblici, etc. Ciò ha indotto il legislatore comunitario a sollecitare i singoli legislatori nazionali ad assumere strumenti legislativi capaci di perseguire direttamente le persone giuridiche ritenute responsabili di reati economici.
La Legge 300/2000 Su tali premesse interviene a livello nazionale la Legge Delega n. 300/2000, che configura storicamente un punto di partenza in quanto per la prima volta il legislatore italiano è chiamato a disciplinare la responsabilità amministrativa degli Enti collettivi per gli illeciti dipendenti da reato. Ciò ha costituito un’importante novità per il nostro ordinamento giuridico, che, più di altri, ha sempre manifestato una forte resistenza all’accoglimento del principio della responsabilità penale degli enti, trovando un ostacolo insormontabile nel principio “societas delinquere non potest” codificato nell’art. 27 della Costituzione. Per dare applicazione al mandato della Legge
Delega 300/2000, è stato emanato il D. Lgs. 231/2001, che istituisce la responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati posti in essere dai suoi amministratori, dirigenti o dipendenti nell’interesse e/o a vantaggio dell’Ente stesso.
Il 231, “tertium genus” Il legislatore italiano, tra le possibili opzioni normative - quali la proclamazione di una vera e propria responsabilità penale degli enti (prevista ad esempio in Belgio, Francia, Olanda, Irlanda, Canada, altri) o in alternativa la configurazione di una responsabilità non penale, sebbene connessa all’illecito penale - ha scelto di introdurre quello che nella relazione governativa accompagnatoria del D. Lgs. 231 viene definito un “tertium genus” di responsabilità: non di natura solo amministrativa poiché presuppone la commissione di un vero e proprio reato (illecito penale) e neppure di natura penale, poiché la sanzione comminabile all’ente, seppur tipicamente punitiva, è priva della funzione rieducativa che è propria della pena. La scelta normativa italiana, secondo alcuni commentatori, è stata quella di contemperare i tratti essenziali del sistema amministrativo e di quello penale, cercando di recepire ed adattare ai sistemi di matrice codicistica l’esperienza anglosassone dei Compliance Programs nord americani.